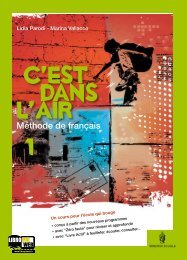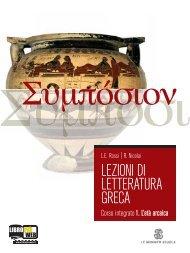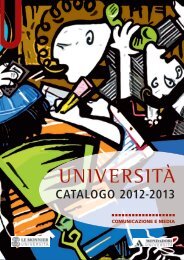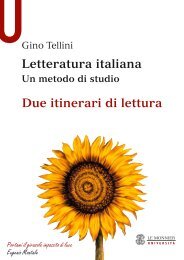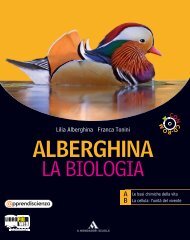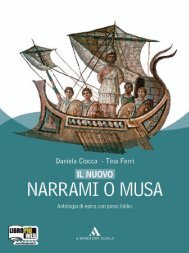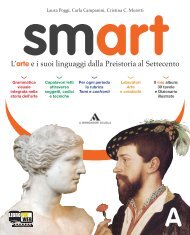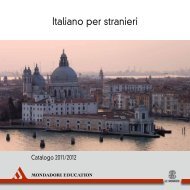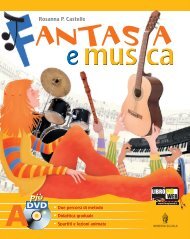Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
222 9 La tarda repubblica (133-44 a.C.)<br />
LA CULTURA IN BREVE<br />
La fi ne della repubblica<br />
• La cultura fa da supporto all’attività<br />
politica<br />
• Il pensiero politico è espressione<br />
dei ceti possidenti, sempre più<br />
conservatori<br />
• L’aspirazione a un princeps garante<br />
della pace pone le premesse del<br />
principato<br />
• Le fi losofi e legittimano sia<br />
l’impegno pubblico (lo stoicismo) sia<br />
il ritiro a vita privata (l’epicureismo)<br />
• La libertà dell’ultima repubblica è<br />
garante di una grande fi oritura<br />
letteraria<br />
12 Busto di Cicerone.<br />
Roma, Musei Capitolini.<br />
Il contesto culturale<br />
1 Il pensiero politico<br />
I testimoni del cambiamento<br />
Di pari passo con l’esplodere della violenza politica come segno di crisi delle<br />
istituzioni repubblicane, il I secolo a.C. fu il momento nel quale maturò la<br />
parte più signifi cativa del pensiero politico romano. Si creò cioè una dialettica<br />
di pensiero e azione nella quale, se l’ultima parola spettava alla forza delle<br />
armi, è anche vero che il dibattito culturale poneva le condizioni per legittimare<br />
il processo politico che sarebbe approdato al principato.<br />
La nostra conoscenza della cultura politica del I secolo fa capo in larga misura<br />
alla trattatistica di Cicerone (12) (vd. Capitolo 16, pp. 422 ss.) e alle considerazioni<br />
sparse che si ritrovano nell’opera storica di Sallustio (vd. Capitolo<br />
18, pp. 612 ss.): due autori che ebbero un ruolo importante nel travaglio ideologico<br />
che dalla crisi del regime cesariano portò al principato augusteo. Il che<br />
non signifi ca, tuttavia, che essi avessero le idee chiare in merito alla questione<br />
istituzionale: il loro moralismo, contaminando valutazioni politiche con elementi<br />
attinenti all’etica e ai costumi, non sempre li mise in condizione di cogliere<br />
distintamente il signifi cato degli eventi.<br />
La confusione ideologica<br />
La confusione è dovuta anche al fatto che alla violenza della lotta<br />
politica non sempre corrispondeva una effettiva diversità degli<br />
interessi in gioco. Per esempio, il pensiero di un ‘democratico’<br />
come Sallustio presenta ampie convergenze con quello di<br />
un conservatore come Cicerone: convinta fede nella libertas<br />
repubblicana, moralismo, appello al mos maiorum, invito alla<br />
concordia, rifi uto del populismo e salvaguardia dei ceti benestanti<br />
al potere sono elementi che accomunano i due scrittori.<br />
Come ha osservato Antonio La Penna, la scarsa differenziazione<br />
ideologica in una lotta spietata come quella<br />
dell’ultima repubblica si spiega con il fatto che<br />
ne furono unici protagonisti i ceti possidenti,<br />
la cui ansia di rinnovamento investiva<br />
esclusivamente l’ambito politico e quello<br />
morale, ma a condizione che permanesse<br />
immutato o quasi l’assetto economico<br />
e sociale.<br />
In questa preoccupazione della legalità<br />
a salvaguardia dei ceti possidenti<br />
si inquadrano non solo il conservatorismo<br />
sociale di Cicerone, ma anche<br />
l’adesione di Sallustio alla politica di<br />
Cesare e la sua avversione per Catilina:<br />
quest’ultimo era il sovversivo che<br />
prometteva remissione di debiti e proscrizione<br />
di ricchi, Cesare era il politico equilibra-