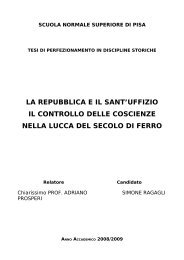- Page 1: SCUOLA NORMALE SUPERIORE P I S A TE
- Page 4 and 5: antiquario che a metà secolo inter
- Page 6 and 7: gentiluomini, agli umanisti, e agli
- Page 8 and 9: dalla latina e dalla greca 18 . Le
- Page 12 and 13: delle medaglie di nuova concezione
- Page 14 and 15: vista, la scelta delle medaglie pon
- Page 16 and 17: per regioni di produzione (“Itali
- Page 18 and 19: proprie soluzioni artisti milanesi,
- Page 20 and 21: dagli altri artefatti in bronzo 73
- Page 22 and 23: di frequente su foto da libro, si p
- Page 24 and 25: condotte a tal fine negli Archivi d
- Page 26 and 27: Il prof. Francesco Caglioti, che mi
- Page 28 and 29: SEZIONE I Leone Leoni e i primi med
- Page 30 and 31: Laddove poi, tra i pochi ritratti m
- Page 32 and 33: nell’altro caso, per l’area che
- Page 34 and 35: identificarono un livello qualitati
- Page 36 and 37: “Nato e nutrito” ad Arezzo o ne
- Page 38 and 39: nostro; dall’altro, l’intento d
- Page 40 and 41: quelle che a Roma e nel Veneto anda
- Page 42 and 43: isalire alla metà del XVI secolo):
- Page 44 and 45: Ferrante Sanseverino, celebrava in
- Page 46 and 47: A Pietro Aretino, più lungimirante
- Page 48 and 49: schema della monetazione imperiale,
- Page 50 and 51: gioielliere papale Pellegrino di Le
- Page 52 and 53: infatti il soggetto di un sesterzio
- Page 54 and 55: tridente e rivolge la testa verso l
- Page 56 and 57: servizio, lo nominò incisore dei c
- Page 58 and 59: stata rintracciata: la soluzione te
- Page 60 and 61:
Una commissione ricevuta da Carlo V
- Page 62 and 63:
Aretino, aveva scritto a Leoni nel
- Page 64 and 65:
Questo secondo periodo emiliano di
- Page 66 and 67:
Nel 1551 Leone ritrasse a tutto ton
- Page 68 and 69:
descrive una tempesta con l’inter
- Page 70 and 71:
ch’io non voglio parer arogante,
- Page 72 and 73:
milanese come palazzo gentilizio (1
- Page 74 and 75:
glorioso” consorte, ne affida i r
- Page 76 and 77:
L’influenza di Leoni sulla medagl
- Page 78 and 79:
cristallo, e le Vite del 1568 collo
- Page 80 and 81:
Bureau des Finances di Bruxelles (1
- Page 82 and 83:
È altresì in questo trentennio ib
- Page 84 and 85:
Il Nizolla, memorabile ai nostri oc
- Page 86 and 87:
Per ridefinire il corpus del Nizoll
- Page 88 and 89:
quando il nostro, laico e loricato,
- Page 90 and 91:
Già con la medaglia di Maria Tudor
- Page 92 and 93:
IV. Iacopo da Trezzo e la cultura f
- Page 94 and 95:
con Leoni un ritorno ai caratteri d
- Page 96 and 97:
può essere assunta come spartiacqu
- Page 98 and 99:
ma abbia addirittura realizzato, in
- Page 100 and 101:
il quale non sono documentate opere
- Page 102 and 103:
SEZIONE II La seconda generazione 7
- Page 104 and 105:
A ciò si è aggiunta la scarsità
- Page 106 and 107:
“LIPPA CAPTA” 407 ; “CAPTIS S
- Page 108 and 109:
datata su basi esterne al 1556-57 4
- Page 110 and 111:
“TRANSILVANIA CAPTA” potrebbero
- Page 112 and 113:
fontaniano di Giovambattista Castal
- Page 114 and 115:
d’Avalos e di Ottaviano Ferrari.
- Page 116 and 117:
inclusione nel corpus di Fontana ci
- Page 119 and 120:
Cap. I.4. Arrivi dall’Italia Cent
- Page 121 and 122:
Sulla scia della generosa menzione
- Page 123 and 124:
concesso da Francesco I a Cellini e
- Page 125 and 126:
Bregno: certo non possiamo dare per
- Page 127 and 128:
d’argent en forme de table quarr
- Page 129 and 130:
2. Il catalogo di “PPR”: propos
- Page 131 and 132:
definizione delle palpebre e dalla
- Page 133 and 134:
configurano infatti un rapporto di
- Page 135 and 136:
soprattutto ai riaffioramenti diret
- Page 137 and 138:
Cap. I.5. Milanesi fuori Milano La
- Page 139 and 140:
volle il Gori, che in pieno Settece
- Page 141 and 142:
medaglia di Enrico II di Valois (15
- Page 143 and 144:
all’opera di Giovannantonio è pe
- Page 145 and 146:
Ansioso di lavorare in proprio, Pom
- Page 147 and 148:
Del ridotto corpus di Pompeo Leoni
- Page 149 and 150:
assunta come un ante quem per la me
- Page 151 and 152:
soprattutto delle ciocche presentan
- Page 153 and 154:
sovrani riconduce anche una medagli
- Page 155 and 156:
Poi, verso la fine del papato farne
- Page 157 and 158:
Cap. I.6. Presunti lombardi: la que
- Page 159 and 160:
compare non lontano dalla biografia
- Page 161 and 162:
seconda versione della medaglia di
- Page 163 and 164:
insieme, prossimo alla maniera “d
- Page 165 and 166:
Nel catalogo di Antonio si delinea
- Page 167 and 168:
Emilia, del resto, che la produzion
- Page 169 and 170:
nell’aggiornamento di Pastorino,
- Page 171 and 172:
maniera rimase quella di un artista
- Page 173 and 174:
Cap. I.7. Appunti per una cronologi
- Page 175 and 176:
che le suggestioni formali attive s
- Page 177 and 178:
anche per dettagli epigrafici (la l
- Page 179 and 180:
L’arrivo a Milano del principe er
- Page 181 and 182:
di Iacopo fornirono così a loro vo
- Page 183 and 184:
capoluogo lombardo. Solo la sua mor
- Page 185 and 186:
(un omonimo, non un parente dell’
- Page 187 and 188:
161
- Page 189 and 190:
Parte II “Che siano più in prezi
- Page 191 and 192:
altri membri della famiglia imperia
- Page 193 and 194:
Cap. II.1. “Legittimamente, e non
- Page 195 and 196:
l’origine romana e la tradizione
- Page 197 and 198:
messaggi politici resi intelligibil
- Page 199 and 200:
Al viaggio del 1530 risale infine u
- Page 201 and 202:
sue figure (ivi compresa la diviniz
- Page 203 and 204:
che omaggiava il rispetto di Carlo
- Page 205 and 206:
Il recto delle nuove emissioni asbu
- Page 207 and 208:
ma potevano anche essere impiegate
- Page 209 and 210:
È noto poi che il Vescovo di Nocer
- Page 211 and 212:
trenta aveva affiancato nomi come G
- Page 213 and 214:
Cap. II.2. Bruxelles, Yuste e Cigal
- Page 215 and 216:
(come Vienna e Parigi, dove la sore
- Page 217 and 218:
successione lo chiamavano a sedimen
- Page 219 and 220:
compare infatti un elenco dei “me
- Page 221 and 222:
collezionista di “medaglie” che
- Page 223 and 224:
iblioteca reale e degli altri ambie
- Page 225 and 226:
Yuste queste misure non davano luog
- Page 227 and 228:
tagli ritrattistici scorciati e mag
- Page 229 and 230:
VIII. I microritratti di commission
- Page 231 and 232:
Ulteriore risalto a tale severa sce
- Page 233 and 234:
edondo”, “un retrato de latón
- Page 235 and 236:
Cap. II.3. “Che si diletta de que
- Page 237 and 238:
egli accumulò competenze che avreb
- Page 239 and 240:
a lui più affine rispetto a quella
- Page 241 and 242:
Le prime ducento monete, de le qual
- Page 243 and 244:
Nel 1551, quando i capelli del Mons
- Page 245 and 246:
Possiamo dunque concludere che alla
- Page 247 and 248:
IV. Le strategie di committenza del
- Page 249 and 250:
soltanto gli anni delle committenze
- Page 251 and 252:
serie non fosse lo stesso Perrenot,
- Page 253 and 254:
Cap. II.4. La città di Milano: gov
- Page 255 and 256:
iconciliazione tra i Francesi e gli
- Page 257 and 258:
Un’operazione culturale simile a
- Page 259 and 260:
grandezza”, mentre a sua volta il
- Page 261 and 262:
Il travestimento letterario (anche
- Page 263 and 264:
itrattistica aulica. Il rovescio di
- Page 265 and 266:
alla nuova cultura letteraria promo
- Page 267 and 268:
quelli attribuiti a Fontana da Rizz
- Page 269 and 270:
del padre era infatti iniziata con
- Page 271 and 272:
Se consideriamo il fatto che nel 15
- Page 273 and 274:
In alcuni casi si assistette ad una
- Page 275 and 276:
Castaldo celebrò postumamente la p
- Page 277 and 278:
potremmo facilmente presupporre per
- Page 279 and 280:
milanese) 1161 . Ma il Discorso di
- Page 281 and 282:
medaglia incoraggiò in particolare
- Page 283 and 284:
dopo aver risparmiato dalla pena ca
- Page 285 and 286:
appresentabili espose la medaglia a
- Page 287 and 288:
milanesi e venete rimase però infl
- Page 289 and 290:
Conclusioni Per una storia sociale
- Page 291 and 292:
soddisfare gli artisti della medagl
- Page 293 and 294:
Appendice I Estratti medaglistici d
- Page 295 and 296:
[…] Le monete di vostra Signoria
- Page 297 and 298:
potendo vostra Signoria con onor su
- Page 299 and 300:
e grandemente riverente del nome di
- Page 301 and 302:
farmi gratia d’accettar il buon a
- Page 303 and 304:
Bibliografia FONTI ARCHIVISTICHE AG
- Page 305 and 306:
Agosti, Amirante e Naldi 2001 = Bar
- Page 307 and 308:
Babelon 1963 = Jean Babelon, A prop
- Page 309 and 310:
Berra 1950 = Luigi Berra, Una sfida
- Page 311 and 312:
Bottari e Ticozzi 1822-25 = Giovann
- Page 313 and 314:
Casati 1884 = Carlo Casati, Leone L
- Page 315 and 316:
Cochrane 1988 = Eric Cochrane, Ital
- Page 317 and 318:
Cupperi c.s. (2) = Walter Cupperi,
- Page 319 and 320:
Deschamps de Pas 1857 = L. Deschamp
- Page 321 and 322:
Fabbro 1977 = Tiziano [Vecellio], L
- Page 323 and 324:
Gaborit 1994 = Jean-René Gaborit,
- Page 325 and 326:
Godoy e Leydi 2003 = Parures triomp
- Page 327 and 328:
Heinzl Wied 1973 = Brigitte Heinzl
- Page 329 and 330:
Hirsch 1908 = Jacob Hirsch, Sammlun
- Page 331 and 332:
Kliemann 1981 = Julian Kliemann, Va
- Page 333 and 334:
Leone De Castris 1997 = Pierluigi L
- Page 335 and 336:
Martinelli 1968 = Valentino Martine
- Page 337 and 338:
Modena 1959 = Silvana Modena, Diseg
- Page 339 and 340:
Norris e Weber 1976 = Andrea S. Nor
- Page 341 and 342:
Philippson 1895 = Martin Philippson
- Page 343 and 344:
Radcliffe 1988 = Anthony Radcliffe,
- Page 345 and 346:
Ruscelli 1552 = Girolamo Ruscelli,
- Page 347 and 348:
Seipel 2003 = Kaiser Ferdinand I. 1
- Page 349 and 350:
Thornton 2006 = Dora Thornton, A Pl
- Page 351 and 352:
Vecce 1997 = Carlo Vecce, Vittoria
- Page 353 and 354:
Welzel 2005 = Barbara Welzel, Widow
- Page 355 and 356:
Indice LA MEDAGLIA NELLA MILANO ASB
- Page 357 and 358:
3. Antonio Abbondio, un esordio emi
- Page 359:
ESTRATTI MEDAGLISTICI DAL «CARGO D