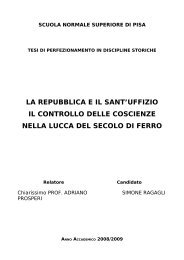La medaglia nella Milano asburgica - Scuola Normale Superiore
La medaglia nella Milano asburgica - Scuola Normale Superiore
La medaglia nella Milano asburgica - Scuola Normale Superiore
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
paragone con le arti maggiori che preparava l’esordio monumentale dell’artista, ma<br />
denunciava anche la centralità ormai assunta dalla microplastica all’interno del sistema<br />
delle arti.<br />
Le effigi di Paolo III realizzate nel 1538 (ivi comprese le medaglie) mostrano con chiarezza<br />
che la riflessione romana investiva anche il ritratto e i suoi problemi specifici – il rapporto<br />
tra caratterizzazione e regolarizzazione, impaginazione di profilo e scorcio 160 . Il cranio<br />
perfettamente circolare del Pontefice si anima <strong>nella</strong> sottile pelle delle tempie; gli occhi sono<br />
incavati in un morbido chiaroscuro; la barba abbandona la stilizzazione a ciocche<br />
paralleliformi per farsi cotonata come fosse dipinta. Il piviale disegna un trapezio smussato<br />
sul lato tergale, ed unisce così la modularità delle superfici, l’avvitamento del busto, il<br />
ritmo circolare dei tagli e del bordo. <strong>La</strong> convenzionale balaustra suggerita dalla cornice<br />
pittorica è recuperata dalla linea orizzontale che delimita l’esergo, reinvenzione leoniana di<br />
un dispositivo usato per impaginare i rovesci nelle monete antiche.<br />
Il primato di Leoni raggiunge i suoi massimi livelli nei coni per moneta, dove l’aria più che<br />
mai raffaellesca delle teste convive con spunti geniali tesi ad esaltare un modellato più<br />
articolato e sapientemente graduato di qualsiasi precedente romano. I suo ritratti monetali<br />
sono caratterizzati dalle dimensioni debordanti del capo; dal busto che emerge, stiacciato,<br />
appena a ridosso del margine del tondello, coprendo il piano dell’iscrizione che lo sfiora<br />
invece come un nimbo inclinato; dalle massicce figure dei rovesci, ingrandite a piano<br />
americano per rendere leggibili i tratti del volto; e dalla muscolatura eroica e analiticamente<br />
descritta. Quale scultore non solo di coni, ma persino di marmi poteva ritrarre con simili<br />
forme <strong>nella</strong> Roma protofarnesiana? Negli anni trenta Leoni rappresentò in città una delle<br />
poche voci di rilievo che non parlasse in scultura con accento puramente toscano.<br />
L’assunzione di Cellini e Leoni ha il valore di un ricambio generazionale: il passaggio di<br />
testimone tra Leoni e Bernardi, che per i ritratti papali ebbe luogo nel 1538, si sarebbe<br />
ripetuto nel 1541 per quelli cesarei. Non è infatti priva di rilievo la ricorrenza con cui i<br />
medaglisti papali (da Bernardi a Leoni) venivano segnalati all’establishment asburgico in<br />
Italia: fino agli anni quaranta, quando a <strong>Milano</strong> lievitò una produzione ad alto livello, Roma<br />
rimase l’interlocutore privilegiato dei luogotenenti di Carlo V: una scelta che, come<br />
vedremo, non fu priva di conseguenze sulla qualità antiquaria degli stili e dei linguaggi che<br />
circolarono tra i filoimperiali.<br />
6. Genova, 1541: immagini per Andrea Doria<br />
<strong>La</strong> competitività della corte romana non risparmiò nemmeno Leone: percepita la sua ultima<br />
provvisione nel marzo del 1540 161 , lo scultore venne arrestato per il ferimento del<br />
160 A tale proposito è di particolare interesse una variante dell’effigie paolina nota solo in un esemplare del<br />
Museo Nazionale del Bargello, nel quale questo ritratto più raro è unito con l’altro recto più comune: Pollard<br />
1984-85, II, p. 982, n. 522 (segnala la firma sul bordo del piviale); Toderi e Vannel 2000, I, p. 42, n. 25 (non<br />
riportano la duplice firma del tipo a busto allungato); Toderi e Vannel 2003, I, p. 49, n. 417 (segnalano la<br />
doppia firma); Modesti 2002-, II, p. 94, n. 301 (ignora la doppia firma). Forse è della stessa effigie conservata<br />
in un diverso ibrido dei Musei Vaticani (riprodotto, ma non schedato in Modesti, 2002-, I, p. 87). Si tratta<br />
probabilmente di un tipo rigettato che documenta una precoce sperimentazione nel taglio del busto (allungato<br />
per consentire un’articolazione tridimensionale più chiara della torsione del bacino). Esso mostra anche che<br />
l’incisore studiò la possibilità di impaginare in maniera più enfatica l’iscrizione autoriale, della quale presenta<br />
sulla stessa faccia due diverse versioni: 1. “LEO”, 2,8x0,6mm, rilevata, centrata, ricavata sul taglio della<br />
spalla sinistra; 2. “LEO”, 2,4x1,4mm, rilevata e ricavata sulla figura all’estremità inferiore del piviale, con<br />
orientamento parallelo all’asse del conio. È possibile che la doppia iscrizione testimoni un primo tentativo di<br />
apporre la ‘firma’ in posizione esposta, ma la soluzione dovette essere scartata per problemi di leggibilità. A<br />
partire dalla <strong>medaglia</strong> di Martin de Hanna (1545), nuovi tentativi di ‘firma’ esposta verranno condotti con<br />
caratteri liberi proprio sul taglio della spalla, che verrà appositamente inclinato di 45 gradi.<br />
161 Müntz 1884, pp. 322-324, dà la notizia (ripresa anche da Martinori 1917-30, IX, p. 52) di alcuni pagamenti<br />
effettuati nei primi tre mesi del 1541 per corrispondere a Leoni la sua provvisione ordinaria; una verifica in<br />
23