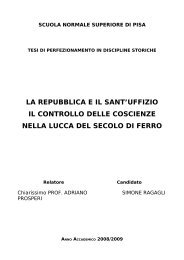La medaglia nella Milano asburgica - Scuola Normale Superiore
La medaglia nella Milano asburgica - Scuola Normale Superiore
La medaglia nella Milano asburgica - Scuola Normale Superiore
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
III. Genesi e campo dell’indagine<br />
1. Le medaglie del Ducato di <strong>Milano</strong> agli inizi dell’età <strong>asburgica</strong><br />
Il presente lavoro nasce sulla scia di precedenti ricerche (non tutte pubblicate) riguardanti la<br />
figura di Leone Leoni: indagare attraverso un caso specifico i complessi rapporti intercorsi<br />
tra oreficeria, microritratti metallici e scultura monumentale <strong>nella</strong> seconda metà del<br />
Cinquecento ha permesso a chi scrive di comprendere l’interesse di uno studio che<br />
affrontasse nel suo complesso il tema delle medaglie realizzate a <strong>Milano</strong> durante i primi<br />
decenni della dominazione spagnola in Lombardia, o più precisamente durante il periodo<br />
compreso tra il 1535, data di morte di Francesco II Sforza, e il 1571, anno nel quale<br />
vennero a mancare Francesco Ferdinando d’Avalos, governatore di <strong>Milano</strong> dal 1560 al<br />
1563, e Gabriel de la Cueva, suo successore dal 1564 al 1571.<br />
Il corpus esaminato in questa ricerca comprende circa duecentocinquanta tipi di medaglie,<br />
la maggior parte delle quali è esclusa dal repertorio di Italian Medals of the Renaissance<br />
before Cellini pubblicato nel 1530 dallo Hill. Sono state però considerate anche le cere, i<br />
cammei e le monete che risultassero importanti per delineare il profilo di un artefice o per<br />
spiegare le classi di una collezione (giacché negli inventari cinquecenteschi il termine<br />
‘<strong>medaglia</strong>’ non indica rigorosamente solo i manufatti in metallo, ma anche piccoli rilievi<br />
realizzati secondo le stesse convenzioni, come intagli ed oggetti che oggi definiremmo<br />
badges o monete fuori corso).<br />
L’impegno maggiore di una simile ricerca consiste ancora oggi nel reperimento dei migliori<br />
esemplari. Una buona parte dei tipi esaminati è rara o estremamente rara (lo sono ad<br />
esempio alcune medaglie papali di Leone Leoni e buona parte di quelle di Pompeo), e a<br />
tutt’oggi collezioni di prima importanza come quelle di Parigi, Brescia e Venezia non sono<br />
illustrate da riproduzioni a stampa, mentre i medaglieri di Monaco di Baviera, Vienna e<br />
Roma sono privi anche di cataloghi. Appena migliore è la fruibilità del patrimonio<br />
medaglistico delle Civiche Raccolte Numismatiche di <strong>Milano</strong>, che è pubblicato solo per<br />
quanto riguarda alcuni artisti, ma rimane quasi insondato per quanto concerne i numerosi<br />
pezzi anonimi della collezione.<br />
Nonostante la pubblicazione di strumenti come il repertorio di Vannel e Toderi (2000) e il<br />
catalogo delle collezioni museali britanniche di Philip Attwood (2003), per il presente<br />
lavoro l’esame autoptico di più collezioni (le Civiche Raccolte Numismatiche di <strong>Milano</strong>, i<br />
Civici Musei di Santa Giulia a Brescia, il Museo del Bargello di Firenze, il Medagliere<br />
Vaticano, il Medagliere Capitolino di Roma, il Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona,<br />
il British Museum e la Wallace Collection di Londra, il Cabinet des Médailles della<br />
Bibliothèque Nationale di Parigi, il Museo Arqueológico Nacional, il Museo del Prado e il<br />
Museo Lázaro-Galdiano di Madrid, l’Ashmolean Museum di Oxford, il Fitzwilliam<br />
Museum di Cambridge) e l’organizzazione dei dati attraverso un database WIN/ISIS si è<br />
reso comunque necessario allo scopo di verificare le attribuzioni operando confronti dal<br />
vero. Il lettore di questa tesi è infatti avvertito che la particolare natura della <strong>medaglia</strong>,<br />
oggetto di dimensioni limitate, di colore scuro e dalla superficie lucida, rende impossibile<br />
illuminarne e riprodurne il rilievo senza generare lustri ed ampie zone d’ombra. <strong>La</strong><br />
cospicua perdita di dettagli (soprattutto <strong>nella</strong> lavorazione dei capelli e delle pupille), i criteri<br />
difformi adottati per l’illuminazione dei pezzi e il fatto che si continuino ad utilizzare<br />
campagne fotografiche realizzate per esigenze diverse da quelle del conoscitore sono fattori<br />
che rendono estremamente scivoloso il ricorso alle riproduzioni disponibili <strong>nella</strong><br />
bibliografia di settore: in alcuni casi anche un semplice cambiamento <strong>nella</strong> patina o la mera<br />
presenza della doratura, dissimulati dall’impiego di pellicole in bianco e nero, possono dar<br />
luogo nelle riproduzioni a differenze fuorvianti. Il repertorio di Vannel e Toderi, che si basa<br />
XIX