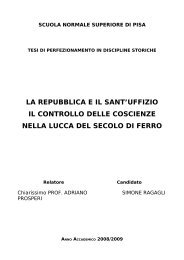La medaglia nella Milano asburgica - Scuola Normale Superiore
La medaglia nella Milano asburgica - Scuola Normale Superiore
La medaglia nella Milano asburgica - Scuola Normale Superiore
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Questa circostanza è alla base della particolare intonazione diplomatica richiesta dal Doria<br />
alle opere genovesi di Leone, nelle quali il ricorso sistematico al codice monetale antico<br />
come mezzo comunicativo tradisce la mano esperta di un numismatico non ancora<br />
identificato, che secondo Gorse potrebbe essere Paolo Giovio 169 . <strong>La</strong> raffinatezza del<br />
riadattamento iconografico può essere apprezzata considerando il fatto che i diversi modelli<br />
monetali, tutti di età repubblicana, furono prescelti per suggerire un grado di decoro<br />
inferiore rispetto a quello “augusteo” impiegato dalla medaglistica imperiale e pontificia. I<br />
valori politici esaltati dai rovesci non erano espressione dei poteri goduti dal celebrato,<br />
bensì di un accordo e di una onorificenza sottoscritti dalla comunità.<br />
Il primo rovescio della <strong>medaglia</strong> di Andrea Doria (“LIBERTAS PVBLICA”), più raro,<br />
allude alla posizione di primus inter pares che l’ammiraglio assunse rispetto al governo<br />
oligarchico di Genova 170 .<br />
Il secondo rovescio raffigura una galea battente bandiera imperiale 171 . Al suo fianco naviga<br />
una barca e in primo piano, sopra uno scoglio, giace una figura seduta che protende un’asta<br />
od un remo (rappresenta Nettuno pacificatore o, come vorrebbe Pollard, una mera parentesi<br />
arcadica di tranquillitas piscatoria?) 172 . Il rovescio è spesso interpretato come la<br />
raffigurazione della liberazione di prigionieri avvenuta nel 1540 grazie alla cattura del<br />
pirata Dragut; ma anche se il significato puntuale dell’immagine rimane incerto, la<br />
derivazione da motivi iconografici della monetazione d’età romana ne fornisce con<br />
sicurezza il senso generale: una galea “coi suoi ordini de remi [...] e alcune figure dentro” è<br />
Doria-Pamphili di Roma, per i quali cfr. Parma Armani 1986, pp. 99-101 e 271-272; Boccardo 1989, p. 110;<br />
Gorse 1995, p. 260). Non a caso lo stesso motivo encomiastico della prima placchetta (“el illustrissimo<br />
príncipe D’Oria, nostro nuevo Neptuno, y general cesareo”) era stato opportunamente ricordato dal<br />
provveditore imperiale Duarte in una lettera all’Aretino del 3 giugno 1541 (Aretino 2003-04, II (1552), p.<br />
172, n. 160). <strong>La</strong> lettera dello scrittore e le opere metalloplastiche del suo protetto applicavano alle<br />
celebrazioni genovesi il loro sperimentato principio di complementarità tra letteratura ed arti visive.<br />
169 Gorse 1995, p. 261 (ma su questo problema ritorneremo più diffusamente nel corso del cap. II.1). In due<br />
dei tre tipi l’assenza d’iscrizioni sul rovescio, alquanto anomala, va senz’altro letta come un indizio<br />
dell’esistenza di un codice celebrativo ampiamente condiviso.<br />
170 Sul tipo con “LIBERTAS PVBLICA cfr. Armand 1883-87, I, p. 164, n. 10, e III, p. 68, n. m; Casati 1883,<br />
p. 50, n. 3; Plon 1887, p. 257; Toderi e Vannel 2000, I, p. 44, n. 35. Esemplari: Johnson e Martini 1994, p.<br />
117, nn. 2233-34; Börner 1997, p. 173, n. 746; Attwood 2003, I, p. 96, n. 9. Come modelli per la didascalia<br />
segnalo in particolare un denario ed un dipondio di Galba (Vico 1548, c. 35v, in RIC, I, p. 203, n. 35 e p. 205,<br />
n. 59). L’iconografia dipende invece dall’asse claudiano riprodotto da Vico 1548, c. 28r (RIC, I, p. 130, n.<br />
69), che presenta Libertas con pileo <strong>nella</strong> destra ed il braccio sinistro estroflesso e legenda “LIBERTAS<br />
AVGVSTA”. <strong>La</strong> scelta di contaminare i due modelli correggendo sulla base del primo la didascalia del<br />
secondo, più attraente dal punto di vista figurativo, prova che la committenza intese presentare la<br />
sopravvivenza della repubblica di Genova come il prodotto di un processo politico interno, e non come<br />
concessione di Carlo o di Andrea.<br />
171 Bibliografia: Armand 1883-87, I, p. 164, n. 9, e III, p. 68, n. l; Plon 1887, p. 256; Fabriczy 1904 (1903), p.<br />
200, tav. XXXIX, fig. 1; Habich 1924, pp. 131-134, tav. XCI, fig. 1; Jones 1979, figg. 132-134 (pubblica i<br />
presunti disegni preparatori per il recto, oggi alla J. Pierpont Morgan Library di New York); Cano Cuesta<br />
1994, p. 174, n. 29; Gorse 1995, p. 260; Toderi e Vannel 2000, I, p. 43, n. 31. Esemplari principali: Rizzini<br />
1892, p. 36, n. 235; Álvarez-Ossorio 1950, p. 132, n. 164; Hill e Pollard 1967, p. 82, n. 431 (con collare);<br />
Valerio 1977, p. 137, n. 94; Pollard 1984-85, III, p. 1218, n. 711; Johnson e Martini 1994, pp. 117-120, nn.<br />
2236-2240 (senza collare i nn. 2236-37); Börner 1997, p. 172, n. 745 (con collare); Attwood 2003, I, p. 94, n.<br />
5, Toderi e Vannel 2003, I, p. 50, nn. 424-427.<br />
172 Erizzo riproduce nel 1559 il verso di una “<strong>medaglia</strong>” di Nerone che rappresenta una simile figura tutelare<br />
(pp. 166-167): “ha per riverso un porto con alquante navi, et di minutissima figura scolpite; et una figura nel<br />
porto sedente, di Nettuno, che con la destra appoggia un temone in terra, e con la sinistra abbraccia un<br />
delfino”. L’emissione celebrava la costruzione del porto di Ostia: “[...] per Nettuno sopra il porto sedente<br />
intendiamo la quiete del mare. Et il temone cacciato a terra ci dà segno della navigatione nel porto” (cfr. RIC,<br />
I, pp. 151-152, nn. 88-108, tav. X, fig. 168).<br />
25