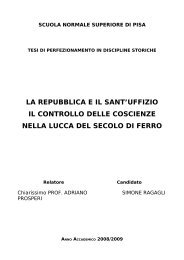La medaglia nella Milano asburgica - Scuola Normale Superiore
La medaglia nella Milano asburgica - Scuola Normale Superiore
La medaglia nella Milano asburgica - Scuola Normale Superiore
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
critiche dell’Aretino, che già nel 1537 collegava il “gran rilievo in acciaio” delle coniazioni<br />
di nuova generazione con la possibilità di conferire più profonda “maestà” di posa<br />
all’“effigie” e di dispiegare in ritratti vividi la “maraviglia de l’arte” 15 ?<br />
L’importanza assunta dalla <strong>medaglia</strong> nel corso del Cinquecento non dipendeva però solo<br />
dalla sua efficacia comunicativa: in diversi casi le raccolte di microritratti metallici<br />
traevano infatti origine da un vero e proprio apprezzamento artistico. È lo stesso Vasari ad<br />
affermare che gli scultori del suo tempo tenevano da conto le medaglie di Antonio<br />
Pollaiolo, e ad osservare che le coniazioni di Benvenuto Cellini (non solo le sue medaglie,<br />
ma anche le sue monete per Alessandro de’ Medici) erano “così belle e con tanta diligenza,<br />
che alcune di esse” si collezionavano “come bellissime medaglie antiche: e meritamente,<br />
perciò che in queste vinse se stesso” 16 . Ai tempi di Vasari, in effetti, erano assai più comuni<br />
le collezioni di monete di età romana, come quella di “medaglie e qualche altra cosa antica”<br />
raccolta da Pietro Bembo e da lui ricordata in una lettera a Flaminio Tomarozzo del 23<br />
agosto 1543 17 .<br />
A proposito della qualità artistica delle migliori medaglie moderne non va poi trascurata<br />
l’enfasi con cui Vasari riportava <strong>nella</strong> Vita di Vittore Pisano (1568) un lungo passo<br />
epistolare con il quale, il 12 novembre 1551, monsignor Paolo Giovio descriveva al duca<br />
Cosimo i propri “medaglioni” di Pisanello, raccomandandoli sulla base di un preciso<br />
giudizio formale:<br />
Costui fu ancora prestantissimo nell’opera de’ bassi rilievi, stimati difficilissimi dagl’artefici, perché sono<br />
il mezzo tra il piano delle pitture e ’l tondo delle statue. E perciò si veggiono di sua mano molte lodate<br />
medaglie di gran prìncipi, fatte in forma maiuscola, della misura propria di quel riverso che il Guidi mi ha<br />
mandato del cavallo armato. Fra le quali io ho quella del gran re Alfonso in zazzera, con un riverso d’una<br />
celata capitanale; quella di papa Martino, con l’arme di casa Colonna per riverso; quella di sultan<br />
Maomete che prese Costantinopoli, con lui medesimo a cavallo in abito turchesco con una sferza in mano;<br />
Sigismondo Malatesta, con un riverso di madonna Isotta d’Arimino; e Niccolò Piccinino con un berettone<br />
bislungo in testa, col detto riverso del Guidi, il quale rimando. Oltra questo ho ancora una bellissima<br />
<strong>medaglia</strong> di Giovanni Paleologo imperatore de Costantinopoli, con quel biz[z]arro cappello alla grecanica<br />
che solevano portare gl’imperatori; e fu fatta da esso Pisano in Fiorenza al tempo del Concilio d’Eugenio,<br />
ove si trovò il prefato imperadore, ch’à per riverso la croce di Cristo sostentata da due mani, verbigrazia<br />
lettera al Sansovino con cui l’Aretino dichiarava il proprio disinteresse ad un paragone tra pittura e scultura<br />
privo di risvolti operativi (ibidem, p. 592, n. II). L’importanza di tali giudizi rispetto alla disputa varchiana<br />
sulle arti e alla storiografia vasariana non è sfuggita a Barocchi 1960-62, I, pp. 315 e ss. (cfr. anche<br />
l’Introduzione a Varchi e Borghini 1998, pp. VII-XII). Tra i testi che risposero all’interrogazione del Varchi,<br />
accenna infatti alla “<strong>medaglia</strong>”, cioè alle monete antiche, solo un passo in cui Francesco da Sangallo<br />
contrappone il giudizio dei finti intenditori a quello dei maestri dell’arte: “Ce n’è pure assai [di scultori] che<br />
fanno professione d’intendere e lodano e biasimano, come se proprio de l’arte fussino, e per aver veduto<br />
quatro medagliucce e imparato qualche vocabolo de l’arte fanno tanto con varie adulazione, perché non sono<br />
stati corteggiati e non hanno avuto le sberettate, e per non essere cacciati di quei luoghi che par loro avere<br />
appresso al quel principe, che mai restano di biasimare altri e lodare loro” (Varchi e Borghini 1998, p. 76).<br />
15 Aretino 1997-2002, I (1538), p. 180, n. 114, lettera al Principe di Salerno del 9 aprile 1537.<br />
16 Cfr. Vasari 1966-87 (1568), III, p. 507: “Fece il medesimo [Pollaiolo] alcune medaglie bellissime, e fra<br />
l’altre in una la congiura de’ Pazzi, <strong>nella</strong> quale sono le teste di Lorenzo e Giuliano de’ Medici, e nel riverso il<br />
coro di Santa Maria del Fiore, e tutto il caso come passò appunto. Similmente fece le medaglie d’alcuni<br />
pontefici, et altre molte cose che sono dagli artefici conosciute”. <strong>La</strong> <strong>medaglia</strong> descritta da Vasari è oggi<br />
attribuita a Bertoldo di Giovanni (cfr. Hill 1930, I, p. 241, n. 915).<br />
Per il giudizio su Cellini medaglista cfr. Vasari 1966-87 (1568), VI, p. 246; sulla produzione monetale del<br />
fiorentino cfr. Pope-Hennessy 1985, p. 70, tav. 35, e pp. 72-75, con bibliografia.<br />
17 <strong>La</strong> lettera è ripubblicata in Barocchi 1971-77, II, pp. 1170-1171, n. II, con bibliografia; sulla collezione<br />
numismatica del Bembo ed i suoi legami con gli interessi epigrafici dell’Umanesimo patavino si veda ora<br />
Bodon 2005, pp. 51-58, con bibliografia precedente.<br />
V