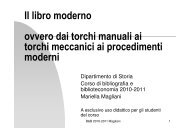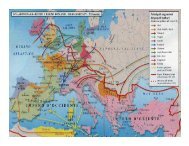Desiderio di Dio e creazione di un ordine mondano nella Regula ...
Desiderio di Dio e creazione di un ordine mondano nella Regula ...
Desiderio di Dio e creazione di un ordine mondano nella Regula ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
con lo scopo <strong>di</strong> interrompere la monotonia delle frasi verbali. Anche dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista tematico sembrano <strong>un</strong> po’<br />
<strong>di</strong>sturbare la relazione tra i precetti concernenti la sopportazione del male e l’invito ad affidare a <strong>Dio</strong> la propria<br />
speranza che si legge in § 41. La superbia sarà oggetto <strong>di</strong> trattazione approfon<strong>di</strong>ta in RB 7; sul vino Benedetto<br />
ritorna in RB 40 e sulla misura del cibo in RB 39.<br />
[41] Spem suam Deo committere (Sal 72, 28; 77, 7).<br />
[42] Bonum aliquid in se cum viderit, Deo applicet, non sibi;<br />
[43] malum vero semper a se factum sciat et sibi reputet.<br />
Il § 41 fornisce la giustificazione del comportamento descritto in §§ 20-33 <strong>di</strong> non resistenza al male: esso è reso<br />
possibile dalla speranza che si affida a <strong>Dio</strong>. Sull’attribuzione a <strong>Dio</strong> del bene che si compie e a sé del male si è già<br />
espresso il prologo al § 29. Si tratta <strong>di</strong> dottrina agostiniana (Serm. 96, 2). Il catalogo degli strumenti si concentra<br />
ora sulla relazione del monaco non più con gli altri, ma <strong>di</strong>rettamente con <strong>Dio</strong>.<br />
[44] Diem iu<strong>di</strong>cii timere (Sir 7, 40),<br />
[45] gehennam expavescere,<br />
[46] vitam aeternam omni concupiscentia spiritali desiderare,<br />
[47] mortem coti<strong>di</strong>e ante oculos suspectam habere (Mt 24, 44; 25, 13 par; 1 Cor 15, 31).<br />
Me<strong>di</strong>tare la morte e il giu<strong>di</strong>zio. RM e RB insistono fortemente sulla proiezione della vita monastica alla vita eterna,<br />
in relazione alla quale ritorna il tema del desiderio; timore del giu<strong>di</strong>zio e desiderio della vita sono due <strong>di</strong>mensioni<br />
contemporaneamente presenti e necessarie a evitare sia la fatua pres<strong>un</strong>zione <strong>di</strong> non correre alc<strong>un</strong> rischio, sia<br />
l’ossessione della paura. Non è fuori luogo ricordare che anche <strong>nella</strong> tra<strong>di</strong>zione ellenica la filosofia è descritta<br />
come <strong>un</strong> esercizio/me<strong>di</strong>tazione della morte.<br />
[48] Actus vitae suae omni hora custo<strong>di</strong>re,<br />
[49] in omni loco Deum se respicere pro certo scire (Prov 15, 3).<br />
[50] Cogitationes malas cor<strong>di</strong> suo advenientes mox ad Christum allidere et seniori spiritali patefacere<br />
(Sal 136, 9),<br />
[51] os suum a malo vel pravo eloquio custo<strong>di</strong>re (Sal 33, 14),<br />
[52] multum loqui non amare,<br />
[53] verba vana aut risui apta non loqui,<br />
[54] risum multum aut excussum non amare.<br />
Vigilanza sui pensieri e sulle parole. Il § 50 riprende prol. § 28: la manifestazione dei pensieri cattivi al padre<br />
spirituale è raccomandata anche da Cassiano (Inst. IV 9); sul padre spirituale cf. RB 46, 5. NB l’insistenza sul<br />
controllo della parola e del riso come strumento per il controllo dei pensieri e della condotta (cf. sopra il § 36 sul<br />
tema della moderazione nel cibo). Il silenzio è oggetto <strong>di</strong> <strong>un</strong>a trattazione specifica in RB 6<br />
[55] Lectiones sanctas libenter au<strong>di</strong>re,<br />
[56] orationi frequenter incumbere (Lc 18, 1; 1 Tess 5, 17),<br />
[57] mala sua praeterita cum lacrimis vel gemitu coti<strong>di</strong>e in oratione Deo confiteri,<br />
[58] de ipsis malis de cetero emendare.<br />
Comp<strong>un</strong>zione e preghiera. Se il gruppo precedente suggerisce i comportamenti da evitare, questi §§ propongono<br />
l’uso alternativo e corretto del pensiero e della parola. Interessante l’associazione fatta in questi §§ fra ascolto delle<br />
sante letture (cioè della Scritturao dei padri) e preghiera frequente; cf. Hier. Ep. 58, 6: «semper ... sacra sit lectio;<br />
frequenter orandum». La lettura è <strong>un</strong> atto com<strong>un</strong>itario, la si ascolta <strong>nella</strong> celebrazione dell’ufficio e durante i pasti,<br />
sia per l’uso antico, sia perché non tutti sanno leggere da soli. Ancora <strong>un</strong>a volta è interessante osservare l’avverbio<br />
libenter: esso precisa che l’ascolto della lettura non è <strong>di</strong> per sé sufficiente a fare <strong>di</strong> questa <strong>un</strong>o strumento dell’arte<br />
spirituale; essa lo <strong>di</strong>venta solo se è fatta volentieri, il che vuol <strong>di</strong>re anche con mo<strong>di</strong> tali da non <strong>di</strong>sturbare gli altri<br />
u<strong>di</strong>tori.<br />
L’invito alla preghiera frequente è ricorrente <strong>nella</strong> letteratura monastica e include la preghiera com<strong>un</strong>itaria e quella<br />
24