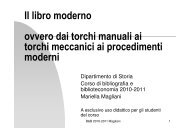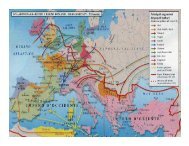Desiderio di Dio e creazione di un ordine mondano nella Regula ...
Desiderio di Dio e creazione di un ordine mondano nella Regula ...
Desiderio di Dio e creazione di un ordine mondano nella Regula ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
incessabiliter a<strong>di</strong>mpleta et in <strong>di</strong>e iu<strong>di</strong>cii reconsignata, illa merces nobis a Domino recompensabitur<br />
quam ipse promisit. [77] «Quod oculus non vi<strong>di</strong>t nec auris au<strong>di</strong>vit, quae praeparauit Deus his qui<br />
<strong>di</strong>lig<strong>un</strong>t illum» (1 Cor 2, 9; Is 64, 4). [78] Officina vero ubi haec omnia <strong>di</strong>ligenter operemur claustra<br />
s<strong>un</strong>t monasterii et stabilitas in congregatione.<br />
Si esplicita la metafora degli “strumenti delle buone opere”: il monastero è <strong>un</strong>’officina, <strong>un</strong> laboratorio nel quale gli<br />
operai praticano me<strong>di</strong>ante utensili appropriati <strong>un</strong>’arte i cui frutti saranno poi ricompensati. L’immagine<br />
dell’operaio era nel prologo (§ 14) e ritorna a RB 7, 69. L’immagine del monastero come scola si arricchisce qui <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong> tratto ulteriore, come luogo <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> esercizio <strong>di</strong> <strong>un</strong> artigianato. Il cenno alla stabilitas riprende la<br />
conclusione del prologo in cui si fa menzione della perseveranza nel monastero fino alla morte (§ 50). RB è<br />
particolarmente insistente su questo tema: condanna dei monaci girovaghi (RB 1), richiesta da parte dei can<strong>di</strong>dati<br />
alla vita monastica <strong>di</strong> impegnarsi esplicitamente a praticare la stabilità (RB 58, 9. 17; 60, 9; 61, 5).<br />
Dopo che il cap. 1 ha presentato i generi <strong>di</strong> monaci, il cap. 2 l’abate e il cap. 3 il modo <strong>di</strong> convocare a consiglio i<br />
fratelli, i capp. 4-7 contengono l’esposizione delle fondamenta spirituali della vita monastica, <strong>un</strong>a specie <strong>di</strong><br />
vademecum per l’esercizio del magistero abbaziale: mentre i capitoli successivi presentano le tre virtù più<br />
importanti — obbe<strong>di</strong>enza, silenzio e umiltà — qui è presentata <strong>un</strong>a l<strong>un</strong>ga lista <strong>di</strong> brevi ammonimenti dal carattere<br />
molto generico: essi infatti si applicano tanto alla vita monastica quanto a qual<strong>un</strong>que vita cristiana (p.e. il § 4, che<br />
cita il comandamento <strong>di</strong> non commettere adulterio, non ha nulla <strong>di</strong> specificamente monastico). Nn è <strong>un</strong>a scelta<br />
casuale: si tratta <strong>di</strong> mostrare che la vita monastica è innanzitutto <strong>un</strong>a vita pienamente e autenticamente cristiana,<br />
del tutto conforme alla tavola dei valori che la tra<strong>di</strong>zione riconosce come vincolanti per tutti i battezzati.<br />
Il cap. 4 riprende con poche varianti RM 3 (ma è significativo che sopprima la conclusione escatologica della<br />
propria fonte) e gli <strong>un</strong>isce in conclusione RM 6, che conclude la l<strong>un</strong>ga trattazione riservata da RM all’ars sancta.<br />
Ci sarebbe molto da <strong>di</strong>re sulla forma letteraria <strong>di</strong> questo testo. Pur senza <strong>un</strong> or<strong>di</strong>ne rigoroso, è evidente che le<br />
ammonizioni <strong>nella</strong> loro gran parte non si susseguono a caso e realizzano <strong>un</strong>a specie <strong>di</strong> alternanza tra norme ispirate<br />
all’amore per <strong>Dio</strong> e norme ispirate all’amore per il prossimo. Si rimane però sconcertati dall’accumulo <strong>di</strong><br />
esortazioni che si collocano a livelli <strong>di</strong> importanza molto <strong>di</strong>fferenti, almeno per la sensibilità attuale: l’amore <strong>di</strong><br />
<strong>Dio</strong> e del prossimo si accompagnano all’invito a non bere troppo e a non ridere smodatamente.<br />
Il ricorso a raccolte <strong>di</strong> massime è <strong>di</strong>ffuso <strong>nella</strong> letteratura ascetico-filosofica antica: cf. le Massime capitali <strong>di</strong><br />
Epicuro, le neopitagoriche Sentenze <strong>di</strong> Sesto, utilizzate anche da Porfirio <strong>nella</strong> Lettera a Marcella, e molta<br />
letteratura cristiana e monastica, che in forma <strong>di</strong> liste <strong>di</strong> brevi sentenze raccoglie e rende più facilmente<br />
memorizzabili insegnamenti utili alla vita spirituale (cf. i primi sei capitoli della Didaché). Del resto, già nel<br />
prologo la citazione dei Sal 33 e 14 aveva ass<strong>un</strong>to la forma, assai più breve, <strong>di</strong> <strong>un</strong> catalogo <strong>di</strong> comportamenti da<br />
adottare per entrare <strong>nella</strong> vita eterna; e la forma del catalogo torna ancora nel cap 7 a proposito della scala<br />
dell’umiltà.<br />
Caput XLIX<br />
De Quadragesimae observatione<br />
[1] Licet omni tempore vita monachi quadragesimae debet observationem habere, [2] tamen, quia<br />
paucorum est ista virtus, ideo suademus istis <strong>di</strong>ebus quadragesimae omni puritate vitam suam<br />
custo<strong>di</strong>re omnes pariter, [3] et neglegentias aliorum temporum his <strong>di</strong>ebus sanctis <strong>di</strong>luere. [4] Quod<br />
t<strong>un</strong>c <strong>di</strong>gne fit si ab omnibus vitiis temperamus, orationi cum fletibus, lectioni et comp<strong>un</strong>ctioni cor<strong>di</strong>s<br />
atque abstinentiae operam damus.<br />
Mentre RM de<strong>di</strong>ca all’osservanza della quaresima tre capitoli (RM 51-53), RB ne tratta brevemente, in<strong>di</strong>cando, più<br />
che osservanze specifiche, l’atteggiamento spirituale con il quale questo periodo deve essere vissuto dal monaco.<br />
L’importanza attribuita alla quaresima emerge dal fatto che <strong>di</strong> essa si tiene conto anche nell’organizzare gli orari <strong>di</strong><br />
lavoro e dei pasti (RB 41, 6-7; 48, 14-16). Ispirandosi a Leone Magno (Serm. de quadr. I 2; IV 1), RB esor<strong>di</strong>sce<br />
con <strong>un</strong> en<strong>un</strong>ciato <strong>di</strong> principio: tutta la vita del monaco dev’essere <strong>un</strong>’osservanza quaresimale (la connotazione<br />
penitenziale è così essenziale al monachesimo che <strong>nella</strong> chiesa antica l’ingresso nello stato monastico può<br />
sostituire la penitenza canonica); subito segue la constatazione <strong>di</strong>sincantata che pochi sono in grado <strong>di</strong> attuare<br />
questa condotta e, quin<strong>di</strong>, l’in<strong>di</strong>cazione pratica: almeno nei giorni della quaresima si <strong>di</strong>a corpo a <strong>un</strong>a condotta<br />
degna della con<strong>di</strong>zione del monaco. De Vogüe in<strong>di</strong>ca in questa tensione tra <strong>un</strong> ideale e <strong>un</strong>’in<strong>di</strong>cazione minimale<br />
cui attenersi <strong>un</strong> tratto caratteristico della RB.<br />
Il § 4 raccoglie i capisal<strong>di</strong> della condotta monastica: ascetismo, preghiera, lettura (infatti in RB 48, 15-16 viene<br />
prescritta la lettura quaresimale), accompagnati dalle lacrime e dalla comp<strong>un</strong>zione del cuore; cf. anche RB 4, 55-<br />
26