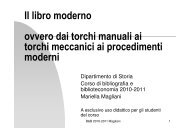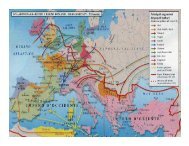Desiderio di Dio e creazione di un ordine mondano nella Regula ...
Desiderio di Dio e creazione di un ordine mondano nella Regula ...
Desiderio di Dio e creazione di un ordine mondano nella Regula ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
esaustività del testo della regola, che non si propone <strong>di</strong> fondare <strong>un</strong>a spiritualità e <strong>un</strong>a teologia della vita monastica,<br />
che l’autore dà in qualche modo per presupposta. Due questioni alle quali RB non dà (deliberatamente?) <strong>un</strong>a<br />
risposta, quanto meno non dà <strong>un</strong>a risposta esplicita, riguardano il senso <strong>di</strong> <strong>un</strong>a <strong>di</strong>stribuzione oraria della preghiera e<br />
le ragioni <strong>di</strong> <strong>un</strong>a celebrazione com<strong>un</strong>e della preghiera. Perché, cioè, si prega in determinate ore e perché questa<br />
preghiera viene fatta tutti insieme?<br />
Sono possibili per entrambi i problemi due risposte <strong>di</strong> massima, entrambe largamente attestate <strong>nella</strong> tra<strong>di</strong>zione<br />
cristiana: l’ideale è quello <strong>di</strong> <strong>un</strong>a preghiera incessante e la moltiplicazione nel corso della giornata <strong>di</strong> momenti<br />
esplicitamente de<strong>di</strong>cati alla preghiera serve ad avviare a <strong>un</strong>a pratica continua dell’orazione; oppure si può pensare<br />
che vi sia <strong>un</strong>a con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> com<strong>un</strong>ione profonda con <strong>Dio</strong> che accompagna le attività profane trasformandole in<br />
preghiera e che solo in alc<strong>un</strong>i momenti si affaccia in modo esplicito <strong>nella</strong> celebrazione della liturgia, come attività<br />
libera e gratuita che interrompe il flusso delle occupazioni mondane.<br />
Per quanto riguarda la <strong>di</strong>mensione com<strong>un</strong>itaria <strong>di</strong> questa preghiera, si può assumerla come <strong>un</strong>a semplice pedagogia<br />
che avvia e sostiene il cammino della preghiera personale, l’<strong>un</strong>ione del solo al Solo; oppure si può pensare che la<br />
<strong>di</strong>mensione com<strong>un</strong>itaria sia <strong>un</strong>a aspetto necessario e irrin<strong>un</strong>ciabile della preghiera, senza il quale smette <strong>di</strong> essere<br />
possibile anche la preghiera personale.<br />
Il § 1 <strong>di</strong> RB 19 riecheggia Cipr. De orat. dom. 4; il passo <strong>di</strong> Prov è già stato citato anche in RB 7, 26. Come già nei<br />
capitoli sulla quaresima (RB 49) e sul silenzio notturno (RB 42), anche qui viene en<strong>un</strong>ciato <strong>un</strong> principio generale<br />
che poi viene circoscritto a <strong>un</strong>a situazione determinata: <strong>Dio</strong> è presente ov<strong>un</strong>que e quin<strong>di</strong> sempre e com<strong>un</strong>que<br />
bisognerebbe essere compenetrati dal senso della sua presenza e agire come se si fosse <strong>di</strong>nanzi a lui; ma questo<br />
atteggiamento è raccomandato in modo particolare <strong>nella</strong> celebrazione della liturgia (opus <strong>di</strong>vinum). Il sapienter che<br />
è raccomandato agli oranti significa presenza a se stessi, consapevolezza <strong>di</strong> quello che si fa, <strong>di</strong> chi si è e <strong>di</strong> chi è<br />
colui in presenza del quale ci si trova. Non basta che i testi della liturgia vengano pron<strong>un</strong>ciati, occore che la mens<br />
sia in consonanza con essi, non sia <strong>di</strong>stratta.<br />
La tra<strong>di</strong>zione monastica più antica tende ad <strong>un</strong>a applicazione letterale del monito biblico <strong>di</strong> pregare senza<br />
interruzione (1 Ts 5, 17; Rm 12, 12; Ef 6, 18; Fil 4, 6; Col 4, 2; Lc 18, 1; 21, 36), quin<strong>di</strong> non fa <strong>di</strong>stinzioni forti tra<br />
preghiera liturgica, preghiera privata, lavoro manuale e tempo de<strong>di</strong>cato ai pasti e <strong>di</strong>lata, invece, su tutte queste<br />
attività la pratica dell’ascolto o della recitazione <strong>di</strong> testi biblici, intervallati da frequenti prostrazioni <strong>di</strong> preghiera<br />
silenziosa. RM e RB (che non citano in alc<strong>un</strong> luogo l’invito alla preghiera continua) mostrano, invece, la tendenza<br />
a separare più nettamente il tempo della preghiera da quello del lavoro, accentuando gli elementi che <strong>di</strong>sciplinano e<br />
sacralizzano il tempo e i luoghi de<strong>di</strong>cati alla celebrazione della liturgia. Una spia lessicale si può cogliere nello<br />
spostamento del significato dell’espressione opus Dei: essa in<strong>di</strong>ca in RM e RB solo l’ufficiatura liturgica, dalla<br />
quale, come si vedrà in RB 52, è escluso il lavoro manuale. Di questa più accentuata <strong>di</strong>stinzione tra l’ambito<br />
profano del lavoro e l’ambito sacro della liturgia può essere spia anche il fatto che l’or<strong>di</strong>namento della liturgia<br />
giornaliera è presentato tutto in blocco separatamente dalla regolamentazione degli altri aspetti della giornata<br />
monastica.<br />
L’opus Dei inteso come celebrazione della liturgia verrà progressivamente percepito come <strong>un</strong>’attività accanto ad<br />
altre, come la più importante fra le attività della giornata monastica (cf. il monito <strong>di</strong> RB 43, 3: nihil operi Dei<br />
praeponatur), fino a <strong>di</strong>ventare più tar<strong>di</strong> — nel monachesimo cl<strong>un</strong>iacense, per esempio — in <strong>un</strong> certo senso il<br />
lavoro stesso del monaco. Si perderà in tal modo l’idea che la preghiera non sia <strong>un</strong>’attività da svolgere in <strong>un</strong><br />
determinato quantitativo nel corso della giornata, ma <strong>un</strong>a con<strong>di</strong>zione che dovrebbe abbracciare l’intera esistenza.<br />
Caput XX<br />
De reverentia orationis<br />
[1] Si, cum hominibus potentibus volumus aliqua suggerere, non praesumimus nisi cum humilitate et<br />
reverentia, [2] quanto magis Domino Deo <strong>un</strong>iversorum cum omni humilitate et puritatis devotione<br />
supplicandum est. [3] Et non in multiloquio (Mt 6, 7), sed in puritate cor<strong>di</strong>s et comp<strong>un</strong>ctione<br />
lacrimarum nos exau<strong>di</strong>ri sciamus. [4] Et ideo brevis debet esse et pura oratio, nisi forte ex affectu<br />
inspirationis <strong>di</strong>vinae gratiae protendatur. [5] In conventu tamen omnino brevietur oratio, et facto<br />
signo a priore omnes pariter surgant.<br />
Questo capitolo e il precedente pongono <strong>un</strong> problema: in essi si tratta <strong>di</strong> due argomenti separati. dell’ufficio<br />
liturgico in RB 19 e della preghiera privata extraliturgica in RB 20, o si tratta <strong>di</strong> due momenti complementari della<br />
celebrazione dell’opus Dei, cioè salmo<strong>di</strong>a recitata/cantata e preghiera personale?<br />
Cassiano descrive (Inst. II 7) l’uso egiziano dell’orazione salmica, la preghiera silenziosa al termine della recita <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong> salmo; tale pratica è attestata anche da RM 14, 1; 20. Si può perciò ragionevolmente supporre che RB 19-20<br />
formino <strong>un</strong>a <strong>un</strong>ità, <strong>nella</strong> quale si descrivono i due momenti fondamentali della celebrazione dell’opus Dei:<br />
salmo<strong>di</strong>a e preghiera personale ispirata dal salmo. Tale preghiera personale silenziosa si faceva in ginocchio o<br />
prostrati (cf. il surgant e RB 50, 3); secondo RB, essa non si deve protrarre troppo a l<strong>un</strong>go, perlomeno non <strong>nella</strong><br />
38