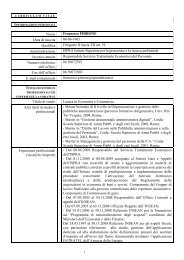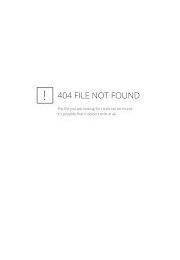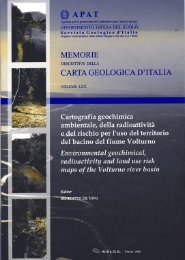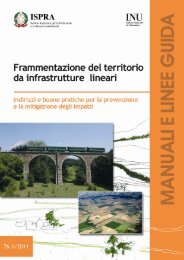Sessione 2 - Ispra
Sessione 2 - Ispra
Sessione 2 - Ispra
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Il sottosuolo della Piana Campana è costituito da una associazione eterogenea di sedimenti<br />
di età plio-pleistocenica a tetto del substrato carbonatico mesozoico ribassato da<br />
sistemi di faglie ad andamento appenninico ed antiappenninico. La successione plio-pleistocenica,<br />
dello spessore complessivo di alcune centinaia di metri, è data da depositi di<br />
ambiente marino, su cui poggiano depositi piroclastici sciolti e litoidi, depositi di ambiente<br />
palustre, torbe e orizzonti di travertino.<br />
Le ricerche hanno interessato la fascia pedemontana di raccordo tra il rilievo di M. Saro e<br />
la piana alluvionale, dove si estendono gli abitati di Sarno e S. Marina di Lavorate (fig. 2).<br />
Fig. 2 – L’area di studio.<br />
In passato, non sono stati effettuati studi specifici riguardo i fenomeni di sprofondamento;<br />
gli unici riferimenti noti in letteratura sono quelli di SCACCHI (1885) e SCHERILLO (1966)<br />
entrambi relativi ad una depressione di forma subcircolare ubicata in località S. Vito, ad<br />
est di Sarno.<br />
SCACCHI (1885), dopo aver descritto le cave di tufo di Fiano e Fossa Lupara poste al piede<br />
del rilievo di S. Maria di Castello, da cui si estraevano sin dall’antichità grandi quantitativi<br />
di tufo grigio campano, si sofferma sulla descrizione della depressione di forma sub-circolare<br />
in località S. Vito ed in particolare sulle caratteristiche della formazione piroclastica<br />
presente al piede delle pareti interne della depressione. Secondo l’Autore, per quanto la<br />
cavità presenti una forma assimilabile a un cratere vulcanico, essa è da attribuirsi ad una<br />
cava di tufo (a dimostrazione di ciò sarebbero – secondo l’Autore - alcune tracce antropiche<br />
sulle pareti di tufo) abbandonata per la cattiva qualità del materiale che si otteneva.<br />
SCHERILLO (1966), nella descrizione di alcune forme del paesaggio dell’agro Falerno, attribuisce<br />
– senza entrare nel merito delle argomentazioni - la genesi della fossa di S. Vito<br />
ad un episodio di sprofondamento.<br />
Segnalazioni più recenti relative a fenomeni deformativi del suolo dell’intera area sono<br />
contenute in FABBROCINO et al. (2007) e CASCINI & DI MAIO (1994).<br />
87