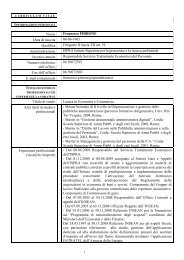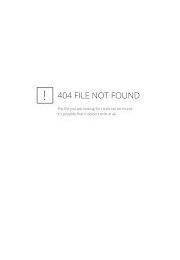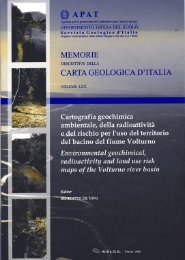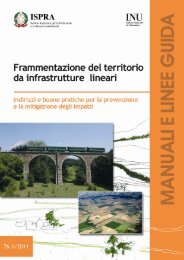Sessione 2 - Ispra
Sessione 2 - Ispra
Sessione 2 - Ispra
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
idrica sotterranea può aver realizzato un processo di erosione-dissoluzione dell’orizzonte<br />
di travertino o, in alternativa, dell’intera successione piroclastico-alluvionale presente a<br />
tetto del substrato carbonatico che, in questo settore della piana, si rinviene a meno di<br />
60 m dal p.c.<br />
Viceversa, per quanto riguarda l’area della fossa di S. Vito, i dati geologici raccolti integrano<br />
il modello geomorfologico e stratigrafico del sottosuolo, confortando l’ipotesi di una<br />
origine da sprofondamento, mentre i dati di carattere storico non forniscono elementi<br />
determinanti, se non una serie di informazioni che ci suggeriscono delle ipotesi e permettono<br />
di porre delle conditio temporali.<br />
Tra esse, l’esistenza di una chiesa sul bordo della depressione, riferita nei manoscritti già<br />
intorno all’anno 1000, dedicata ad un santo (S. Vito) il cui culto è generalmente attestato<br />
in aree interessate da terremoti e/o sprofondamenti. La circostanza riportata da alcuni<br />
Autori (LIGUORI ROSSI A., 1990,) che la chiesa di S. Vito sia stata edificata sui resti di un<br />
tempio di età romana consente di ipotizzare che la depressione possa essersi formata<br />
in età romana e che il tempio possa essere stato edificato proprio come espressione di<br />
culto alla divinità ritenuta responsabile dell’evento.<br />
Parallelamente, la presenza all’interno della depressione dei ruderi di una piccola chiesa<br />
di età paleocristiana dedicata a S. Apollonia, consente di ipotizzare che la costruzione della<br />
chiesa possa essere stata realizzata a sprofondamento già avvenuto, e che questo sia<br />
pertanto precedente all’intervallo VI-IX sec d.C..<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
AA.VV. (1994) – Guida al territorio del Sarno, tracce storiche, archeologiche e mitiche.<br />
Comune di Sarno, Muso Archeologico “Valle del Sarno”. Centro Stampa Ercolano.<br />
CARRELLA A. (2006) - Il Pentamerone sarnese ovvero nuie ‘a ccà e lloro ‘a llà, Ed. RIPO-<br />
STES – Battipaglia (SA).<br />
CASCINI L. DI MAIOC. (1994) – Emungimento delle acque sotterranee e cedimenti nell’abitato<br />
di Sarno: analisi preliminare. Riv. It. Geot. 3/1994, p. 217-231.<br />
CIMMELLI V. (1991) – Sarno nell’età moderna. Sarno: Centro ricerche e documentazione<br />
Valle del Sarno, 298 pp.<br />
CORNIELLO A. (1996) - Lineamenti idrogeochimici delle sorgenti dei principali massicci<br />
carbonatici della Campania. Mem. Soc. Geol. It., 51 (1996), 333-342, 3 ff., 3 tabb.<br />
DEL PRETE S., GUARINO P.M., NISIO S., SANTO A. (2008) - I sinkholes in Campania. In Nisio S.:<br />
I fenomeni naturali di sinkholes nelle aree di pianura italiane. Mem. Descr. della Carta<br />
Geologica d’It. Vol. LXXXV; 149-209.<br />
DI DOMENICO C. (1972) - Sarno nella vita e nella storia. Piccola antologia di scrittori sarnesi.<br />
Scala, Sarno.<br />
DI DOMENICO C. (1981) - Sarno sacra.<br />
FERRARA O. (1995) - Arcaiche radici e diafane presenze: storie e miti di Sarno e dintorni.<br />
Sarno, Scala Ed. 182 pp.<br />
FISCHETTI C. (1926) - Appunti sulla città di Sarno illustrata. Salerno & Milone, Sarno.<br />
GUARINO P.M., NISIO S. (2007) - Sinkholes in the Sarno Plain area. FIST - Sesto Forum<br />
italiano di Scienze della Terra. Vol. Abs.2, 244, Rimini 12-14 settembre, 2007.<br />
GUARINO P.M. & NISIO S. (2010) (in questo volume) – I sinkhole del settore nord-orientale<br />
della piana del F. Sarno: ulteriori dati relativi all’assetto stratigrafico del territorio. Atti<br />
95