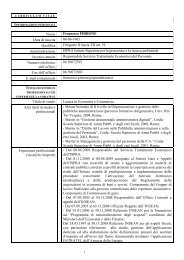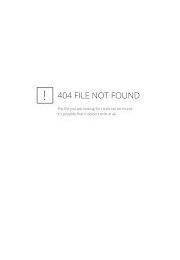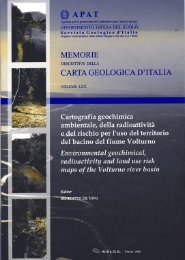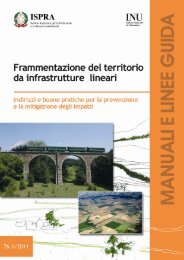Sessione 2 - Ispra
Sessione 2 - Ispra
Sessione 2 - Ispra
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Lungo le pareti della fossa affiorano, a partire dal piano campagna, alternanze di strati di<br />
forma tabulare (fig. 6) costituiti da piroclastiti cineritiche fini rimaneggiate di colore<br />
marrone chiaro-avana, contenenti rari clasti calcarei (Ø = 1–2 cm), scorie nerastre, strutture<br />
da bioturbazione e strati di ghiaie con ciottoli e blocchi (Ø anche maggiore di 20 cm),<br />
in matrice fina sabbiosa. I clasti e i ciottoli, di natura calcarea, hanno forma irregolare e<br />
spigoli vivi o poco smussati. Si tratta di depositi alluvionali e di conoide di età compresa<br />
tra l’Attuale e l’Olocene, deposti dal torrente S. Marco, dello spessore massimo di circa<br />
15 m.<br />
A letto dei depositi alluvionali si rinviene la formazione dell’Ignimbrite Campana, data da<br />
un tufo ricco di scorie, lapilli lapidei e clasti calcarei metamorfosati, di colore grigiastro<br />
(che nella parte alta del deposito vira verso il giallastro) che affiora limitatamente al piede<br />
di alcune pareti della fossa, con uno spessore massimo di pochi metri.<br />
Per quanto riguarda la genesi della depressione, si esclude un’origine legata ad attività<br />
estrattive e vulcaniche e si propende ad assimilarla ad una cavità da sprofondamento in<br />
base alle seguenti considerazioni.<br />
La morfologia sub-circolare della cavità appare naturale: le pareti, sub verticali, non<br />
presentano alterazioni antropiche. Non si ritiene plausibile l’ipotesi che la fossa costituisca<br />
una antica cava di tufo, poiché interessa terreni eterogenei e dalle proprietà scadenti<br />
(alternanze di ghiaie e piroclastiti rimaneggiate) ad eccezione di un modesto livello di tufo<br />
presente alla base delle pareti. Diversamente, a poca distanza dalla fossa, erano noti fin<br />
dall’antichità affioramenti di tufo di molte decine di metri spessore, dove l’attività estrattiva<br />
si è protratta per secoli (cave di Fiano e di Fossa Lupara).<br />
Si esclude una connessione con episodi di degassazione vulcanica (cavità da maar), poiché<br />
non sono presenti ai bordi della stessa depositi primari riconducibili a questo tipo di eventi,<br />
né la cavità presenta un rilievo perimetrale, che avrebbe dovuto essere ancora ben<br />
conservato se si pensa che la cavità, poiché taglia i depositi di conoide recenti, è successiva<br />
ad essi. Inoltre, nell’areale di studio non sono segnalate forme di origine vulcanica e<br />
91<br />
Fig. 5 – Ortofoto della<br />
fossa di S. Vito.