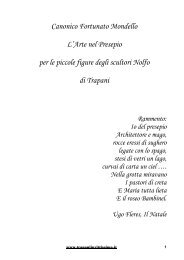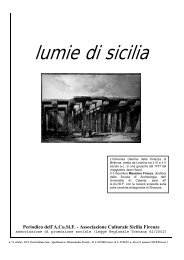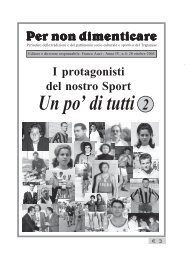libro -- i vultaggio di monte san giuliano rivisto - 3 - Trapani Nostra
libro -- i vultaggio di monte san giuliano rivisto - 3 - Trapani Nostra
libro -- i vultaggio di monte san giuliano rivisto - 3 - Trapani Nostra
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
missione furono conservati nella regia cancelleria, in un volume dal titolo “Liber<br />
prelatiarum”. Questo materiale confluì nei “Beneficia Ecclesiasticae”, portata a<br />
compimento nel 1511. Egli interpretava le molte controversie tra Stato e Chiesa anche alla<br />
luce della bolla "quia propter prudentiam tuam", con la quale Urbano II, nel 1098, aveva<br />
concesso a Ruggero I il privilegio della Apostolica Legazia. Questo documento,<br />
<strong>di</strong>menticato nei secoli precedenti, era stato ritrovato, non si sa come né dove, dallo stesso<br />
Barberi che lo aveva inserito nel "liber regiae monarchiae". Intanto le turbolenze dei baroni<br />
non si chetarono, ma gli attacchi si fecero più scaltri e mirati. Con il Capitolo CIX del 1514<br />
il Parlamento siciliano sferrò una serie <strong>di</strong> accuse circostanziate, che trovarono ascolto<br />
presso la Corte. Barberi veniva accusato <strong>di</strong> trarre guadagno illecito facendo pagare, in<br />
modo arbitrario, ai beneficiari il riconoscimento delle ragioni <strong>di</strong> patronato; secondo gli<br />
accusatori, infatti, l'inquisitore doveva <strong>di</strong>mostrare l'esistenza <strong>di</strong> "ius patronatus", non<br />
costringere i beneficiari ad esibire la prova della loro eventuale autonomia. Un'altra<br />
accusa, già avanzata nel 1508, riguardava il modo in cui Barberi lucrava per effettuare<br />
ricerche nella Cancelleria, pretendendo compensi esosi per il rilascio <strong>di</strong> copie dei benefici.<br />
La terza accusa riguardava l'irritualità delle procedure nel formulare le allegazioni. La<br />
notizia è da ritenere poco atten<strong>di</strong>bile, tuttavia dal re non fu spesa una parola in sua <strong>di</strong>fesa<br />
e fu accolta la richiesta <strong>di</strong> togliere valore normativo alle allegazioni e anche quella <strong>di</strong> non<br />
obbligare i Baroni ad esibire i documenti se non lo volessero. L'incarico a Barberi non fu<br />
revocato ma non gliene vennero dati altri e la morte <strong>di</strong> Fer<strong>di</strong>nando, infine, concorse a<br />
relegare la sua opera in secondo piano. Barberi continuò a lavorarci fino al 1516 e fino al<br />
1521 produsse aggiunte e aggiornamenti ai capibrevi. Si deve presumere pertanto che egli<br />
sia morto negli anni imme<strong>di</strong>atamente successivi al 1529.<br />
I Capibrevi: Sotto questo vocabolo si definivano le raccolte dei privilegi e delle<br />
prerogative della monarchia, l’opera del Barberi è un rapporto, un ren<strong>di</strong>conto sulla<br />
situazione sia dei beni feudali che ecclesiastici in Sicilia. Relativamente ai beni feudali<br />
Barberi compila due gran<strong>di</strong> opere. La Descriptio terrarum in hoc Siciliae Regno<br />
existentium in tre volumi, comunemente denominato, anche dallo stesso Barberi, Magnum<br />
Capibrevium, riguarda i feu<strong>di</strong> popolati o terre o contee. Fu composto nel 1508 e, insieme al<br />
capibreve della Secrezia, alla “Dignitates Ecclesiasticae” e al De Monarchia, Barberi li<br />
presentò al Re Fer<strong>di</strong>nando nel suo primo viaggio in Spagna nel 1509. Il testo, rimasto<br />
ine<strong>di</strong>to, solo recentemente è stato pubblicato dalla Società Siciliana per la Storia Patria <strong>di</strong><br />
Palermo a cura <strong>di</strong> Giovanna Stalteri Ragusa. Il Capibrevium Feudorum, in tre volumi,<br />
riguarda, invece, i feu<strong>di</strong> minori non popolati, <strong>di</strong>stribuiti in modo tra<strong>di</strong>zionale secondo le<br />
tre valli amministrative, val <strong>di</strong> Noto, val Demone e val <strong>di</strong> Mazzara. Oltre ai feu<strong>di</strong> minori<br />
sono trattate anche alcune terre: è il caso <strong>di</strong> Aidone, Lico<strong>di</strong>a e Alcamo ma si tratta <strong>di</strong><br />
approfon<strong>di</strong>menti o integrazioni su terre già esaminate nel “Magnum Capibrevium”,<br />
inoltre, per ciascuna valle sono esaminate le ren<strong>di</strong>te e i titoli <strong>di</strong> porti, mulini, giar<strong>di</strong>ni,<br />
tonnare, magazzini. La pubblicazione del capibreve dei feu<strong>di</strong> fu curata in gran parte da<br />
Giuseppe Silvestri, Soprintendente agli archivi, e alla sua morte, avvenuta nel 1899, fu<br />
portata a compimento da Giuseppe La Mantia. Fra i due capibrevi non sembra ci sia una<br />
vera e propria <strong>di</strong>fferenza né <strong>di</strong> sostanza né <strong>di</strong> metodo, ma l’uno integra e completa l’altro.<br />
Nelle due opere sono descritti tutti i feu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Sicilia insieme agli atti <strong>di</strong> investitura, le<br />
successioni e le decadenze del rapporto feudale, le ren<strong>di</strong>te percepite dal fisco e la<br />
legittimità o meno del possesso a partire dai primi beneficiari fino a quelli contemporanei<br />
allo stesso Barberi. Ne risulta un ampio affresco ben documentato della situazione feudale<br />
in Sicilia, dalla fine del XIII secolo agli inizi del XVI secolo. Da quest’opera, a piene mani,<br />
27