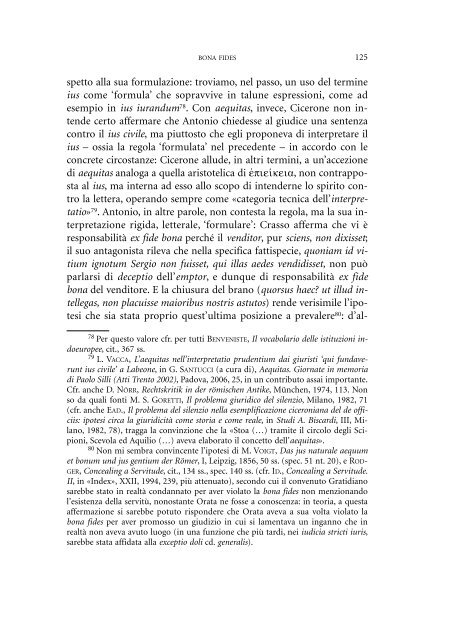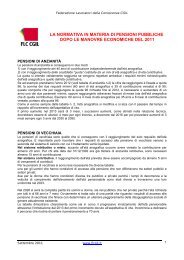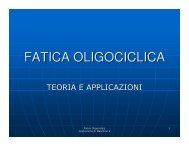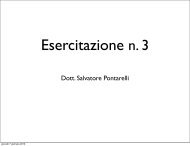Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato 4
Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato 4
Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato 4
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BONA FIDES<br />
125<br />
spetto alla sua formulazione: troviamo, nel passo, un uso <strong>del</strong> termine<br />
ius come ‘formula’ che sopravvive in talune espressioni, come ad<br />
esempio in ius iurandum 78 .Con aequitas, invece, Cicerone non intende<br />
certo affermare che Antonio chiedesse al giudice una sentenza<br />
contro il ius civile, ma piuttosto che egli proponeva di interpretare il<br />
ius – ossia la regola ‘formulata’ nel precedente – in accordo con le<br />
concrete circostanze: Cicerone allude, in altri termini, a un’accezione<br />
di aequitas analoga a quella aristotelica di ejpieivkeia, non contrapposta<br />
al ius, ma interna ad esso allo scopo di intenderne lo spirito contro<br />
la lettera, operando sempre come «categoria tecnica <strong>del</strong>l’interpretatio»<br />
79 . Antonio, in altre parole, non contesta la regola, ma la sua interpretazione<br />
rigida, letterale, ‘formulare’: Crasso afferma che vi è<br />
responsabilità ex fide bona perché il venditor, pur sciens, non dixisset;<br />
il suo antagonista rileva che <strong>nella</strong> specifica fattispecie, quoniam id vitium<br />
ignotum Sergio non fuisset, qui illas aedes vendidisset, non può<br />
parlarsi di deceptio <strong>del</strong>l’emptor, e dunque di responsabilità ex fide<br />
bona <strong>del</strong> venditore. E la chiusura <strong>del</strong> brano (quorsus haec? ut illud intellegas,<br />
non placuisse maioribus nostris astutos) rende verisimile l’ipotesi<br />
che sia stata proprio quest’ultima posizione a prevalere 80 : d’al-<br />
78 Per questo valore cfr. per tutti BENVENISTE, Il vocabolario <strong>del</strong>le istituzioni indoeuropee,<br />
cit., 367 ss.<br />
79 L. VACCA, L’aequitas nell’interpretatio prudentium dai giuristi ‘qui fundaverunt<br />
ius civile’ a Labeone, in G. SANTUCCI (a cura di), Aequitas. Giornate in memoria<br />
di Paolo Silli (Atti Trento 2002), Padova, 2006, 25, in un contributo assai importante.<br />
Cfr. anche D. NÖRR, Rechtskritik in der römischen Antike, München, 1974, 113. Non<br />
so da quali fonti M. S. GORETTI, Il problema giuridico <strong>del</strong> silenzio, Milano, 1982, 71<br />
(cfr. anche EAD., Il problema <strong>del</strong> silenzio <strong>nella</strong> esemplificazione ciceroniana <strong>del</strong> de officiis:<br />
ipotesi circa la giuridicità come <strong>storia</strong> e come reale, in Studi A. Biscardi, III, Milano,<br />
1982, 78), tragga la convinzione che la «Stoa (…) tramite il circolo degli Scipioni,<br />
Scevola ed Aquilio (…) aveva elaborato il concetto <strong>del</strong>l’aequitas».<br />
80 Non mi sembra convincente l’ipotesi di M. VOIGT, Das jus naturale aequum<br />
et bonum und jus gentium der Römer, I, Leipzig, 1856, 50 ss. (spec. 51 nt. 20), e ROD-<br />
GER, Concealing a Servitude, cit., 134 ss., spec. 140 ss. (cfr. ID., Concealing a Servitude.<br />
II, in «Index», XXII, 1994, 239, più attenuato), secondo cui il convenuto Gratidiano<br />
sarebbe stato in realtà condannato per aver violato la bona fides non menzionando<br />
l’esistenza <strong>del</strong>la servitù, nonostante Orata ne fosse a conoscenza: in teoria, a questa<br />
affermazione si sarebbe potuto rispondere che Orata aveva a sua volta violato la<br />
bona fides per aver promosso un giudizio in cui si lamentava un inganno che in<br />
realtà non aveva avuto luogo (in una funzione che più tardi, nei iudicia stricti iuris,<br />
sarebbe stata affidata alla exceptio doli cd. generalis).