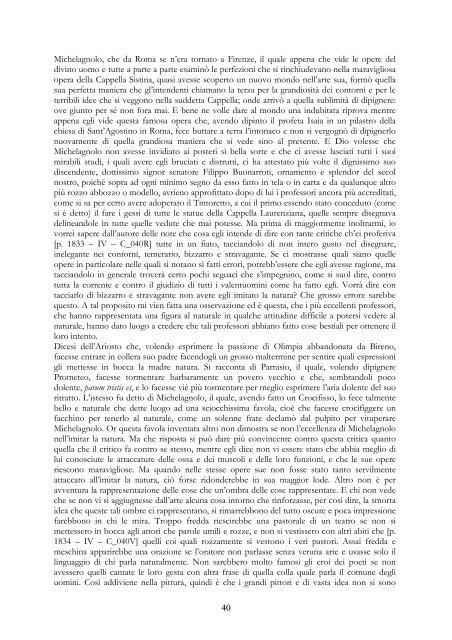You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Michelagnolo, che da Roma se n’era tornato a Firenze, il quale appena che vide le opere del<br />
divino uomo e tutte a parte a parte esaminò le perfezioni che si rinchiudevano nella maravigliosa<br />
opera della Cappella Sistina, quasi avesse scoperto un nuovo mondo nell’arte sua, formò quella<br />
sua perfetta maniera che gl’intendenti chiamano la terza per la grandiosità dei contorni e per le<br />
terribili idee che si veggono nella suddetta Cappella; onde arrivò a quella sublimità di dipignere:<br />
ove giunto per sé non fora mai. E bene ne volle dare al mondo una indubitata riprova mentre<br />
appena egli vide questa famosa opera che, avendo dipinto il profeta Isaia in un pilastro della<br />
chiesa di Sant’Agostino in Roma, fece buttare a terra l’intonaco e non si vergognò di dipignerlo<br />
nuovamente di quella grandiosa maniera che si vede sino al presente. E Dio volesse che<br />
Michelagnolo non avesse invidiato ai posteri sì bella sorte e che ci avesse lasciati tutti i suoi<br />
mirabili studi, i quali avere egli bruciati e distrutti, ci ha attestato più volte il dignissimo suo<br />
discendente, dottissimo signor senatore Filippo Buonarroti, ornamento e splendor del secol<br />
nostro, poiché sopra ad ogni minimo segno da esso fatto in tela o in carta e da qualunque altro<br />
più rozzo abbozzo o modello, avrieno approfittato dopo di lui i professori ancora più accreditati,<br />
come si sa per certo avere adoperato il Tintoretto, a cui il primo essendo stato conceduto (come<br />
si è detto) il fare i gessi di tutte le statue della Cappella Laurenziana, quelle sempre disegnava<br />
delineandole in tutte quelle vedute che mai potesse. Ma prima di maggiormente inoltrarmi, io<br />
vorrei sapere dall’autore delle note che cosa egli intende di dire con tante critiche ch’ei proferiva<br />
[p. 1833 – <strong>IV</strong> – C_040R] tutte in un fiato, tacciandolo di non intero gusto nel disegnare,<br />
inelegante nei contorni, temerario, bizzarro e stravagante. Se ci mostrasse quali siano quelle<br />
opere in particolare nelle quali si notano sì fatti errori, potrebb’essere che egli avesse ragione, ma<br />
tacciandolo in generale troverà certo pochi seguaci che s’impegnino, come si suol dire, contro<br />
tutta la corrente e contro il giudizio di tutti i valentuomini come ha fatto egli. Vorrà dire con<br />
tacciarlo di bizzarro e stravagante non avere egli imitato la natura? Che grosso errore sarebbe<br />
questo. A tal proposito mi vien fatta una osservazione ed è questa, che i più eccellenti professori,<br />
che hanno rappresentata una figura al naturale in qualche attitudine difficile a potersi vedere al<br />
naturale, hanno dato luogo a credere che tali professori abbiano fatto cose bestiali per ottenere il<br />
loro intento.<br />
Dicesi dell’Ariosto che, volendo esprimere la passione di Olimpia abbandonata da Bireno,<br />
facesse entrare in collera suo padre facendogli un grosso maltermine per sentire quali espressioni<br />
gli mettesse in bocca la madre natura. Si racconta di Parrasio, il quale, volendo dipignere<br />
Prometeo, facesse tormentare barbaramente un povero vecchio e che, sembrandoli poco<br />
dolente, parum tristis es, e lo facesse viè più tormentare per meglio esprimere l’aria dolente del suo<br />
ritratto. L’istesso fu detto di Michelagnolo, il quale, avendo fatto un Crocifisso, lo fece talmente<br />
bello e naturale che dette luogo ad una sciocchissima favola, cioè che facesse crocifiggere un<br />
facchino per tenerlo al naturale, come un solenne frate declamò dal pulpito per vituperare<br />
Michelagnolo. Or questa favola inventata altro non dimostra se non l’eccellenza di Michelagnolo<br />
nell’imitar la natura. Ma che risposta si può dare più convincente contro questa critica quanto<br />
quella che il critico fa contro se stesso, mentre egli dice non vi essere stato che abbia meglio di<br />
lui conosciute le attaccature delle ossa e dei muscoli e delle loro funzioni, e che le sue opere<br />
riescono maravigliose. Ma quando nelle stesse opere sue non fosse stato tanto servilmente<br />
attaccato all’imitar la natura, ciò forse ridonderebbe in sua maggior lode. Altro non è per<br />
avventura la rappresentazione delle cose che un’ombra delle cose rappresentate. E chi non vede<br />
che se non vi si aggiugnesse dall’arte alcuna cosa intorno che rinforzasse, per così dire, la smorta<br />
idea che queste tali ombre ci rappresentano, si rimarrebbono del tutto oscure e poca impressione<br />
farebbono in chi le mira. Troppo fredda riescirebbe una pastorale di un teatro se non si<br />
mettessero in bocca agli attori che parole umili e rozze, e non si vestissero con altri abiti che [p.<br />
1834 – <strong>IV</strong> – C_040V] quelli coi quali rozzamente si vestono i veri pastori. Assai fredda e<br />
meschina apparirebbe una orazione se l’oratore non parlasse senza veruna arte e usasse solo il<br />
linguaggio di chi parla naturalmente. Non sarebbero molto famosi gli eroi dei poeti se non<br />
avessero quelli cantate le loro gesta con altra frase di quella colla quale parla il comune degli<br />
uomini. Così addiviene nella pittura, quindi è che i grandi pittori e di vasta idea non si sono<br />
40