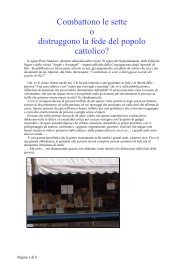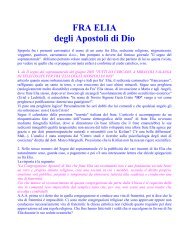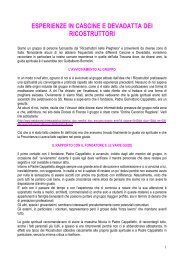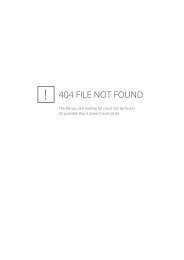Il discernimento nella cultura contemporanea alla luce del ... - ASAAP
Il discernimento nella cultura contemporanea alla luce del ... - ASAAP
Il discernimento nella cultura contemporanea alla luce del ... - ASAAP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1.1 Un simbolismo eloquente<br />
<strong>Il</strong> tema <strong>del</strong>la <strong>luce</strong> costituisce una privilegiata “porta d’accesso” allo studio <strong>del</strong> fenomeno <strong>del</strong>le<br />
religioni, la quasi totalità <strong>del</strong>le confessioni religiose, infatti, pensa ed esprime i suoi capisaldi<br />
filosofici, dottrinali e morali in termini di “illuminazione”, di “seguire la via <strong>del</strong>la <strong>luce</strong>”. La Bibbia<br />
stessa inizia con l’opera di Dio che separa la <strong>luce</strong> dalle tenebre (Gen 1-2) e termina con la visione<br />
<strong>del</strong>lo splendore <strong>del</strong>la nuova Gerusalemme (Ap 21). La tenebra, per contrasto, sviluppa in ogni credo<br />
un significato negativo, in quanto raffigura la via <strong>del</strong>la morte, il male stesso. La forza e<br />
l’universalità di questo simbolismo risiedono nel fatto che è un simbolo naturale: la <strong>luce</strong> è la<br />
condizione necessaria affinché la vita si sviluppi, cresca e, con essa, l’uomo. 1 Allo stesso modo<br />
possiamo avventurarci nel Vangelo di Giovanni attraverso l’argumentum lucis e arrivare a coglierne<br />
lo spirito. Esso è come un “filo rosso” che attraversa tutto il libro permettendo la visione <strong>del</strong>la<br />
struttura portante <strong>del</strong>lo scritto catechetico: Gesù di Nazaret è il Figlio di Dio e il prototipo<br />
<strong>del</strong>l’uomo in quanto suo Creatore e Redentore. 2 Una lettura attenta <strong>del</strong> IV Vangelo evidenzia il<br />
concorrere, l’avanzare ed il procedere sincronico di un duplice ed indipendente progetto, uno di <strong>luce</strong><br />
ed uno di tenebra, che si scontrano definitivamente nell’appuntamento <strong>del</strong>l’«ora di Gesù» (Gv 17,1)<br />
e si concludono con la glorificazione <strong>del</strong> Figlio. <strong>Il</strong> “Vangelo spirituale” si offre <strong>alla</strong> lettura <strong>del</strong><br />
credente come la cronaca di una vittoria annunciata, il racconto nel tempo <strong>del</strong> progetto eterno <strong>del</strong><br />
Padre. <strong>Il</strong> lettore attento e appassionato <strong>del</strong> IV Vangelo s’imbatte però immediatamente in un<br />
problema che, se male impostato, può condurre ad un’inaccettabile conseguenza: il dualismo. Si<br />
nota con facilità che l’autore 3 gioca, lungo tutto il corso <strong>del</strong> racconto, con <strong>del</strong>le “coppie d’opposti”. 4<br />
La caratteristica duale <strong>del</strong> Vangelo, sintomo di una chiara mentalità semitica, è quasi una struttura<br />
portante <strong>del</strong>l’opera, e affiora evidentemente in esempi desunti dall’ambito legale, morale, spaziale,<br />
biologico, spirituale. I contrasti giovannei nei quali ci si imbatte più frequentemente e dal più alto<br />
valore simbolico sono “spirito-carne”, “verità-menzogna”, “quaggiù-lassù”, “giudizio-peccato”,<br />
“terreno-celeste”, “Dio-mondo”, “libertà-schiavitù”, ed i più importanti sono certamente “vitamorte”,<br />
e “<strong>luce</strong>-tenebre”. L’ambiente spirituale e geografico in cui il Vangelo è stato redatto e, non<br />
ultimo, i problemi che si presentarono al sorgere <strong>del</strong>la fede hanno lasciato il loro influsso<br />
permanente in questo modo di pensare e di scrivere, tanto giudaico quanto ellenistico. Ciò<br />
nonostante il IV Vangelo gode di una consistenza tematica propria, che ci permette di individuare<br />
una sua “dimensione teologica fondamentale” che si distingue per una forte nonché spiccata<br />
originalità. 5 L’evangelista, infatti, pur a contatto con la diffusa mentalità di un dualismo mitigato di<br />
matrice veterotestamentaria che non metteva in discussione l’unicità di Dio, e pur a contatto con il<br />
giudaismo eterodosso <strong>del</strong>la comunità di Qumrân, utilizza e cita l’Antico Testamento in piena<br />
libertà, in funzione <strong>del</strong> suo impianto teologico ed in relazione all’annuncio di Cristo. 6 Al contempo,<br />
pur conoscendo l’ellenismo extragiudaico <strong>del</strong>l’ermetismo e soprattutto l’influenza <strong>del</strong>la letteratura<br />
mandaica, l’evangelista non scade tuttavia in una visione parziale <strong>del</strong>la fede, ma aggiunge <strong>alla</strong> gnosi<br />
<strong>del</strong>la sola illuminazione intellettuale, la fede radicale <strong>del</strong>l’uomo integrale ed integrato nel mistero<br />
1 Cf. P. GIRONI, «Luce/Tenebre», in Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, Milano 1988, 857.<br />
2 Cf. V. PASQUETTO, In comunione con Cristo e con i fratelli. Lessico antropologico <strong>del</strong> Vangelo e <strong>del</strong>le Lettere di<br />
Giovanni, Roma 2001, 211-215.<br />
3 È doveroso notare che in questo contributo useremo indistintamente il termine autore, scrittore, evangelista; non è<br />
nostro obiettivo chiarire le questioni specialistiche in merito all’identità <strong>del</strong>l’autore e <strong>alla</strong> storia <strong>del</strong>la composizione <strong>del</strong><br />
Vangelo, per un approfondimento cf. R. BROWN, Giovanni, Assisi 1979, CII-CXXV; R. SCHNACKENBURG, <strong>Il</strong> vangelo di<br />
Giovanni – I, Brescia 1973, 92-131.<br />
4 Cf. R. SCHNACKENBURG, <strong>Il</strong> vangelo…, I, 163-168.<br />
5 Cf. ivi, 192-216.<br />
6 Cf. X. LÈON-DUFOUR, Lettura <strong>del</strong>l’Evangelo secondo Giovanni – I, Milano 1990, 133-134: «Per Gv, come per la<br />
Genesi e il Giudaismo, la coppia <strong>luce</strong>-tenebra è primordiale, ma Dio con la sua parola le ha separate […] Questa<br />
coabitazione <strong>del</strong>la <strong>luce</strong> e <strong>del</strong>la tenebra, cui fa eco la letteratura di Qumrân che descrive la lotta dei figli <strong>del</strong>la <strong>luce</strong> contro<br />
i figli <strong>del</strong>le tenebre, ha aperto la strada al dualismo metafisico che lo gnosticismo ha poi esaltato.».<br />
6