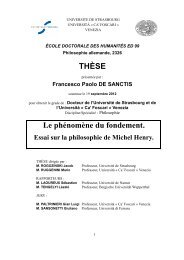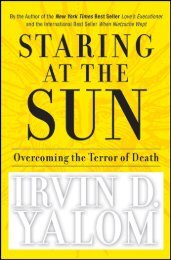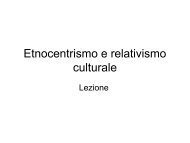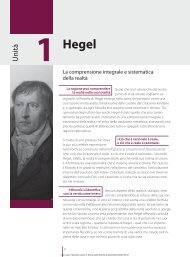- Page 1 and 2: Università degli Studi di Cagliari
- Page 3 and 4: Indice Introduzione p. 3 Cap. I. Il
- Page 5 and 6: san Bonaventura; motivo per cui il
- Page 7 and 8: propriamente memoria. Cosa signific
- Page 9 and 10: appartiene a Dante autore che ricor
- Page 11 and 12: edenzione di Cristo è un fattore d
- Page 13 and 14: percorre un viaggio che lo conduce
- Page 15 and 16: originario (l’Eden), e l’Incarn
- Page 17 and 18: ciò che si era diviso 25 . Nel fen
- Page 19 and 20: Lascio lo fele implica l’esperien
- Page 21 and 22: secondo regno, la progressiva illum
- Page 23 and 24: il poeta abbia sperimentato la terz
- Page 25 and 26: Sul piano dell’invenzione formale
- Page 27 and 28: quelle del cielo e quelle della ter
- Page 29 and 30: Lo schema metrico qui riportato è
- Page 31 and 32: Tutto ciò è dovuto all’esclusiv
- Page 33 and 34: Le anime beate che danzano nel ciel
- Page 35 and 36: all’altra estremità. Ma, ancor d
- Page 37: Capitolo I Il pellegrino, il narrat
- Page 41 and 42: Per me si va ne la città dolente,
- Page 43 and 44: Tirando essenzialmente le fila dall
- Page 45 and 46: Poca favilla gran fiamma seconda: f
- Page 47 and 48: Il racconto degli ultimi momenti de
- Page 49 and 50: attribuisce anche un compito profet
- Page 51 and 52: La domanda che Dante pone a Virgili
- Page 53 and 54: con tristo annunzio di futuro danno
- Page 55 and 56: Si confronti il passo con quanto af
- Page 57 and 58: prende il suo stato nella trama com
- Page 59 and 60: Comincia dunque; e dì ove s’appu
- Page 61 and 62: Analoga è la situazione di partenz
- Page 63 and 64: della crocifissione, perché l’uo
- Page 65 and 66: costruisce il poema, immaginando l
- Page 67 and 68: E io udi’ ne la luce più dia del
- Page 69 and 70: intraprendere; solo chi prende sua
- Page 71 and 72: grazie alla comunione dei santi, ne
- Page 73 and 74: sinistro, non si stacca dalla figur
- Page 75 and 76: Inoltre, il suo viaggio è un atto
- Page 77 and 78: La maggior parte dei critici si sof
- Page 79 and 80: Gianfranco Contini definisce io tra
- Page 81 and 82: Il narratore Come si è visto, Mich
- Page 83 and 84: la tecnica dell’episodio parallel
- Page 85 and 86: stavolta nei confronti sia delle Mu
- Page 87 and 88: Marziano Guglielminetti sottolinea
- Page 89 and 90:
dell’autore, Ahi quanto a dir qua
- Page 91 and 92:
di educazione e portatrice di valor
- Page 93 and 94:
Lodare sé è da fuggire sì come m
- Page 95 and 96:
sempre un’anima. Già questo pone
- Page 97 and 98:
L’autore Nel Convivio si legge ch
- Page 99 and 100:
Colui che conosce il principio e la
- Page 101 and 102:
E io a lui: «I’ mi son un che, q
- Page 103 and 104:
di Macrobio in quanto il patrimonio
- Page 105 and 106:
E io: «Per filosofici argomenti e
- Page 107 and 108:
destino ultimo dell’anima, il com
- Page 109 and 110:
Dante usa spesso la stessa serie di
- Page 111 and 112:
dantesca che fa parte della disposi
- Page 113 and 114:
Nella Commedia il tempo si riduce a
- Page 115 and 116:
di grado basso dell’amanuense o s
- Page 117 and 118:
volsersi a me con salutevol cenno,
- Page 119 and 120:
Nel movimento dialettico tra negazi
- Page 121 and 122:
E con ciò sia cosa che la vera int
- Page 123 and 124:
Capitolo II L’itinerario dei tre
- Page 125 and 126:
smarrito la via, è preferita dalla
- Page 127 and 128:
quello di un’esperienza aliena al
- Page 129 and 130:
com’è risaputo, si ritiene che i
- Page 131 and 132:
poetico e di conversione è paragon
- Page 133 and 134:
che l’ha sollecitata a soccorrere
- Page 135 and 136:
non vi mettete in pelago, ché fors
- Page 137 and 138:
lunari: Dante, oramai, dovrebbe ben
- Page 139 and 140:
con quanto di quel salmo è poscia
- Page 141 and 142:
senza allontanarsene; l’altra, co
- Page 143 and 144:
Ai versi 112-123 è detto in cosa c
- Page 145 and 146:
emblematica: una profonda voragine,
- Page 147 and 148:
similitudo che, nell’antropologia
- Page 149 and 150:
sì ch’a bene sperar m’era cagi
- Page 151 and 152:
Anche San Bonaventura descrive la c
- Page 153 and 154:
In un passo successivo sempre del I
- Page 155 and 156:
Ma, riemergendo dal sonno, all’im
- Page 157 and 158:
immedesimazione con la passione di
- Page 159 and 160:
parere, delle vere e proprie forze
- Page 161 and 162:
e dopo ’l pasto ha più fame che
- Page 163 and 164:
sintetizza nei vv. 34-36, raccontan
- Page 165 and 166:
Una volta interpretata la scena del
- Page 167 and 168:
Diverse lingue, orribili favelle, p
- Page 169 and 170:
dei millenni scambiate le rispettiv
- Page 171 and 172:
Ma quell’ anime, ch’eran lasse
- Page 173 and 174:
la divina vendetta li martelli». I
- Page 175 and 176:
passando per li cerchi sanza scorta
- Page 177 and 178:
Nel canto successivo, Virgilio, rif
- Page 179 and 180:
Per orrore di lui e del suo contatt
- Page 181 and 182:
della stella del mattino (faceva tu
- Page 183 and 184:
scalata del monte ha avuto lo scopo
- Page 185 and 186:
inascita qui simboleggiata è, infa
- Page 187 and 188:
l’aquila vecchia, avendo le ali a
- Page 189 and 190:
l’uomo vola con l’ale snelle e
- Page 191 and 192:
Quanto accade successivamente è an
- Page 193 and 194:
accosta loro, Gesù in persona si a
- Page 195 and 196:
Il monte del Purgatorio si scuote o
- Page 197 and 198:
vedere si può in quello canto del
- Page 199 and 200:
la sua vita colpevole, implorando D
- Page 201 and 202:
Il terzo regno In Paradiso, i passi
- Page 203 and 204:
che in Purgatorio guiderà l’asce
- Page 205 and 206:
La perifrasi con cui la donna espri
- Page 207 and 208:
Ma dimmi la cagion che non ti guard
- Page 209 and 210:
su la fiumana ove ’l mar non ha v
- Page 211 and 212:
iguarda il principio del viaggio ne
- Page 213 and 214:
Qualche verso prima, Catone era sta
- Page 215 and 216:
Quello infinito e ineffabil bene ch
- Page 217 and 218:
qualità, e se le differenze dipend
- Page 219 and 220:
una materia plasmata 444 . Nella te
- Page 221 and 222:
trasparenza del diamante: lucida, s
- Page 223 and 224:
«Frate, la nostra volontà quïeta
- Page 225 and 226:
e ora lì, come a sito decreto, cen
- Page 227 and 228:
fisico: un rapporto a cui si è ele
- Page 229 and 230:
concepirsi insieme, membra di un un
- Page 231 and 232:
verso Dio e, in particolare se, olt
- Page 233 and 234:
Pd. IX, 118-120 Dante è qui chiama
- Page 235 and 236:
Nei primi cieli, Dante distingue, a
- Page 237 and 238:
La tradizione scritturale su cui si
- Page 239 and 240:
del Purgatorio si distacca dalle ri
- Page 241 and 242:
L’invenzione del secondo regno Qu
- Page 243 and 244:
Egli ne fa conseguire che i beni te
- Page 245 and 246:
avem veduto” (If. XXXIV, 67-69),
- Page 247 and 248:
uomini, e così Dante, sono ottusi
- Page 249 and 250:
cioè la sua parte più nobile, ded
- Page 251 and 252:
cammino a spirale; se nell’Infern
- Page 253 and 254:
immediatamente naufragò prima di a
- Page 255 and 256:
Soprattutto l’ultima frase, in cu
- Page 257 and 258:
Satana e anche con la Croce la posi
- Page 259 and 260:
È, anche significativo, pertanto,
- Page 261 and 262:
quale ristabilimento del cammino, c
- Page 263 and 264:
distanza da Dio sono fondamentali n
- Page 265 and 266:
questa è triplice, e il primo grad
- Page 267 and 268:
uomini, a causa di mari e monti fra
- Page 269 and 270:
il mondo e l’uomo secondo un ordi
- Page 271 and 272:
confrontino le virtù aristoteliche
- Page 273 and 274:
della Commedia. Il numero è costit
- Page 275 and 276:
calla, usato per descrivere il tort
- Page 277 and 278:
Noi salavam per entro ’l sasso ro
- Page 279 and 280:
Per che è da notare che pericolosi
- Page 281 and 282:
là dove purgatorio ha dritto inizi
- Page 283 and 284:
avarizia, gola, lussuria. In cima a
- Page 285 and 286:
generale, Singleton definisce l’i
- Page 287 and 288:
non viste mai fuor ch’a la prima
- Page 289 and 290:
a Cristo, uomo-Dio. È possibile, i
- Page 291 and 292:
vicenda di Ulisse, al tentativo del
- Page 293 and 294:
per Dante, figura Christi 636 , gua
- Page 295 and 296:
Ciò che da essa sanza mezzo piove.
- Page 297 and 298:
delle proprie azioni; in lui volont
- Page 299 and 300:
Il peccato dipende da una opzione e
- Page 301 and 302:
terrestre egli rincontra la donna a
- Page 303 and 304:
Or perché a questa ogn’ altra si
- Page 305 and 306:
Successivamente, uno stuolo di demo
- Page 307 and 308:
mi convien la valle buia. Virgilio
- Page 309 and 310:
L’immagine, Lascio lo fele, che i
- Page 311 and 312:
a giungere alla meta che ora è raf
- Page 313 and 314:
egli è salvo, prima di varcare la
- Page 315 and 316:
Non so se ’ntendi: io dico di Bea
- Page 317 and 318:
con questa vera carne che ’l seco
- Page 319 and 320:
Giunti in cima alla scala, Virgilio
- Page 321 and 322:
commozione di Dante orfano del suo
- Page 323 and 324:
cagione parlare 671 , secondo la do
- Page 325 and 326:
quella circostanza, era stato Dante
- Page 327 and 328:
gradini, perché ora Beatrice gli r
- Page 329 and 330:
Beatrice si rivestì della superior
- Page 331 and 332:
nell’Inferno, nel Purgatorio e ne
- Page 333 and 334:
* * La spia linguistica dei falsi p
- Page 335 and 336:
Allo stesso tempo, il critico ameri
- Page 337 and 338:
secondo avvento è in mentem, occul
- Page 339 and 340:
I’ mi volsi a man destra, e puosi
- Page 341 and 342:
fa pronunciare, addirittura, alle v
- Page 343 and 344:
hanno accompagnato il percorso del
- Page 345 and 346:
accompagnare Dante nei suoi passi f
- Page 347 and 348:
modello arnaudiano, o al sonetto co
- Page 349 and 350:
della poesia non lirica comporta l
- Page 351 and 352:
La terzina dantesca Luisa Ferretti
- Page 353 and 354:
Luisa Ferretti Cuomo rafforza l’i
- Page 355 and 356:
L’apertura del primo dei tre ende
- Page 357 and 358:
il sistema della terza rima costitu
- Page 359 and 360:
Così dicendo, egli intende dire ch
- Page 361 and 362:
per lo gran mar de l’essere, e ci
- Page 363 and 364:
imanda alle 33 parti di ogni cantic
- Page 365 and 366:
non mi lascia più ir lo fren de l
- Page 367 and 368:
cronista ricorda che nella Firenze
- Page 369 and 370:
drammatica e teologica, è un analo
- Page 371 and 372:
373
- Page 373 and 374:
La Commedia secondo l’antica vulg
- Page 375 and 376:
VIRGILIO Eneide, a cura di Ettore P
- Page 377 and 378:
Expositio Psalmi CXVIII, in Opera o
- Page 379 and 380:
Tavola delle abbreviazioni DANTE AL
- Page 381 and 382:
Genesi contra Manichaeos In Evangel
- Page 383 and 384:
PIETRO ALIGHIERI Il Commentarium di
- Page 385 and 386:
ALBERT RUSSELL ASCOLI The Unfinishe
- Page 387 and 388:
DINO BIGONGIARI Essays on Dante and
- Page 389 and 390:
JAMES THOMAS CHIAMPI Dante’s Para
- Page 391 and 392:
HENRY DE LUBAC Exégèse médiéval
- Page 393 and 394:
REMO FASANI La metrica della Divina
- Page 395 and 396:
397
- Page 397 and 398:
RENÈ GUENON Il demiurgo e altri sa
- Page 399 and 400:
gennaio 2004), a cura di Daniela Ro
- Page 401 and 402:
Lexicon der mittelalterlichen Zahle
- Page 403 and 404:
Symbolism of the Supernatural in th
- Page 405 and 406:
WILHELM PÖTTERS Nascita del sonett
- Page 407 and 408:
GIAN ROBERTO SAROLLI Prolegomena al
- Page 409:
PAOLA VECCHI GALLI La fabbrica dell