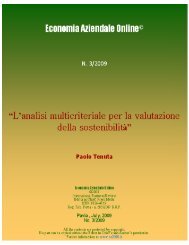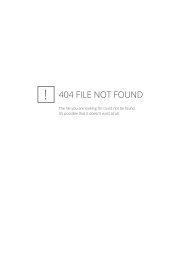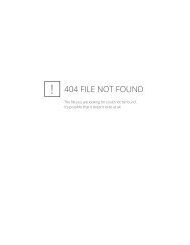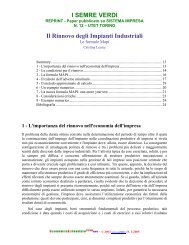il modello di Schilling e la proposta di - Economia Aziendale Online
il modello di Schilling e la proposta di - Economia Aziendale Online
il modello di Schilling e la proposta di - Economia Aziendale Online
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bor<strong>di</strong>gnon M. – L’analisi delle forze che favoriscono <strong>la</strong> modu<strong>la</strong>rità: <strong>il</strong> <strong>modello</strong> <strong>di</strong> Sch<strong>il</strong>ling e <strong>la</strong> <strong>proposta</strong> <strong>di</strong> un nuovo <strong>modello</strong>elevato, <strong>di</strong> modu<strong>la</strong>rità.Emerge pertanto <strong>la</strong> necessità <strong>di</strong> rispondere al seguente interrogativo, al fine <strong>di</strong> poter trattare inmodo ut<strong>il</strong>e, efficace ed adeguato <strong>la</strong> modu<strong>la</strong>rità, le sue implicazioni e i suoi effetti nel campoeconomico aziendale: quando un sistema può essere definito modu<strong>la</strong>re?Per trovare una valida risposta a questa domanda, si ritiene necessario in<strong>di</strong>viduare glielementi caratterizzanti una struttura modu<strong>la</strong>re per poter così definire in modo chiaro e nonambiguo <strong>il</strong> concetto <strong>di</strong> modu<strong>la</strong>rità.A tal proposito, un primo passo consiste nel considerare l’architettura <strong>di</strong> prodotto 4 , <strong>la</strong> quale,come afferma Simon (Simon, 1962), costituisce <strong>la</strong> chiave <strong>di</strong> comprensione <strong>di</strong> ogni sistemacomplesso.In tale ambito si <strong>di</strong>mostra <strong>di</strong> partico<strong>la</strong>re ut<strong>il</strong>ità <strong>il</strong> contributo <strong>di</strong> Ulrich (Ulrich, 1995), <strong>il</strong> qualedefinisce l’architettura prodotto come «the scheme by which the function of a product is allocatedto physical component» (Ulrich, 1995: 422).L’architettura <strong>di</strong> prodotto può essere descritta e definita attraverso <strong>la</strong> considerazione deiseguenti aspetti (Ulrich, 1995):- gli elementi funzionali (o funzioni) del prodotto. Le funzioni costituiscono le operazioni che,nel loro insieme, vanno ad implementare le prestazioni <strong>di</strong> un prodotto;- <strong>la</strong> mappatura delle re<strong>la</strong>zioni tra gli elementi funzionali e i componenti del prodotto. Uncomponente è una qualsiasi regione del prodotto logicamente <strong>di</strong>stinta. Non è necessario quin<strong>di</strong>che un componente per essere definito tale debba essere separab<strong>il</strong>e in una parte fisicamenteautonoma. Al concetto <strong>di</strong> componente si accompagnano quelli <strong>di</strong> subsistema e <strong>di</strong> componenteelementare. Il subsistema è una regione fisicamente o logicamente <strong>di</strong>stinta a cui è legata unaspecifica funzione. Esso può comprendere <strong>di</strong>versi componenti tra loro collegati e si riferisce adun livello <strong>di</strong> <strong>di</strong>saggregazione meno dettagliato rispetto a quello in cui si vanno ad in<strong>di</strong>viduarequesti ultimi. Il componente elementare è invece un componente non ulteriormente scomponib<strong>il</strong>eottenuto al massimo livello <strong>di</strong> <strong>di</strong>saggregazione, detto livello iota;- le interfacce tra i componenti. L’interfaccia è ciò che connette a sistema due o piùcomponenti e che descrive come questi ultimi interagiscono tra loro. Considerato che due o piùcomponenti possono essere posti in re<strong>la</strong>zione anche senza una connessione fisica, <strong>il</strong> concetto <strong>di</strong>interfaccia non può essere limitato a ciò che connette fisicamente due o più componenti. Non acaso, nel definire l’interfaccia si è posta l’attenzione sull’“interazione” e non sul<strong>la</strong> “connessionefisica” tra componenti. Da tale considerazione emerge che l’interfaccia è costituita da unprotocollo <strong>di</strong> collegamento che assicura l’interazione tra due o più componenti e, solo qualorasussista un legame fisico tra le parti, da una «connessione geometrica» (Ulrich, 1995: 421).4 Le considerazioni che seguono con riferimento all’architettura, sebbene siano riferite principalmente al prodotto,possono essere considerate valide e ut<strong>il</strong>i per qualsiasi tipo <strong>di</strong> sistema.- © 2003 p. 4