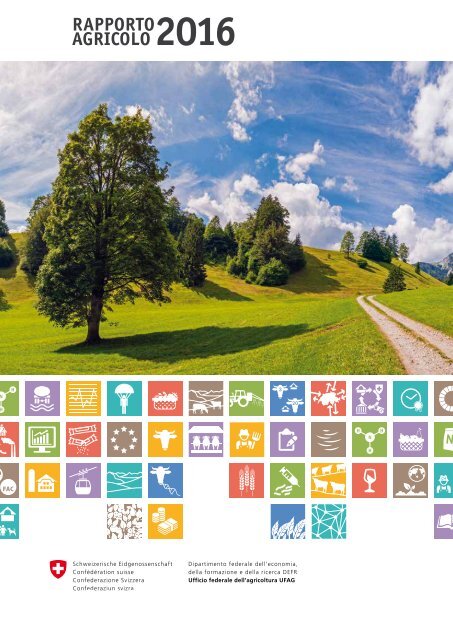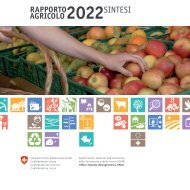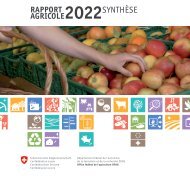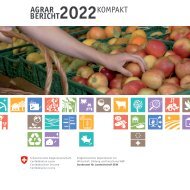AB2016_Printversion_i_Ansicht
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Editore<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
CH-3003 Berna<br />
Telefono: 058 462 25 11<br />
Telefax: 058 462 26 34<br />
Internet: www.rapportoagricolo.ch<br />
Copyright: UFAG, Berna 2016<br />
Veste grafica<br />
Panache AG, Berna<br />
Distribuzione<br />
UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna<br />
www.pubblicazionifederali.admin.ch<br />
2<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
L’UOMO<br />
8 Introduzione<br />
Famiglie contadine<br />
9 Le donne e la loro sicurezza<br />
11 Assicurazioni sociali<br />
15 Condizioni di lavoro e di vita (RIFOS)<br />
21 Condizioni di vita (SILC)<br />
27 Soddisfazione sul lavoro in Svizzera e nella Germania nord orientale<br />
Società<br />
29 «Notfallhilfe» – La piattaforma per le emergenze<br />
32 Protezione delle terre coltive<br />
34 Studio sulla vitalità e l‘attrattiva delle aree rurali<br />
AZIENDA<br />
36 Introduzione<br />
Strutture<br />
37 Aziende<br />
41 Aziende d’estivazione<br />
46 Lavoratori<br />
48 Superficie agricola utile<br />
50 Animali<br />
Situazione economica<br />
52 Conto economico<br />
54 Singole aziende<br />
PRODUZIONE<br />
60 Introduzione<br />
Mezzi di produzione<br />
61 OGM negli alimenti per animali<br />
62 Piano d’azione sui prodotti fitosanitari<br />
Produzione vegetale<br />
63 Utilizzazione della superficie<br />
65 Strategia Selezione vegetale Svizzera 2050<br />
Produzione animale<br />
66 Allevatori e effettivi di animali da reddito<br />
68 Produzione lattiera<br />
69 Produzione di carne e uova<br />
Sicurezza della produzione primaria<br />
70 Strategia contro le resistenze agli antibiotici<br />
72 Strategia per la sicurezza della catena alimentare<br />
3
MERCATO<br />
76 Introduzione<br />
Evoluzione dei mercati<br />
78 Valore aggiunto lordo<br />
79 Commercio estero<br />
82 Grado di autoapprovvigionamento<br />
83 Evoluzione degli indici dei prezzi<br />
84 Prezzi ai diversi livelli commerciali<br />
90 Competitività del settore lattiero<br />
Prodotti di origine vegetale<br />
99 Cereali<br />
101 Semi oleosi<br />
102 Patate<br />
103 Zucchero<br />
105 Frutta<br />
108 Verdura<br />
110 Vino<br />
Prodotti di origine animale<br />
112 Latte e latticini<br />
116 Carne e uova<br />
AMBIENTE<br />
122 Introduzione<br />
Monitoraggio agro-ambientale<br />
123 Indicatori agroambientali (IAA)<br />
Azoto<br />
124 L‘azoto nell‘agricoltura<br />
130 Emissioni di ammoniaca<br />
137 Emissioni di protossido di azoto<br />
140 Nitrati nell’acqua<br />
Acqua<br />
145 Acqua e agricoltura<br />
146 Utilizzo di prodotti fitosanitari<br />
151 Impiego di medicamenti veterinari<br />
4<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
POLITICA<br />
160 Introduzione<br />
Produzione e smercio<br />
164 Panoramica<br />
166 Economia lattiera<br />
171 Produzione animale<br />
179 Produzione vegetale<br />
183 Promozione dello smercio<br />
185 Promozione della qualità e della sostenibilità<br />
186 Caratterizzazione dei prodotti agricoli<br />
188 Disposizioni sulle norme d’importazione ed esecuzione<br />
191 Legge sul cioccolato<br />
Pagamenti diretti<br />
192 Sistema dei pagamenti diretti<br />
195 Condizioni per il versamento di pagamenti diretti<br />
197 Esecuzione<br />
199 Contributi per il paesaggio rurale<br />
207 Contributi per la sicurezza dell‘approvvigionamento<br />
212 Contributi per la qualità del paesaggio<br />
223 Contributi per la biodiversità<br />
239 Contributi per i sistemi di produzione<br />
245 Contributi per l‘efficienza delle risorse<br />
249 Contributo di transizione<br />
251 Variazioni dei pagamenti diretti a livello aziendale e regionale<br />
Miglioramenti strutturali e misure sociali collaterali<br />
257 Miglioramenti strutturali<br />
260 Misure sociali collaterali<br />
261 Ricostruzione della funivia sull‘Alpe Sigel<br />
266 Manutenzione delle strade agricole<br />
271 Intervento ecologico minimo nella costruzione di strade<br />
276 Irrigazione nella regione Seeland-Broye<br />
280 PSR «Genussregion»<br />
Ricerca, consulenza, formazione professionale<br />
286 Piano direttore della ricerca per l‘agricoltura e la filiera alimentare<br />
288 Agricoltura biologica e agricoltura sostenibile<br />
289 Consulenza agricola<br />
292 Formazione professionale<br />
Gestione dei dati<br />
295 Gestione dei dati lungo la filiera alimentare<br />
298 HODUFLU<br />
Programmi regionali e settoriali<br />
304 Contributi per la protezione delle acque<br />
305 Contributi per i programmi sulle risorse<br />
5
INTERNAZIONALE<br />
308 Introduzione<br />
Dimensione commerciale<br />
310 FAO<br />
312 OCSE<br />
318 OMC<br />
320 CIC/CAA<br />
321 UE<br />
Sostenibilità<br />
324 2030 Agenda per lo sviluppo sostenibile<br />
326 10YFP Programma per sistemi alimentari sostenibili<br />
328 Agrobiodiversità / Risorse genetiche<br />
331 Sicurezza alimentare e resilienza<br />
333 Investimenti responsabili nell’agricoltura e nei sistemi alimentari<br />
Accordo di libero scambio<br />
334 Accordo di libero scambio<br />
Statistiche e modellizzazione<br />
336 Sviluppi dei mercati agricoli<br />
339 Statistiche agricole di alcuni partner commerciali<br />
343 Confronto internazionale<br />
344 Analisi quantitative<br />
A<br />
TABELLE<br />
6<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
7
Il mio Rapporto agricolo 2 / 29<br />
L’UOMO > INTRODUZIONE<br />
Introduzione<br />
Cosa sarebbe l'agricoltura senza il lavoro delle singole famiglie contadine? Esse hanno compiti<br />
vari e distinti tra loro, ma sono accomunate dalla particolare forma di vita: il legame tra vita<br />
professionale e privata, l'indipendenza, il lavoro a contatto con la natura e gli animali. Le famiglie<br />
contadine plasmano l'agricoltura. La loro situazione è pertanto un importante aspetto<br />
del presente rapporto. Essa viene trattata sviluppando le seguenti tematiche.<br />
• Sicurezza sociale delle famiglie contadine sulla base di una valutazione speciale delle<br />
statistiche AVS e sugli assegni familiari, entrambe dell'Ufficio federale delle assicurazioni<br />
sociali (UFAS), nonché della statistica dell'aiuto sociale dell'Ufficio federale di statistica<br />
(UST)<br />
• Donne e sicurezza sociale in adempimento della mozione «Donne<br />
nell'agricoltura» (12.3990) della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio<br />
degli Stati<br />
• Condizioni di lavoro e di vita (RIFOS) della popolazione agricola rispetto alla restante<br />
popolazione, sulla base di una valutazione speciale della rilevazione sulle forze di lavoro<br />
in Svizzera dell'UST<br />
• Condizioni di vita (SILC) delle famiglie contadine rispetto ad altre economie domestiche<br />
rurali, sulla base di una valutazione speciale delle statistiche sul reddito e sulle condizioni<br />
di vita dell'UST<br />
• Reddito e consumo sulla base dell'indagine sul budget delle economie domestiche (segue<br />
a fine 2016)<br />
La società rivolge numerose richieste di diverso tipo al settore agroalimentare. Tra queste si<br />
annoverano, ad esempio, le derrate alimentari di qualità, la diversità paesaggistica, l’elevato<br />
benessere degli animali o la riduzione dell'inquinamento ambientale. Nel presente rapporto<br />
è pertanto rilevante anche la visione che la società ha del settore. Essa viene analizzata sulla<br />
scorta delle seguenti tematiche.<br />
• Protezione del paesaggio rurale, valenza e misure per la protezione del paesaggio rurale,<br />
in particolare delle superfici per l'avvicendamento delle colture<br />
• Studio sulla vitalità e sull'attrattiva delle aree rurali di Ecoplan e della Scuola superiore<br />
di scienze agrarie, forestali e alimentari (SSAFA)<br />
• «Notfallhilfe» – La piattaforma per le emergenze con offerte particolari e sportelli per le<br />
famiglie contadine confrontate con sfide sul piano sociale e/o con difficoltà finanziarie<br />
8<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 3 / 29<br />
L’UOMO > FAMIGLIE CONTADINE<br />
Le donne e la loro sicurezza<br />
L’importanza delle donne nell’agricoltura è enorme. Hanno infatti un ruolo fondamentale<br />
nell’economia domestica e nell’educazione dei figli, lavorano spesso anche in azienda o si<br />
prendono cura dei genitori/suoceri. Molte hanno altresì un’attività professionale al di fuori<br />
dell’azienda e impegni vari nel campo del volontariato.<br />
Il ruolo delle donne in azienda è molto eterogeneo. Alcune sono a capo dell’azienda e se ne<br />
assumono la piena responsabilità, altre se la spartiscono con un socio, altre ancora aiutano<br />
solo sporadicamente in fattoria mentre alcune se ne disinteressano totalmente.<br />
In adempimento della mozione «Donne nell'agricoltura» (12.3990) della Commissione<br />
dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati è stato stilato un rapporto incentrato<br />
sulla sicurezza economica, giuridica e sociale delle donne. Tale rapporto ha preso spunto dallo<br />
studio condotto a livello nazionale nel 2012 sul tema Donne nell’agricoltura a cura di UFAG<br />
e Agroscope, nonché dalla Giornata nazionale delle donne nell’agricoltura svizzera lanciata<br />
nell’autunno 2012. Di seguito sono riassunti e suddivisi per temi i risultati più importanti.<br />
Sicurezza economica<br />
La sicurezza economica delle donne nell’agricoltura è basata sull’attività remunerata, dipendente<br />
o indipendente, all’interno dell’azienda, su un’attività lucrativa extraziendale o su mandati<br />
remunerati. A ciò si sommano altre forme diffuse nel settore agricolo quali usufrutto o<br />
diritto d’abitazione.<br />
La sicurezza economica delle donne nell’agricoltura sostanzialmente non si differenzia da<br />
quella di altre donne che lavorano (collaborano) nell’azienda di famiglia, gestiscono indipendentemente<br />
l’intera azienda (un ramo aziendale) o esercitano un’attività lucrativa extraziendale.<br />
Nel caso delle aziende agricole, rette dal diritto fondiario rurale, la sicurezza economica<br />
è disciplinata anche da questo diritto.<br />
Nel caso delle aziende agricole ai sensi del diritto fondiario rurale, il coniuge non proprietario,<br />
generalmente la donna, dovrebbe tutelarsi in caso di partecipazione finanziaria. È importante<br />
che le quote acquisite e gli investimenti in beni propri fatti dalle donne possano essere comprovati.<br />
Per tutti i coniugi è bene tener presente che in caso di decesso del titolare del conto decade<br />
qualsiasi procura sul conto in questione. Per questo motivo anche la gestione del patrimonio<br />
personale assume una particolare importanza.<br />
Sicurezza giuridica<br />
L’ordinamento giuridico svizzero adempie pienamente il principio di parità tra donna e uomo.<br />
Come per gli uomini, lo status giuridico delle contadine e delle donne nell'agricoltura dipende<br />
da:<br />
• status personale, nonché regime dei beni e responsabilità,<br />
• status in base al diritto delle assicurazioni sociali (status AVS) o al diritto del lavoro,<br />
• status in base al diritto aziendale e<br />
• rapporti di proprietà.<br />
La sicurezza giuridica delle donne nell’agricoltura sostanzialmente non si differenzia da quella<br />
di altre donne che lavorano (collaborano) nell’azienda di famiglia, gestiscono indipendentemente<br />
l’intera azienda (un ramo aziendale) o esercitano un’attività lucrativa extraziendale.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
9
Il mio Rapporto agricolo 4 / 29<br />
L’UOMO > FAMIGLIE CONTADINE<br />
Il diritto fondiario rurale si basa su un’immagine tradizionale dell’agricoltura con il modello<br />
classico di famiglia. Dal profilo del diritto successorio le donne coniugate nel contesto agricolo<br />
sono ampiamente tutelate.<br />
A livello di codice civile e di diritto fondiario rurale, in alcuni casi sono necessarie informazioni<br />
e precisazioni sul caso di divorzio: occorre pertanto elaborare supporti informativi per<br />
la consulenza agricola, vagliare possibilità di adeguamento degli atti normativi e integrare i<br />
commenti degli atti normativi con spiegazioni. In caso di divorzio, il coniuge non proprietario,<br />
generalmente la moglie, è tendenzialmente svantaggiato dal principio del valore di reddito e<br />
dalla richiesta di prova inconfutabile dei beni propri o dei compensi: investimenti in beni propri<br />
e quote acquisite fatti dalle donne devono poter essere comprovati. A seguito di un divorzio è<br />
altresì necessario appurare la copertura assicurativa.<br />
Sicurezza sociale<br />
La sicurezza sociale delle donne nell'agricoltura è garantita, come per il resto della popolazione,<br />
da una fitta rete di assicurazioni sociali, che offre un’ampia protezione contro i rischi le<br />
cui conseguenze economiche non si possono affrontare da soli.<br />
La sicurezza sociale delle donne nell'agricoltura non si differenzia da quella di altre donne<br />
che lavorano (collaborano) nell'azienda di famiglia, gestiscono indipendentemente l'intera<br />
azienda (un ramo aziendale) o esercitano un'attività lucrativa extraziendale. Nel primario i<br />
membri della famiglia che collaborano in azienda generalmente non sono soggetti all’obbligo<br />
contributivo per l’assicurazione contro la disoccupazione e dunque non sono assicurati.<br />
La sicurezza sociale delle donne dipende concretamente dal loro status in base al diritto delle<br />
assicurazioni sociali (p.es. come persone senza attività lucrativa in caso di collaborazione<br />
non remunerata in azienda), dall’importo del loro reddito e dalle assicurazioni individuali che<br />
hanno stipulato: se le donne collaborano nell’azienda di famiglia con o senza salario, è necessario<br />
chiarire caso per caso la loro assicurazione non obbligatoria, come ad esempio quella di<br />
un’indennità giornaliera.<br />
Nell’ambito della previdenza per la vecchiaia, le donne nell’agricoltura che divorziano possono<br />
ritrovarsi in una situazione difficile. Generalmente i risparmi vengono investiti nell’azienda,<br />
che nella liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi viene stimata al valore di reddito,<br />
e viene a mancare anche la possibilità di avere un alloggio economico per la vecchiaia con diritto<br />
d’abitazione. S’impone una previdenza sociale indipendente per le donne nell’agricoltura<br />
attraverso un’attività lucrativa aziendale o extraziendale.<br />
» Rapporto del Consiglio federale «Donne nell’agricoltura» in adempimento della mozione<br />
della CET-S del 14 novembre 2012 (12.3990)<br />
Letteratura<br />
Rapporto del Consiglio federale «Donne nell’agricoltura» in adempimento della mozione della CET-S del 14 novembre<br />
2012 (12.3990)<br />
Esther Grossenbacher, UFAG, Settore Ricerca, consulenza e valutazione, esther.grossenbacher@blw.admin.ch<br />
10<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 5 / 29<br />
L’UOMO > FAMIGLIE CONTADINE<br />
Assicurazioni sociali<br />
Le opere sociali dello Stato, le assicurazioni di persone e quelle di cose nonché le istituzioni<br />
private costituiscono parte della rete di sicurezza formale per la popolazione contadina e non.<br />
Le diverse assicurazioni sociali come l'AVS/AI o l'assicurazione malattia e infortuni offrono alle<br />
persone un'ampia protezione contro i rischi di cui non possono fronteggiare da soli le conseguenze<br />
finanziarie.<br />
» Assicurazioni sociali<br />
Per la maggior parte delle assicurazioni sociali è impossibile effettuare una valutazione in base<br />
alla categoria professionale. Per tale motivo, l'analisi di seguito riportata si limita ad AVS, assegni<br />
familiari nell'agricoltura e aiuto sociale.<br />
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti<br />
L'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) è il pilastro principale su cui poggia il sistema<br />
svizzero di previdenza per la vecchiaia e i superstiti. Essa copre il fabbisogno vitale in<br />
caso di perdita del reddito da attività lucrativa in seguito al raggiungimento dell'età AVS o al<br />
decesso della persona che manteneva la famiglia. Introdotta nel 1948, la rendita AVS dipende<br />
dal reddito assoggettato ai contributi nel periodo attivo e da eventuali accrediti per compiti<br />
educativi e assistenziali.<br />
» AVS<br />
La statistica dei redditi AVS comprende tutti i redditi di un anno di contribuzione soggetti<br />
all'obbligo contributivo AVS, a prescindere dalla durata dell'attività lucrativa. Nel 2012 i contribuenti<br />
AVS (persone attive e non attive) sono stati circa 5,4 milioni. Di questi, 4,9 milioni<br />
erano assicurati professionalmente attivi, di età compresa tra i 18 e i 63/64 anni.<br />
La statistica dei redditi AVS più recente disponibile è quella del 2012. Da questa emerge che su<br />
un totale di 4,908 milioni di contribuenti attivi [persone con esclusivamente reddito sostitutivo<br />
(indennità giornaliera IPG, indennità giornaliera AI, indennità giornaliera dell’assicurazione<br />
militare) del tipo di contributo 1 nei conti individuali dell’AVS (=lavoratori dipendenti) ma<br />
senza altri redditi dell’attività lucrativa assoggettati ai contributi AVS non sono considerate nel<br />
totale delle persone attive)] nella fascia d'età 18-63/64, 53 200 erano agricoltori o contadine<br />
indipendenti. Per 35 600 agricoltori e 4600 contadine il reddito AVS proveniente dall'attività<br />
agricola rappresentava la parte maggiore del loro reddito AVS totale. Circa la metà dei contribuenti<br />
con attività indipendente nel settore primario aveva un'attività extraaziendale.<br />
Redditi AVS di lavoratori indipendenti nell'agricoltura¹ (Persone nella fascia d'età<br />
18-63/64 anni)²<br />
Reddito AVS<br />
2012<br />
Numero<br />
Totale reddito<br />
AVS medio<br />
Di cui<br />
dall'agricoltura<br />
Di cui da altra attività<br />
lucrativa³<br />
Età media<br />
Fr. Fr. Fr. Anni<br />
Uomini 47 100 67 400 48 400 19 000 48,2<br />
Donne 6000 37 600 26 000 11 600 47,9<br />
Totale o valore<br />
medio<br />
53 200 64 000 45 900 18 100 48,1<br />
1<br />
Analisi speciale<br />
2<br />
Le persone attive nell'anno del raggiungimento dell'età AVS (64 o 65 anni) e quelle che l’hanno superata (>65 o<br />
>66 anni) non sono considerate.<br />
3<br />
Persone senza un’altra attività lucrativa: nel calcolo del valore medio si inserisce l'importo 0 franchi.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
11
Il mio Rapporto agricolo 6 / 29<br />
L’UOMO > FAMIGLIE CONTADINE<br />
Fonti: conti individuali AVS, Ufficio centrale di compensazione (UCC) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali<br />
(UFAS); stato marzo 2016<br />
Ogni anno le casse di compensazione inoltrano i dati sul reddito dei conti individuali AVS<br />
all'Ufficio centrale di compensazione (UCC) suddivisi per tipo di contributo. I lavoratori indipendenti<br />
attivi nell'agricoltura sono notificati con un tipo di contributo separato (tipo di contributo<br />
9). Nel conto individuale dei lavoratori indipendenti che versano solo l'importo minimo<br />
di contribuzione AVS viene inserito un reddito (2012: 9094 fr.). Nel settore primario ciò interessa<br />
il 17 per cento della popolazione con attività indipendente, segnatamente 7350 uomini<br />
e 1880 donne.<br />
Assegni familiari<br />
Gli assegni familiari sono, assieme alle agevolazioni fiscali, la principale misura di compensazione<br />
degli oneri familiari. Contrariamente alle prestazioni delle altre assicurazioni sociali, essi<br />
costituiscono un reddito complementare e non sostitutivo.<br />
» Assegni familiari nell’agricoltura<br />
Nell'agricoltura gli assegni familiari vengono versati solo agli agricoltori e alpigiani indipendenti,<br />
ai pescatori professionisti e ai lavoratori agricoli dipendenti. Sono finanziati principalmente<br />
con fondi pubblici, segnatamente per due terzi dalla Confederazione e un terzo dai<br />
Cantoni.<br />
Importo degli assegni familiari nell’agricoltura<br />
Tipo di assegno familiare<br />
Importo (in fr.)<br />
Assegno per i figli¹ (figli fino a 16 anni) 200<br />
Assegno di formazione¹ (figli da 16 a 25 anni) 250<br />
Assegno per l'economia domestica 100<br />
¹ Regioni di montagna: importo maggiorato di 20 franchi<br />
Fonte: Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)<br />
L'importo degli assegni per i figli e di formazione nell'agricoltura corrisponde a quello minimo<br />
secondo la legge federale sugli assegni familiari (LAFam). Nelle regioni di montagna l'importo<br />
è maggiorato di 20 franchi. I lavoratori agricoli dipendenti ricevono inoltre, ogni mese, un<br />
assegno per l'economia domestica del valore di 100 franchi. Singoli Cantoni versano anche<br />
altri assegni.<br />
12<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 7 / 29<br />
L’UOMO > FAMIGLIE CONTADINE<br />
Percepimento degli assegni familiari nell'agricoltura 2015<br />
Beneficiari<br />
Numero<br />
Assegni<br />
Mio. fr.<br />
Lavoratori agricoli dipendenti 7884<br />
Assegni per i figli 8651 15,599<br />
Assegni di formazione 2365 4,731<br />
Assegni per l'economia domestica 7591 7,478<br />
Agricoltori 13 982<br />
Assegni per i figli 24 336 55,559<br />
Assegni di formazione 10 852 25,490<br />
Totale 21 866 108,857<br />
Senza alpigiani e pescatori<br />
Fonte: UFAS<br />
Negli ultimi anni sono diminuiti notevolmente i fondi versati nell'agricoltura sotto forma di<br />
assegni familiari a causa del calo dei beneficiari o del numero di figli e perché in seguito a<br />
una modifica della legislazione le famiglie contadine dal 2013 possono contare anche sulla<br />
legge federale sugli assegni familiari invece che sulla legge federale sugli assegni familiari<br />
nell'agricoltura. Nel 2015 gli assegni versati ammontavano a un totale di 109 milioni di franchi.<br />
Fino a fine 2007 gli assegni familiari venivano versati solo ai piccoli contadini (limite di reddito:<br />
30 000 fr.). Tale limite è stato soppresso nel 2008, anno dal quale hanno diritto agli assegni familiari<br />
tutti gli agricoltori indipendenti e sono pertanto disponibili dati comparabili. Nel 2009<br />
gli assegni familiari versati nell'agricoltura ammontavano a un totale di 150 milioni di franchi.<br />
Aiuto sociale<br />
La Costituzione federale garantisce il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno a ogni persona<br />
soggiornante in Svizzera. Nel quadro dell'aiuto sociale pubblico, i Cantoni garantiscono prestazioni<br />
a persone che non riescono a far fronte ai propri bisogni o a quelli della famiglia.<br />
L’organizzazione e l’applicazione concreta sono disciplinate in maniera diversa a seconda del<br />
Cantone o del Comune.<br />
» Aiuto sociale<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
13
Il mio Rapporto agricolo 8 / 29<br />
L’UOMO > FAMIGLIE CONTADINE<br />
Lavoratori nell'agricoltura beneficiari di aiuto sociale nel 2014¹<br />
Casi<br />
Persone in unità assistenziali<br />
(adulti e<br />
bambini)<br />
Somma dei contributi<br />
versati<br />
Importo versato per<br />
singolo caso<br />
Numero Numero Mio. fr. Fr.<br />
Lavoratore indipendente<br />
Lavoratore impiegato<br />
regolarmente<br />
Altri lavoratori<br />
in economie domestiche<br />
Lavoratori in strutture<br />
stazionarie /<br />
forme abitative particolari<br />
45 91 0,798 17 700<br />
163 360 2,324 14 300<br />
267 487 4,124 15 400<br />
24 24 0,400 16 700<br />
Totale lavoratori 499 962 7,646 15 300<br />
1<br />
Analisi speciale settore agricoltura: casi di aiuto sociale e valore medio degli importi versati in base alla situazione<br />
lavorativa.<br />
Campione: persone in casi (unità assistenziali) in cui il lavoratore richiedente è attivo nell'agricoltura (incl. silvicoltura,<br />
piscicoltura) e ha tra 15 e 64 anni.<br />
Fonte: Ufficio federale di statistica (UST)<br />
Nel 2014, per un totale di 499 casi nel settore agricolo, sono stati erogati 7,6 milioni di franchi<br />
di aiuto sociale, corrispondenti a 15 300 franchi per singolo caso; indipendentemente dal settore,<br />
la media svizzera è di 15 500 franchi per caso.<br />
Chiunque intenda ottenere prestazioni sociali deve dimostrare che ne ha bisogno. Deve pertanto<br />
presentare documenti relativi alla situazione finanziaria dell’economia domestica e<br />
dell’azienda e mettere le autorità al corrente di questioni fino a quel momento private. Per<br />
le famiglie contadine la richiesta di aiuto sociale non è conciliabile con valori diffusi quali autonomia,<br />
libertà e indipendenza. Inoltre, considerata la stretta correlazione tra azienda ed<br />
economia domestica privata, nell'agricoltura vi è anche elevata flessibilità nell'impiego di lavoro<br />
e denaro. Anche per questo motivo, le contadine e gli agricoltori fanno raramente ricorso<br />
all'aiuto sociale: in tempi difficili stringono ulteriormente la cinghia e attingono alla «sostanza».<br />
Per quanto riguarda l’aiuto sociale c’è un notevole divario fra le zone urbane e quelle rurali.<br />
Quanto più grande è il Comune o la città tanto maggiore è la percentuale di aiuti sociali. Altrettanto<br />
elevata resta la paura di essere «bollati» come beneficiari dell'aiuto sociale soprattutto<br />
nelle aree rurali.<br />
Esther Grossenbacher, UFAG, Settore Ricerca, consulenza e valutazione, esther.grossenbacher@blw.admin.ch<br />
14<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 9 / 29<br />
L’UOMO > FAMIGLIE CONTADINE<br />
Condizioni di lavoro e di vita (RIFOS)<br />
Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera<br />
» Scheda della rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera<br />
(RIFOS)<br />
I risultati più importanti della valutazione speciale della rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera<br />
(RIFOS) sono riportati nelle sezioni «Età e dimensioni dell'economia domestica» e «Formazione<br />
professionale e situazione lavorativa». Le cifre corrispondono ai dati annuali della RIFOS<br />
2015, che confronta la situazione delle cinque seguenti categorie professionali di lavoratori:<br />
• agricoltori/contadine (550 uomini e 352 donne);<br />
• lavoratori indipendenti nell’artigianato/industria (1288 uomini e 191 donne);<br />
• altri lavoratori indipendenti (2000 uomini e 2233 donne);<br />
• lavoratori dipendenti nell’agricoltura (113 uomini e 65 donne);<br />
• altri lavoratori dipendenti (17 082 uomini e 17 459 donne).<br />
Nella categoria «agricoltori/contadine» rientrano agricoltori e contadine indipendenti nonché<br />
membri della famiglia che collaborano nell'azienda. I campioni di lavoratori dipendenti del<br />
primario sono molto esigui e pertanto i dati per questa categoria sono solo parzialmente affidabili<br />
dal profilo statistico. Di conseguenza, i confronti con le altre categorie vanno interpretati<br />
con cautela.<br />
Età e dimensioni dell'economia domestica<br />
In questa sezione vengono illustrati i dati relativi agli indicatori «Età delle persone occupate»<br />
e «Numero di persone nell'economia domestica».<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
15
Il mio Rapporto agricolo 10 / 29<br />
L’UOMO > FAMIGLIE CONTADINE<br />
L'età media degli agricoltori e delle contadine interpellati è di 51 anni, ovvero simile a quella<br />
di altri lavoratori indipendenti. I lavoratori dipendenti sono invece mediamente nove anni più<br />
giovani.<br />
Le economie domestiche contadine, con una media di 3,1 componenti, continuano a costituire<br />
nuclei più numerosi rispetto alle altre economie domestiche interpellate: in più di un quinto<br />
dei casi sono composte da 5 o più persone. Vive invece in un'economia domestica formata da<br />
una singola persona il 10 per cento dei contadini.<br />
Formazione professionale e situazione lavorativa<br />
Di seguito vengono illustrati i dati relativi a «Titolo di studi», «Frequenza di corsi di perfezionamento»,<br />
«Ore di lavoro settimanali», «Lavoro nel fine settimana» e «Giorni di ferie».<br />
16<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 11 / 29<br />
L’UOMO > FAMIGLIE CONTADINE<br />
In tutti i gruppi interpellati, ma soprattutto nel settore agricolo, le donne possiedono titoli di<br />
studio inferiori rispetto agli uomini: il 30 per cento non ha un diploma professionale, mentre<br />
alcune hanno frequentato una scuola per contadine. La formazione più elevata conseguita si<br />
rileva tra gli uomini del gruppo «Altri lavoratori indipendenti», nel quale il 56 per cento ha una<br />
formazione professionale superiore.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
17
Il mio Rapporto agricolo 12 / 29<br />
L’UOMO > FAMIGLIE CONTADINE<br />
Per «Corsi di perfezionamento» s’intendono esclusivamente le varie forme di perfezionamento<br />
professionale. Tra i lavoratori dipendenti (uomini e donne), almeno il 17 per cento ha seguito<br />
un corso di questo tipo, mentre tra gli indipendenti la percentuale si attesta tra il 5 e il 14 per<br />
cento.<br />
Per quanto riguarda le ore di lavoro settimanali, vengono considerate esclusivamente le ore dedicate<br />
all’attività lucrativa principale (nel caso in cui si svolgano più attività lucrative); i lavori<br />
domestici non sono tenuti in considerazione. Circa il 70 per cento degli agricoltori interpellati<br />
lavora 50 o più ore alla settimana. Il tempo di lavoro medio degli agricoltori e delle contadine<br />
è di rispettivamente 54 e 32 ore settimanali.<br />
18<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 13 / 29<br />
L’UOMO > FAMIGLIE CONTADINE<br />
Nel gruppo «Agricoltori/contadine», nel 2015, si sono astenuti dal lavoro nel fine settimana<br />
l'8 per cento degli uomini e il 13 per cento delle donne. Molto probabilmente si tratta di persone<br />
non dedite alla detenzione di animali da reddito. Oltre il 60 per cento dei contadini lavora<br />
regolarmente nel fine settimana.<br />
Mediamente, nel 2015, agricoltori e contadine sono andati in ferie rispettivamente 10 e 8<br />
giorni. Contrariamente agli altri lavoratori indipendenti, per le famiglie contadine, in particolare<br />
quelle che possiedono bestiame da reddito, è complicato allontanarsi temporaneamente<br />
dall’azienda.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
19
Il mio Rapporto agricolo 14 / 29<br />
L’UOMO > FAMIGLIE CONTADINE<br />
Rapporto agricolo 2011, 1.2.1.2 Formazione e lavoro, pag. 50<br />
Rapporto agricolo 2015 L'uomo/Famiglie contadine/Condizioni di lavoro e di vita<br />
Esther Grossenbacher, UFAG, Settore Ricerca, consulenza e valutazione, esther.grossenbacher@blw.admin.ch<br />
20<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 15 / 29<br />
L’UOMO > FAMIGLIE CONTADINE<br />
Condizioni di vita (SILC)<br />
Sulla base dei risultati di una valutazione speciale dell'indagine «Statistics on Income and Living<br />
Conditions» (SILC), le condizioni di vita delle famiglie contadine sono state analizzate e<br />
messe a confronto con quelle di altre economie domestiche.<br />
SILC<br />
Nell'ambito della SILC, nel 2014 sono state intervistate 262 persone di estrazione contadina.<br />
Per economia domestica contadina si intende un nucleo familiare comprendente almeno una<br />
persona che lavora come agricoltore indipendente. Per consentire il confronto tra le economie<br />
domestiche contadine e quelle non agricole, le prime sono state classificate nel gruppo «Economie<br />
domestiche in regioni scarsamente popolate», dove la persona di riferimento esercita<br />
un’attività lucrativa (gruppo di controllo: 2033 persone).<br />
Tutte le stime effettuate sulla base di un campione - analogamente alla SILC - hanno un certo<br />
margine di incertezza, perché per valutare una caratteristica di tutta la popolazione ne viene<br />
interpellata solo una parte. Questa incertezza può essere quantificata calcolando un cosiddetto<br />
intervallo di confidenza: minore è la sua ampiezza, maggiore è la precisione dei risultati. Con<br />
l'intervallo di confidenza si indica che il valore effettivo di una caratteristica nella popolazione<br />
intera rientra con grande probabilità (95 %) nell'intervallo. Grazie all'intervallo di confidenza<br />
si può inoltre stabilire se le differenze sono significative in termini statistici. Il campione delle<br />
economie domestiche contadine è piccolo; gli intervalli di incertezza e di confidenza, di conseguenza,<br />
sono ampi.<br />
Di seguito vengono illustrati i risultati principali relativi a soddisfazione, situazione finanziaria,<br />
contesto e ambiente abitativo nonché fiducia nello Stato/nella politica.<br />
Soddisfazione<br />
Nel valutare la soddisfazione in diversi ambiti, quali vita, rapporti personali o stato di salute,<br />
emerge un quadro eterogeneo. In entrambi i gruppi la soddisfazione per la propria situazione<br />
finanziaria raggiunge un valore pressoché analogo, per il reddito dall'attività a titolo<br />
principale, invece, vi sono differenze notevoli. Il 44 per cento degli interpellati di economie<br />
domestiche contadine dice di essere molto soddisfatto, nelle economie domestiche rurali la<br />
percentuale sale addirittura al 56 per cento. I membri di economie domestiche contadine che si<br />
dichiarano molto soddisfatti delle condizioni lavorative sono meno rispetto al gruppo di controllo,<br />
mentre per il clima lavorativo la situazione si ribalta. Anche i risultati relativi al tempo<br />
libero sono eterogenei. La soddisfazione per le attività nel tempo libero è la stessa sia per i<br />
membri delle famiglie contadine sia per il gruppo di controllo, ma i contadini si dicono un po’<br />
meno soddisfatti per quel che riguarda la disponibilità di tempo libero. Le altre differenze di<br />
minore portata non sono significative. Nel complesso (media dei 12 valori mediani) le persone<br />
interpellate appartenenti a economie domestiche contadine sono tanto soddisfatte quanto<br />
quelle del gruppo di controllo.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
21
Il mio Rapporto agricolo 3 / 7<br />
L’UOMO > FAMIGLIE CONTADINE<br />
22<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 17 / 29<br />
L’UOMO > FAMIGLIE CONTADINE<br />
Situazione finanziaria<br />
I contadini interpellati che hanno affermato di essere molto soddisfatti della situazione finanziaria<br />
sono meno rispetto al gruppo di controllo. In termini percentuali il numero di persone<br />
che affermano di avere difficoltà finanziarie è analogo nelle economie domestiche contadine e<br />
in quelle non contadine in regioni scarsamente popolate (ca. 10 %).<br />
La percentuale delle economie domestiche contadine che dichiarano di avere difficoltà nel sostenere<br />
spese inattese è minore rispetto alle economie domestiche del gruppo di controllo, ma<br />
un numero sensibilmente più alto di economie domestiche contadine (7 %) ha problemi a riscaldare<br />
sufficientemente l'abitazione. La quota di economie domestiche che non possono andare<br />
in ferie per ragioni economiche è simile in entrambi i gruppi (contadino e rurale) e si<br />
attesta attorno all'8 per cento.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
23
Il mio Rapporto agricolo 18 / 29<br />
L’UOMO > FAMIGLIE CONTADINE<br />
Contesto e ambiente abitativo<br />
La popolazione contadina vive significativamente più spesso (17 %) in abitazioni troppo buie<br />
rispetto al gruppo di controllo (7 %). Anche la percentuale di contadini che vivono in abitazioni<br />
troppo umide è alta ma la differenza rispetto al gruppo di controllo, in questo caso, non<br />
è significativa.<br />
24<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 19 / 29<br />
L’UOMO > FAMIGLIE CONTADINE<br />
Per quel che riguarda il contesto abitativo, dai risultati emerge che i membri di economie domestiche<br />
contadine sono meno infastiditi dai rumori rispetto al gruppo di controllo.<br />
Fiducia nello Stato/nella politica<br />
Le valutazioni relative alle domande sulla fiducia nel sistema legislativo sono andate tutte più<br />
o meno nella stessa direzione (punteggio di 6,6-7 su 10), ma le differenze tra le economie domestiche<br />
contadine e le altre economie domestiche rurali sono significative in termini statistici.<br />
I contadini ripongono una fiducia minore nel sistema legislativo svizzero. La fiducia nel<br />
sistema politico è la stessa per tutti e due i gruppi (ca. 6,5).<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
25
Il mio Rapporto agricolo 20 / 29<br />
L’UOMO > FAMIGLIE CONTADINE<br />
Esther Grossenbacher, UFAG, Settore Ricerca, consulenza e valutazione, esther.grossenbacher@blw.admin.ch<br />
26<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 21 / 29<br />
L’UOMO > FAMIGLIE CONTADINE<br />
Soddisfazione sul lavoro in Svizzera e nella Germania nord<br />
orientale<br />
Ogni anno vi sono aziende che abbandonano l’agricoltura. Mentre da un lato diminuiscono le<br />
piccole aziende, dall’altro aumentano quelle grandi. A partire da tale scenario, uno studio di<br />
Agroscope ha analizzato le differenze tra l’agricoltura svizzera, caratterizzata da piccole strutture,<br />
praticata quasi esclusivamente da aziende familiari, e l’agricoltura della Germania nord<br />
orientale, piuttosto industriale, nella quale sono le aziende non familiari, come ad esempio le<br />
cooperative, che dominano la produzione. L’azienda media nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore<br />
ha, ad esempio, una dimensione di 286 ettari mentre mediamente l’azienda svizzera<br />
gestisce 19 ettari. Nello studio, tra le altre cose, è stata confrontata la soddisfazione sul lavoro<br />
dei contadini.<br />
Per poter paragonare aspetti differenti tra i due diversi sistemi agricoli è stato creato un questionario<br />
che è stato inviato a 3000 contadini svizzeri e a 2000 contadini della Germania nord<br />
orientale tra dicembre 2013 e marzo 2014. Complessivamente 1687 partecipanti hanno rispedito<br />
il questionario e di questi 1 158 intervistati (833 svizzeri e 325 tedeschi dell’area nord orientale)<br />
hanno valutato la soddisfazione in merito alla loro attività agricola con una scala da 0<br />
(“assolutamente insoddisfatto”) a 10 (“assolutamente soddisfatto”). Inoltre sono stati rilevati<br />
dati sulla struttura aziendale e sulla situazione finanziaria.<br />
Gli autori hanno condotto due analisi statistiche per spiegare la soddisfazione sul lavoro dei<br />
contadini; una comprendeva la dimensione aziendale e l’altra la situazione finanziaria stimata<br />
soggettivamente. Sono stati analizzati altri fattori come ad esempio la presenza nell’azienda di<br />
attività affini all’agricoltura (p.es. vendita diretta, agriturismo o attività nel settore ricettivo),<br />
il grado di occupazione al di fuori dell’agricoltura, il metodo di produzione (biologico / non<br />
biologico), ma anche l’età o il livello di formazione degli intervistati.<br />
Risultati del sondaggio<br />
Senza considerare la dimensione dell’azienda e la situazione finanziaria, nel periodo oggetto<br />
dell’analisi in generale non c’è stata alcuna differenza nel grado medio di soddisfazione sul<br />
lavoro tra gli agricoltori svizzeri e quelli della Germania nord orientale. Tuttavia prendendo in<br />
considerazione la struttura e la situazione finanziaria delle aziende si evincono significative<br />
differenze tra le regioni. I contadini svizzeri in generale erano più soddisfatti del loro lavoro<br />
rispetto a quelli della Germania nord orientale.<br />
Di seguito maggiori dettagli. Mentre nella Germania nord orientale i capoazienda di grandi aziende<br />
erano più soddisfatti del loro lavoro rispetto a quelli delle piccole aziende, in Svizzera<br />
la dimensione non è rilevante. Anche la situazione finanziaria stimata soggettivamente ha influenzato<br />
in misura differente il grado di soddisfazione sul lavoro nelle regioni. Certamente<br />
per entrambe è risultato vero che il grado di soddisfazione sul lavoro è stato tanto maggiore<br />
quanto migliore era la situazione finanziaria dell’azienda ma per i contadini svizzeri questa<br />
correlazione era meno rilevante.<br />
Per i capoazienda di entrambe le regioni, inoltre, il grado di soddisfazione sul lavoro in ambito<br />
agricolo diminuiva quanto maggiore era il loro grado di occupazione al di fuori dell’agricoltura.<br />
Inoltre i contadini in generale erano più soddisfatti del proprio lavoro se il loro reddito era<br />
generato da attività extraagricole ma con riferimento all’azienda. Da un lato ciò determina sicuramente<br />
un’alternanza nella quotidianità lavorativa e dall’altro offre una maggiore garanzia<br />
dal profilo finanziario per l’azienda, il che, a sua volta, può influenzare in modo positivo la<br />
soddisfazione.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
27
Il mio Rapporto agricolo 22 / 29<br />
L’UOMO > FAMIGLIE CONTADINE<br />
Un’ulteriore analisi ha mostrato l’effetto positivo di una gamma variata di rami di produzione<br />
(come latte, ingrasso, campicoltura) sulla soddisfazione sul lavoro dei contadini svizzeri. I capoazienda<br />
che avevano più rami di produzione agricola hanno mostrato una maggiore soddisfazione<br />
nel loro lavoro rispetto a quelli attivi in aziende più specializzate. Nella Germania nord<br />
orientale la varietà dei rami aziendali non svolge alcun ruolo poiché gli aspetti finanziari sembrano<br />
essere fondamentali e questa strategia di specializzazione fa sperare in un maggior successo.<br />
Conclusioni<br />
Lo studio evidenzia che la struttura delle singole aziende, ma anche quella dell’intera agricoltura,<br />
influenza la soddisfazione sul lavoro dei contadini. Particolarmente interessante è<br />
l’effetto positivo delle varie modalità di diversificazione aziendale sulla soddisfazione dei contadini<br />
per quanto riguarda il loro lavoro. Ciò dimostra che una tale strategia della gestione<br />
aziendale, oltre agli effetti positivi nel garantire una determinata situazione dal profilo del<br />
reddito, è positiva anche per la percezione del lavoro nell’agricoltura. Ciò vale in particolare per<br />
i contadini svizzeri per i quali gli aspetti finanziari sembrano svolgere un ruolo secondario per<br />
la loro soddisfazione rispetto ai colleghi della Germania nord orientale. Nel complesso, nelle<br />
aziende svizzere tali fattori qualitativi hanno una maggiore influenza sulla soddisfazione sul<br />
lavoro rispetto agli aspetti economici.<br />
Which farm characteristics influence work satisfaction?<br />
Bibliografia<br />
T. Besser, S. Mann (2015): Which farm characteristics influence work satisfaction? An analysis of two agricultural<br />
systems, Agricultural Systems 141, 107-112.<br />
S. Mann, T. Besser (in esame): Diversification and work satisfaction - testing a claim by Marx and Engels for farmers.<br />
Rural Sociology.<br />
Tim Besser, Agroscope<br />
Contato: Esther Grossenbacher, UFAG, Settore Ricerca, consulenza e valutazione,<br />
esther.grossenbacher@blw.admin.ch<br />
28<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 23 / 29<br />
L’UOMO > SOCIETÀ<br />
«Notfallhilfe» - La piattaforma per le emergenze<br />
Per le famiglie contadine la forte interazione tra azienda e famiglia o tra vita professionale<br />
e privata può comportare situazioni in alcuni casi molto complesse. Raramente, infatti, i problemi<br />
in un ambito o nell'altro possono essere affrontati o risolti in maniera isolata.<br />
Per affrontare queste particolari sfide esistono, nella maggior parte dei casi già da diversi anni,<br />
offerte particolari per le famiglie contadine con difficoltà sociali e/o finanziarie. Dalla primavera<br />
2015, rappresentanti di sportelli di questo tipo della Svizzera tedesca si incontrano, sotto<br />
la direzione di AGRIDEA, nel quadro della piattaforma «Notfallhilfe», con la quale è stato compiuto<br />
un primo passo verso lo scambio di informazioni e di esperienze. L'obiettivo è imparare<br />
gli uni dagli altri e sviluppare ulteriormente le offerte dal profilo sia contenutistico sia istituzionale.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
29
Il mio Rapporto agricolo 3 / 4<br />
L’UOMO > SOCIETÀ<br />
Sportelli per famiglie contadine in situazioni difficili<br />
Nome<br />
Contatto<br />
CH Bäuerliches Sorgentelefon 041 820 02 15 (lun 8.15-12 e gio<br />
18-22),<br />
info@baeuerlichessorgentelefon.ch<br />
AG<br />
AR<br />
BE<br />
BE<br />
FR<br />
Unterstützung im Rahmen der betriebswirtschaftlichen<br />
Beratung<br />
Weitblick – Bauernfamilien orientieren<br />
sich im Zeitwandel<br />
Inforama Aufwind: für Bauernfamilien<br />
in Bedrängnis<br />
Anlaufstelle Überlastung Landwirtschaft<br />
Unterstützung für Landwirtschaftsbetriebe<br />
in Schwierigkeiten<br />
Landwirtschaftliches Zentrum Liebegg<br />
5772 Gränichen<br />
062 855 86 24,<br />
christoph.beyeler@ag.ch<br />
Betriebs- und bäuerlich hauswirtschaftliche<br />
Beratung<br />
9102 Herisau<br />
071 353 67 56,<br />
irene.muehlebach@ar.ch;<br />
071 353 67 51,<br />
jeannette.stadelmann@ar.ch<br />
Rütti, Zollikofen, 031 910 51 11<br />
inforama.ruetti@vol.be.ch;<br />
Berner Oberland, Hondrich,<br />
033 650 84 00<br />
inforama.oberland@vol.be.ch;<br />
Emmental Bäregg, Bärau,<br />
034 409 37 11<br />
inforama.emmental@vol.be.ch;<br />
Seeland, Ins, 032 312 91 11<br />
inforama.seeland@vol.be.ch;<br />
Waldhof, Langenthal, 062 916 01 01<br />
inforama.waldhof@vol.be.ch<br />
Oekonomische und Gemeinnützige<br />
Gesellschaft (OGG) des Kantons Bern<br />
Erlachstrasse 5, 3001 Berna<br />
079 200 00 44,<br />
hildegard.wyss@ogg.ch,<br />
Landwirtschaftliches Institut des<br />
Kantons Freiburg<br />
Route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux<br />
026 305 58 00<br />
LU Offeni Türe i de Not Luzerner Bäuerinnen- und Bauern<br />
Schellenrain 5, 6210 Sursee<br />
041 939 20 39,<br />
offeni.tuer@bluewin.ch<br />
SG<br />
TG<br />
UR<br />
ZH<br />
Offni Tür – Unterstützung von Bäuerinnen<br />
und Bauern in schwierigen Situationen<br />
e<br />
Ostschweizer Gruppe für getrenntlebende<br />
oder geschiedene Bäuerinnen<br />
Wegweiser für Thurgauer Bauernfamilien<br />
Zentralschweizer Erfahrungsgruppe<br />
für Bäuerinnen nach Trennung oder<br />
Scheidung<br />
Offeni Tür – für Bäuerinnen und<br />
Bauern zur Beratung in sozialen und<br />
finanziellen Notlagen<br />
Landwirtschaftliches Zentrum SG,<br />
9456 Salez<br />
058 228 24 07 und 058 228 08<br />
(lun 16-18 e gio 10-12),<br />
silvia.hohl@lzsg.ch<br />
Verband Thurgauer Landwirtschaft<br />
Bildungs- und Beratungszentrum<br />
Arenenberg<br />
8268 Salenstein<br />
071 663 33 70,<br />
christian.eggenberger@tg.ch<br />
Agnes Schneider-Wermelinger<br />
Lochland, 6017 Ruswil<br />
041 495 13 63,<br />
agnes.schneider@pop.agri.ch<br />
044 869 21 68 (lun-ven 13-14, gio<br />
19-20)<br />
30<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 4 / 4<br />
L’UOMO > SOCIETÀ<br />
Fonte: Bäuerliches Sorgentelefon<br />
Anche nella Svizzera romanda esistono sportelli speciali per le famiglie contadine in difficoltà,<br />
in genere d'iniziativa privata come «Solidarité Paysans Romandie» e il nuovo «Aumônier dans<br />
le monde agricole» (Pierre-André Schütz). Dal 1997 al 2012, nel Cantone Vaud era attiva «Cellule<br />
de crises», un'offerta specifica di Prométerre per famiglie contadine con difficoltà finanziarie,<br />
che oggi rientra nell'ordinaria attività di consulenza dell'associazione.<br />
Il sostegno alle famiglie in situazioni difficili deve essere ulteriormente migliorato. Alcuni studi<br />
scientifici hanno individuato delle possibilità in questo senso: oltre a potenziare la collaborazione<br />
e l'utilizzo di sinergie delle offerte esistenti è necessario creare, dapprima nel quadro di<br />
un progetto pilota, un servizio di coordinamento tra la consulenza agricola e quella sociale in<br />
un Cantone o in una regione. Inoltre, bisogna puntare a moduli di perfezionamento professionale<br />
specifici per la consulenza riguardo a sfide sociali come sovraccarico/burn out. Per il riconoscimento<br />
precoce di famiglie contadine in situazioni difficili è altresì importante analizzare<br />
più a fondo il ruolo di prestatori di servizi che entrano regolarmente in contatto con loro, come<br />
i fiduciari o i controllori del latte, nell'obiettivo di coinvolgerli maggiormente.<br />
Bäuerliches Sorgentelefon<br />
Rapporto agricolo 2004, pag. 68<br />
Esther Grossenbacher, UFAG, Settore Ricerca, consulenza e valutazione, esther.grossenbacher@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
31
Il mio Rapporto agricolo 26 / 29<br />
L’UOMO > SOCIETÀ<br />
Protezione delle terre coltive<br />
Sviluppi generali della sicurezza delle terre coltive<br />
Una sfida centrale della politica agricola svizzera consiste nella preservazione della qualità e<br />
della quantità dei suoli agricoli. Recentemente in Svizzera nella politica e tra la popolazione si<br />
riscontra una maggiore sensibilità nei confronti della tematica del suolo e del massiccio sfruttamento<br />
delle terre coltive. In vari Cantoni e a livello nazionale iniziative sulla protezione delle<br />
terre coltive sono in corso o sono state già discusse nei Parlamenti.<br />
Benché nel 1992, vista la perdita costante e rapida di terre coltive, il Consiglio federale abbia<br />
decretato, mediante un piano settoriale, una superficie minima per le superfici di avvicendamento<br />
delle colture (SAC) e i Cantoni siano tenuti a garantire una quota di questa superficie<br />
minima, perdura la pressione sulle restanti terre coltive, tanto che ogni anno ne vanno persi<br />
circa 3400 ettari. Pertanto si pone la questione se le attuali condizioni poste dal diritto federale<br />
in materia di protezione delle terre coltive siano opportune e in quale misura potrebbero essere<br />
migliorate onde arrestare la perdita di terre coltive.<br />
In tale contesto le Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG) hanno conferito<br />
al Controllo parlamentare dell'amministrazione l'incarico di effettuare una valutazione delle<br />
misure volte a garantire le terre coltive con particolare attenzione alla protezione delle SAC. La<br />
valutazione ha interessato soltanto il ruolo della Confederazione relativamente alla protezione<br />
delle terre coltive poiché il loro utilizzo nei Cantoni non rientra nell'ambito di vigilanza delle<br />
CdG. Dal rapporto valutativo sono emerse diverse raccomandazioni per migliorare la protezione<br />
delle terre coltive.<br />
Maggiore protezione delle superfici per l’avvicendamento delle colture<br />
Per i terreni agricoli prioritari in Svizzera vigono particolari disposizioni di protezione. Il piano<br />
settoriale delle SAC mira a preservare almeno 438 460 ettari dei migliori suoli e ogni Cantone<br />
deve garantire un contingente. La forte estensione degli insediamenti urbani ha determinato<br />
una maggiore pressione per le SAC.<br />
Al momento è in corso la prima fase di revisione della legge sulla pianificazione del territorio<br />
(LPT), nel quadro della quale sono state stabilite diverse misure volte ad arginare la crescita<br />
degli insediamenti e quindi indirettamente a consentire una maggiore protezione delle terre<br />
coltive. È stata potenziata in particolare la protezione delle SAC; in futuro potranno essere<br />
azzonate SAC soltanto se:<br />
• senza sfruttare tali zone, non è ragionevolmente possibile raggiungere un obiettivo importante<br />
anche dal punto di vista del Cantone; e<br />
• viene garantito che le superfici sfruttate sono impiegate in modo ottimale secondo lo stato<br />
attuale delle conoscenze.<br />
Il Tribunale federale conferisce particolare importanza a una reale ponderazione degli interessi,<br />
come prescrive da tempo l’articolo 3 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio<br />
(OPT).<br />
Nell’ambito della seconda fase di revisione della LPT vi sarebbero anche un potenziamento della<br />
protezione delle terre coltive e l’attuazione del Piano settoriale SAC. Mediante questa revisione<br />
dovrebbero essere elaborate le modalità per la compensazione delle SAC. In base ai pareri inoltrati<br />
il 4 dicembre 2015, il Consiglio federale ha deciso di limitare la seconda fase di revisione<br />
a pochi temi fondamentali per la pianificazione territoriale. Sulla scorta di tale decisione, i<br />
temi della protezione delle terre coltive e SAC sono stati eliminati dal progetto di revisione.<br />
L'attenzione va posta sull'elaborazione e il potenziamento del piano direttore delle SAC e sulle<br />
32<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 27 / 29<br />
L’UOMO > SOCIETÀ<br />
condizioni quadro necessarie a tal fine. I lavori sono condotti sotto la co-direzione degli Uffici<br />
federali dello sviluppo territoriale e dell'agricoltura. Approssimativamente sono previste tre<br />
fasi di lavoro che richiederanno diversi anni.<br />
• Nella prima fase dell'elaborazione è stato istituito un gruppo di esperti le cui conoscenze<br />
tecniche sono ampiamente riconosciute, consentendo una visione completa dello stato<br />
delle cose.<br />
• Nella seconda fase saranno elaborati elementi concreti di un piano settoriale delle SAC al<br />
passo con i tempi.<br />
• Durante la terza fase (2017/18), sarà avviata una consultazione tra i Cantoni e le cerchie<br />
interessate giusta l'articolo 19 OPT.<br />
Il varo da parte del Consiglio federale è previsto per il 2018. Ad oggi non è possibile affermare<br />
se in questa fase siano necessarie modifiche a livello di legge o di ordinanza (in particolare LPT<br />
e OPT) e come sarà l'attuazione della versione rivista del piano settoriale nei Cantoni. Le CdG<br />
inoltre hanno espresso ulteriori raccomandazioni per il Consiglio federale.<br />
Maggior ancoraggio normativo della protezione delle terre coltive<br />
Il Consiglio federale dovrebbe esaminare un maggior ancoraggio delle prescrizioni del diritto<br />
federale in materia di protezione delle terre coltive e indicare quali vantaggi e svantaggi comporterebbe<br />
l'introduzione di un obbligo di compensazione sancito dal diritto federale in caso<br />
di utilizzo di SAC nonché come valutare l’inserimento di tale obbligo a livello federale.<br />
Vigilanza della Confederazione sull’esecuzione nei Cantoni<br />
Il Consiglio federale deve tutelare in maniera attiva e completa la sua funzione di vigilanza nel<br />
settore della protezione delle terre coltive e di conseguenza sfruttare il margine di manovra<br />
esistente.<br />
Considerazione della protezione delle terre coltive nei progetti della<br />
Confederazione<br />
Nei progetti della Confederazione il Consiglio federale deve proporre misure determinanti una<br />
maggiore protezione delle terre coltive. Verifica in particolare se le modifiche nella procedura<br />
di pianificazione sono adeguate a coinvolgere tempestivamente i servizi specializzati<br />
competenti. Inoltre provvede affinché sia adeguatamente considerata la protezione delle SAC<br />
nell'approntamento dei piani settoriali della Confederazione, segnatamente nel piano settoriale<br />
dei trasporti.<br />
Anton Stübi, UFAG, Settore Migliorie fondiarie, anton.stuebi@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
33
Il mio Rapporto agricolo 28 / 29<br />
L’UOMO > SOCIETÀ<br />
Studio sulla vitalità e l'attrattiva delle aree rurali<br />
Le aree rurali e le regioni di montagna in Svizzera forniscono prestazioni importanti per l'intero<br />
Paese. Non sono soltanto lo spazio in cui vive e risiede la popolazione, bensì svolgono funzioni<br />
rilevanti come spazio economico, ricreativo e d'identificazione nonché ad elevato valore naturalistico<br />
e paesaggistico.<br />
Nel 2015 il Consiglio federale ha varato, per la prima volta, una politica per le aree rurali e<br />
le regioni montane che coinvolge più Uffici federali, sottolineando la valenza di queste aree<br />
nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. Lo sviluppo decentrato del territorio può essere garantito<br />
a lungo termine soltanto se le aree rurali possiedono vitalità e attrattiva come spazio<br />
abitativo, di lavoro e naturale. La preservazione dell'occupazione decentrata è un'importante<br />
prestazione dell'agricoltura nell'interesse della collettività, alla stessa stregua della preservazione<br />
dell'apertura del paesaggio o della conservazione delle basi vitali naturali. Queste prestazioni<br />
hanno un'elevata valenza anche per altri rami economici, come il turismo ad esempio.<br />
La promozione di aree rurali vitali e attrattive è quindi anche un interesse fondamentale della<br />
politica agricola e costituisce uno dei quattro obiettivi strategici del Consiglio federale per la<br />
PA 14-17.<br />
Per quanto riguarda le misure di politica agricola volte a promuovere la vitalità e l'attrattiva<br />
delle aree rurali la questione è definire quando le aree rurali sono attrattive, quali proprietà<br />
hanno le aree rurali vitali e come può la politica agricola potenziare in maniera mirata<br />
l'attrattiva e la vitalità delle aree rurali svizzere. Per trovare una risposta a queste domande<br />
l'UFAG ha commissionato uno studio sul «Contributo dell'agricoltura all'attrattiva e alla vitalità<br />
delle aree rurali», allo scopo di definire le proprietà delle aree rurali attrattive e vitali e<br />
sviluppare indicatori per misurarle. L'obiettivo era, inoltre, analizzare le correlazioni tra agricoltura<br />
e politica agricola da un lato e attrattiva e vitalità delle aree rurali dall'altro.<br />
Indicatori per misurare la vitalità e l'attrattiva delle aree rurali<br />
Nello studio sono stati sviluppati attributi e parametri (indicatori) per descrivere e misurare la<br />
vitalità e l'attrattiva delle aree rurali a livello comunale. Sono stati così visionati i dati disponibili<br />
nei Comuni per appurare se si addicevano alla misurazione della vitalità e dell'attrattiva<br />
delle aree rurali.<br />
» A1<br />
» A2<br />
Per stabilire la vitalità dei Comuni sono stati utilizzati 13 indicatori che descrivono la vitalità di<br />
un'area nelle tre dimensioni della sostenibilità: società (popolazione vitale, società civile viva<br />
e coesistenza intatta, salute e situazione sociale della popolazione), economia (competitività)<br />
ed ecologia (ecosistema intatto e resiliente).<br />
L'attrattiva dei Comuni delle aree rurali svizzere è stata definita sulla base di 10 indicatori scelti<br />
secondo tre ottiche distinte in cui il Comune è considerato come luogo di residenza (servizio<br />
pubblico e assetto di base, possibilità di lavoro e formazione, varietà naturale e del paesaggio<br />
rurale, situazione del reddito e carico fiscale), come piazza economica (disponibilità di manodopera<br />
qualificata, infrastrutture economiche e relative alle risorse) e come spazio ricreativo<br />
per il tempo libero (raggiungibilità dal profilo tecnico dei trasporti, infrastruttura e offerta turistiche).<br />
Grazie a questi indicatori la vitalità e l'attrattiva delle aree rurali è stata misurata per la prima<br />
volta a livello comunale su tutto il territorio nazionale. I risultati dello studio indicano che<br />
i Comuni a elevata vitalità ecologica e quelli a elevata attrattiva economica non coincidono.<br />
La vitalità e l'attrattiva sono strettamente correlate ad attributi geografici quali topografia e<br />
raggiungibilità. I Comuni economicamente attrattivi sono spesso ubicati nelle aree periurbane<br />
mentre quelli valutati vitali dal profilo ecologico si collocano piuttosto nelle aree rurali periferiche.<br />
Queste ultime sono maggiormente forgiate dall’agricoltura rispetto a quelle periurbane.<br />
34<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 29 / 29<br />
L’UOMO > SOCIETÀ<br />
Ruolo della politica agricola nelle aree rurali<br />
Il contributo dell'agricoltura e della politica agricola alla vitalità e all'attrattiva delle aree<br />
rurali è complesso. Quello della politica agricola non ha potuto essere valutato in maniera definitiva<br />
nel quadro dello studio a causa della mancanza di dati, soprattutto sui «soft factors»<br />
come bellezza del luogo o impegno nella vita pubblica, e delle notevoli differenze strutturali<br />
tra i Comuni delle aree rurali svizzere.<br />
Tuttavia, i dati analizzati indicano una stretta correlazione tra agricoltura e vitalità dal profilo<br />
ecologico dei Comuni. Gli impulsi di sviluppo a livello economico che scaturiscono dal primario,<br />
invece, sono relativamente deboli nell'insieme delle aree rurali. Ciononostante le aree rurali<br />
periferiche continuano a essere fortemente forgiate dall'agricoltura e dall'attuazione delle misure<br />
della politica agricola.<br />
Sintesi<br />
I risultati dello studio suggeriscono che la promozione della vitalità e dell'attrattiva delle aree<br />
rurali va considerata sempre più come un compito condiviso, cui la politica agricola può contribuire<br />
in modo sostanziale grazie ai suoi strumenti. Nell'ottica della politica per le aree rurali<br />
e le regioni di montagna, in futuro, gli strumenti della politica agricola finalizzati allo sviluppo<br />
delle aree rurali dovranno essere impiegati laddove possano avere il massimo impatto in vista<br />
di uno sviluppo sostenibile.<br />
Bibliografia<br />
Consiglio federale svizzero (2015): Politica della Confederazione per le aree rurali e le regioni montane; Rapporto in<br />
adempimento della mozione 11.3927 Maissen del 29 settembre 2011. Per uno sviluppo territoriale coerente in Svizzera.<br />
Rapporto del 18 febbraio 2015. Berna<br />
Ecoplan e Scuola superiore di scienze agrarie, forestali e alimentari SSAFA (2016): Beitrag der Landwirtschaft<br />
und der Agrarpolitik zur Vitalität und Attraktivität des ländlichen Raums. Studio su mandato dell’Ufficio federale<br />
dell’agricoltura (UFAG). Berna<br />
Susanne Menzel, UFAG, Settore Economia agricola, spazio rurale e strutture, susanne.menzel@blw.admin.ch<br />
Daniel Baumgartner, UFAG, Settore Economia agricola, spazio rurale e strutture,<br />
daniel.baumgartner@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
35
Il mio Rapporto agricolo 2 / 31<br />
AZIENDA > INTRODUZIONE<br />
Introduzione<br />
Nella rubrica Azienda vengono trattati gli sviluppi strutturali e la situazione economica<br />
dell'agricoltura. Il rapporto si focalizza in particolare sul numero di aziende e le rispettive dimensioni,<br />
nonché su numero di lavoratori, superficie agricola utile ed effettivo di animali. Presenta<br />
inoltre la situazione economica dell'intero settore e delle aziende individuali.<br />
36<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 3 / 31<br />
AZIENDA > STRUTTURE<br />
Aziende<br />
» A3<br />
In Svizzera, nel 2015 si sono registrate 53 232 aziende agricole, con un calo dell’1,5 per cento<br />
rispetto all’anno precedente.<br />
» Rilevazione sulle strutture agricole 2015<br />
Evoluzione del numero di aziende per classe di dimensioni<br />
Classe di dimensioni<br />
Numero di aziende<br />
Numero di aziende<br />
Numero di aziende<br />
Variazione per<br />
anno in %<br />
Variazione per<br />
anno in %<br />
2000 2014 2015 2000-2015 2014-2015<br />
0–3 ha 8 371 5 615 5 582 -2,7 -0,6<br />
3-10 ha 18 542 10 481 10148 -3,7 -3,2<br />
10-20 ha 24 984 16 731 16209 -2,8 -3,1<br />
20-30 ha 11 674 11 121 11007 -0,4 -1,0<br />
30-50 ha 5 759 7 651 7 734 2,0 1,1<br />
> 50 ha 1 207 2 447 2 552 5,1 4,3<br />
Totale 70 537 54 046 53 232 -1,9 -1,5<br />
Fonte: UST<br />
Dal 2000 al 2015 il numero di aziende agricole è diminuito complessivamente di 17 305 unità,<br />
ossia dell'1,9 per cento all'anno. In tale periodo il calo assoluto maggiore si è registrato per le<br />
aziende della classe di dimensioni 3-10 ettari. Il numero di aziende è, invece, aumentato per<br />
le classi di dimensioni oltre i 30 ettari.<br />
Evoluzione del numero di aziende con capoazienda donna per classe di dimensioni<br />
Classe di dimensioni<br />
Numero di aziende<br />
con capoazienda<br />
donna<br />
Numero di aziende<br />
con capoazienda<br />
donna<br />
Numero di aziende<br />
con capoazienda<br />
donna<br />
Variazione per<br />
anno in %<br />
Variazione per<br />
anno in %<br />
2000 2014 2015 2000-2015 2014-2015<br />
0–3 ha 654 555 562 -1,0 1,3<br />
3-10 ha 1 116 1 007 1 008 -0,7 0,1<br />
10-20 ha 418 756 762 4,1 0,8<br />
20-30 ha 95 298 320 8,4 7,4<br />
30-50 ha 52 154 169 8,2 9,7<br />
> 50 ha 11 31 28 6,4 -9,7<br />
Totale 2 346 2 801 2 849 1,3 1,7<br />
Fonte: UST<br />
Nell'anno oggetto del rapporto, 2 849 aziende, ovvero il 5,4 per cento di tutte le aziende, erano<br />
gestite da donne. Tra il 2000 e il 2015 il numero delle aziende agricole gestite da un capoazienda<br />
di sesso femminile è aumentato di 503 unità all’anno, ossia dell’1,3 per cento.<br />
Rispetto alla totalità delle aziende, quelle gestite da donne sono la maggioranza nelle classi di<br />
dimensioni fino a 10 ettari, mentre la situazione si inverte nelle classi di dimensioni oltre 10<br />
ettari. Ciò significa che le aziende gestite da donne sono mediamente più piccole rispetto alla<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
37
Il mio Rapporto agricolo 4 / 31<br />
AZIENDA > STRUTTURE<br />
totalità delle aziende. Anche tra le aziende con un capoazienda donna si osserva, tuttavia, una<br />
tendenza verso classi di dimensioni più grandi.<br />
Evoluzione del numero di aziende per regione<br />
Regione<br />
Regione di pianura<br />
Numero di aziende<br />
Numero di aziende<br />
Numero di aziende<br />
Variazione per<br />
anno in %<br />
Variazione per<br />
anno in %<br />
2000 2014 2015 2000-2015 2014-2015<br />
31 612 24 016 23 644 -1,9 -1,5<br />
Regione collinare 18 957 14 994 14 770 -1,7 -1,5<br />
Regione di montagna<br />
19 968 15 036 14 818 -2,0 -1,4<br />
Totale 70 537 54 046 53 232 -1,9 -1,5<br />
Fonte: UST<br />
Tra il 2000 e il 2015, per quanto riguarda le singole regioni, il tasso di flessione annuo con<br />
il valore massimo si è registrato nella regione di montagna (-2 %). Nell’anno oggetto del rapporto<br />
in tutte e tre le regioni tale tasso è rimasto pressoché invariato.<br />
Evoluzione del numero di aziende con capoazienda donna per regione<br />
Regione<br />
Regione di pianura<br />
Numero di aziende<br />
Numero di aziende<br />
Numero di aziende<br />
Variazione per<br />
anno in %<br />
Variazione per<br />
anno in %<br />
2000 2014 2015 2000-2015 2014-2015<br />
924 1 125 1 146 1,4 1,9<br />
Regione collinare 580 729 724 1,5 -0,7<br />
Regione di montagna<br />
842 947 979 1,0 3,4<br />
Totale 2 346 2 801 2 849 1,3 1,7<br />
Fonte: UST<br />
Nel 2015 la ripartizione delle aziende gestite da donne per regione corrispondeva ampiamente<br />
a quella di tutte le aziende. Nella regione di pianura la quota, pari al 41 per cento, è leggermente<br />
inferiore a quella relativa al totale delle aziende (44 %); lo stesso vale per la regione<br />
collinare (25 % contro 28 %); in quella di montagna, invece, la quota è leggermente superiore<br />
in quanto ammonta al 34 per cento contro il 28 per cento.<br />
38<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 5 / 31<br />
AZIENDA > STRUTTURE<br />
Evoluzione del numero di aziende gestite a titolo principale o a titolo accessorio per regione<br />
Caratteristiche<br />
Numero di aziende<br />
Numero di aziende<br />
Numero di aziende<br />
Variazione<br />
annua in %<br />
Variazione<br />
annua in %<br />
2000 2014 2015 2000-2015 2014-2015<br />
Aziende a titolo<br />
principale<br />
Regione di pianura<br />
23 536 17 996 17 689 -1,9 -1,7<br />
Regione collinare 13 793 10 719 10 464 -1,8 -2,4<br />
Regione di<br />
montagna<br />
11 910 10 122 9 879 -1,2 -2,4<br />
Totale 49 239 38 837 38 032 -1,7 -2,1<br />
Aziende a titolo<br />
accessorio<br />
Regione di pianura<br />
8 076 6 020 5 955 -2,0 -1,1<br />
Regione collinare 5 164 4 275 4 306 -1,2 0,7<br />
Regione di<br />
montagna<br />
8 058 4 914 4 939 -3,2 0,5<br />
Totale 21 298 15 209 15 200 -2,2 -0,1<br />
Fonte: UST<br />
Tra il 2000 e il 2015, il tasso di flessione delle aziende a titolo principale, pari all’1,7 per cento<br />
l’anno, è risultato lievemente inferiore a quello delle aziende a titolo accessorio pari al 2,2<br />
per cento l’anno. Si riscontrano notevoli differenze tra le regioni. Per le aziende a titolo principale,<br />
nella regione di pianura e in quella collinare si è registrata una flessione rispettivamente<br />
dell’1,9 e dell’1,8 per cento, mentre il tasso rilevato nella regione di montagna è dell'1,2 per<br />
cento. La situazione è diversa per le aziende a titolo accessorio. La flessione più elevata ha interessato<br />
la regione di montagna, con il 3,2 per cento, seguita da quella di pianura e da quella<br />
collinare, rispettivamente con il 2,0 e l'1,2 per cento. Nell’anno oggetto del rapporto i tassi di<br />
flessione per le aziende a titolo principale complessivamente risultano decisamente superiori<br />
rispetto agli anni scorsi a causa di un forte calo nella regione collinare e in quella di montagna.<br />
Per le aziende a titolo accessorio, invece, il numero resta praticamente invariato; si è registrato<br />
persino un aumento per le aziende nella regione collinare e in quella di montagna.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
39
Il mio Rapporto agricolo 6 / 31<br />
AZIENDA > STRUTTURE<br />
Evoluzione del numero di aziende gestite da una donna a titolo principale o a titolo accessorio<br />
per regione<br />
Caratteristiche<br />
Numero di aziende<br />
Numero di aziende<br />
Numero di aziende<br />
Variazione<br />
annua in %<br />
Variazione<br />
annua in %<br />
2000 2014 2015 2000-2015 2014-2015<br />
Aziende a titolo<br />
principale<br />
Regione di pianura<br />
331 624 613 4,2 -1,8<br />
Regione collinare 175 352 338 4,5 -4,0<br />
Regione di<br />
montagna<br />
211 426 432 4,9 1,4<br />
Totale 717 1 402 1 383 4,5 1,4<br />
Aziende a titolo<br />
accessorio<br />
Regione di pianura<br />
593 501 533 -0,7 6,4<br />
Regione collinare 405 377 386 -0,3 2,4<br />
Regione di<br />
montagna<br />
631 521 547 -0,9 5,0<br />
Totale 1 629 1 399 1 466 -0,7 4,8<br />
Fonte: UST<br />
La ripartizione delle aziende a titolo principale / accessorio gestite da donne non rispecchia<br />
la situazione che si osserva per la totalità delle aziende. Prendendo in esame queste ultime, si<br />
nota che per oltre il 70 per cento sono gestite a titolo principale, mentre tra le aziende gestite<br />
da donne, lo sono solo per la metà. Tra il 2000 e il 2015, questa relazione ha tuttavia subito<br />
variazioni a favore delle aziende a titolo principale.<br />
Martina De Paola, UFAG, Settore Ricerca, consulenza e valutazione, martina.depaola@blw.admin.ch<br />
40<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 8 / 31<br />
AZIENDA > STRUTTURE<br />
Aziende d’estivazione<br />
L'esteso paesaggio alpestre svizzero è stato forgiato dagli animali al pascolo. Soltanto mediante<br />
l'utilizzazione e la cura il paesaggio rurale può essere preservato. L'utilizzazione sotto<br />
forma di pascolo è inoltre necessaria affinché la regione d'estivazione continui a svolgere il suo<br />
importante ruolo per la sicurezza alimentare, per l'ecologia e per la società. Con l'abbandono<br />
dell'utilizzazione, i pascoli alpestri si trasformano in bosco.<br />
Caratterizzazione delle aziende d’estivazione<br />
Le aziende d’estivazione sono gestite durante la stagione alpestre e sono destinate all'alpeggio<br />
di ruminanti. La loro gestione stagionale è la differenza principale rispetto alle aziende annuali.<br />
Un’altra caratteristica delle aziende d’estivazione è la loro specializzazione nei pascoli,<br />
costituiti soltanto da terreni inerbiti che vanno utilizzati in maniera adeguata al luogo<br />
e con intensità variabili. La regione d’estivazione comprende la superficie tradizionalmente<br />
utilizzata per l’economia alpestre. Normalmente i pascoli alpestri si trovano ad altitudini elevate,<br />
ma possono anche trovarsi a quote comparativamente basse, in quanto è determinante<br />
l'utilizzazione tradizionale. La regione d'estivazione è delimitata verso il basso (rispetto alla<br />
superficie agricola utile), ma non verso l'alto rispetto alle superfici improduttive (pietre,<br />
ghiacci, rocce, ecc.).<br />
Preservazione dell'apertura del paesaggio<br />
Preservare l'apertura del paesaggio dei pascoli alpestri è uno degli obiettivi principali della<br />
Politica agricola 2014-2017. Ciò è possibile soltanto alpeggiando animali che consumano foraggio<br />
grezzo. Per garantire la gestione e la cura di queste preziose superfici, nel 2014 è stato<br />
incrementato il contributo d'estivazione. Contemporaneamente è stato introdotto un contributo<br />
di alpeggio come incentivo per le aziende principali a estivare il loro bestiame. La combinazione<br />
di queste due misure garantisce un effettivo di bestiame sufficiente affinché cespugli<br />
e alberi non compromettano a lungo termine i pascoli alpestri.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
41
Il mio Rapporto agricolo 9 / 31<br />
AZIENDA > STRUTTURE<br />
Utilizzazione sostenibile nella regione d'estivazione<br />
I pascoli alpestri devono essere gestiti in modo sostenibile; tale principio è concretizzato come<br />
segue.<br />
• Le aziende d'estivazione devono essere gestite in modo razionale e rispettoso<br />
dell’ambiente, evitando un'utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva. Le superfici<br />
che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni.<br />
• La concimazione dei pascoli avviene in linea di principio con i prodotti sull’alpe (letame,<br />
liquame). L'impiego di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti sull’alpe è<br />
vietato. Per l’apporto di altri concimi (p.es. fosforo o calce) è necessaria un’autorizzazione.<br />
• Gli animali sono foraggiati con erba dell'alpe. Per il superamento di situazioni eccezionali<br />
e per il bestiame da latte è possibile un limitato apporto di foraggio.<br />
• I pascoli devono essere protetti dall’incespugliamento e dall’abbandono. Occorre lottare<br />
contro le piante problematiche. Sulla pagina Internet di Agridea è disponibile una Guida<br />
per la valutazione delle superfici.<br />
Evoluzione delle aziende d'estivazione<br />
La dimensione di un'azienda d'estivazione è misurata in carichi normali. Per carico normale<br />
si intende l’estivazione di un’unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo durante<br />
100 giorni e corrisponde alla quantità di erba necessaria a foraggiare una vacca per 100 giorni.<br />
Il rapporto tra la crescita dell'erba e il fabbisogno di foraggio degli animali su un alpe deve<br />
essere il più possibile equilibrato; a tal fine è stato stabilito per ogni azienda d'estivazione un<br />
carico usuale.<br />
Tra il 2003 e il 2013 il numero di aziende d'estivazione si è ridotto da 7472 a 7058; nello stesso<br />
periodo il carico usuale complessivo è rimasto stabile. Le aziende d'estivazione sono diventate<br />
tendenzialmente più grandi poiché le aziende esistenti si sono fuse o sono state rilevate da<br />
aziende confinanti.<br />
42<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 10 / 31<br />
AZIENDA > STRUTTURE<br />
Rapporti di gestione<br />
I gestori delle aziende d'estivazione sono per lo più persone fisiche e società semplici (società<br />
di fratelli o formate da diverse generazioni, ecc.); queste forme giuridiche sono usuali anche<br />
per le aziende annuali. Tuttavia nell'estivazione vi sono anche altre forme giuridiche, come le<br />
cooperative o le corporazioni di diritto pubblico, che affondano le loro radici da un lato nella<br />
tradizione, dall'altro anche nella redditività poiché la gestione collettiva presenta, soprattutto<br />
nell'utilizzazione estensiva, chiari vantaggi economici.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
43
Il mio Rapporto agricolo 11 / 31<br />
AZIENDA > STRUTTURE<br />
Sviluppo dell'effettivo di animali nella regione d'estivazione<br />
Complessivamente negli ultimi anni l'effettivo di animali sugli alpi svizzeri è leggermente diminuito,<br />
con fluttuazioni annue in base alle condizioni atmosferiche. Le vacche da latte e i<br />
bovini (categoria «altri bovini») con gli anni diminuiscono tendenzialmente, le vacche madri,<br />
invece, aumentano costantemente.<br />
Evoluzione dell'estivazione degli ovini<br />
Dal 2003 vengono stanziati contributi d’estivazione per ovini (pecore lattifere escluse) in<br />
maniera differenziata a seconda del sistema di pascolo. Con contributi più elevati per pas-<br />
44<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 12 / 31<br />
AZIENDA > STRUTTURE<br />
coli da rotazione e sorveglianza permanente da un lato si considerano i costi maggiori e,<br />
dall’altro si incentiva un’estivazione sostenibile del bestiame ovino. Per sorveglianza permanente<br />
s’intende la conduzione del gregge effettuata giornalmente da un pastore con cani, in<br />
luoghi di pascolo stabiliti dal pastore stesso. Per pascolo da rotazione s’intende un pascolo effettuato<br />
alternativamente per tutta la durata dell’estivazione, in parchi cintati o chiaramente<br />
delimitati da elementi naturali.<br />
Con la presenza di grandi predatori aumenta l'incentivo a un’estivazione sostenibile. Negli ultimi<br />
anni questo ha influenzato notevolmente l'estivazione degli ovini. Il numero di ovini sugli<br />
altri pascoli negli ultimi anni è diminuito nettamente; nello stesso periodo il numero di quelli<br />
sotto sorveglianza permanente è aumentato. Tale tendenza è perdurata anche nel 2015.<br />
E in futuro?<br />
In futuro la preservazione dell'apertura dei pascoli alpestri resta una sfida, in particolare sulle<br />
superfici con difficili rapporti di gestione.<br />
Denis Morand, UFAG, Settore Pagamenti diretti Basi, denis.morand@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
45
Il mio Rapporto agricolo 13 / 31<br />
AZIENDA > STRUTTURE<br />
Lavoratori<br />
Nel 2015 nell'agricoltura sono stati impiegati 155 184 lavoratori, registrando un calo del 2,3<br />
per cento rispetto all'anno precedente.<br />
Evoluzione del numero di lavoratori<br />
Caratteristica<br />
Manodopera<br />
familiare<br />
Numero di lavoratori<br />
Numero di lavoratori<br />
Numero di lavoratori<br />
Variazione per<br />
anno in %<br />
Variazione per<br />
anno in %<br />
2000 2014 2015 2000-2015 2014-2015<br />
Uomini 101 685 78 234 76 828 -1,9 -1,8<br />
Donne 64 292 47 824 46 766 -2,1 -2,2<br />
Totale 165 977 126 058 123 594 -1,9 -2,0<br />
di cui:<br />
Capoazienda Uomini 74 724 51 245 50 383 -2,6 -1,7<br />
Donne 2 346 2 801 2 849 1,3 1,7<br />
Totale 77 070 54 046 53 232 -2,4 -1,5<br />
Manodopera<br />
extra-familiare<br />
Uomini 27 476 22 539 21 864 -1,6 -3,0<br />
Donne 10 340 10 165 9726 -0,4 -4,3<br />
Totale 37 816 32 704 31 590 -1,3 -3,4<br />
Lavoratori Totale 203 793 158 762 155 184 -1,8 -2,3<br />
Fonte: UST<br />
» A4<br />
Tra il 2000 e il 2015 il numero dei lavoratori è diminuito, nel complesso, di circa 48 600 unità,<br />
segnando una flessione annua dell’1,8 per cento, ovvero praticamente uguale a quella delle<br />
aziende. Il calo percentuale è stato superiore per la manodopera familiare rispetto a quella<br />
extra-familiare, mentre in cifre assolute la manodopera familiare ha subito una flessione di<br />
circa 42 400 unità, quella extra-familiare di 6200 unità. Dal 2000 è aumentato il numero delle<br />
donne a capo di un’azienda nel quadro della manodopera familiare.<br />
46<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 14 / 31<br />
AZIENDA > STRUTTURE<br />
Evoluzione del numero di lavoratori in base ai lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale<br />
Caratteristica<br />
Numero di lavoratori<br />
Numero di lavoratori<br />
Numero di lavoratori<br />
Variazione per<br />
anno in %<br />
Variazione per<br />
anno in %<br />
2000 2014 2015 2000-2015 2014-2015<br />
Lavoratori a<br />
tempo pieno<br />
Uomini 76 985 58 886 57 430 -1,9 -2,5<br />
Donne 19 010 12 688 12 221 -2,9 -3,7<br />
Totale 95 995 71 574 69 651 -2,1 -2,7<br />
Lavoratori a<br />
tempo parziale<br />
Uomini 52 176 41 887 41 262 -1,6 -1,5<br />
Donne 55 622 45 301 44 271 -1,5 -2,3<br />
Totale 107 798 87 188 85 533 -1,5 -1,9<br />
Fonte: UST<br />
Negli ultimi 15 anni il numero di lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale è diminuito rispettivamente<br />
del 2,1 e dell'1,5 per cento all'anno. In cifre assolute il numero dei lavoratori<br />
a tempo pieno, con 26 300 unità, è diminuito maggiormente rispetto a quello dei lavoratori a<br />
tempo parziale (22 300). Mentre per i lavoratori a tempo parziale non vi è quasi differenza tra i<br />
sessi, il calo in percentuale dei lavoratori a tempo pieno per le donne è leggermente maggiore<br />
rispetto agli uomini.<br />
Evoluzione del numero di lavoratori per regione<br />
Regione<br />
Numero di lavoratori<br />
Numero di lavoratori<br />
Numero di lavoratori<br />
Variazione<br />
annua in %<br />
Variazione<br />
annua in %<br />
2000 2014 2015 2000-2015 2014-2015<br />
Regione di pianura<br />
102 950 80 147 78 211 -1,8 -2,4<br />
Regione collinare 51 108 40 454 39 679 -1,7 -1,9<br />
Regione di montagna<br />
49 735 38 161 37 294 -1,9 -2,3<br />
Totale 203 793 158 762 155 184 -1,8 -2,3<br />
Fonte: UST<br />
Il calo del numero di lavoratori in atto dal 2000 è praticamente identico in tutte le regioni.<br />
Invece la variazione rispetto all’anno precedente evidenzia che nella regione di pianura e in<br />
quella di montagna si registra un calo maggiore (risp. -2,4 e -2,3 %) rispetto alla regione collinare<br />
(-1,9 %).<br />
Martina De Paola, UFAG, Settore Ricerca, consulenza e valutazione, martina.depaola@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
47
Il mio Rapporto agricolo 16 / 31<br />
AZIENDA > STRUTTURE<br />
Superficie agricola utile<br />
Nel 2015 la superficie agricola utile (SAU), rispetto al 2014, è aumentata di 1 705 ettari, attestandosi<br />
a 1,049 milioni di ettari.<br />
Evoluzione della superficie agricola utile (SAU) per classe di dimensioni<br />
Classe di dimensioni<br />
SAU in ha SAU in ha SAU in ha Variazione<br />
per anno in %<br />
Variazione<br />
per anno in %<br />
2000 2014 2015 2000–2015 2014-2015<br />
0–3ha 10 196 6 882 6 818 -2,6 -0,9<br />
3-10 ha 120 404 69 217 66 883 -3,8 -3,4<br />
10-20 ha 365 673 248 716 241 275 -2,7 -3,0<br />
20-30 ha 282 316 272 540 269 843 -0,3 -1,0<br />
30-50 ha 212 766 286 308 289 659 2,1 1,2<br />
> 50 ha 81 136 167 520 175 000 5,3 4,5<br />
Totale 1 072 492 1 051 183 1 049 478 -0,1 -0,2<br />
Fonte: UST<br />
» A5<br />
Dal 2000 la superficie agricola utile è diminuita di circa 23 000 ettari (-0,1 % all'anno). In tale<br />
periodo nelle aziende con più di 30 ettari si è registrato un incremento della superficie gestita<br />
di 171 000 ettari (+58 %). Queste aziende, con una quota del 19,3 per cento rispetto a tutte<br />
le aziende, nel 2015 hanno gestito circa 465 000 ettari, ovvero il 44,3 per cento dell'intera<br />
superficie agricola utile.<br />
Evoluzione della superficie agricola utile (SAU) per regione<br />
Regione SAU in ha SAU in ha SAU in ha Variazione<br />
annua in %<br />
Variazione<br />
annua in %<br />
2000 2014 2015 2000–2015 2014-2015<br />
Regione di pianura<br />
510 392 494 158 493 158 -0,2 -0,2<br />
Regione collinare 277 214 272 042 271 424 -0,1 -0,2<br />
Regione di montagna<br />
284 886 284 983 284 896 0,0 0,0<br />
Totale 1 072 492 1 051 183 1 049 478 -0,1 -0,2<br />
Fonte: UST<br />
Il lieve calo della superficie agricola utile registrato tra il 2000 e il 2015 si è concentrato nella<br />
regione di pianura e in quella collinare, con punte nella regione di pianura sia in valori assoluti<br />
sia in punti percentuali.<br />
48<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 17 / 31<br />
AZIENDA > STRUTTURE<br />
Evoluzione della superficie agricola utile (SAU) per tipo di utilizzo<br />
Tipo di utilizzo SAU in ha SAU in ha SAU in ha Variazione<br />
annua in %<br />
Variazione<br />
annua in %<br />
2000 2014 2015 2000–2015 2014-2015<br />
Superficie coltiva<br />
aperta<br />
292 548 271 474 272 816 -0,5 0,5<br />
Prati artificiali 115 490 127 953 125 537 0,6 -1,9<br />
Prati naturali 629 416 613 155 612 901 -0,2 0,0<br />
Colture perenni 23 750 23 747 23 795 0,0 0,2<br />
Restante SAU 11 287 14 853 14 429 1,7 -2,9<br />
Totale 1 072 492 1 051 183 1 049 478 -0,1 -0,2<br />
Fonte: UST<br />
La superficie agricola utile è composta, per la maggior parte, da superfici inerbite (70 %) e<br />
colture cerealicole (14 %). Dal 2000 questa ripartizione è rimasta pressoché invariata. Tra il<br />
2000 e il 2015 la superficie coltiva aperta e i prati naturali sono diminuiti, complessivamente,<br />
di circa 36 000 ettari. Un incremento di circa 10 000 ettari si è registrato, invece, per i prati<br />
artificiali. Le superfici inerbite in questo periodo sono diminuite solo in misura lieve, segnatamente<br />
di circa 6500 ettari.<br />
Martina De Paola, UFAG, Settore Ricerca, consulenza e valutazione, martina.depaola@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
49
Il mio Rapporto agricolo 19 / 31<br />
AZIENDA > STRUTTURE<br />
Animali<br />
Nel 2015 l’effettivo di animali si è attestato a 1,32 milioni di unità di bestiame grosso (UBG),<br />
segnando un incremento dell’1,0 per cento rispetto al 2014.<br />
Evoluzione delle unità di bestiame grosso (UBG) per classe di dimensioni<br />
Classe di dimensioni<br />
Numero<br />
di UBG<br />
Numero<br />
di UBG<br />
Numero<br />
di UBG<br />
Variazione<br />
annua in %<br />
Variazione<br />
annua in %<br />
2000 2014 2015 2000–2015 2014-2015<br />
0–3ha 75 827 64 126 66 375 -0,9 3,5<br />
3-0 ha 159 508 86 268 84 951 -4,1 -1,5<br />
10-20 ha 492 432 331 517 324 977 -2,7 -2,0<br />
20-30 ha 332 084 342 690 343 410 0,2 0,2<br />
30-50 ha 210 956 321 078 329 928 3,0 2,8<br />
>50 ha 65 911 162 193 170 764 6,6 5,3<br />
Totale 1 336 719 1 307 872 1 320 406 -0,1 1,0<br />
Fonte: UST<br />
» A6<br />
Il numero di unità di bestiame grosso negli ultimi 15 anni è diminuito di 16 313 unità (-1,2 %).<br />
Come per la superficie, gli animali si concentrano sempre più nelle grandi aziende. Le aziende<br />
con più di 30 ettari (19,3 % delle aziende) detengono il 38 per cento delle unità di bestiame<br />
grosso.<br />
Il numero di unità di bestiame grosso tra il 2014 e il 2015 è aumentato leggermente (+1,0 %).<br />
Evoluzione delle unità di bestiame grosso (UBG) per regione<br />
Regione<br />
Regione di pianura<br />
Numero<br />
di UBG<br />
Numero<br />
di UBG<br />
Numero<br />
di UBG<br />
Variazione<br />
annua in %<br />
Variazione<br />
annua in %<br />
2000 2014 2015 2000–2015 2014-2015<br />
620 098 609 693 614 422 -0,1 0,8<br />
Regione collinare 397 984 395 996 400 493 0,0 1,1<br />
Regione di montagna<br />
318 636 302 184 305 491 -0,3 1,1<br />
Totale 1 336 719 1 307 872 1 320 406 -0,1 1,0<br />
Fonte: UST<br />
Il lieve calo degli effettivi di animali in atto dal 2000 si è registrato prevalentemente nella<br />
regione di pianura e in quella di montagna. In termini assoluti (-13 145 UBG) e soprattutto<br />
relativi (-4,1 %) le unità di bestiame grosso nella regione di montagna sono diminuite in misura<br />
maggiore rispetto alla regione di pianura (risp. -5 676 UBG e -0,9 %).<br />
50<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 20 / 31<br />
AZIENDA > STRUTTURE<br />
Evoluzione delle unità di bestiame grosso per categoria di animali<br />
Categoria di animali<br />
Numero<br />
di UBG<br />
Numero<br />
di UBG<br />
Numero<br />
di UBG<br />
Variazione<br />
annua in %<br />
Variazione<br />
annua in %<br />
2000 2014 2015 2000–2015 2014-2015<br />
Bovini 1 013 585 956 828 967 336 -0,3 1,1<br />
Suini 194 417 190 924 193 061 0,0 1,1<br />
Pollame 42 649 59 667 60 917 2,4 2,1<br />
Ovini 40 427 41 083 40 142 0,0 -2,3<br />
Caprini 8298 11 741 11 370 2,1 -3,2<br />
Equini 35 667 44 062 43 922 1,4 -0,3<br />
Altri animali da<br />
reddito che<br />
consumano foraggio<br />
grezzo<br />
919 2 389 2 513 6,9 5,2<br />
Altri animali 757 1 178 1 146 2,8 -2,7<br />
Totale 1 336 719 1 307 872 1 320 406 -0,1 1,0<br />
Fonte: UST<br />
Il calo degli effettivi di animali tra il 2000 e il 2015 è riconducibile quasi esclusivamente alla<br />
categoria bovini. L’effettivo di suini e di ovini resta invariato. Tutte le altre categorie hanno<br />
registrato incrementi, tra cui, degni di nota, quelli di pollame, caprini ed equini.<br />
Martina De Paola, UFAG, Settore Ricerca, consulenza e valutazione, martina.depaola@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
51
Il mio Rapporto agricolo 22 / 31<br />
AZIENDA > SITUAZIONE ECONOMICA<br />
Conto economico<br />
Conformemente all’articolo 5 LAgr, i provvedimenti di politica agricola hanno lo scopo di permettere<br />
alle aziende gestite in maniera sostenibile e redditizia di conseguire in media su vari<br />
anni redditi comparabili a quelli della rimanente popolazione attiva della stessa regione.<br />
La valutazione è disciplinata nell’ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura<br />
(art. 3–7) e viene effettuata avvalendosi di due sistemi di indicatori. La valutazione settoriale<br />
si basa sul conto economico dell’agricoltura (CEA) allestito dall’UST in collaborazione<br />
con il Segretariato dell’USC.<br />
» Conto economico dell’agricoltura<br />
Risultati del conto economico dell’agricoltura in Svizzera Indicazioni ai prezzi correnti, in<br />
mio. fr.<br />
2000/02 2012 2013 2014 1 2015 2 2016 3<br />
Produzione<br />
del settore<br />
primario<br />
- Consumi intermedi<br />
Valore aggiunto<br />
lordo<br />
ai prezzi di<br />
fabbricazione<br />
- Ammortamenti<br />
Valore aggiunto<br />
netto<br />
ai prezzi di<br />
fabbricazione<br />
- Imposte<br />
sulla produzione<br />
+ Sovvenzioni<br />
(non vincolate<br />
alla produzione)<br />
Reddito dei<br />
fattori<br />
- Costo della<br />
manodopera<br />
10 694 10 084 10 312 10 691 10 086 10 176<br />
6174 6308 6310 6458 6241 6219<br />
4520 3776 4002 4233 3845 3958<br />
1983 2073 2075 2075 2024 1983<br />
2537 1703 1927 2158 1821 1975<br />
99 152 147 143 149 141<br />
2407 2926 2923 2944 2932 2939<br />
4845 4477 4703 4958 4604 4774<br />
1134 1257 1242 1276 1271 1261<br />
Eccedenza aziendale<br />
netta/<br />
Reddito indipendente<br />
3711 3220 3461 3683 3333 3513<br />
- (Canoni<br />
d’affitto e interessi<br />
-interessi riscossi)<br />
504 469 461 457 448 451<br />
Reddito da impresa<br />
3206 2750 2999 3226 2884 3062<br />
4<br />
netto<br />
1<br />
Dati semidefinitivi, stato 08.09.2016<br />
52<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 23 / 31<br />
AZIENDA > SITUAZIONE ECONOMICA<br />
2<br />
Dati provvisori, stato 08.09.2016<br />
3<br />
Stima, stato 08.09.2016<br />
4<br />
Nella bibliografia e nel metodo Eurostat viene indicato come utile aziendale netto<br />
Le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto, per cui la somma delle componenti può differire dal totale o dai<br />
saldi.<br />
Fonte: UST<br />
Nel 2015 il reddito da impresa netto ammontava a 2,884 miliardi di franchi, segnando un calo<br />
di 342 milioni di franchi rispetto al 2014. Sia per i prodotti di origine vegetale (-253 mio. fr.)<br />
sia per quelli di origine animale (-370 mio. fr.), i ricavi sul mercato sono diminuiti rispetto<br />
all'anno precedente. I costi invece sono diminuiti di 276 milioni di franchi. In particolare i costi<br />
per i consumi intermedi hanno segnato un calo netto di 217 milioni di franchi. Le entrate sono<br />
rimaste stabili per le prestazioni di servizio nell’agricoltura mentre per le attività extragricole<br />
hanno segnato un incremento di 17 milioni.<br />
Nel 2016 la stima del valore della produzione, con 10,176 miliardi di franchi, sarà inferiore<br />
dell'1,8 per cento rispetto alla media triennale 2013/15, ma superiore di 90 milioni di franchi<br />
rispetto all'anno precedente. Ciò è riconducibile in particolare ai migliori risultati rispetto<br />
all'anno precedente nel settore del bestiame da macello.<br />
Nel 2016 la produzione vegetale (4,005 mia. fr.; incl. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale),<br />
rispetto alla media dei tre anni precedenti, secondo le stime sarà inferiore del 2,5<br />
per cento. Rispetto all'anno precedente, invece, sarà leggermente superiore. Si prevedono valori<br />
più bassi per i cereali e più elevati per piante foraggere e vino.<br />
» A7<br />
Produzione del settore primario ai prezzi alla produzione correnti<br />
» A8<br />
Conto economico dell'agricoltura ai prezzi correnti<br />
Nel 2016 la produzione animale, con 5,001 miliardi di franchi, rispetto alla media dei tre anni<br />
precedenti, segnerà una flessione del 2,3 per cento, che rispetto all'anno precedente, invece,<br />
corrisponde a un incremento di 72 milioni di franchi, ovvero dell'1,5 per cento. Ai migliori<br />
risultati contribuirà la buona congiuntura del settore del bestiame da macello, all’interno del<br />
quale la situazione dovrebbe nettamente migliorare rispetto al 2015 in particolare per i suini.<br />
Per il latte, invece, si attende un ulteriore peggioramento.<br />
Stando alle stime, nel 2016 la produzione di prestazioni di servizio nell'agricoltura segnerà un<br />
aumento dell'1,4 per cento (709 mio. fr.) rispetto alla media del triennio precedente. Il valore<br />
delle attività accessorie non agricole non separabili (462 mio. fr.) dovrebbe aumentare del 5,4<br />
per cento rispetto alla media triennale 2013/15. Si stima che la trasformazione dei prodotti<br />
agricoli, quali frutta da sidro, carne o latte, sia destinata ad aumentare rispetto all'anno precedente.<br />
Nel 2016 le uscite per i consumi intermedi dovrebbero ammontare a 6,219 miliardi di franchi,<br />
segnando un calo dell'1,9 per cento rispetto alla media triennale 2013/15. Il reddito da impresa<br />
netto si attesterebbe a 3,062 miliardi di franchi, segnando un incremento di 26 milioni<br />
di franchi, ovvero 0,9 per cento in più rispetto alla media triennale 2013/15. Rispetto all'anno<br />
precedente la stima del reddito settoriale, invece, registra un aumento di 178 milioni di franchi,<br />
ovvero del 6,2 per cento.<br />
Mauro Ryser, UFAG, Settore Politica agricola, mauro.ryser@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
53
Il mio Rapporto agricolo 26 / 31<br />
AZIENDA > SITUAZIONE ECONOMICA<br />
Singole aziende<br />
La valutazione della situazione economica delle aziende si fonda sui risultati dell’Analisi centralizzata<br />
dell’Istituto delle scienze della sostenibilità (ISS) di Agroscope. A fornire importanti<br />
informazioni in merito non sono soltanto i diversi dati concernenti il reddito, bensì anche indicatori<br />
come, ad esempio, quello sulla stabilità finanziaria.<br />
» Analisi centralizzata dei dati contabili<br />
Cambiamento nell’analisi centralizzata dei dati contabili<br />
Dal 2015 Agroscope effettua una nuova stima del reddito che si basa su un campione aleatorio<br />
in cui possono essere presentati i risultati degli anni 2014 e 2015. Ad eccezione di aziende<br />
molto piccole, è ora possibile selezionare aziende delle più importanti forme aziendali e giuridiche<br />
(temporaneamente escl. persone giuridiche) per mettere a disposizione i dati contabili<br />
per la valutazione, su base volontaria e in forma anonima. Tale procedura, rispetto alla precedente<br />
selezione non casuale delle aziende, determina un netto miglioramento della rappresentatività<br />
del campione. I risultati del nuovo campione nel 2014 sono serviti come base di<br />
paragone per stimare la variazione del reddito dell'anno contabile 2015.<br />
Il campione nell'anno contabile 2014 non ha ancora raggiunto l'entità prevista e la composizione<br />
ottimale. Pertanto per l'anno 2015 sono state intraprese modifiche nel piano di selezione<br />
e contattate molte nuove aziende. Questo considerevole cambiamento del campione ha<br />
reso difficile la comparabilità dei risultati dei due anni di rilevazione e ha influenzato la stima<br />
delle variazioni tra i valori medi del 2014 e del 2015. Pertanto la variazione percentuale delle<br />
cifre analizzate è stata calcolata sulla base delle aziende che hanno fornito i dati in entrambi<br />
gli anni. I valori medi pubblicati per l'anno contabile 2015 sono stati stimati sulla base di tutto<br />
il campione.<br />
Reddito<br />
Nel 2015 il reddito agricolo è diminuito del 6,1 per cento rispetto all'anno precedente, attestandosi<br />
in media a 61 400 franchi per azienda. Il calo è dovuto soprattutto ai bassi prezzi del<br />
latte e della carne di suino nonché alla scarsità dei raccolti in campicoltura, foraggicoltura e<br />
frutticoltura a causa delle avverse condizioni meteo. Il reddito extragricolo è aumentato del<br />
3,4 per cento. Il reddito totale ha segnato dunque una diminuzione del 2,9 per cento.<br />
54<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 27 / 31<br />
AZIENDA > SITUAZIONE ECONOMICA<br />
Reddito agricolo per regioni (in fr., incl. aziende comunitarie, campione intero)<br />
Reddito per regione 2015 Variazione 2014–2015 in %<br />
Svizzera 61 402 -6,1<br />
Regione di pianura 74 764 -6,9<br />
Regione collinare 53 645 -8,9<br />
Regione di montagna 49 775 -1,1<br />
Nella regione di pianura si è registrata una diminuzione del 6,9 per cento e il reddito agricolo<br />
si è attestato a quota 74 800 franchi. In quella collinare il calo è stato più massiccio, ovvero<br />
dell'8,9 per cento con un valore di 53 600 franchi. Ciò è riconducibile al fatto che, a fronte del<br />
calo dei ricavi le spese per materiale, beni e servizi sono diminuite in maniera meno marcata<br />
rispetto alle altre regione. Nella regione di montagna il reddito agricolo è rimasto quasi sul<br />
livello dell'anno precedente (-1,1 % rispetto al 2014) ammontando a 49 800 franchi. Data la<br />
quota elevata di pagamenti diretti rispetto ai ricavi totali delle aziende nella regione di montagna,<br />
qui il reddito agricolo generalmente risente in maniera meno sensibile delle fluttuazioni<br />
dei ricavi dovute alle condizioni meteo o al mercato. Inoltre, in questa regione i pagamenti<br />
diretti per azienda sono leggermente aumentati (+1,4 %).<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
55
Il mio Rapporto agricolo 28 / 31<br />
AZIENDA > SITUAZIONE ECONOMICA<br />
Reddito delle aziende agricole, per regioni (in fr., escl. aziende comunitarie)<br />
Reddito per regione 2015 Variazione 2014–2015 in %<br />
Svizzera<br />
Reddito agricolo 58 468 -5,8<br />
Reddito extragricolo 29 874 3,4<br />
Reddito totale 88 342 -2,9<br />
Regione di pianura<br />
Reddito agricolo 70 562 -6,3<br />
Reddito extragricolo 30 331 3,5<br />
Reddito totale 100 892 -3,5<br />
Regione collinare<br />
Reddito agricolo 51 627 -8,2<br />
Reddito extragricolo 33 045 13,0<br />
Reddito totale 84 672 -1,2<br />
Regione di montagna<br />
Reddito agricolo 47 980 -5,3<br />
Reddito extragricolo 26 397 -2,4<br />
Reddito totale 74 377 -3,4<br />
Fonte: Agroscope ISS, Analisi centralizzata<br />
» A9<br />
» A10<br />
» A11<br />
» A12<br />
Il reddito totale di un'economia domestica agricola è composto dal reddito agricolo e da quello<br />
extragricolo ed è a disposizione delle famiglie contadine per il consumo privato e per la costituzione<br />
di capitale proprio. Il reddito extragricolo non viene rilevato per le comunità aziendali.<br />
Di conseguenza è possibile calcolare il reddito totale soltanto per le singole imprese, comunità<br />
aziendali escluse. Nel 2015 il reddito extragricolo in media è ammontato a 29 900 franchi per<br />
azienda superando del 3,4 per cento il livello del 2014. Questa crescita è riuscita a compensare<br />
parzialmente il calo del reddito agricolo. Il reddito totale, pari in media a 88 300 franchi per<br />
azienda, ha segnato un calo del 2,9 per cento rispetto al 2014.<br />
Risultati d'esercizio: tutte le regioni<br />
Risultati d'esercizio: regione di pianura<br />
Risultati d'esercizio: regione collinare<br />
Risultati d'esercizio: regione di montagna<br />
Reddito del lavoro<br />
Il reddito del lavoro corrisponde al reddito agricolo al netto dei costi calcolatori del capitale<br />
proprio dell'azienda, detti anche interessi per il capitale proprio. Il reddito del lavoro per manodopera<br />
familiare in equivalenti tempo pieno corrisponde all'importo dell'indennizzo della<br />
manodopera familiare che lavora in azienda.<br />
56<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 29 / 31<br />
AZIENDA > SITUAZIONE ECONOMICA<br />
Reddito del lavoro delle aziende agricole – 2014/15: per regioni e suddiviso in quattro<br />
classi<br />
Regione Valori medi Valori medi Valori medi Valori medi<br />
I quartile<br />
(0–25 %)<br />
II quartile<br />
(25–50 %)<br />
III quartile<br />
(50–75 %)<br />
IV quartile<br />
(75–100 %)<br />
Regione di pianura 17 688 40 293 62 305 106 035<br />
Regione collinare 11 944 30 215 43 665 74 669<br />
Regione di montagna 12 850 27 258 37 797 67 170<br />
Totale 13 874 32 344 48 575 88 723<br />
Fonte: Agroscope ISS, Analisi centralizzata<br />
L’interesse negativo applicato sulle obbligazioni decennali della Confederazione ha comportato,<br />
per la prima volta, interessi pari a zero. Il conseguente calo degli interessi rispetto al<br />
2014, associato a una lieve diminuzione del numero di unità di manodopera familiare (-1,5<br />
%), ha determinato una leggera crescita dello 0,9 per cento del reddito del lavoro per unità di<br />
manodopera in equivalenti tempo pieno che si è attestato a 44 600 franchi. Con 54 700 franchi<br />
per unità di manodopera familiare, il reddito del lavoro nella regione di pianura è superiore del<br />
38 per cento rispetto alla regione collinare (39 700 fr.) e del 55 per cento rispetto alla regione<br />
di montagna (35 200 fr.).<br />
Salario comparabile 2014/15, per regioni<br />
Regione Reddito del lavoro per ULAF 1 Salario comparabile 2<br />
Fr. per anno<br />
Fr. per anno<br />
Regione di pianura 49 618 74 000<br />
Regione collinare 36 261 69 000<br />
Regione di montagna 32 052 66 200<br />
1 ULAF: unità di lavoro della famiglia, valore mediano<br />
2 Valore mediano dei salari lordi annui di tutte le persone impiegate nel secondario e nel terziario<br />
Fonti: UST, Agroscope ISS, Analisi centralizzata<br />
Il reddito del lavoro medio per unità di manodopera familiare nell’agricoltura in generale è<br />
diminuito rispetto a quello dei salari dei lavoratori nel secondario e nel terziario. Nel 2015<br />
il valore mediano del reddito del lavoro per unità di manodopera familiare nella regione di<br />
pianura, collinare e di montagna si è attestato rispettivamente al 67, 53 e 48 per cento del<br />
salario comparabile. Va tuttavia tenuto in considerazione il fatto che a causa della situazione<br />
relativa ai dati può essere considerato soltanto un anno. La media degli ultimi tre anni sarebbe<br />
risultata maggiore in base ai dati positivi del 2013 e del 2014. Il reddito del lavoro per azienda<br />
nel 2015 corrisponde al reddito agricolo poiché non sono stati inclusi interessi applicati sul<br />
capitale proprio.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
57
Il mio Rapporto agricolo 30 / 31<br />
AZIENDA > SITUAZIONE ECONOMICA<br />
Reddito delle aziende agricole secondo i tipi di azienda – 2015 (escl. aziende comunitarie)<br />
Tipo di azienda<br />
Superficie agricola<br />
utile<br />
Manodopera familiare<br />
Reddito agricolo<br />
(reddito del lavoro)<br />
Reddito globale<br />
ha ULAF Fr. Fr. Fr.<br />
Campicoltura 32,69 1,09 64 880 38 004 102 884<br />
Colture speciali 16,47 1,29 79 021 28 919 107 940<br />
Vacche da latte 22,17 1,36 51 038 28 368 79 406<br />
Vacche madri 28,63 1,33 48 906 32 936 81 842<br />
Bovini misti 24,44 1,36 47 257 27 235 74 492<br />
Reddito extragricolo<br />
Equini/ovini/caprini<br />
20,91 1,38 48 206 24 871 73 077<br />
Trasformazione 16,22 1,30 77 518 28 353 105 871<br />
Aziende combinate,<br />
vacche da<br />
latte/campicoltura<br />
Aziende combinate,<br />
vacche<br />
madri<br />
Aziende combinate,<br />
tra-sformazione<br />
Aziende combinate,<br />
altre<br />
30,70 1,38 65 496 24 875 90 372<br />
30,43 1,24 53 368 44 453 97 821<br />
23,39 1,33 69 079 29 080 98 159<br />
27,60 1,33 59 899 33 712 93 611<br />
Fonte: Agroscope ISS, Analisi centralizzata<br />
L'ammontare del reddito del lavoro per unità di manodopera familiare è strettamente correlato<br />
al tipo di azienda. Tre degli undici tipi di azienda sono caratterizzati da un reddito del lavoro<br />
superiore alla media svizzera del 30-40 per cento. Rientrano in questi tipi di azienda le colture<br />
speciali, la campicoltura e la trasformazione (suini/allevamento di pollame) con redditi del lavoro<br />
medi di 60 000 franchi. Un reddito del lavoro prossimo al valore mediano svizzero è registrato<br />
da tutti i tipi di aziende combinate. Redditi del lavoro nettamente più bassi, nell'ordine di<br />
grandezza di 37 000 franchi, si sono segnati per i tipi di aziende vacche da latte, vacche madri,<br />
bovini misti (bovini con una quota bassa di vacche da latte) ed equini/ovini/caprini. I redditi<br />
del lavoro realizzati da questo tipo di aziende sono risultati in media inferiori del 15-20 per<br />
cento rispetto alla media nazionale.<br />
» A13<br />
» A14<br />
Risultati d'esercizio: campicoltura<br />
Risultati d'esercizio: colture speciali<br />
» A15<br />
» A16<br />
» A17<br />
Risultati d'esercizio: vacche da latte<br />
Risultati d'esercizio: vacche madri<br />
Risultati d'esercizio: bovini misti<br />
58<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 31 / 31<br />
AZIENDA > SITUAZIONE ECONOMICA<br />
Risultati d'esercizio: equini/ovini/caprini<br />
» A18<br />
» A19<br />
» A20<br />
» A21<br />
» A22<br />
Risultati d'esercizio: trasformazione<br />
Risultati d'esercizio: aziende combinate, vacche da latte/campicoltura<br />
Risultati d'esercizio: aziende combinate, vacche da latte<br />
Risultati d'esercizio: aziende combinate, trasformazione<br />
» A23<br />
Risultati d'esercizio: aziende combinate, altre<br />
Mauro Ryser, UFAG, Settore Politica agricola, mauro.ryser@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
59
Il mio Rapporto agricolo 2 / 18<br />
PRODUZIONE > INTRODUZIONE<br />
Introduzione<br />
Mezzi di produzione<br />
Nella produzione agricola vengono impiegati concimi, alimenti per animali, sementi e materiale<br />
vegetale nonché prodotti fitosanitari.<br />
• I concimi servono al nutrimento delle piante, ne promuovono la crescita, ne aumentano la<br />
resa o ne migliorano la qualità.<br />
• Gli alimenti per animali vengono somministrati agli animali da reddito e da compagnia in<br />
modo da assicurare la produttività degli animali da reddito agricoli e la qualità dei prodotti<br />
animali.<br />
• I prodotti fitosanitari, con principi attivi chimici o biologici, vengono impiegati allo scopo<br />
di proteggere le piante coltivate dagli organismi nocivi e in modo da assicurare un cospicuo<br />
raccolto.<br />
• Il materiale di moltiplicazione vegetale di elevata qualità come sementi, tuberi-seme,<br />
marze per innesto, portainnesti e piante giovani di varietà di frutta e vite contribuisce sostanzialmente<br />
alla produzione sostenibile in Svizzera.<br />
I mezzi di produzione consentono al settore agricolo di incrementare notevolmente rese e<br />
qualità, ma nascondono anche un potenziale di effetti collaterali indesiderati sulla salute<br />
dell'uomo e degli animali, nonché sull'ambiente. Per tale motivo, è necessario regolamentarne<br />
l'immissione sul mercato e l'impiego. A tale scopo vengono applicate diverse disposizioni<br />
di legge che disciplinano l'omologazione, i requisiti dei prodotti e della produzione,<br />
l'etichettatura, le modalità di utilizzo, gli obblighi di notifica, l'inserimento di piante agricole<br />
nel catalogo delle varietà e la certificazione delle sementi.<br />
Produzione di origine animale e vegetale<br />
Le piante coltivate e gli animali da reddito agricoli sono la base per la produzione di materie<br />
prime e derrate alimentari. Le rispettive coltivazione e detenzione dipendono notevolmente<br />
dal suolo, come luogo di produzione, e dalla sua fertilità, nonché dall'acqua. La Confederazione<br />
promuove la sostenibilità dell'utilizzo di questi fattori di produzione nonché la salvaguardia<br />
della loro salute e diversità genetica.<br />
Sicurezza della produzione primaria<br />
La produzione primaria, anello iniziale della filiera alimentare «dalla forca alla forchetta», è<br />
confrontata con numerose sfide. I sistemi di produzione moderni, molto mirati, legati agli sviluppi<br />
del contesto economico, climatico e sociale, richiedono un'ottima conoscenza dei rischi<br />
connessi alla produzione di derrate alimentari. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha<br />
riunito in un settore la gestione dei rischi connessi alla produzione primaria e il coordinamento<br />
dei controlli effettuati in quest’ambito. Esso lavora in stretta collaborazione con l'Ufficio federale<br />
della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), incaricato della sicurezza delle derrate<br />
alimentari fino alla loro immissione sul mercato. L'Unità federale per la filiera alimentare<br />
(UFAL), guidata congiuntamente da UFAG e USAV, è un partner essenziale considerato che ha il<br />
compito di elaborare il piano di controllo nazionale nella filiera alimentare e il rispettivo rapporto<br />
annuale, nonché di monitorare i controlli effettuati dai Cantoni sulla base delle disposizioni<br />
dei due Uffici.<br />
60<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 3 / 18<br />
PRODUZIONE > MEZZI DI PRODUZIONE<br />
OGM negli alimenti per animali<br />
Nel 2015 non sono stati importati alimenti per animali geneticamente modificati in Svizzera.<br />
Su 400 campioni di mercato controllati solo uno ha dovuto essere contestato.<br />
Alimenti per animali contenenti OGM notificati alla dogana all’importazione<br />
Anno Quantitativo totale Alimenti per animali<br />
contenenti OGM<br />
Alimenti per animali<br />
contenenti OGM<br />
In t In t In %<br />
2011 491 419 0 0<br />
2012 436 099 0 0<br />
2013 445 381 13 0,003<br />
2014 477 813 0 0<br />
2015 493 491 0 0<br />
Fonti: UFAG, Amministrazione federale delle dogane<br />
Analisi sulla presenza di componenti OGM negli alimenti per animali da reddito a cura della<br />
dogana all'importazione o di Agroscope sul mercato<br />
Anno Campioni dogana Indicazione di<br />
dati errati<br />
Campioni mercato<br />
Indicazione di<br />
dati errati<br />
Numero Numero Numero Numero<br />
2011 59 0 239 4<br />
2012 41 0 284 1<br />
2013 62 0 311 1<br />
2014 64 0 327 0<br />
2014 60 0 400 1<br />
Analisi sulla presenza di componenti OGM negli alimenti per animali da compagnia a cura<br />
di Agroscope<br />
Anno<br />
Alimenti per animali da<br />
compagnia controllati<br />
Numero<br />
Indicazione di dati errati<br />
Numero<br />
2011 106 2<br />
2012 14 1<br />
2013 0 0<br />
2014 9 0<br />
2015 0 0<br />
Fonte: Agroscope<br />
Markus Hardegger, UFAG, Settore Risorse genetiche e tecnologie, markus.hardegger@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
61
Il mio Rapporto agricolo 4 / 18<br />
PRODUZIONE > MEZZI DI PRODUZIONE<br />
Piano d’azione sui prodotti fitosanitari<br />
Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione<br />
e della ricerca (DEFR) di elaborare un Piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo<br />
sostenibile dei prodotti fitosanitari in collaborazione con il Dipartimento federale dell'interno<br />
(DFI) e con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni<br />
(DATEC). Mediante il piano d'azione s'intende definire obiettivi e misure per una riduzione<br />
del rischio e l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. Un progetto di piano d'azione<br />
è stato inviato in consultazione presso le cerchie interessate fino al 31 ottobre 2016.<br />
I prodotti fitosanitari vengono utilizzati in ambito agricolo e non per difendere le colture da<br />
malattie e parassiti nonché dalla concorrenza esercitata dalle malerbe. Questi prodotti forniscono<br />
un notevole contributo alla garanzia delle rese e alla qualità dei raccolti. Tuttavia, le sostanze<br />
biologicamente attive in essi contenute possono avere effetti indesiderati sull'uomo e<br />
sugli organismi non bersaglio che devono essere limitati.<br />
Il progetto di piano d’azione inviato in consultazione descrive i rischi comprovati e/o possibili<br />
dei prodotti fitosanitari per gli utilizzatori, i consumatori e l'ambiente. Definisce obiettivi per<br />
la riduzione dei rischi e illustra quali misure vanno adottate per raggiungerli.<br />
Con l'attuazione del piano d'azione i rischi dei prodotti fitosanitari saranno dimezzati e il loro<br />
utilizzo diventerà più sostenibile.<br />
Vi sono quattro ambiti di intervento:<br />
1. ridurre in maniera mirata i rischi attuali;<br />
2. sfruttare, indipendentemente dal rischio, il potenziale di riduzione delle applicazioni e delle<br />
emissioni di prodotti fitosanitari;<br />
3. sviluppare nuove possibilità per ridurre le applicazioni e le emissioni di prodotti fitosanitari;<br />
4. migliorare le conoscenze sugli effetti indesiderati dei prodotti fitosanitari.<br />
Il piano d'azione definisce obiettivi da raggiungere a lungo termine realizzabili mediante obiettivi<br />
intermedi che, secondo le stime attuali, sono raggiungibili con le misure proposte.<br />
Il successo del piano d'azione dipende da fattori come la disponibilità dei contribuenti a indennizzare<br />
le maggiori spese cui dovrà far fronte l'agricoltura attraverso i prezzi o i pagamenti<br />
diretti, la disponibilità dei commercianti a fissare requisiti meno esigenti per quanto riguarda<br />
la qualità oppure la disponibilità degli agricoltori ad applicare misure di difesa preventive e<br />
alternative. Anche le risorse finanziarie di Confederazione e Cantoni sono fattori decisivi per il<br />
successo nell’attuazione del piano d’azione.<br />
Il piano d'azione, oltre a ridurre i rischi per l’uomo e l’ambiente, è un'opportunità per<br />
l'agricoltura svizzera che, applicandolo, potrà avvicinarsi ai consumatori particolarmente sensibili<br />
alle questioni ecologiche con prodotti ottenuti nel rispetto di elevati standard ambientali.<br />
Viene così rafforzata anche la fiducia della popolazione nel lavoro dell'agricoltura elvetica.<br />
Olivier Félix, UFAG, Settore protezione sostenibile dei vegetali, olivier.felix@blw.admin.ch<br />
62<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 5 / 18<br />
PRODUZIONE > PRODUZIONE VEGETALE<br />
Utilizzazione della superficie<br />
» A34<br />
La superficie agricola utile è composta dalle colture campicole e perenni, da prati naturali e<br />
pascoli nonché da superfici destinate ad altre utilizzazioni, compresi i terreni da strame e per<br />
l’estrazione di torba. Nell'anno oggetto del rapporto ha segnato un calo dello 0,16 per cento<br />
rispetto al 2014, diminuendo di circa 1700 ettari.<br />
Colture campicole<br />
La superficie coltiva aperta nell'anno oggetto del rapporto, rispetto all'anno precedente, ha<br />
registrato un lieve incremento (+0,5 %) ma le superfici coltive totali hanno subito una leggera<br />
flessione (-0,5 %). Ciò è dovuto al calo dei prati artificiali diminuiti di 3000 ettari circa. Come<br />
negli anni precedenti, continua la tendenza al rialzo della coltivazione di leguminose e semi<br />
oleosi. Il calo costante della coltivazione di cereali foraggeri sembra essersi attenuato (+1,3<br />
% rispetto all'anno precedente). La coltivazione di sarchiate, rispetto all'anno precedente, è<br />
diminuita (-5,4 %).<br />
Colture perenni<br />
Nel 2015 la superficie totale destinata alla frutticoltura, registrata dall’Ufficio federale<br />
dell’agricoltura (UFAG) nella banca dati obst.ch (frutteti giusta l’art. 22 cpv. 2 dell’ordinanza<br />
sulla terminologia agricola; OTerm) ammontava a 6297 ettari, con una flessione di 22 ettari<br />
rispetto all'anno precedente, riconducibile soprattutto al calo della coltivazione della frutta a<br />
granella (-0,8 %). Persiste la crescita della coltivazione di frutta a nocciolo (+0,8 %) che tuttavia<br />
ha minore rilevanza per quanto riguarda le superfici.<br />
Nell'anno oggetto del rapporto la superficie delle bacche pluriennali è ammontata a 293 ettari,<br />
registrando un calo rispetto al 2014 di 23 ettari (-7,3 %).<br />
Nel 2015 in Svizzera i vigneti ammontavano a 14 793 ettari, segnando una lieve flessione rispetto<br />
al 2014 (-42 ha). La distribuzione delle varietà è rimasta stabile con quote del 42 per<br />
cento per le uve bianche e del 58 per cento per le rosse.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
63
Il mio Rapporto agricolo 6 / 18<br />
PRODUZIONE > PRODUZIONE VEGETALE<br />
Sotto «altre colture perenni» rientrano, ad esempio, piante da vivaio, piante ornamentali, alberi<br />
di Natale, colture orticole perenni, materie prime rinnovabili, come miscanto, e piante<br />
aromatiche e medicinali pluriennali.<br />
Link al sito Internet UFAG:<br />
Produzione sostenibile: Frutta - Statistiche frutta<br />
Produzione sostenibile : Vini e distillati – Statistiche vitivinicole<br />
Peter Schwegler, UFAG, Settore Prodotti vegetali, peter.schwegler@blw.admin.ch<br />
64<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 8 / 18<br />
PRODUZIONE > PRODUZIONE VEGETALE<br />
Strategia Selezione vegetale Svizzera 2050<br />
La disciplina della selezione vegetale è all'inizio della catena del valore nella produzione di<br />
derrate alimentari. La maggior parte di ciò che consumiamo ogni giorno proviene da varietà vegetali<br />
selezionate. L'intera filiera agroalimentare poggia sulle prestazioni preliminari basilari<br />
della selezione, che incide, direttamente e indirettamente, sulle abitudini alimentari di oggi e<br />
di domani. Sono numerosi gli attori coinvolti in questo settore che contribuiscono a sviluppare<br />
prodotti di successo (varietà vegetali) richiesti anche sul mercato. Ciò implica un approccio<br />
caratterizzato da una cooperazione stretta e proficua tra discipline assai diverse tra di loro,<br />
come ad esempio entomologia, patologia, fitofisiologia, biologia molecolare o bioinformatica.<br />
La selezione vegetale contribuisce in maniera fondamentale alla sostenibilità dell'agricoltura<br />
perché le novità varietali rispettano le risorse naturali e offrono rese sicure. I tempi di pianificazione<br />
nella selezione vegetale sono dilatati perché solitamente ci vogliono oltre 15 anni<br />
prima che una varietà nuova riesca a posizionarsi sul mercato. Anche in questo settore è decisivo<br />
essere in grado di concepire per tempo la strategia giusta e valutarla periodicamente.<br />
Considerata la valenza strategica della selezione vegetale per l'intero primario, negli ultimi tre<br />
anni l'UFAG ha elaborato la Strategia Selezione vegetale Svizzera, che volutamente copre un<br />
arco di tempo lungo (fino al 2050) e che per questo motivo ha una valenza generale. Si basa su<br />
una visione che riconosce il significato della selezione vegetale in Svizzera considerate le sfide<br />
dei prossimi decenni ed è rivolta a un'agricoltura sostenibile e multifunzionale.<br />
Visione 2050 per la Selezione vegetale Svizzera<br />
La Selezione vegetale Svizzera, con le sue varietà e competenze eccezionali, è una colonna<br />
portante di una filiera agroalimentare innovativa e sostenibile.<br />
La strategia è stata sviluppata coinvolgendo diversi gruppi d’interesse e tenendo conto dei<br />
pareri delle cerchie consultate. Crea i presupposti per i punti strategici che la Confederazione<br />
fissa per la selezione di nuove varietà vegetali, nonché le basi per i responsabili chiamati a decidere<br />
in merito all'impiego dei fondi pubblici in questo ambito. Definisce le condizioni essenziali<br />
per un maggior coordinamento in seno alla comunità della selezione vegetale in Svizzera,<br />
suggella l'importanza fondamentale della cooperazione internazionale per una selezione vegetale<br />
di successo e crea i presupposti necessari per un impiego efficiente delle risorse pubbliche.<br />
Gli attori del settore possono utilizzarla come riferimento per mettere a punto le loro<br />
strategie.<br />
Il documento sulla strategia serve da base per lo sviluppo di un piano d'azione concreto che<br />
sarà elaborato negli anni 2016 e 2017, sempre coinvolgendo le cerchie interessate, sotto la<br />
guida dell'UFAG.<br />
Hans Dreyer, UFAG, Settore Salute delle piante e varietà<br />
Contatto: Gabriele Schachermayr, UFAG, Settore Salute delle piante e varietà,<br />
gabriele.schachermayr@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
65
Il mio Rapporto agricolo 9 / 18<br />
PRODUZIONE > PRODUZIONE ANIMALE<br />
Allevatori e effettivi di animali da reddito<br />
Nel 2015 si sono registrati 36 700 detentori di animali della specie bovina, con un calo del 2,7<br />
per cento circa rispetto all'anno precedente. Una diminuzione percentuale analoga si rileva per<br />
il numero dei detentori di ovini e suini. Anche il numero dei detentori di animali della specie<br />
equina è sceso, seppur in misura lieve e meno massiccia rispetto agli anni precedenti. Soltanto<br />
per gli allevatori di pollame si è registrato un leggero incremento.<br />
Evoluzione del numero di allevatori<br />
2000/02 2013 2014 2015 2000/02–<br />
2013/15<br />
Capi Capi Capi Capi %<br />
Detentori di animali<br />
Detentori di bovini<br />
Detentori di<br />
equini<br />
58 602 46 621 45 711 44 789 -22,0<br />
49 598 38 546 37 742 36 738 -24,0<br />
10 564 8671 8528 8483 -19,0<br />
Detentori di suini 14 656 7277 7045 6865 -51,8<br />
Detentori di ovini 12 158 8903 8700 8414 -28,7<br />
Detentori di caprini<br />
Detentori di<br />
pollame da reddito<br />
6977 6466 6333 6313 -8,7<br />
19 943 11 982 11 953 12 065 -39,8<br />
Fonte: UST, dati sui bovini a partire dal 2009 provenienti dalla Banca dati sul traffico di animali<br />
2015: giorno di riferimento spostato da inizio maggio al 1° gennaio<br />
Paragonando il numero di detentori di animali dell'anno oggetto del rapporto con gli anni<br />
2000/02, spiccano i dati dei detentori di suini e di pollame da reddito. Questi sono infatti diminuiti<br />
rispettivamente del 50 e del 40 per cento circa. Ma anche il numero di detentori di bovini e<br />
ovini in questo lasso di tempo è sceso rispettivamente del 24 e del 29 per cento. Mentre nel 2015<br />
il numero di animali per tutte le specie non ha subito praticamente riduzioni rispetto al periodo<br />
2000/02, per il pollame si è registrato addirittura un aumento di oltre il 50 per cento. Tale situazione<br />
palesa il cambiamento strutturale e la concentrazione su effettivi medi più grandi.<br />
Nell'anno oggetto del rapporto i contadini hanno detenuto circa 1,55 milioni di capi di bovini<br />
(0,5 % in meno rispetto al 2014). L'effettivo di vacche (vacche da latte e madri) ha subito una<br />
flessione di 4000 capi rispetto all'anno precedente.<br />
66<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 10 / 18<br />
PRODUZIONE > PRODUZIONE ANIMALE<br />
L'effettivo di suini, composto da circa 1,5 milioni di capi, si è attestato lievemente al di sotto<br />
del valore dell’anno precedente, subendo un calo dello 0,2 per cento. La flessione piuttosto<br />
considerevole degli effettivi di ovini e caprini registrata nel 2015 è prevalentemente dovuta<br />
allo spostamento del giorno di riferimento da inizio maggio al 1° gennaio.<br />
» A24<br />
Grazie alla buona congiuntura per uova e carne di pollame, l'effettivo totale di pollame è nuovamente<br />
aumentato, attestandosi, nell'anno oggetto del rapporto, a quota 10,75 milioni di<br />
capi; l'incremento maggiore, pari al 6 per cento circa, si è registrato per le galline ovaiole e<br />
da allevamento.<br />
Hans Ulrich Leuenberger, UFAG, Settore Prodotti animali e allevamento, hansulrich.leuenberger@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
67
Il mio Rapporto agricolo 12 / 18<br />
PRODUZIONE > PRODUZIONE ANIMALE<br />
Produzione lattiera<br />
L'economia lattiera è la filiera principale dell'agricoltura svizzera con una quota del 20 per<br />
cento circa rispetto alla produzione dell'intero settore primario. Nel 2015, in Svizzera sono<br />
stati censiti 21 850 produttori di latte circa, di cui 10 270 nella regione di montagna e 11 580 in<br />
quella di pianura. Nell'anno oggetto del rapporto sono stati commercializzati circa 3,49 milioni<br />
di tonnellate di latte, di cui quasi un terzo di produzione biologica, senza somministrazione<br />
di insilati agli animali. Il latte prodotto da animali cui non vengono somministrati insilati è il<br />
presupposto per fabbricare i tipici formaggi svizzeri a base di latte crudo come, ad esempio,<br />
Emmentaler DOP, Gruyère DOP, Sbrinz DOP o Tête de Moine DOP. La quota principale del latte<br />
commercializzato in Svizzera è trasformata in formaggio (41 %), seguono burro (16 %), latte<br />
di consumo (11 %), latticini a lunga conservazione, come latte scremato e intero in polvere,<br />
(10 %), panna di consumo (8 %), yogurt (3 %) e altri.<br />
Nel 2015 il quantitativo di latte commercializzato ammontava mediamente a 196 992 chilogrammi<br />
per azienda di pianura e a 105 503 chilogrammi per azienda di montagna. Rispetto<br />
all'anno lattiero 2014, nella regione di pianura sono stati forniti mediamente 15 064 chilogrammi<br />
in più, in quella di montagna circa 4319 chilogrammi in più. Negli ultimi dieci anni<br />
si sono registrati incrementi delle forniture del 60,1 per cento per le aziende di pianura e del<br />
41,7 per cento per quelle di montagna. Tale mancanza di uniformità nell’evoluzione palesa le<br />
migliori possibilità di crescita nella regione di pianura. Anche nel 2015 l'aumento in percentuale<br />
del quantitativo medio di latte paragonato all'anno precedente è stato superiore nella<br />
regione di pianura rispetto alla regione di montagna.<br />
Nell'anno oggetto del rapporto, il quantitativo di latte commercializzato è stato pari a 3,49<br />
milioni di tonnellate, registrando un calo dell'1,5 per cento circa rispetto al 2014. L'effettivo<br />
di vacche ha subito soltanto una lieve flessione (-0,5 %).<br />
» Latte e latticini<br />
Hans Ulrich Leuenberger, UFAG, Settore Prodotti animali e allevamento, hansulrich.leuenberger@blw.admin.ch<br />
68<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 13 / 18<br />
PRODUZIONE > PRODUZIONE ANIMALE<br />
Produzione di carne e uova<br />
Nell'anno oggetto del rapporto il valore della produzione della carne (tutti i tipi di carne) è<br />
stato di circa 2,6 miliardi di franchi. Tale importo corrisponde a un quarto circa del valore della<br />
produzione dell'intero settore primario.<br />
La quota indigena della carne bovina ha raggiunto l'80,6 per cento; rispetto al 2014 si segnala<br />
un incremento dello 0,7 per cento della produzione di carne da banco e un calo del 2,3 per cento<br />
nell'approvvigionamento in animali da salumeria. A causa della domanda persistentemente<br />
alta di animali da salumeria si sono rese necessarie continue importazioni.<br />
Nel 2015 la produzione di carne di vitello ha subito una flessione del 4 per cento, riconducibile<br />
in primo luogo all'utilizzo di razze da carne con caratteristiche genetiche particolari laddove i<br />
vitelli magri sono destinati prevalentemente all'ingrasso di bestiame grosso.<br />
Anche la produzione di carne di maiale è lievemente diminuita, attestandosi a 241 322 tonnellate.<br />
Le condizioni climatiche hanno prolungato la stagione delle grigliate, contribuendo a<br />
sgravare il mercato del bestiame suino, ma eccedenze di produzione sporadiche hanno determinato<br />
un calo dei prezzi dei suini da macello.<br />
Come era già stato il caso negli anni scorsi, la produzione indigena di carne di pollame è nuovamente<br />
aumentata, segnatamente del 3,1 per cento.<br />
Nel 2015, sono stati prodotti 868 milioni di uova, ovvero il 3,7 per cento in più rispetto a un<br />
anno prima.<br />
» Carne e uova<br />
Hans Ulrich Leuenberger, UFAG, Settore Prodotti animali e allevamento, hansulrich.leuenberger@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
69
Il mio Rapporto agricolo 14 / 18<br />
PRODUZIONE > SICUREZZA DELLA PRODUZIONE PRIMARIA<br />
Strategia contro le resistenze agli antibiotici<br />
Obiettivi<br />
L'efficacia degli antibiotici va garantita a lungo termine e occorre arginare la formazione della<br />
resistenza. Con tale obiettivo il Consiglio federale alla fine del 2015 ha varano una strategia<br />
nazionale di ampio consenso contro le resistenze agli antibiotici. L'impiego eccessivo e inopportuno<br />
di antibiotici accelera lo sviluppo di germi resistenti che possono creare problemi per<br />
l'uomo e gli animali. Gli sforzi intrapresi finora per la lotta contro le resistenze agli antibiotici<br />
non sono sufficienti. In futuro gli antibiotici devono essere impiegati in modo più scrupoloso<br />
e ne va ridotto l'uso.<br />
Strategia «One-Health»<br />
La strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici (StAR) evidenzia dove in Svizzera<br />
sussiste necessità d'intervento, quali obiettivi vanno raggiunti e quali misure sono necessarie<br />
a tal fine. L'approccio di «One-Health» è vasto; il problema riguarda la medicina umana e quella<br />
veterinaria, l'agricoltura e l'ambiente.<br />
Comprendere la situazione<br />
La strategia è stata elaborata da quattro uffici federali in collaborazione con importanti stakeholder<br />
nell’arco di due anni e mezzo. Questa cooperazione e le notizie fornite dai mezzi di<br />
comunicazione hanno sensibilizzato i relativi gruppi professionali e la popolazione. Anche se<br />
nel settore veterinario i quantitativi totali di antibiotici venduti all'anno segnano un calo, va<br />
potenziata la coerente sorveglianza dell'utilizzo di antibiotici nella medicina umana e veterinaria<br />
nonché sviluppata la rilevazione di dati più precisi. I dati sui medicamenti veterinari rilevati<br />
nel quadro degli indicatori agro-ambientali (IAA) consentono di pubblicare dati garantiti<br />
dal profilo statistico riguardanti solo le aziende specializzate nella detenzione di lattifere. La<br />
rilevazione del singolo utilizzo di antibiotici consentirà di adottare misure mirate ad esempio<br />
in quegli ospedali e studi medici, studi veterinari o aziende agricole che impiegano antibiotici<br />
in misura maggiore rispetto alla media.<br />
70<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 15 / 18<br />
PRODUZIONE > SICUREZZA DELLA PRODUZIONE PRIMARIA<br />
Potenziare la prevenzione e un utilizzo consono<br />
Per preservare a lungo termine l'efficacia degli antibiotici è necessaria una maggiore prevenzione:<br />
ad ogni infezione evitata si riduce l'utilizzo di antibiotici. Ad esempio va migliorata<br />
l'igiene negli ospedali e nelle cure nonché ottimizzata la detenzione degli animali.<br />
Direttive uniformi valide a livello nazionale promuovono inoltre un utilizzo consono di antibiotici.<br />
Le direttive definiranno a quali condizioni vanno utilizzati gli antibiotici nella medicina<br />
umana e veterinaria e conterranno informazioni sulla scelta dell'antibiotico adatto, sulla posologia<br />
e sulla durata della terapia.<br />
Markus Hardegger, UFAG, Settore Risorse genetiche e tecnologie, markus.hardegger@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
71
Il mio Rapporto agricolo 16 / 18<br />
PRODUZIONE > SICUREZZA DELLA PRODUZIONE PRIMARIA<br />
Strategia per la sicurezza della catena alimentare<br />
Contesto<br />
Molti attori operano lungo la catena alimentare per garantirne la sicurezza. I Cantoni controllano<br />
le derrate alimentari e gli oggetti d'uso, effettuano controlli veterinari nonché quelli<br />
della produzione primaria e dei mezzi di produzione per l'agricoltura. La Confederazione, mediante<br />
Agroscope, garantisce un controllo centralizzato degli alimenti per animali commercializzati.<br />
La crescente complessità della catena alimentare e delle aspettative dei consumatori nonché<br />
la penuria delle risorse obbligano a strutturare e a coordinare sempre più tali controlli per preservare<br />
un livello di sicurezza elevato per i consumatori.<br />
Il Piano di controllo nazionale pluriennale (PCN) illustra le basi legali, gli attori coinvolti nei<br />
controlli e le attività effettuate lungo la catena alimentare. Nel 2015 è stata definita una strategia<br />
globale in collaborazione con tutti gli organi coinvolti. Questa tiene conto di tale evoluzione<br />
e mira a strutturare e a coordinare tali attività per migliorarne l'efficacia.<br />
Obiettivi comuni in una strategia<br />
In Svizzera sono affidati compiti esecutivi e controlli ufficiali a tutela della sicurezza alimentare<br />
a oltre 70 servizi nella Confederazione e nei Cantoni. L’organizzazione settoriale del sistema di<br />
controllo e la struttura federalista consentono un’attuazione ottimale delle direttive uniformi<br />
e presuppongono un elevato coordinamento e cooperazione.<br />
Ogni anno l'Unità federale per la filiera alimentare (UFAL) organizza una giornata PCN. Riunisce<br />
tutti gli attori della catena alimentare, chimici, veterinari e i servizi di agricoltura cantonali,<br />
l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), l'Ufficio federale<br />
dell'agricoltura (UFAG) e l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Dalle discussioni nei<br />
gruppi di lavoro creati in occasione di questa giornata è scaturito il bisogno di lavorare su obiettivi<br />
comuni.<br />
72<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 17 / 18<br />
PRODUZIONE > SICUREZZA DELLA PRODUZIONE PRIMARIA<br />
Un gruppo di lavoro misto (GL), composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni,<br />
è stato incaricato di elaborare obiettivi strategici lungo la catena alimentare. Obiettivo<br />
di portata superiore è garantire la sicurezza lungo la catena alimentare nel modo più efficace<br />
possibile.<br />
La missione del gruppo di lavoro prevede due fasi.<br />
• Formulazione di obiettivi strategici e operativi lungo la catena alimentare, definendo le<br />
competenze e i compiti degli attori.<br />
• Attuazione della strategia nel Piano di controllo nazionale (PCN).<br />
La strategia comprende quattro obiettivi strategici.<br />
1. Le derrate alimentari sul mercato sono sicure e conformi.<br />
La sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso è mantenuta alta lungo la catena<br />
alimentare per proteggere i consumatori dai pericoli per la salute e rispondere alle loro aspettative<br />
nei confronti delle derrate alimentari.<br />
2. Il sistema continua a evolversi e promuove la collaborazione.<br />
Il sistema di esecuzione e di controllo lungo la catena alimentare diventa più efficiente attraverso<br />
una migliore collaborazione e un flusso di dati più trasparente. I responsabili della politica<br />
sono connessi e si persegue un continuo miglioramento delle sinergie nell'organizzazione.<br />
Si presta attenzione allo sgravio amministrativo.<br />
3. Il sistema previene le crisi in maniera attiva e le supera con successo.<br />
La collaborazione nelle diverse sfere di competenza nell'ambito dell'organizzazione è impostata<br />
in modo che si prevengano le crisi e sia possibile gestirle. Il manuale delle crisi è aggiornato<br />
e sostiene l'organizzazione.<br />
4. Sono create condizioni ottimali per l'accesso al mercato.<br />
La collaborazione degli attori lungo la catena alimentare è organizzata in modo che le derrate<br />
alimentari, i prodotti semilavorati e le materie prime, che rientrano nella nostra sfera di competenza,<br />
siano idonei alla commercializzazione, con o senza condizioni, in Svizzera, nell'Unione<br />
europea e negli altri Paesi selezionati (Stati con i quali la Svizzera ha concluso o aspira a concludere<br />
accordi commerciali).<br />
Dopo la consultazione delle cerchie interessate questa strategia ha ottenuto l'avallo di tutte<br />
le parti in questione.<br />
La strategia globale costituisce una prima tappa. Include già alcuni obiettivi strategici e misure<br />
possibili per la sua realizzazione. Un nuovo gruppo di lavoro per l'attuazione della strategia<br />
globale, costituito da rappresentanti del comparto operativo delle diverse organizzazioni,<br />
studia in dettaglio queste proposte, le completa in funzione della loro esperienza e stabilisce<br />
delle priorità.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
73
Il mio Rapporto agricolo 18 / 18<br />
PRODUZIONE > SICUREZZA DELLA PRODUZIONE PRIMARIA<br />
Proposte di obiettivi operativi e di misure possibili per la realizzazione del primo obiettivo<br />
strategico<br />
Obiettivo strategico<br />
Punti chiave Obiettivi parziali operativi Misure<br />
Le derrate alimentari sul mercato<br />
sono sicure e conformi<br />
Comprensione globale del rischio<br />
lungo la catena alimentare.<br />
Possibilità di misurare la sicurezza<br />
alimentare: esiste un indice della sicurezza<br />
alimentare per quantificarla<br />
con l'obiettivo di migliorarla.<br />
Elaborazione di un catalogo consolidato<br />
di possibili rischi e rispettiva<br />
priorità come base per la pianificazione.<br />
Aggiornamento costante<br />
della legislazione a sostegno di<br />
un'esecuzione efficace.<br />
Definizione, da parte del GL Analisi<br />
dei dati, di indicatori e rispettiva<br />
ponderazione considerando le<br />
soluzioni già esistenti in Svizzera e<br />
all'estero.<br />
Avvio dei lavori per l'elaborazione,<br />
l'attuazione e il controlling<br />
dell'indice della sicurezza alimentare.<br />
Riduzione dei casi di campilobatteriosi:<br />
inversione a medio termine<br />
della tendenza epidemiologica.<br />
Entro la fine del 2019 il tasso di campilobatteriosi<br />
nell’uomo raggiunge<br />
quello degli anni 2005/2006 (incidenza<br />
inferiore a 70 casi ogni 100<br />
000 persone e anno).<br />
Presentazione di una Strategia nazionale<br />
contro le resistenze agli antibiotici<br />
(StAR).<br />
Disponibilità, per tutti gli attori, dei<br />
dati e delle informazioni necessari al<br />
loro lavoro.<br />
Allestimento e attuazione di un<br />
piano di riduzione «Campy minus»<br />
nonché monitoraggio del suo sviluppo<br />
con il coinvolgimento di tutti<br />
gli interessati.<br />
Allestimento di un piano di attuazione<br />
della Strategia nazionale<br />
contro le resistenze agli antibiotici<br />
(StAR).<br />
Esecuzione di un'analisi dello stato<br />
attuale/auspicato volta a stabilire<br />
dove sono presenti dati e informazioni<br />
nonché la rispettiva qualità e<br />
di quali dati necessitano i singoli attori<br />
per l’adempimento ottimale del<br />
mandato di esecuzione.<br />
Louis Tamborini, UFAG, Settore Sicurezza della produzione e alimentazione animale, louis.tamborini@blw.admin.ch<br />
74<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
75
Il mio Rapporto agricolo 2 / 93<br />
MERCATO > INTRODUZIONE<br />
Introduzione<br />
Nel 2015 la temperatura annuale in Svizzera è stata mediamente superiore di 2 gradi a quella<br />
di riferimento dal profilo climatico registrata nel periodo 1961-1990 su tutto il territorio nazionale.<br />
Il 2015 è stato quindi l’anno più caldo mai registrato in Svizzera. L'estate 2015, dopo<br />
quella del 2003, è stata la seconda più calda dall'inizio delle rilevazioni sistematiche nel 1864.<br />
In tutto il periodo estivo in Svizzera si sono registrarti 3,5 gradi in più rispetto alla media pluriennale.<br />
Nella maggior parte delle località l'estate 2015 è stata troppo secca. Soprattutto a<br />
inizio luglio il suolo è diventato estremamente arido a causa di canicola, vento e 14 giorni di<br />
sole quasi ininterrotto. Soltanto a partire dalla seconda metà del mese di agosto sono cadute<br />
grandi quantità di piogge. Nella maggior parte delle località è stato possibile solo in parte compensare<br />
la carenza di precipitazioni.<br />
Già a inizio 2015 gennaio ha registrato temperature oltre la media; in alcuni giorni la colonnina<br />
ha toccato 20 gradi e non si sono praticamente rilevate gelate. Dopo un inizio invernale, marzo<br />
è stato molto soleggiato e secco. Soltanto a fine aprile sono arrivate le tanto attese precipitazioni.<br />
I mesi di maggio e giugno sono stati umidi e freschi. In particolare giugno è stato caratterizzato<br />
da forti oscillazioni di temperature. Alla fine di giugno è iniziata l'ondata di caldo<br />
estiva. In autunno e fino a dicembre le temperature si sono nuovamente attestate su valori<br />
oltre la media. Complessivamente, ad eccezione di ottobre, è stato un autunno troppo secco.<br />
Prodotti di origine vegetale<br />
Nella produzione vegetale le condizioni climatiche del 2015 hanno avuto impatti diversi a seconda<br />
delle colture. Suoli secchi e caldi hanno consentito semina e piantagione primaverili precoci<br />
di verdura, barbabietole da zucchero, cereali, semi oleosi e patate. All'inizio della stagione<br />
estiva freddo e umidità hanno però rallentato la crescita delle colture e determinato in parte<br />
perdite di resa nell'orticoltura. La canicola e la siccità in piena estate hanno causato un gran<br />
dispendio per l'irrigazione e nelle regioni più secche dell'Altopiano e della Svizzera settentrionale<br />
hanno determinato rese inferiori alla media sulle superfici inerbite, nella coltivazione<br />
di mais e per le verdura da stoccaggio e destinate alla trasformazione (escl. carote). Nell'anno<br />
precedente soltanto l'80 per cento del frumento panificabile raccolto è stato destinato alla panificazione,<br />
mentre nel 2015, grazie al clima secco nella fase di maturazione e di raccolto quasi<br />
il 100 per cento del frumento ha raggiunto lo standard per la panificazione. Dopo le rese record<br />
dell'anno precedente, è stato possibile ottenere anche nel 2015 ottime rese di colza. Le patate<br />
e le barbabietole da zucchero hanno sofferto ristagni idrici all'inizio dell'estate e successivamente<br />
la siccità estiva.<br />
Tutto sommato si può trarre un bilancio positivo per l'annata vitivinicola e frutticola. I frutti<br />
sono giunti a maturazione in buone condizioni determinando qualità elevata nelle uve e nella<br />
frutta. Tuttavia la vendemmia, a causa della siccità, è stata una delle più esigue degli ultimi<br />
anni. Grazie alle possibilità di irrigazione nella frutticoltura, in generale è stato possibile ricavare<br />
rese nella media. In particolare le bacche hanno sofferto la canicola estiva. La drosofila<br />
del ciliegio è stata sempre presente, ma nella frutticoltura ha causato meno danni rispetto a<br />
quanto temuto e nella viticoltura non ha provocato alcun problema.<br />
Prodotti di origine animale<br />
La tendenza al ribasso per gli effettivi di bovini in atto ormai da anni ha avuto ripercussioni<br />
sull'approvvigionamento indigeno. Mentre la produzione di carne da banco nel 2015 è aumentata,<br />
è diminuito l'approvvigionamento di mezzene da salumeria. La quota indigena sul consumo<br />
per il bestiame grosso si è attestata all'80,6 per cento. La produzione di carne di vitello<br />
nell'anno oggetto del rapporto è diminuita del 4 per cento rispetto all'anno precedente e si<br />
è attestata a circa 29 100 tonnellate di peso alla macellazione. La produzione e il consumo<br />
pro capite di carne di suino sono diminuiti leggermente rispetto all'anno precedente. È inceve<br />
76<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 3 / 93<br />
MERCATO > INTRODUZIONE<br />
aumentato il consumo di carne ovina. La popolazione continua ad apprezzare uova e carne di<br />
pollame svizzere che si sono potute affermare sul mercato nonostante le enormi differenze di<br />
prezzo rispetto ai prodotti d'importazione. Il prezzo alla produzione del latte ha subito pressioni<br />
a causa soprattutto delle difficoltà sul mercato internazionale del latte. La bilancia commerciale<br />
del formaggio Svizzera-UE è stata nuovamente positiva in termini di valore, mentre<br />
dal profilo dei quantitativi le importazioni sono state, come già l'anno scorso, superiori alle<br />
esportazioni.<br />
Evoluzione dei mercati<br />
Nel 2015 il valore aggiunto lordo del settore primario ha seguito un andamento negativo; lo<br />
stesso dicasi per il commercio di prodotti agricoli. Sia l'indice dei prezzi alla produzione dei<br />
prodotti agricoli sia quello dei prezzi al consumo delle derrate alimentari e delle bevande analcoliche,<br />
invece, hanno segnato una tendenza leggermente positiva. Come si sono invece sviluppati<br />
i prezzi ai diversi livelli commerciali? Come evolve la competitività nel settore lattiero?<br />
La risposta a queste domande è contenuta nell'articolo della sottorubrica «Evoluzione dei mercati».<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
77
Il mio Rapporto agricolo 4 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
Valore aggiunto lordo<br />
Nel 2015 l'economia svizzera ha realizzato un valore aggiunto lordo di 625 miliardi di franchi,<br />
ovvero di circa 3 miliardi superiore a quello dell'anno precedente. La quota del settore primario<br />
si attesta sullo 0,7 per cento.<br />
Evoluzione del valore aggiunto lordo dei tre settori dell’economia<br />
Settore 2000 2014 1 2015 1 Quota 2015<br />
mio. fr. mio. fr. mio. fr. %<br />
Primario 5300 4680 4256 0,7<br />
Secondario 115 366 159 866 159 462 25,5<br />
Terziario 317 079 458 202 461 162 73,8<br />
Totale 437 745 622 748 624 880 100,0<br />
Avvertenza: in seguito alla revisione totale del conto economico del 2014 (adeguamento al Sistema europeo dei<br />
conti nazionali e regionali 2010), sono state modificate tutte le sequenze di dati degli aggregati.<br />
¹ Dati provvisori<br />
Fonte: UST<br />
Alessandro Rossi, UFAG, Settore Comunicazione e servizi linguistici, alessandro.rossi@blw.admin.ch<br />
78<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 5 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
Commercio estero<br />
Nel 2015, dopo anni di crescita moderata, il commercio svizzero estero ha registrato un calo:<br />
le importazioni e le esportazioni, con rispettivamente 166,3 e 202,9 miliardi di franchi, sono<br />
risultate inferiori del 6,9 % e del 2,6 % rispetto al 2014. Il saldo della bilancia commerciale nel<br />
2015 ha dato un'eccedenza d'esportazione di 36,6 miliardi di franchi, vale a dire 6,6 miliardi<br />
di franchi in più rispetto al 2014.<br />
Nell’anno oggetto del rapporto il commercio di prodotti agricoli ha avuto, nel complesso, un<br />
andamento negativo. Rispetto al 2014 il valore delle importazioni è sceso di 0,6 raggiungendo<br />
11,5 miliardi di franchi, quello delle esportazioni ha segnato un calo di 0,3 miliardi di franchi<br />
attestandosi a 8,5 miliardi di franchi. Nel 2015 la bilancia commerciale per i prodotti agricoli<br />
si è chiusa con un’eccedenza d’importazione di 3,0 miliardi di franchi, vale a dire 0,3 miliardi<br />
di franchi in meno rispetto al 2014. Tuttavia, nel complesso, tra il 2000 e il 2015 l’eccedenza<br />
d’importazione ha subito una flessione di 2 miliardi di franchi.<br />
Nell’anno oggetto del rapporto il 71,7 per cento circa delle importazioni agricole proveniva<br />
dall’UE. Il 57,3 per cento dei prodotti esportati dalla Svizzera era destinato all’area europea.<br />
Rispetto al 2014 le importazioni dall'UE sono diminuite di 0,5 miliardi di franchi, fissandosi<br />
a 8,3 miliardi di franchi, mentre le esportazioni verso l'UE sono diminuite di 0,4 miliardi di<br />
franchi segnando un livello di 4,9 miliardi di franchi. Nel 2015 la bilancia commerciale con l'UE<br />
per i prodotti agricoli ha chiuso con un’eccedenza d’importazione di 3,4 miliardi di franchi.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
79
Il mio Rapporto agricolo 6 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
In termini di valore, i prodotti agricoli importati in Svizzera provenivano soprattutto dalla Germania,<br />
seguita da Italia e Francia. Poco più del 60 per cento dell’insieme delle importazioni<br />
dall’UE proveniva da questi tre Paesi. A Germania, Francia e Italia è stato destinato circa il 56<br />
per cento del valore delle esportazioni nell’UE del 2015.<br />
La bilancia commerciale con i Paesi UE confinanti nonché con la Spagna e i Paesi Bassi ha registrato<br />
eccedenze d’importazione nell’anno oggetto del rapporto. La Svizzera ha registrato il<br />
peggior bilancio con l’Italia. È risultato invece più equilibrato il bilancio con l’Austria. Nel commercio<br />
con i restanti Paesi membri dell’UE la Svizzera ha registrato, nel 2015, un’eccedenza<br />
d’esportazione di 88 milioni di franchi.<br />
80<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 7 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
Nell’anno oggetto del rapporto le importazioni hanno interessato essenzialmente bevande,<br />
prodotti animali (compreso il pesce), generi voluttuari (caffè, tè e spezie) e preparati alimentari.<br />
In termini di valore le importazioni di bevande si compongono per un buon 60 per cento<br />
di vini, per il 19 per cento di acque minerali e per il 14 per cento circa di liquori. L’importazione<br />
totale di prodotti della voce «prodotti di origine animale, pesce» si compone di oltre il 40 per<br />
cento di carne, del 30 per cento circa di pesce e, per il resto, di preparati e conserve di carne.<br />
Com’era già stato il caso negli anni precedenti, nel 2015 si sono esportati soprattutto generi<br />
voluttuari e bevande, seguiti da preparati alimentari, cereali, preparazioni e latticini. I generi<br />
voluttuari esportati sono prevalentemente caffè con 1 943 milioni di franchi (2014: 2 025 mio.<br />
fr.) nonché cioccolata e generi alimentari contenenti cacao con 786 milioni di franchi (2014:<br />
796 mio. fr.). I preparati alimentari, gli estratti di caffè, le zuppe e le salse rappresentano la<br />
quota principale delle esportazioni totali di derrate alimentari.<br />
La bilancia commerciale secondo la categoria di prodotti registra un’eccedenza d’importazione<br />
soprattutto per i prodotti animali, compreso il pesce (–1 561 mio. fr.) e la frutta (–1 213 mio.<br />
fr.). Nel 2015 sono state realizzate eccedenze d’esportazione per generi voluttuari, tabacchi e<br />
diversi, latticini nonché bevande.<br />
Alessandro Rossi, UFAG, Settore Comunicazione e servizi linguistici, alessandro.rossi@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
81
Il mio Rapporto agricolo 8 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
Grado di autoapprovvigionamento<br />
Il grado di autoapprovvigionamento è la quota della produzione indigena rispetto al consumo<br />
all'interno del Paese. Esso si distingue tra lordo e netto. In quello netto si tiene in considerazione<br />
il fatto che una parte della produzione indigena si ottiene utilizzando alimenti importati<br />
per animali. Nel calcolo del grado di autoapprovvigionamento netto, dalla produzione animale<br />
indigena è dedotta la quota ottenuta con alimenti importati per animali.<br />
» A25<br />
La produzione di punta dell’agricoltura svizzera è quella animale, il che spiega anche il grado di<br />
autoapprovvigionamento relativamente elevato in questo settore. Nel 2014 la quota indigena<br />
di prodotti animali ha fatto segnare, con il 100 per cento, quasi tre punti in più rispetto al 2013<br />
(97 %). La causa principale è stata l'elevata produzione di latte, carne di maiale, uova e carne<br />
di pollame. La quota di prodotti di origine vegetale nel 2014 è aumentata di 5 punti rispetto al<br />
2013, attestandosi al 46 per cento a causa soprattutto di un maggior raccolto di barbabietole<br />
da zucchero. Nel complesso, il grado di autoapprovvigionamento lordo nel 2014, pari al 63 per<br />
cento, ha registrato un incremento di 5 punti rispetto al 2013 (58 %); quello netto ha raggiunto<br />
quota 55 per cento, superando del 5 per cento il livello del 2013.<br />
Alessandro Rossi, UFAG, Settore Comunicazione e servizi linguistici, alessandro.rossi@blw.admin.ch<br />
82<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 10 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
Evoluzione degli indici dei prezzi<br />
Tra il 2000/02 e il 2007 l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli ha fatto registrare<br />
un lieve calo. Dopo un aumento di breve durata nel 2008 a quota 105,3 per cento, l’indice<br />
ha subito un nuovo drastico calo perdurato fino al 2012. Dopo un'ulteriore ripresa nel 2013 e<br />
nel 2014 segnando un livello poco più del 98 per cento, nell'anno oggetto del rapporto l'indice<br />
è diminuito di nuovo di quasi 6 punti percentuali attestandosi a 92,2 per cento. Al momento<br />
l'indice segna un livello simile a quello del 2010.<br />
Contrariamente all’indice dei prezzi alla produzione, nel 2015 gli altri indici sono risultati superiori<br />
a quelli del 2000/02. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per il sottogruppo «derrate<br />
alimentari e bevande analcoliche» è aumentato del 7 per cento tra il 2000/02 e il 2008,<br />
per poi ridiscendere al 101,2 per cento nel 2012. Dopo un lieve aumento nel 2013 (102,4 %) e<br />
nel 2014 (103,4 %), l'indice ha segnato nuovamente un calo attestandosi a 102,6 per cento.<br />
L’indice dei prezzi dei mezzi di produzione agricoli ha segnato un rialzo fino al 2008, toccando<br />
quota 110,6 per cento. Dopo una lieve flessione al 108,0 per cento (2010), tra il 2011 e il 2013<br />
l’indice è risultato pressoché stabile sul 108,5 per cento. Nel 2014 e nell'anno oggetto del<br />
rapporto è diminuito ancora una volta, attestandosi nel 2015 a 105,5 per cento. L’indice può<br />
essere Il mio Rapporto suddiviso agricolo in mezzi di produzione di origine agricola (sementi, alimenti per animali) e 11 / 93<br />
altri mezzi di produzione. Il primo nel 2015 è aumentato di 2,1 punti percentuali, il secondo<br />
del 2,3 per cento.<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
Fino al 2008 l'indice dei prezzi all’importazione per le derrate alimentari e le bevande è salito<br />
al 114,5 per cento e in seguito fino al 2012 è diminuito attestandosi a 107,1 per cento. Dopo<br />
un incremento nel 2013 (107,4 %) e nel 2014 (108,7 %), nell'anno oggetto del rapporto ha<br />
subito un calo di 4,7 punti percentuali segnando quota 104,0 per cento.<br />
Alessandro Rossi, UFAG, Settore Comunicazione e servizi linguistici, alessandro.rossi@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
83
Il mio Rapporto agricolo 12 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
Prezzi ai diversi livelli commerciali<br />
Introduzione<br />
Nel messaggio concernente l'evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 si mette<br />
in risalto l'importanza della garanzia di un'adeguata trasparenza da parte di un osservatorio<br />
indipendente nei mercati delle derrate alimentari sempre più liberalizzati e volatili. L’UFAG<br />
monitora da anni i mercati agricoli più importanti ai vari livelli commerciali. L'Osservazione<br />
del mercato, in quanto servizio esecutivo, si fonda sulla base legale stabilita nell'articolo 27<br />
capoverso 1 LAgr. In particolare si concentra sulle evoluzioni di prezzo nei settori carne, latte,<br />
uova, prodotti della campicoltura, frutta e verdura che costituiscono oggetto di analisi approfondita<br />
del presente contributo.<br />
Nelle sezioni seguenti sono descritte le evoluzioni di prezzo dei prodotti biologici e non, ai<br />
livelli commerciali «Produzione», «Commercio all'ingrosso per il canale della ristorazione»<br />
nonché «Commercio al dettaglio» e «Consumo». Occorre tener presente che i confronti del livello<br />
e dell’andamento dei prezzi tra i diversi gruppi di prodotti e livelli commerciali sono resi<br />
difficili dall'eterogenea definizione di prezzo ai diversi livelli (p.es. diversa combinazione di<br />
label o diverso grado di trasformazione).<br />
Prezzi alla produzione<br />
Negli ultimi anni i prezzi alla produzione in Svizzera si sono sviluppati in maniera molto diversa.<br />
Nel 2015 importanti fattori che hanno influito sull'evoluzione dei prezzi sono stati l'abolizione<br />
della soglia minima per il cambio EURO-CHF e il conseguente turismo degli acquisti verso i Paesi<br />
limitrofi.<br />
» A26<br />
Prezzi, biologico escluso<br />
Nella produzione lattiera il 2015 è stato caratterizzato da un netto calo dei prezzi. In media<br />
il prezzo del latte rispetto all'anno precedente ha subito una flessione del 9,3 per cento attestandosi<br />
a 61.9 centesimi al chilogrammo e ha seguito l'evoluzione dei prezzi esteri. Rispetto<br />
al 2000 sia il prezzo del latte in generale sia quello del latte di caseificio sono nettamente diminuiti<br />
(-17,3 % nel periodo 2013/15). L'apertura del mercato caseario nel 2007, l'abolizione<br />
del contingentamento lattiero nel 2009, l'aumento delle riserve di burro a causa della sovraproduzione<br />
nonché gli sviluppi internazionali nel mercato lattiero hanno avuto nette ripercussioni<br />
sui prezzi.<br />
Nel 2015 sul mercato del bestiame da macello per i bovini si sono registrati prevalentemente<br />
rincari. Rispetto al 2014 le vacche da macello sono state commercializzate a prezzi maggiori<br />
a causa della scarsa offerta e della domanda elevata di carne macinata e di insaccati. Dal confronto<br />
tra i periodi 2000/02 e 2013/2015 si evince che i prezzi alla produzione nel mercato<br />
della carne (eccezione agnello e suino) sono aumentati. Negli anni la carne suina, a causa del<br />
ciclo della produzione del maiale, ha subito sensibili oscillazioni di prezzo, tuttavia nel periodo<br />
2000/02, rispetto al 2013/15, i prezzi alla produzione erano maggiori a causa dell'esigua offerta.<br />
Negli ultimi anni i prezzi delle uova sono restati relativamente costanti e prevedibili grazie alla<br />
pianificazione della produzione e alla gestione dei quantitativi nel quadro dell'integrazione<br />
verticale predominante in questo mercato. Rispetto al periodo 2013/15, negli anni 2002/04 i<br />
prezzi erano nel complesso leggermente maggiori.<br />
Nel 2015 rispetto al 2014 per i cereali indigeni sono stati osservati prezzi leggermente più<br />
bassi. Nel 2015 circa 53 000 tonnellate di raccolto all'interno del Paese sono state declassate<br />
84<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 13 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
dalla Federazione svizzera dei produttori di cereali (FSPC) a causa di un’eccedenza di produzione.<br />
In tal modo è stato possibile evitare una situazione di eccedenza e quindi un crollo dei<br />
prezzi. Il calo di prezzo tra il 2000/02 e il 2013/15 è in parte riconducibile alle mutate condizioni<br />
quadro, come la riduzione dei prezzi soglia.<br />
Per quanto riguarda le sarchiate le condizioni meteorologiche hanno avuto una grande influenza<br />
sui prezzi alla produzione. Nel 2015 i prezzi alla produzione delle patate sono stati nettamente<br />
superiori rispetto all'anno precedente, in primo luogo a causa delle perdite di raccolto<br />
dovute all'estate calda. Tra il 2000/02 e il 2013/15 i prezzi delle sarchiate in media sono aumentati<br />
(eccezione barbabietola da zucchero con -38,6% a causa dei bassi prezzi dello zucchero).<br />
Dal 2000 i prezzi della frutta osservata hanno avuto uno sviluppo per lo più positivo. Tra il<br />
2000/03 e il 2012/15 i prezzi sono aumentati fino al 60 per cento (ciliegie da tavola 2015: 6,02<br />
fr./kg; 2000/03: 3,86 fr./kg). Per le ciliegie da tavola va notato che l'evoluzione dei prezzi<br />
negli ultimi anni è stata correlata anche agli adeguamenti del calibro e alla coltivazione di<br />
nuove varietà (frutti più grandi rispetto al passato). Tra la frutta a nocciolo, le albicocche sono<br />
rincarate di circa l'1,4 per cento, mentre per le prugne da tavola è stato registrato un aumento<br />
del 5,1 per cento. Per le mele si è osservato sia un incremento pari al 6,1 per cento (Golden<br />
Delicious 2015: 1.06 fr./kg) sia un calo pari all’8,4 per cento (Maigold/Braeburn 2015: 1.01<br />
fr./kg).<br />
Come per la frutta, anche per la verdura sono aumentati i prezzi indicativi franco grossista per<br />
tutte le categorie di prodotti osservate (eccezione: cipolle, con un calo del prezzo del 30 %).<br />
Ad esempio i prezzi delle carote sono aumentati del 10,7 per cento tra il 2000/02 e il 2013/15.<br />
I pomodori sono rincarati di oltre l'8,3 per cento, sedano rapa, lattuga cappuccio, cetrioli e<br />
cavolfiore hanno registrato aumenti compresi tra il 14 e il 38 per cento.<br />
» A27<br />
Prezzi dei prodotti biologici<br />
Nel commercio al dettaglio sono aumentate sia l'offerta sia la domanda nel segmento del biologico.<br />
Poiché i prezzi di alcuni prodotti biologici vengono osservati soltanto dal 2010-2011,<br />
non è sempre possibile effettuare un confronto pluriennale. Laddove possibile, è stata osservata<br />
un'evoluzione al rialzo dei prezzi nel commercio al dettaglio, con singole eccezioni.<br />
Nel 2015 i prezzi dei latticini prodotti secondo metodi biologici sono evoluti in maniera differenziata.<br />
Dal 2010 i prezzi del latte da bere sono aumentati, per poi ristagnare e diminuire<br />
leggermente nell'ultimo anno (analogamente all'evoluzione dei prezzi nella produzione).<br />
Per la carne biologica nel 2015 i prezzi sono per lo più aumentati (eccezione: carne di suino<br />
e singoli prodotti carnei); in particolare per la carne bovina (di manzo e di vitello) tutti i tagli<br />
pregiati hanno subito rincari.<br />
Per le uova biologiche tra il 2002/04 e il 2013/15 i prezzi sono rimasti relativamente costanti.<br />
L'incremento di prezzo per le uova crude si attesta all'1,2 per cento (2015: 81.1 ct./uovo) e<br />
per quelle sode al 2,1 % (2014: 95.93 ct./uovo).<br />
Anche per le patate biologiche i prezzi sono complessivamente aumentati nel confronto pluriennale<br />
(eccezione: patate da raclette). Nel 2015, rispetto all'anno precedente, i prezzi sono<br />
diminuiti, a causa della scarsa offerta registrata nel 2014, il che ha determinato forti rincari.<br />
Anche i prezzi della frutta biologica tra il periodo 2002/05 e 2012/15 sono aumentati (eccezione:<br />
fragole negli anni 2002/04 - 2013/15). Per le prugne l'incremento è stato di oltre il 40<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
85
Il mio Rapporto agricolo 14 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
per cento. Rispetto al 2014, nel 2015 fragole e mele (Golden Delicious) hanno segnato un calo<br />
di prezzo.<br />
Per la verdura biologica non si sono osservate evoluzioni di prezzo uniformi. Mentre le verdure<br />
destinate all'immagazzinamento, ossia sedano rapa, cipolle, carote nonché lattuga cappuccio<br />
biologici nel periodo 2013/15 hanno registrato rincari nel commercio al dettaglio rispetto al<br />
periodo 2002/04, i prezzi dei pomodori (tondi) e dei cetrioli sono diminuiti. Rispetto al 2014,<br />
nel 2015 la verdura biologica osservata, tranne i cetrioli, è rincarata.<br />
» A28<br />
Prezzi nella fornitura e nell’acquisto all’ingrosso<br />
Gli addetti alla ristorazione e i consumatori privati possono avere accesso a un ampio assortimento<br />
di alimenti in confezioni di dimensioni più grandi, mediante una carta di acquisto, grazie<br />
alla fornitura e all’acquisto all’ingrosso. Dal 2013 pertanto vengono osservati anche i prezzi a<br />
livello di fornitura e acquisto all’ingrosso.<br />
Prezzi, biologico escluso<br />
Per quanto riguarda i latticini sono stati smerciati prevalentemente latte intero standardizzato<br />
UHT (1.23 fr./l), panna intera (5.88 fr./l), yogurt (3.65 fr./l), mozzarella (8.28 fr./kg) e burro<br />
(12.75 fr./kg). Rispetto all'anno precedente i prezzi dei prodotti osservati nel 2015 sono per<br />
lo più diminuiti, ad eccezione del formaggio (Gruyère) e del latte scremato oggetto di offerte<br />
promozionali.<br />
Nel segmento della carne fresca è stata venduta prevalentemente carne di manzo (31,0 %)<br />
e di suino (36,9 %). La quota d'importazione ammonta, in tutto il segmento, a circa il 15 per<br />
cento. I tagli preferiti sono entrecôte di manzo (35.37 fr./kg), carne macinata bovina (11.77<br />
fr./kg), costolette di maiale (11.38 fr./kg) e petto di pollo (18.93 fr./kg). Mentre la carne di<br />
manzo, in particolare quella macinata, tendenzialmente è rincarata, per la carne di suino si<br />
sono osservate vendite promozionali su vasta scala.<br />
Per le uova la quota d'importazione nel commercio all’ingrosso è aumentata nettamente rispetto<br />
a quella nel commercio al dettaglio. Le uova di allevamento al suolo importate, crude e<br />
sode, costituiscono circa il 54 per cento dell'intera offerta di uova in guscio. Il motivo risiede<br />
principalmente nel prezzo; le uova crude, contrariamente a quelle provenienti da allevamento<br />
al suolo indigene (41.3 ct./uovo), sono più economiche di oltre il 25 per cento (29 ct./uovo).<br />
Per le patate le varietà più vendute sono quelle resistenti alla cottura nonché quelle della categoria<br />
«patate da tavola per alte temperature», particolarmente adatte per essere arrostite<br />
e fritte. Rispetto al 2014 i prezzi in generale sono aumentati (eccezione: patate da tavola per<br />
alte temperature).<br />
Tra la verdura osservata le carote e i pomodori hanno registrato le vendite maggiori. Nel 2015<br />
i prezzi si sono attestati tra 1.62 fr./kg e 2.80 fr./kg. In generale i prezzi dei prodotti osservati<br />
hanno subito un incremento (eccezione: carote).<br />
» A29<br />
Prezzi dei prodotti biologici<br />
Lo smercio di prodotti biologici nel commercio all'ingrosso è ancora esiguo. Contrariamente al<br />
commercio al dettaglio, il biologico nella ristorazione non riveste ancora una grande importanza.<br />
Nell'ultimo anno gli acquisti di latticini biologici non sono stati degni di nota.<br />
Anche per la carne fresca nel 2014 sono stati smerciati soltanto scarsi quantitativi di prodotti<br />
biologici. La quota di mercato, sia per la carne di manzo sia per quella di vitello e di suino, è<br />
86<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 15 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
inferiore allo 0,1 per cento. Il livello di prezzo, rispetto ai prodotti convenzionali, si attesta tra<br />
il 20 (per la carne di vitello) e il 90 per cento (per la carne suina).<br />
Le uova biologiche nel commercio all’ingrosso detengono una quota di mercato di circa l'1,2<br />
per cento. Nel 2014 il prezzo delle uova biologiche crude, con 59.9 ct./uovo, supera il prezzo<br />
di un uovo crudo da allevamento al suolo di circa il 30 per cento.<br />
Anche le patate biologiche sono relativamente poco vendute nel commercio all'ingrosso; la<br />
loro quota di mercato nel 2014 è stata inferiore allo 0,1 per cento. I prezzi superano quelli dei<br />
prodotti convenzionali, con oscillazioni che vanno dal 40 al 90 per cento. Si osserva lo stesso<br />
scenario per i prodotti a base di verdura selezionati, come carote e pomodori.<br />
Prezzi al consumo<br />
Negli ultimi anni i prezzi al consumo in Svizzera si sono sviluppati in maniera molto diversa.<br />
Nel 2015 importanti fattori che hanno influito sull'evoluzione dei prezzi sono stati l'abolizione<br />
della soglia minima per il cambio EURO-CHF e il conseguente turismo degli acquisti verso i Paesi<br />
limitrofi.<br />
» A30<br />
Prezzi, biologico escluso<br />
I prezzi dei latticini hanno segnato una diminuzione netta, salve poche eccezioni. Alcuni formaggi,<br />
come la mozzarella (-36,5 % nel confronto degli anni 2000/02-2012/14), sono diventati<br />
complessivamente più convenienti grazie al libero scambio e anche i prezzi dei prodotti della<br />
linea bianca, come il latte intero standardizzato UTH 35 g (-17,7 %), sono nettamente diminuiti.<br />
Tale sviluppo si è quindi allineato all'evoluzione dei prezzi alla produzione.<br />
Per la carne l'evoluzione è specifica per specie animale. Per la carne di manzo, vitello e agnello i<br />
prezzi sono aumentati sia rispetto agli anni 2000/02-2012/14 sia rispetto al 2014. Ciò è riconducibile<br />
alla crescente quota di label nell'assortimento per cui la produzione, e anche i prodotti<br />
smerciati, sono rincarati. Per la carne di suino, invece, l'evoluzione è stata complessivamente<br />
negativa. Nel periodo tra il 2000/02 e il 2012/14 i tagli dei singoli pezzi di carne sono diminuiti<br />
di oltre il 10 per cento (spezzatino, spalla), per quelli più pregiati la differenza era minore (p.es.<br />
1,2 per cento per la fettina). Occorre comunque ricordare che, oltre alla tendenza al consumo<br />
di carne povera di grassi, anche il rapporto tra offerta e domanda ha una notevole influenza sul<br />
prezzo della carne di suino (il che si ripercuote sul ciclo di produzione del maiale).<br />
I prezzi al consumo delle uova sono evoluti in maniera differenziata. Mentre dal 2002/04 i<br />
prezzi delle uova importate e delle uova crude da allevamento al suolo sono diminuiti (fino al<br />
16 per cento per le uova da allevamento al suolo importate, sode), le uova sode svizzere sono<br />
rincarate (+9,3 % per le uova da allevamento all'aperto, sode).<br />
I prezzi di farina e pane dal 2012 sono rimasti piuttosto costanti.<br />
Per le patate, i prezzi sono fortemente influenzati dall'offerta e dalla domanda. Mentre i prezzi<br />
nel 2013 sono rincarati in seguito allo scarso raccolto, nel 2014 sono notevolmente diminuiti.<br />
Comparando il periodo tra il 2005 e il 2012/14, ad eccezione delle patate novelle da tavola, si<br />
è constatata un'evoluzione dei prezzi al ribasso. Ciò è dovuto, tra le altre cose, alla crescente<br />
domanda di prodotti convenience e alla conseguente riduzione di prezzo come reazione del<br />
commercio al dettaglio per contrastare la diminuzione di consumo di patate fresche.<br />
Lo zucchero cristallizzato nel periodo tra il 2000/02 e il 2012/14 è diventato nettamente più<br />
conveniente (-16,8 %; 1.18 fr./kg nel 2014). Tale sviluppo si è quindi allineato all'evoluzione<br />
dei prezzi alla produzione.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
87
Il mio Rapporto agricolo 16 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
Per la frutta prodotta in modo convenzionale, i prezzi dei singoli prodotti sono evoluti in maniera<br />
differente. Nel 2014 i prezzi al dettaglio di mele (Golden Delicious), albicocche e fragole<br />
sono aumentati rispetto all'anno precedente. Pere (Conférence), ciliegie e prugne, invece,<br />
sono state offerte a prezzi inferiori. L’osservazione sul lungo periodo indica un ribasso dei<br />
prezzi delle mele Golden Delicious e delle pere Conférence tra il 2000/02 e il 2012/14 (-6,7 %;<br />
-0,7 %). Nello stesso periodo albicocche, fragole, ciliegie e prugne hanno registrato un rincaro<br />
fino al 35 per cento (+35,7 %, +24,1 %, +20,9 %; +19,5 %).<br />
Come per la frutta, anche i prezzi della verdura prodotta convenzionalmente sono evoluti in<br />
maniera differente. Nel periodo compreso tra il 2000/02 e il 2012/14 sono aumentati i prezzi<br />
delle verdure destinate all'immagazzinamento, ossia sedano rapa (+27,2 %, 2014: 4.94 fr./<br />
kg), carote (+16,3 %, 2014: 2.49 fr./kg) e cipolle (+5,6 %, 2014: 2.42 fr./kg) nonché pomodori<br />
(tondi) (+6,2 %, 2014: 3.79 fr./kg) e lattuga cappuccio (+3,1 %, 2014: 1.72 fr./pz.). Nello<br />
stesso periodo hanno registrato una diminuzione di prezzo cetrioli (-7,9 %, 2014: 1.42 fr./pz.)<br />
e cavolfiori (-1,2 %, 2014: 3.89 fr./kg).<br />
» A31<br />
Prezzi dei prodotti biologici<br />
Nel commercio al dettaglio sono aumentate sia l'offerta sia la domanda nel mercato del biologico.<br />
Poiché i prezzi di alcuni prodotti biologici vengono osservati soltanto dal 2010-2011,<br />
non è sempre possibile effettuare un confronto decennale. Laddove possibile, è stata osservata<br />
un'evoluzione al rialzo dei prezzi nel commercio al dettaglio, con singole eccezioni.<br />
I prezzi dei latticini prodotti secondo metodi biologici sono evoluti in maniera differenziata<br />
(fino a +5 % per il latte intero standardizzato UHT, 2014: 1.81 fr./l). Dal 2010 i prezzi del latte<br />
da bere sono aumentati. I prodotti molto elaborati come ad esempio lo yogurt, il formaggio e<br />
il burro, invece, hanno segnato un calo del prezzo, benché nel 2014 per la maggior parte dei<br />
prodotti è stato constatato tendenzialmente un lieve incremento di prezzo rispetto all'anno<br />
precedente.<br />
Per la carne biologica dal 2011 i prezzi sono aumentati notevolmente (eccezione: pollo e singoli<br />
prodotti carnei); per i bovini (carne di manzo e di vitello) sono stati registrati maggiori<br />
rincari rispetto alla carne suina.<br />
Per le uova biologiche i prezzi sono rimasti relativamente costanti nel periodo tra il 2002/04 e<br />
il 2012/2014. L'incremento di prezzo per le uova crude si è attestato allo 0,7 per cento (2014:<br />
82.1 ct./uovo) e per le uova sode allo 0,3 per cento (2014: 93.69 ct./uovo), anche a causa<br />
dell'integrazione verticale nella produzione e nella trasformazione.<br />
Anche per le patate biologiche i prezzi sono complessivamente aumentati nel confronto decennale<br />
(eccezione patate da raclette). Nel 2014, rispetto al 2013, i prezzi sono nuovamente<br />
diminuiti, a causa della scarsa offerta registrata nel 2013, il che ha determinato maggiori rincari.<br />
Anche i prezzi della frutta biologica sono aumentati nel confronto decennale tra gli anni<br />
2002/04 e 2012/14 (eccezione fragole). Per le prugne l'incremento è stato di oltre il 40 per<br />
cento.<br />
Per la verdura biologica non si sono osservate evoluzioni di prezzo uniformi. Mentre le verdure<br />
destinate all'immagazzinamento, ossia sedano rapa, cipolle, carote nonché lattuga cappuccio<br />
biologici nel periodo 2012/14 hanno registrato rincari nel commercio al dettaglio rispetto al<br />
periodo 2002/04, i prezzi dei pomodori (tondi) e dei centrioli sono diminuiti.<br />
88<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 17 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
Confronto tra il paniere delle merci biologico e quello non biologico<br />
» A32<br />
» A33<br />
Il paniere delle merci corrisponde al consumo mensile di alimenti selezionati (una volta prodotti<br />
biologici incl. e una volta escl.) di una famiglia di quattro persone (due adulti, due bambini).<br />
Esso non considera il consumo totale, bensì determinati prodotti, significativi dal profilo<br />
dell’agricoltura.<br />
Rispetto all'anno precedente le spese per il paniere delle merci convenzionali sono rimaste<br />
pressoché costanti (-0,2 %) e si sono attestate a 132.12 franchi. Ma sul piano del paniere delle<br />
merci parziale si evince che le spese per prodotti di origine animale (latticini, carne e uova)<br />
sono diminuite. In particolare prodotti con carne di suino (p.es. scaloppine e wienerli) sono<br />
diventati più convenienti. Per il paniere delle merci parziale dei prodotti di origine vegetale le<br />
spese, invece, sono in media aumentate, a livello di prodotto a volte di oltre il 10 per cento<br />
(zucchine).<br />
Anche le spese per il paniere delle merci biologico sono leggermente diminuite attestandosi a<br />
190.16 franchi (-0,3 %). Al contrario, il paniere delle merci senza i prodotti biologici ha segnato<br />
un calo delle spese per il paniere delle merci parziale con prodotti di origine vegetale (eccezione:<br />
farina bianca, +4,1 %). Soltanto il paniere delle merci parziale della carne ha segnato<br />
un lieve rincaro (+0,8 %), a causa soprattutto dell'aumento dei prezzi della carne di manzo e<br />
di pollo.<br />
Il confronto tra i due panieri delle merci mostra che rispetto al 2014 i prezzi dei panieri delle<br />
merci parziali sono evoluti in maniera diversa, in particolare per quanto riguarda carne, patate,<br />
frutta e verdura. Il rapporto tra le spese dei due panieri delle merci è rimasto invece costante.<br />
Il supplemento bio (differenza percentuale tra le spese dei panieri delle merci bio e non bio)<br />
ammonta, come l'anno precedente, a 43,9 per cento.<br />
Cornel Herrmann, UFAG, Settore Osservazione del mercato, cornel.herrmann@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
89
Il mio Rapporto agricolo 25 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
Competitività del settore lattiero<br />
L'aumento della competitività del settore agroalimentare svizzero è un aspetto fondamentale<br />
della politica agricola. Con la valutazione del franco nel 2015, alla luce della crescente risonanza<br />
del turismo degli acquisti e degli sviluppi internazionali sul piano dei negoziati per accordi<br />
di libero scambio, la valenza della competitività internazionale sta aumentando. Alcuni<br />
mercati parziali, ad esempio quello caseario, sono stati già liberalizzati nei confronti dell'UE,<br />
è ora quindi il caso di interrogarsi su quanto sia competitiva la filiera agroalimentare svizzera<br />
rispetto alla concorrenza internazionale.<br />
Per competitività s'intende come il settore è in grado di ottenere e difendere in modo sostenibile<br />
la quota di mercato sui mercati indigeni ed esteri (cfr. Weindlmeier 1998). Per poter osservare<br />
la competitività dei vari settori a lungo termine il PF di Zurigo, su incarico dell'UFAG, ha<br />
elaborato un sistema di monitoraggio (cfr. Aepli e Kuhlgatz 2015).<br />
Di seguito tale sistema di monitoraggio viene applicato al settore lattiero svizzero. Nel concreto<br />
si analizza la competitività del settore lattiero e della trasformazione del latte. Inoltre sono<br />
esaminati nel dettaglio prodotti quali formaggio fresco e formaggio a pasta dura.<br />
Analisi della struttura della categoria<br />
La competitività dei singoli livelli della catena del valore è analizzata mediante indicatori per<br />
la struttura aziendale. Sono utilizzati i seguenti indicatori.<br />
• Produttività del lavoro: la produttività del lavoro è un fattore determinante della competitività<br />
poiché influenza i prezzi attraverso i costi del lavoro.<br />
• Dimensione dell’azienda, produttività del capitale, produttività delle superfici: questi indicatori<br />
mostrano in quale misura sono presenti eventuali vantaggi mediante la dimensione<br />
dell’azienda (economie di scala).<br />
• Valore aggiunto: il valore aggiunto lordo indica la redditività del settore. È calcolato a partire<br />
dal valore di produzione lordo del settore considerato meno i costi dei consumi intermedi.<br />
Per la produzione agricola si utilizza il cash flow del ramo aziendale in questione.<br />
Il calcolo degli indicatori è illustrato nel glossario alla fine del presente contributo.<br />
Competitività del settore lattiero<br />
Per stabilire la competitività del settore lattiero a livello internazionale, vengono analizzati<br />
dati delle aziende specializzate nella detenzione di lattifere in Svizzera e nei Paesi limitrofi.<br />
I dati provengono dall'International Farm Comparison Network (IFCN) a cui, per la Svizzera,<br />
partecipa Agroscope. Le aziende comparate sono diffuse in tutti i Paesi, si tratta di aziende<br />
tipiche che tuttavia non sono rappresentative a livello nazionale. Per la Svizzera nel confronto<br />
è utilizzata una tipica azienda nella zona collinare con 23 vacche nel 2014. Per la dimensione è<br />
paragonabile con le aziende dell’Austria (16 vacche) e della Germania del sud (30 vacche). Le<br />
aziende in Francia (66 vacche), Germania del nord (126 vacche) e della Pianura Padana in Italia<br />
(154 vacche) sono nettamente più grandi. Il confronto può spiegare in quale misura diverse<br />
strutture aziendali influenzano la competitività a livello internazionale.<br />
Nella seguente figura, nella parte superiore, si illustra come la produttività e il reddito delle<br />
aziende svizzere sono evoluti tra il 2012 e il 2014.<br />
90<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 26 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
Nel periodo sotto osservazione la produttività del lavoro è leggermente aumentata: nel 2014<br />
in un'ora di lavoro si è ottenuto circa 1,3 kg di latte in più rispetto al 2012. Anche la produttività<br />
della superficie è aumentata costantemente nel periodo 2012-2014. La produttività del<br />
capitale, invece, non ha registrato alcun incremento. Il cash flow della produzione lattiera tra<br />
il 2012 e il 2014 ha subito nette oscillazioni e non ha mostrato una tendenza uniforme.<br />
Nella parte inferiore della figura è illustrato come interpretare i valori nel contesto internazionale<br />
nel 2014. Ad ogni lato del grafico radar si trova uno degli indicatori della competitività<br />
citati. Quanto più un Paese è indicato all'esterno, tanto più è competitivo per quanto<br />
riguarda l'indicatore considerato. Per tenere conto del diverso contesto dei costi delle aziende<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
91
Il mio Rapporto agricolo 27 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
confrontate, l'indicatore cash flow è stato considerato a parità di potere d'acquisto. La linea<br />
nera indica il valore medio dei Paesi confrontati. L’azienda svizzera è contrassegnata con una<br />
linea blu. Per ogni indicatore si trova al di sotto della linea nera e, rispetto alle altre aziende,<br />
presenta una competitività inferiore alla media. La produzione lattiera svizzera, ad alta intensità<br />
di capitale e caratterizzata da piccole strutture, è analoga alle aziende dell’Austria e<br />
della Germania del sud e realizza un reddito comparabile. Tuttavia rispetto alle aziende della<br />
Francia, Germania del nord e Italia del nord, la competitività è debole. Oltre alla dimensione<br />
dell'azienda, anche il sistema di produzione influisce sulla produttività. Un'elevata quota di<br />
foraggio grezzo nella razione, com’è consuetudine in Svizzera, incide sulla produttività del lavoro,<br />
riducendola.<br />
Gli indicatori sono influenzati dalle misure di politica agricola in ciascuno dei Paesi confrontati.<br />
In Svizzera i pagamenti diretti, la protezione doganale per latte e latticini e i supplementi per il<br />
latte trasformato in formaggio hanno un effetto positivo sui ricavi mentre ad esempio la protezione<br />
doganale per i foraggi determina costi più elevati nella produzione lattiera. Con l'influsso<br />
delle misure statali sui ricavi e sui costi sono influenzate anche le decisioni degli agricoltori in<br />
materia di produzione. Nel presente contributo è presa in considerazione la competitività alle<br />
condizioni quadro politiche date (Traill e Pitts 1998).<br />
Competitività nella trasformazione del latte<br />
La competitività degli addetti alla trasformazione del latte è misurata mediante dati delle statistiche<br />
aziendali strutturali di Eurostat e dell'UST. In base alla diversa disponibilità di dati,<br />
si calcola la competitività per gli anni 2011-2013 a questo livello della catena del valore e la<br />
si misura sulla scorta della produttività del lavoro dal profilo quantitativo, della dimensione<br />
aziendale e del valore aggiunto lordo. L'evoluzione della competitività nel periodo 2011-13 è<br />
raffigurata nella parte superiore della seguente figura.<br />
92<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 28 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
Secondo i tre indicatori, la competitività della trasformazione svizzera del latte tra il 2011 e il<br />
2013 è aumentata costantemente. La produttività del lavoro nel 2013 era superiore a quella<br />
del 2011 di circa il 22 per cento. In questo periodo in numero di impiegati nel settore della<br />
trasformazione del latte è aumentato leggermente (+2 %). La dimensione aziendale tra il 2011<br />
e il 2013 è incrementata del 29 per cento, ma il numero delle aziende addette alla trasformazione<br />
del latte ha subito una flessione (-4 %). Anche il valore aggiunto nel 2013 era superiore<br />
(+28 %) rispetto a due anni prima. Va notato che il numero di impiegati e il numero di aziende<br />
sono stati rilevati soltanto all'interno del Paese mentre gli indicatori della cifra d'affari ricavata<br />
all'estero comprendono il valore di produzione e il valore aggiunto. Di conseguenza investimenti<br />
redditizi all'estero, effettuati da aziende del settore della trasformazione del latte<br />
nel periodo 2011-13, hanno un effetto positivo su tutti gli indicatori. La crescita inoltre può<br />
ad esempio essere dovuta a una nuova gamma di prodotti, misure che aumentano l'efficienza<br />
o adeguamenti nell'orientamento strategico dell'azienda.<br />
Rispetto all'estero si evince tuttavia che gli addetti alla trasformazione svizzeri sono competitivi<br />
in modo differente (cfr. grafico in basso). I tre indicatori sono a parità di potere d'acquisto<br />
per tener conto del diverso livello dei costi nei vari Paesi. Il valore aggiunto della trasformazione<br />
del latte in Svizzera è maggiore rispetto all'Austria, tuttavia è nettamente inferiore a<br />
quello di grandi Paesi quali Italia, Germania e Francia. Per quanto riguarda la produttività del<br />
lavoro la Svizzera è chiaramente dietro i Paesi presi a confronto. La trasformazione del latte in<br />
Svizzera presenta strutture più piccole rispetto alla maggior parte dei Paesi ed è praticamente<br />
sullo stesso livello dell'Italia per la dimensione aziendale media. Non possono essere pertanto<br />
utilizzati a pieno eventuali effetti dell’economia di scala nella trasformazione del latte.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
93
Il mio Rapporto agricolo 29 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
Analisi a livello del prodotto<br />
La trasformazione del latte comprende un'ampia gamma di prodotti e metodi di produzione<br />
considerati e interessati in modo diverso dalle misure politiche. Poiché ciò ha ripercussioni<br />
sulla competitività di singoli prodotti del settore, in seguito è analizzata la competitività di<br />
singoli gruppi di prodotti. La competitività è misurata con l'ausilio di indicatori di produzione<br />
calcolati sulla base di dati relativi ai prezzi e al commercio estero (cfr. glossario). Gli indicatori<br />
sono:<br />
• Quota d'esportazione: indica il valore delle esportazioni di un Paese rispetto alle esportazioni<br />
mondiali. Tale indicatore fornisce informazioni su come un Paese può garantire per<br />
il prodotto osservato la quota di mercato a livello internazionale. Nell'interpretazione va<br />
considerato che la Svizzera è un Paese relativamente piccolo.<br />
• Specializzazione del commercio: fornisce informazioni su come un Paese si è specializzato<br />
nel commercio di un bene (Scott e Vollrath 1992, Banca mondiale 2010). Si calcola a partire<br />
dai dati sull'importazione e sull'esportazione e segnala, con valori positivi, il grado di specializzazione<br />
del Paese superiore alla media nelle esportazioni del prodotto in questione e<br />
importazioni inferiori alla media.<br />
• Relazione prezzo-commercio estero: l'indicatore confronta il prezzo medio delle esportazioni<br />
e quello delle importazioni. Se l'indicatore è maggiore a uno, le esportazioni del prodotto<br />
in questione hanno avuto in media un prezzo maggiore rispetto alle importazioni.<br />
Elevati prezzi di esportazione possono indicare che sono esportate merci con valore elevato<br />
e nessuna merce standard intercambiabile (Weindlmeier 1998).<br />
• Rapporto prezzo estero/Svizzera: indica il rapporto tra il prezzo estero per un determinato<br />
prodotto e quello indigeno, in seguito alla conversione nella stessa valuta. Il prezzo estero<br />
è calcolato come valore medio ponderato dei prezzi dei Paesi limitrofi, anche se la quota<br />
del Paese vicino è utilizzata come peso nelle esportazioni. Se questo rapporto di prezzo<br />
è maggiore a uno, indica un'elevata competitività poiché un acquirente con un bilancio<br />
fisso può comprare una quantità maggiore del prodotto in questione all'interno del Paese<br />
rispetto all'estero. Tale indicatore misura sia l'evoluzione dei prezzi sia del cambio di corso.<br />
Competitività del formaggio fresco<br />
Gli indicatori di competitività del formaggio fresco sono rappresentati nella seguente figura.<br />
94<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 30 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
La quota d'esportazione nel 2015 si è attestata a 0,48 per cento ed ha segnato un lieve calo rispetto<br />
alla media del periodo 2011-14. Inoltre la specializzazione del commercio con 1,18 punti,<br />
è decisamente negativa. Ciò è dovuto al fatto che la Svizzera ha una quota d'esportazione inferiore<br />
alla media e allo stesso tempo importa molto formaggio fresco superando i livelli medi.<br />
La Svizzera nella relazione prezzo-commercio estero ha un valore prossimo a 1. Quindi i prezzi<br />
medi delle esportazioni e importazioni di formaggio fresco sono relativamente simili. Il rapporto<br />
prezzo estero/Svizzera è stato calcolato con i prezzi al dettaglio della mozzarella e mostra<br />
che la Svizzera presenta prezzi più cari rispetto agli altri Paesi oggetto del confronto. Nel 2015<br />
gli effetti del franco forte sono stati inferiori per la mozzarella rispetto a ciò che è stato il caso<br />
per altri prodotti osservati, perché i prezzi della mozzarella sono aumentati anche all'estero.<br />
Nel confronto internazionale della competitività la Svizzera per quanto riguarda il formaggio<br />
fresco si posiziona al di sotto della media. Soprattutto il basso rapporto di prezzo estero/ Svizzera<br />
indica una situazione di competitività sfavorevole. La Svizzera ha un valore simile all'Italia<br />
per quanto riguarda la specializzazione del commercio, tuttavia la situazione è diversa. L'Italia<br />
presenta la maggiore quota d'esportazione di formaggio fresco tra tutti i Paesi oggetto del confronto<br />
ma allo stesso tempo una quota d'importazione ancora più elevata. L'indicatore della<br />
specializzazione del commercio considera tale commercio di transito e presenta un valore basso<br />
per l'Italia. Nella relazione prezzo-commercio estero l'Italia ha invece il valore maggiore. Si<br />
evince che per il formaggio fresco il prezzo d'esportazione è nettamente maggiore rispetto a<br />
quello d'importazione.<br />
Competitività del formaggio a pasta dura<br />
La seguente figura mostra la situazione della competitività per il formaggio a pasta dura.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
95
Il mio Rapporto agricolo 31 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
Contrariamente al formaggio fresco, il formaggio a pasta dura svizzero registra un andamento<br />
positivo per la maggior parte degli indicatori. La Svizzera, con il 3,48 per cento, ha una quota<br />
d'esportazione comparativamente elevata che inoltre è aumentata rispetto alla media degli<br />
anni 2011-14. Di conseguenza anche la specializzazione del commercio ha segnato un andamento<br />
positivo: il valore 1,05 è nettamente superiore allo zero e quindi mostra che la Svizzera<br />
presenta una specializzazione del commercio nel formaggio a pasta dura. La relazione<br />
prezzo-commercio estero con un valore superiore a 1 indica che le esportazioni di formaggio<br />
a pasta dura in media presentano un prezzo maggiore rispetto alle importazioni. La Svizzera<br />
importa quindi formaggio a pasta dura a un prezzo comparativamente basso ed esporta tendenzialmente<br />
specialità che spuntano sul mercato mondiale un prezzo più elevato. Il rapporto<br />
prezzo-commercio estero è stato calcolato con i prezzi al dettaglio dell'Emmentaler e, contrariamente<br />
agli indicatori precedenti, denota un andamento negativo. A causa del corso di cambio<br />
96<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 32 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
e dell'andamento dei prezzi in Svizzera e all'estero, l'Emmentaler svizzero nel 2015 ha registrato<br />
un ulteriore rincaro rispetto agli anni 2011-14.<br />
Rispetto agli altri Paesi vicini, la Svizzera presenta una specializzazione del commercio nel<br />
formaggio a pasta dura superiore alla media. Nel commercio internazionale è più specializzata<br />
nel formaggio a pasta dura rispetto alla maggior parte degli altri Paesi (eccezione: Francia). Al<br />
contrario la Germania presenta una specializzazione del commercio negativa nonostante una<br />
quota d'esportazione comparativamente elevata (12,9 %), poiché importa anche molto formaggio<br />
a pasta dura. Il basso valore dell'indicatore nel rapporto di prezzo estero/Svizzera indica<br />
una situazione di competitività sfavorevole per il formaggio svizzero a pasta dura.<br />
Conclusioni<br />
L'economia lattiera, dopo la liberalizzazione del mercato caseario con l'UE, è esposta a una<br />
certa pressione concorrenziale. L'analisi della competitività con l'ausilio degli indicatori presentati<br />
mostra che la categoria, nel confronto internazionale, in molti aspetti presenta ancora<br />
una competitività al di sotto della media. A causa della limitata disponibilità di dati, soprattutto<br />
per gli indicatori strutturali, al momento è impossibile esprimersi in merito all'evoluzione<br />
a lungo termine.<br />
Gli indicatori presentati forniscono informazioni sugli aspetti parziali della competitività e dovrebbero<br />
essere interpretati con cautela. Anche le misure statali influenzano la competitività<br />
osservata (Frohberg e Hartmann 1997). Per una stima adeguata della competitività internazionale<br />
è utile avvalersi di quanti più indicatori di competitività possibili.<br />
Bibliografia<br />
Aepli, M. e C. Kuhlgatz (2015). Entwicklung eines Monitorings zur Analyse der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer<br />
Agrarwertschöpfungskette. Gruppo Agroeconomia, Institut für Umweltentscheidungen, PF Zurigo, Zurigo.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
97
Il mio Rapporto agricolo 33 / 93<br />
MERCATO > EVOLUZIONE DEI MERCATI<br />
Frohberg, K. e M. Hartmann (1997), Comparing measures of competitiveness. Institute of Agricultural Development<br />
in Central and Eastern Europe (IAMO), Halle.<br />
Hemme, T. (editore) (2013). IFCN Dairy Report 2013, IFCN, Kiel.<br />
Hemme, T. (editore) (2014). IFCN Dairy Report 2014, IFCN, Kiel.<br />
Hemme, T. (editore) (2015). IFCN Dairy Report 2015, IFCN, Kiel.<br />
OCSE (2015): OECD Review of Agricultural Policies: Switzerland 2015, OECD Publishing, Parigi. http://<br />
dx.doi.org/10.1787/9789264168039-en<br />
Scott, L. e T. Vollrath (1992). Global Competitive Advantages and Overall Bilateral Complementarity in Agriculture: A<br />
Statistical Review. Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, Washington.<br />
Traill, W. B. e Pitts, E. (1998). Competitiveness in the Food Industry. Blackie Academic & Professional, Londra.<br />
Weindlmeier, H. (1999). Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Ernährungswirtschaft: Methodische Ansatzpunkte<br />
zur Messung und empirische Analyse, relazione al quarantesimo convegno annuale della Gesellschaft für Wirtschaftsund<br />
Sozialwissenschaften, Kiel.<br />
Weltbank (2010). World Integrated Trade Solution (WITS). 2005, Washington DC.<br />
Christian Kuhlgatz, UFAG, Settore Osservazione del mercato, christian.kuhlgatz@blw.admin.ch<br />
98<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 34 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE<br />
Cereali<br />
Nel 2015 la superficie messa a cereali è stata di circa 144 000 ettari, registrando un esiguo<br />
incremento rispetto all'anno precedente. Per i cereali panificabili si è rilevata una marginale<br />
diminuzione delle superfici mentre per i cereali da foraggio si è riscontrato un lieve incremento.<br />
Le rese, però, sono state buone: circa 890 000 tonnellate di cereali.<br />
» A34<br />
» A35<br />
Superficie agricola utile secondo le forme di utilizzo<br />
Produzione<br />
Qualità dei cereali<br />
Il tempo secco nella fase di maturazione e di raccolto del frumento ha determinato che soltanto<br />
una quantità straordinariamente bassa di frumento panificabile (circa 1000 t) non adempiva<br />
le esigenze di molitura e ha pertanto dovuto venire utilizzata per l'alimentazione animale.<br />
Nell'anno precedente è stato necessario destinare a tale uso circa 100 000 tonnellate. Secondo<br />
le stime dell’associazione di categoria swiss granum, le tonnellate di cereali panificabili indigeni<br />
adatti alla molitura erano circa 465 000; di queste la Federazione svizzera dei produttori<br />
di cereali ne ha destinate 53 000 all’alimentazione animale al fine di sostenere il prezzo dei<br />
cereali panificabili. Nonostante il declassamento di lotti con scarsa qualità, nel confronto pluriennale<br />
complessivamente è risultato un tenore inferiore di proteine e una minore qualità del<br />
glutine umido.<br />
Gestione alla frontiera dei cereali panificabili<br />
Per le importazioni di cereali panificabili nel quadro del contingente doganale di 70 000 tonnellate<br />
si applica un prezzo di riferimento e si valuta trimestralmente la protezione variabile<br />
alla frontiera. Considerato che sui mercati internazionali i prezzi del frumento panificabile<br />
sono a un livello basso da ottobre 2013, da allora nel quadro del contingente doganale dei cereali<br />
panificabili si applica solo il tributo doganale massimo (aliquota di dazio e contributo al<br />
fondo di garanzia) di 23 franchi il quintale. In seguito al raccolto di cattiva qualità del 2014,<br />
l'organizzazione di categoria swiss granum nell'anno oggetto del rapporto ha richiesto un incremento<br />
temporaneo del contingente doganale dei cereali panificabili di 20 000 tonnellate.<br />
Nel quadro del pacchetto di ordinanze di primavera concernente la politica agricola, il Con-<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
99
Il mio Rapporto agricolo 35 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE<br />
siglio federale ha dato seguito a tale richiesta incrementando il contingente doganale dei cereali<br />
panificabili a 90 000 tonnellate per il 2015. I quantitativi liberati a gennaio e aprile 2015<br />
sono stati portati entrambi da 20 000 a 30 000 tonnellate, quello di luglio da 15 000 a 20 000<br />
tonnellate. Il quantitativo parziale del contingente doganale liberato a ottobre 2015 è stato<br />
invece ridotto da 15 000 a 10 000 tonnellate.<br />
» A36<br />
Commercio estero<br />
Foraggi concentrati<br />
A causa delle minori rese del mais da granella e del ridimensionamento della superficie coltiva<br />
dettato da un maggior fabbisogno di mais da insilamento e verde, nel 2015 la produzione di cereali<br />
da foraggio è diminuita. Tenendo conto del quantitativo di cereali panificabili declassato<br />
dalla Federazione svizzera dei produttori di cereali pari a 53 000 tonnellate, per l'alimentazione<br />
degli animali da reddito erano a disposizione circa 455 000 tonnellate di cereali. A integrazione<br />
dei sottoprodotti dell'industria alimentare sono stati importati cereali da foraggio e prodotti<br />
campicoli proteici.<br />
» swiss granum<br />
Hans-Ulrich Tagmann, UFAG, Settore Prodotti vegetali, hans-ulrich.tagmann@blw.admin.ch<br />
100<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 39 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE<br />
Semi oleosi<br />
Produzione e rese<br />
La produzione svizzera di semi oleosi si basa su contratti quadro stipulati tra la produzione<br />
e la trasformazione (oleifici), gestiti dal «pool di produzione semi oleosi» della Federazione<br />
svizzera dei produttori di cereali (FSPC), il quale è finanziato per due terzi dai produttori e un<br />
terzo dagli oleifici.<br />
Produzione di semi e olio - 2015<br />
Contratti quadro<br />
(semi)<br />
Produzione di semi Produzione di olio Grado di autoapprovvigionamento<br />
t t t %<br />
Colza 82 000 87 004 32 191 83<br />
Girasole 18 000 9782 3325 6<br />
Soia 3500 1 4054 527 27<br />
¹ 2000 tonnellate nel settore foraggero<br />
Fonti: swiss granum/SwissOlio<br />
La produzione di girasole normalmente raggiunge solo la metà della quantità contrattuale. A<br />
tal proposito il 2015 non fa eccezione. Diverso è il caso della colza: dopo il raccolto eccezionale<br />
del 2014, quello del 2015 è stato ancora molto elevato. Anche se gli addetti alla trasformazione<br />
hanno accettato di trasformare una quantità superiore a quella inizialmente prevista, sono rimaste<br />
circa 6 500 tonnellate da immagazzinare. Le attribuzioni del 2015 sono state effettuate<br />
nella primavera 2014, ovvero prima del raccolto eccezionale dell'anno in questione, pertanto<br />
non era possibile agire immediatamente a livello della produzione. Di conseguenza, per riassorbire<br />
le scorte immagazzinate nel 2014 e ripristinare un certo equilibrio, si prevede che le<br />
attribuzioni per il 2016 siano corrette fortemente al ribasso.<br />
» A34<br />
» A35<br />
Superficie agricola utile secondo le forme di utilizzo<br />
Produzione<br />
Quote di mercato e importazioni<br />
Con una quota di mercato del 34,3 per cento il consumo di olio di girasole è diminuito rispetto al<br />
2014 (-3,4 %) ma resta tuttavia l'olio alimentare più consumato in Svizzera. Si tratta di un olio<br />
prevalentemente importato. Anno dopo anno, l'incremento della quota di mercato dell'olio di<br />
colza è proseguito fino a raggiungere quota 27,3 per cento nel 2015 (+7 % rispetto al 2014).<br />
Con una quota di mercato inferiore all’1 per cento, la valenza dell’olio di soia resta irrilevante.<br />
Per quanto concerne gli oli importati, quelli di palma e d’oliva registrano quote di mercato<br />
elevate, rispettivamente del 15,2 e del 9,4 per cento. Da notare che se la quota di mercato<br />
dell'olio d’oliva è lievemente evoluta negli ultimi 10 anni, quella dell'olio di palma è diminuita<br />
dal 2011, passando dal 18,7 al 15,2 per cento.<br />
Fonte: SwissOlio<br />
» A36<br />
Commercio estero<br />
Arnaud de Loriol, UFAG, Settore Prodotti vegetali, arnaud.deloriol@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
101
Il mio Rapporto agricolo 43 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE<br />
Patate<br />
Quantità e qualità<br />
La canicola dell'estate 2015 ha avuto un impatto negativo sul raccolto. Questo è stato di 389<br />
000 tonnellate, ovvero 115 000 tonnellate in meno rispetto al 2014. Per le due categorie principali<br />
di patate (da tavola e per l’industria) i quantitativi prodotti sono diminuiti del 27 per<br />
cento rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Le rese sono calate di circa 205 kg/ara raggiungendo<br />
quota 357 kg/ara; anche le superfici hanno registrato una flessione segnatamente del<br />
4 per cento e si sono attestate a 10 891 ettari. Il numero di produttori è diminuito del 5 per<br />
cento. Oltre alla flessione delle rese si è registrata una scarsa qualità, con una grande quantità<br />
di piccoli tuberi e praticamente l'assenza di alcune specialità (baked potato).<br />
Nel 2015 le superfici destinate alla coltivazione biologica ammontavano a 584 ettari, ovvero<br />
31 ettari in più rispetto al 2014, per un raccolto totale di 11 190 tonnellate (2014: 13 007 t).<br />
È interessante notare che dal 2000 al 2014 il numero di aziende che producono patate biologiche<br />
si è ridotto del 30 per cento, mentre la superficie riservata a questo tipo di produzione<br />
è aumentata del 22 per cento.<br />
Fonte: Bioaktuell/swisspatat<br />
Raccolto 2015<br />
Patate da tavola<br />
Patate destinate alla trasformazione<br />
Patate da semina<br />
Foraggiamento con finanziamenti privati<br />
Foraggiamento normale<br />
Esportazioni<br />
156 300 t<br />
141 000 t<br />
20 100 t<br />
9800 t<br />
51 600 t<br />
10 300 t<br />
Fonte: swisspatat<br />
Dal 2012, solo i produttori titolari di un contratto di ritiro possono usufruire del fondo di valorizzazione<br />
delle eccedenze dell’organizzazione di categoria.<br />
Gestione delle importazioni<br />
Gli accordi dell’OMC prescrivono un accesso al mercato di 22 250 tonnellate di equivalenti di<br />
patate. Questo quantitativo si suddivide tra il contingente doganale parziale n. 14.1 (patate,<br />
incluse patate da semina), con 18 250 tonnellate, e il contingente doganale parziale n. 14.2<br />
(prodotti di patate), con 4000 tonnellate. Nel 2015 il contingente doganale parziale n. 14.1 è<br />
stato temporaneamente aumentato di 18 500 tonnellate.<br />
Ripartizione del contingente parziale n. 14.1<br />
Categoria merceologica Contingente di base Aumento temporaneo del con-tingente<br />
doganale parziale<br />
Patate da semina<br />
Il mio Rapporto agricolo<br />
2500 t 1500 t<br />
44 / 93<br />
Il mio Rapporto agricolo<br />
Patate da tavola 6500 t 2000 t<br />
44 / 93<br />
» A36<br />
Patate destinate alla trasforma-zione<br />
9250 t 15 000 t<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE<br />
Totale 18 250 t 18 500 t<br />
Commercio estero<br />
Commercio estero<br />
102<br />
Arnaud de Loriol, UFAG, Settore Prodotti vegetali, arnaud.deloriol@blw.admin.ch<br />
Arnaud de Loriol, UFAG, Settore Prodotti vegetali, arnaud.deloriol@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 46 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE<br />
Zucchero<br />
» A34<br />
» A35<br />
Nel 2015 una minore superficie coltiva e un inizio d'estate caratterizzato da un clima freddo e<br />
umido seguito da caldo secco hanno fatto crollare la produzione di barbabietole da zucchero<br />
rispetto all'anno precedente del 30 per cento, che si è quindi attestata su 1,3 milioni di tonnellate.<br />
Pertanto si è registrato un calo della produzione di zucchero rispetto all'anno precedente<br />
che è passata da 305 000 a 23 400 tonnellate.<br />
Superficie agricola utile secondo le forme di utilizzo<br />
Produzione<br />
Evoluzione della redditività nella coltivazione di barbabietole da zucchero<br />
Nell'anno oggetto del rapporto il prezzo medio dello zucchero è rimasto stabile, nell'UE, passando<br />
da circa 414 a 427 euro, con un picco di 436 euro la tonnellata nell'estate 2016. Tale<br />
andamento, in combinazione con il corso di cambio, ha avuto ripercussioni sui prezzi dello zucchero<br />
svizzeri, attraverso la cosiddetta soluzione doppio zero, ovvero la rinuncia a misure di<br />
compensazione del prezzo per lo zucchero nei prodotti agricoli trasformati, che richiede prezzi<br />
dello zucchero comparabili tra Svizzera e UE allo scopo di ottenere pari opportunità per la filiera<br />
alimentare a valle.<br />
Considerate le perdite di redditività nella coltivazione di barbabietole da zucchero, nella primavera<br />
2016 il Consiglio federale ha deciso di incrementare il contributo per singole colture a<br />
favore delle barbabietole da zucchero da 1600 a 1800 franchi l'ettaro, con effetto retroattivo al<br />
1° gennaio 2016. L'incremento del contributo non ha inciso sul Preventivo poiché l'evoluzione<br />
delle superfici delle colture sostenute mediante i contributi per singole colture e il fabbisogno<br />
di fondi per la valorizzazione della frutta sono stati inferiori alle aspettative.<br />
» A36<br />
Commercio estero<br />
Con circa 99 000 tonnellate di zucchero allo stato puro importate e circa 114 000 esportate, per<br />
lo più in prodotti agricoli trasformati, si sono registrati flussi di merci in calo rispetto a quelli<br />
dell'anno precedente in entrambe le direzioni. Nel 2015 l'86 per cento delle importazioni di<br />
zucchero proveniva dall'Europa, il 7 per cento dal Sud America e il 4 per cento dall'Africa, il 10<br />
per cento dai Paesi in via di sviluppo, di cui lo 0,1 per cento da quelli più poveri.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
103
Il mio Rapporto agricolo 47 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE<br />
» A36<br />
Commercio estero<br />
» Sucre Suisse SA<br />
Hans-Ulrich Tagmann, UFAG, Settore Prodotti vegetali, hans-ulrich.tagmann@blw.admin.ch<br />
104<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 51 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE<br />
Frutta<br />
Nel 2015 la superficie totale destinata alla frutticoltura, registrata dall’Ufficio federale<br />
dell’agricoltura (UFAG) nella banca dati obst.ch (frutteti giusta l’art. 22 cpv. 2 dell’ordinanza<br />
sulla terminologia agricola OTerm), è stata pari a 6297 ettari.<br />
Superfici 2015<br />
Frutteti<br />
L’anno scorso la superfice dei meleti è diminuita complessivamente di 31 ettari (-0,8 %) raggiungendo<br />
quota 3863 ettari. In particolare è calata la superficie delle varietà Golden Delicious<br />
(-15,9 ha; -3 %), Maigold (-16,2 ha; -14 %), Idared (-13,3 ha; -14,9 %) e Jonagold (-10,9 ha;<br />
-5,2 %). Per le cosiddette varietà club (Scifresh, Milwa, Cripps Pink, ecc.) continua, come negli<br />
anni scorsi, la tendenza al rialzo (+19,5 ha) e, nonostante il forte calo della superficie per la<br />
varietà La Flamboyante (Mairac®) (-12,3 ha; -16,2 %), la superficie totale ha registrato un valore<br />
del 3 per cento superiore a quello del 2014. I pereti sono diminuiti dell'1,2 per cento (-8,9<br />
ha) rispetto al 2014, attestandosi a 752 ettari nel 2015.<br />
L'ulteriore crescita della superficie delle colture di frutta a nocciolo (+13,1 ha), attestatasi a<br />
1628 ettari, è riconducibile principalmente all'aumento di 17,4 ettari (+3,1 %) della superficie<br />
coltivata a ciliegi, che ha raggiunto 579 ettari. Oltre a quest'ultima è cresciuta anche quella<br />
messa ad albicocchi (+1 ha; +0,1 %), raggiungendo un totale di 709 ettari. La superficie dei<br />
pruneti è invece scesa a 330 ettari (-3,6 ha; -1,1 %). Per pesche e pesche noci dal 2014 al<br />
2015 il calo della superficie, attestatasi a 10 ettari, è stato ancora più forte rispetto all'anno<br />
precedente (-1,7 ha; -14,4 %).<br />
Fatta eccezione per kiwi e nashi, tutti gli altri frutteti oggetto della rilevazione hanno segnato<br />
un notevole incremento: mini-kiwi +120,2 per cento (+1 ha), cotogni +21,8 per cento (+1,4<br />
ha), sambuco +12 per cento (+1,8 ha) e noci +8,2 per cento (+0,6 ha). La superficie coltivata a<br />
kiwi è diminuita del 12,2 per cento (-2,7 ha), mentre quella messa a nashi è rimasta invariata<br />
rispetto al 2014 (0,4 ha).<br />
» Frutteti e vigneti di uva da tavola in Svizzera 2015<br />
Bacche<br />
Secondo le rilevazioni dell’Associazione Svizzera Frutta (ASF), la superficie messa a bacche,<br />
pari complessivamente a 801 ettari, ha segnato un calo di 18 ettari rispetto al 2014 (819 ha).<br />
La flessione più marcata è stata registrata per i lamponi, la cui superficie è scesa da 169,8 a 158<br />
ettari. La maggior parte della superficie messa a bacche è occupata dalle colture di fragole, che<br />
nel 2015 hanno tuttavia subito un lieve calo rispetto al 2014 (-5,2 ha).<br />
Le superfici messe a mirtilli e uva spina hanno segnato un lieve aumento, al contrario di quelle<br />
messe a ribes e more. La superficie totale delle colture di bacche non comprende quella messa<br />
a sambuco che viene considerata nella superficie totale dei frutteti.<br />
» Rapport d’activité Fruit-Union Suisse 2015<br />
Raccolti 2015<br />
Frutta da tavola<br />
Nel 2015 sono state raccolte complessivamente 160 055 tonnellate di frutta da tavola (incl.<br />
bacche), ovvero il 2 per cento in meno rispetto al 2014. Rispetto alla media del quadriennio<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
105
Il mio Rapporto agricolo 52 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE<br />
precedente, si è registrato un incremento dell'8,6 per cento. I volumi del raccolto per tipo di<br />
frutta e su un arco di tempo più lungo sono consultabili nella tabella riportata di seguito.<br />
» A35<br />
Frutta da sidro<br />
Nel 2015 il raccolto delle mele da sidro, pari a 65 207 tonnellate, non ha raggiunto il valore<br />
stimato. Rispetto all'anno precedente, ha segnato un calo del 19 per cento. Anche il raccolto<br />
di pere da sidro, pari a 11 005 tonnellate, è stato dell'11 per cento inferiore alle stime, registrando<br />
una flessione del 9 per cento rispetto all'anno precedente. Dato che il raccolto di frutta<br />
da sidro era stato molto abbondante nel 2011, gli scarsi raccolti del 2015 di mele e pere da<br />
sidro hanno segnato rispettivamente il 32 e il 22 per cento in meno rispetto alla media del periodo<br />
2011-2014.<br />
Una sintesi sul volume di frutta da sidro trasformato negli ultimi anni negli stabilimenti di<br />
ammostatura industriali è disponibile sotto: Statistiche frutta UFAG.<br />
Commercio estero 2015<br />
Frutta fresca (frutta da sidro escl.)<br />
Nel 2015 le importazioni di frutta fresca coltivabile in Svizzera, esclusa quella da sidro, si sono<br />
attestate a quasi 47 000 tonnellate, ovvero 1000 tonnellate in più rispetto al 2014 e 4 per<br />
cento in meno rispetto alla media del quadriennio precedente. Le esportazioni, pari a circa<br />
1400 tonnellate, sono state inferiori di quasi 1000 tonnellate al livello del 2014 e del 39 per<br />
cento alla media del quadriennio precedente.<br />
Frutta da sidro<br />
Nel 2015, nel quadro del contingente doganale OMC «Frutta da sidro e per la distillazione»,<br />
sono state importate 3 tonnellate di mele da sidro e 0,7 tonnellate di pere da sidro. Al di fuori<br />
del contingente, le importazioni di mele da sidro sono state, come l'anno scorso, di 6,6 tonnellate,<br />
mentre non sono state importate pere da sidro.<br />
Consumo pro capite 2015<br />
Frutta fresca (frutta da sidro escl.)<br />
Sulla base del volume di mercato della frutta selezionata, nel 2015 (produzione indigena di<br />
frutta da tavola più importazioni di frutta fresca meno esportazioni di frutta fresca, frutta da<br />
sidro e frutta esotica escl.) il consumo pro capite annuale di frutta fresca si è attestato a 24<br />
chilogrammi, segnando un aumento del 3 per cento rispetto alla media del quadriennio precedente.<br />
Dettagli sul volume di produzione svizzero, sui dati del commercio estero nonché sul «consumo<br />
pro capite tangibile» della frutta selezionata sono disponibili nelle tabelle seguenti.<br />
» A35<br />
» A36<br />
» A37<br />
Produzione<br />
Commercio estero<br />
Consumo pro capite<br />
Prezzi 2015<br />
I prezzi alla produzione e al consumo della frutta selezionata nel 2015 e negli anni precedenti<br />
sono riportati nelle tabelle seguenti.<br />
106<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 53 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE<br />
Prezzi alla produzione, bio escl.<br />
Prezzi al consumo, bio escl.<br />
» A26<br />
» A30<br />
» A31<br />
Prezzi al consumo bio<br />
Nel 2015 il prezzo di costo e quello di vendita della frutta osservata sono stati inferiori ai prezzi<br />
dell'anno precedente rispettivamente di 15 ct./kg (1.69 fr./kg) e di 30 ct./kg (4.28 fr./kg). Di<br />
conseguenza, è diminuita anche la quota del prezzo di costo sul prezzo di vendita passando dal<br />
40,2 per cento (2014) al 39,5 per cento (2015). In calo anche il margine lordo che, con 2.59 fr./<br />
kg, ha segnato un valore del 3 per cento circa inferiore alla media del quadriennio precedente<br />
(2011-2014).<br />
Marianne Glodé, UFAG, Settore Prodotti vegetali, marianne.glode@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
107
Il mio Rapporto agricolo 61 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE<br />
Verdura<br />
La superficie orticola totale (comprese le particelle coltivate a più riprese nell’arco di un anno)<br />
rilevata dalla Centrale svizzera dell’orticoltura (CSO), composta dalla superficie destinata alla<br />
coltivazione di verdure fresche (incl. quelle destinate all’immagazzinamento) e per la trasformazione,<br />
nell'anno oggetto del rapporto ha raggiunto 15 609 ettari, segnando un incremento<br />
di 676 ettari circa rispetto alla media del quadriennio precedente.<br />
Retrospettiva sui quantitativi e sulla qualità della verdura<br />
» A35<br />
» A38<br />
Nell'anno oggetto del rapporto sono state raccolte 378 875 tonnellate di verdure fresche (incl.<br />
quelle destinate all'immagazzinamento / escl. quelle per la trasformazione). Rispetto alla<br />
media del quadriennio precedente, si segnala un incremento di resa dello 0,7 per cento.<br />
Il raccolto di verdure per la trasformazione è stato di circa 52 800 tonnellate, segnando un incremento<br />
dello 0,7 per cento rispetto alla media del quadriennio precedente. I prodotti principali<br />
sono fagioli da conserva, piselli da trebbiare, carote parigine e baby nonché spinaci in<br />
foglia e tritati. Tra le altre verdure per la trasformazione si annoverano il cavolo e le rape per<br />
crauti e i cetrioli per conserva, ma anche i consueti tipi di verdura fresca destinata alla trasformazione.<br />
Nel 2015 i quantitativi sono cresciuti rispetto al quadriennio precedente, pur rimanendo al di<br />
sotto dei valori del 2014, a causa dell'estate torrida.<br />
Copertura del mercato e importazioni integrative / (esportazioni)<br />
Nell'anno oggetto del rapporto il volume di mercato dei tipi di verdura fresca coltivata in Svizzera<br />
(incl. quella fresca per la trasformazione, ma escl. le classiche verdure per la trasformazione)<br />
si è attestato a 623 000 tonnellate. Questo valore è dato dalla somma di produzione<br />
indigena e volume delle importazioni meno il volume delle esportazioni (quantitativi netti)<br />
secondo la statistica del commercio estero svizzero. Il 64 per cento di questo volume è stato<br />
prodotto in Svizzera (incl. zona franca e zona di confine estera). Negli ultimi anni, tale quota<br />
è aumentata in maniera lieve, ma costante.<br />
» A36<br />
» A26<br />
» A27<br />
» A28<br />
» A29<br />
» A30<br />
» A31<br />
Nella seguente tabella è possibile consultare i dettagli sui dati del commercio estero di tipi di<br />
verdura scelti.<br />
Prezzi<br />
I prezzi delle verdure fresche ai diversi livelli commerciali (franco grossista / fornitura e acquisto<br />
all’ingrosso / commercio al dettaglio = prezzi al consumo) per alcuni prodotti principali<br />
sono disponibili nelle tabelle seguenti:<br />
Prezzi alla produzione, bio escl.<br />
Prezzi alla produzione Bio<br />
Prezzi nella fornitura e acquisto all'ingrosso, bio escl.<br />
Prezzi nella fornitura e acquisto all'ingrosso bio<br />
Prezzi al consumo, bio escl.<br />
Prezzi al consumo bio<br />
Nel 2015 i prezzi di costo e di vendita delle verdure osservate sono diminuiti rispetto al 2014,<br />
scendendo rispettivamente da 1.29 a 1.26 fr./kg e da 3.11 a 2.96 fr./kg. In calo anche il mar-<br />
108<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 62 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE<br />
gine lordo che, con un valore di 1.70 fr./kg, si è attestato al livello del 2012. Nel 2015 la quota<br />
del prezzo di costo su quello di vendita ammontava al 42,6 per cento.<br />
Consumo<br />
Nel 2015 il consumo pro capite di verdura fresca è stato di 73 chilogrammi. Si tratta del cosiddetto<br />
consumo pro capite tangibile, dato dalla somma di produzione indigena di verdure<br />
fresche (incl. quelle destinate all’immagazzinamento) e volume delle importazioni meno il volume<br />
delle esportazioni secondo la statistica del commercio estero svizzero. Tale valore è leggermente<br />
inferiore alla media del quadriennio precedente.<br />
» A37<br />
Nella tabella seguente sono indicati i dati dei prodotti principali.<br />
» Centrale svizzera dell’orticoltura e delle colture speciali (CSO)<br />
Peter Schwegler, UFAG, Settore Prodotti vegetali, peter.schwegler@blw.admin.ch<br />
Christian Kuhlgatz, UFAG, Settore Osservazione del mercato<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
109
Il mio Rapporto agricolo 73 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE<br />
Vino<br />
Il rapporto sul vino si fonda sulla statistica federale vitivinicola pubblicata a cadenza annuale<br />
(cfr. L'anno viticolo 2015). L'edizione attuale di tale statistica comprende le cifre sulla viticoltura<br />
in Svizzera relativamente al 2015 (vigneti e raccolti d'uva). Fornisce inoltre informazioni<br />
sulle scorte di vino al 31 dicembre 2015, sul volume di produzione, sul consumo, sulle importazioni<br />
e sulle esportazioni nel 2015.<br />
La vitivinicoltura in Svizzera - 2015<br />
Nel 2015 in Svizzera i vigneti hanno coperto complessivamente 14 793 ettari, registrando, rispetto<br />
all'anno precedente, un calo di 42 ettari. Le due varietà di vite più diffuse sono tuttora<br />
Pinot Noir (Blauburgunder) e Chasselas (Gutedel), benché anche nel 2015 per questi vitigni<br />
tradizionali si è protratta la tendenza in atto da anni al ridimensionamento della superficie<br />
coltiva. Complessivamente 8517 ettari sono stati coltivati con varietà rosse, 6275 ettari con<br />
quelle bianche.<br />
» A34<br />
Superficie agricola utile secondo le forme di utilizzo<br />
» A35<br />
La vendemmia 2015, rispetto all'anno precedente, ha registrato un calo di circa 8 milioni di<br />
litri. Con 85 milioni di litri, è stato uno degli anni con i valori più bassi. I motivi principali<br />
sono stati, da un lato, l'estate estremamente calda e scarse precipitazioni, e dall'altro, puntuali<br />
perdite di raccolto a causa del prodotto fitosanitario «Moon Privilege». Le temperature<br />
calde e il buon soleggiamento hanno consentito di raggiungere un elevato tenore di zucchero<br />
al momento del raccolto. Il volume medio di mosto è in parte nettamente superiore alla media<br />
pluriennale.<br />
Produzione<br />
Produzione, importazione, esportazione e consumo - 2015<br />
Nel 2015 complessivamente in Svizzera sono stati prodotti 40 milioni di litri di vino bianco e<br />
45 milioni di litri di rosso. A fronte di questa produzione si rileva un consumo di 49 milioni di<br />
litri di vino bianco e di 50 milioni di litri di vino rosso svizzeri. Le scorte di vino bianco indigeno<br />
si sono pertanto ridotte a circa 61 milioni di litri, mentre quelle di vino rosso indigeno a 79<br />
milioni di litri.<br />
Nel 2015 in Svizzera sono stati consumati complessivamente 262 milioni di litri di vino e poco<br />
più di 1 milione di litri di vino circa è stato esportato o esportato nuovamente. Si è riproposta la<br />
tendenza negativa degli anni precedenti; il consumo complessivo è infatti diminuito di 3 milioni<br />
di litri, soprattutto a causa del calo del consumo di vini esteri. Nell'anno oggetto del rapporto<br />
quest’ultimo è diminuito di 3,6 milioni di litri attestandosi a 165 milioni di litri. Il consumo di<br />
vini indigeni, invece, è aumentato di 0,5 milioni di litri, raggiungendo quota 99 milioni di litri.<br />
» A37<br />
Consumo pro capite<br />
Per i vini bianchi sono state maggiori le importazioni di vino in fusto rispetto a quello in bottiglia;<br />
il volume totale di importazione è aumentato di 1,2 milioni di litri, attestandosi a 40 milioni<br />
di litri. Per il vino rosso, invece, è stato esattamente il contrario (maggiori importazioni di<br />
vino in bottiglia rispetto a quello in fusto) e il volume d’importazione è diminuito di 1,8 milioni<br />
di litri attestandosi a 126 milioni di litri. A fronte di queste importazioni si rileva un consumo<br />
di 39 milioni di litri di vino bianco estero e di 126 milioni di litri di vino rosso estero. Le scorte<br />
di vini rossi esteri sono aumentate leggermente attestandosi a fine anno a circa 44 milioni di<br />
110<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 74 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE<br />
litri. Anche le scorte di vini bianchi esteri sono aumentate, segnatamente di 1,2 milioni di litri<br />
segnando quota 12 milioni di litri. Nel 2015 complessivamente sono stati importati 188 milioni<br />
di litri di vino, vino dolce, specialità, mistelle, spumante e mosto d’uva, di cui 160 milioni di<br />
litri di vino naturale rosso e bianco, fermo, all'interno del contingente doganale (170 milioni<br />
di litri), che quindi, come negli anni precedenti, non è stato esaurito.<br />
» A36<br />
Commercio estero<br />
Bibliografia<br />
L'anno viticolo 2015 - statistica federale vitivinicola (pubblicata dall'Ufficio federale dell'agricoltura)<br />
David Raemy, UFAG, Settore Prodotti vegetali, david.raemy@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
111
Il mio Rapporto agricolo 79 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE<br />
Latte e latticini<br />
Produzione<br />
Nel 2015 la produzione totale di latte ha toccato quota 4 milioni di tonnellate. Le forniture<br />
di latte, incluso quello della zona franca attorno a Ginevra e del Principato del Liechtenstein,<br />
pari a 3,49 milioni di tonnellate, hanno segnato una flessione dell'1,54 per cento. L'economia<br />
lattiera ha conseguito una quota di circa il 20 per cento della produzione dell'intero settore<br />
economico agricolo. Nel 2015 in Svizzera si sono contati circa 21 850 produttori lattieri di cui<br />
10 270 nella regione di montagna e 11 580 in quella di pianura.<br />
Secondo l'Interprofessione Latte (IP Latte, 2015) la quota del quantitativo di latte commercializzato<br />
nel segmento A si attesta a 84,9 per cento, quelle nel segmento B al 13,1 per cento<br />
e nel segmento C al 2 per cento. Il segmento A comprende il latte che confluisce nei mercati<br />
protetti o sostenuti con supplementi e ricava il maggior valore aggiunto.<br />
L'anno oggetto del rapporto si è caratterizzato per un crollo dei prezzi alla produzione del latte.<br />
A causa dei bassi prezzi sono diminuiti anche gli effettivi di bestiame da latte. Secondo il Settore<br />
Osservazione del mercato dell'UFAG, nel 2015 il prezzo alla produzione del latte è diminuito<br />
rispetto all'anno precedente sia in Svizzera (–11 %) sia in UE (–28 %). Tale calo di prezzo è<br />
riconducibile all'abolizione delle quote latte nell'UE a partire del 1° aprile 2015, alla disparità<br />
tra offerta e domanda sul mercato mondiale e ai bassi prezzi dei latticini nonché alla debolezza<br />
dell'euro e al turismo degli acquisti.<br />
Valorizzazione<br />
Nella fabbricazione dei vari latticini si utilizzano percentuali diverse delle componenti del latte.<br />
Nella caseificazione, ad esempio, a seconda della categoria di grasso del formaggio prodotto si<br />
aggiunge o si toglie grasso del latte. Per tale motivo, la valorizzazione del latte commercializzato<br />
è espressa in equivalente del latte (EL) in base alle sue componenti. Un EL corrisponde a<br />
73 grammi di proteine e grasso, ovvero a un chilogrammo di latte di qualità media contenente<br />
33 grammi di proteine e 40 grammi di grasso. L’EL funge da unità di misura per il calcolo della<br />
quantità di latte trasformato in latticini.<br />
Circa il 43 per cento degli EL di latte commercializzato è tuttora destinato alla produzione di<br />
formaggio e ricotta (quark), che resta pertanto il tipo di valorizzazione preminente. Nel 2015<br />
si è osservato l'aumento, superiore alla media, della trasformazione di latte in quark rispetto<br />
all'anno precedente (+38,6 %). L'utilizzo come latte di consumo ha segnato un calo del 3,3<br />
per cento.<br />
112<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 80 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE<br />
» A39<br />
La produzione di formaggio nel 2015 rispetto all'anno precedente è aumentata dell'1,9 per<br />
cento attestandosi a 188 806 tonnellate. Il formaggio a pasta dura rappresenta tuttora, con<br />
un totale di 64 034 tonnellate, la varietà con la quota maggioritaria, anche se registra una diminuzione<br />
del 4,6 per cento rispetto all'anno precedente. Oltre all'Emmentaler DOP, con un<br />
calo della produzione del 7 per cento, anche gli altri formaggi a pasta dura segnano una diminuzione,<br />
tuttavia minore, compresa tra il 3 e il 5 per cento.<br />
Da diversi anni si rileva un incremento costante della produzione di formaggio a pasta semidura<br />
che nel 2015 si è attestato all'1 per cento (+632 t) rispetto al 2014 e a oltre il 33 per cento<br />
rispetto agli anni 2000/02. La crescita nel 2015 ha riguardato tuttavia soltanto il formaggio da<br />
raclette (+931 t), le altre varietà hanno registrato un calo o sono restate invariate.<br />
Per il formaggio fresco è stato possibile aumentare la produzione di 5528 tonnellate rispetto<br />
all'anno precedente, mentre per il formaggio a pasta molle essa è diminuita leggermente.<br />
» A40<br />
Nonostante un calo nel 2015, in testa alla graduatoria delle varietà di formaggio con i volumi<br />
di produzione maggiori vi è il Gruyère DOP (28 552 t; -3,0 %), al secondo posto la mozzarella<br />
(23 551 t; +3,8 %) e al terzo posto l’Emmentaler DOP (18 843 t; -7,0 %).<br />
Commercio estero<br />
In termini di quantitativi, nell’anno oggetto del rapporto in Svizzera la bilancia commerciale<br />
per il latte e i latticini è stata leggermente negativa (esportazione 86 656 t; importazione 91<br />
754 t). Le esportazioni sono state superiori alle importazioni solo nel caso del formaggio e del<br />
latte in polvere. In termini di valore, le esportazioni sono state pari a 668,2 milioni di franchi<br />
mentre le importazioni a 423,6 milioni di franchi, il che equivale a un'eccedenza delle esportazioni<br />
di 244,5 milioni di franchi (Statistica svizzera sul latte, 2015).<br />
Nell'anno oggetto del rapporto le esportazioni di formaggio sono aumentate di 554 tonnellate<br />
raggiungendo quota 64 231 tonnellate. Le importazioni di formaggio si sono attestate a 55 432<br />
tonnellate con un incremento di 1587 tonnellate. In termini di valore nel 2015 le esportazioni<br />
sono state pari a 573 milioni di franchi (608 nel 2014) e le importazioni a 346 milioni di franchi<br />
(393 nel 2014).<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
113
Il mio Rapporto agricolo 81 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE<br />
La Svizzera, con 51 979 tonnellate, ha esportato lo 0,9 per cento in meno di formaggio nei Paesi<br />
dell’UE rispetto al 2014. I maggiori acquirenti sono stati la Germania con 29 546 tonnellate e<br />
l’Italia con 10 814 tonnellate. Va tuttavia tenuto in considerazione il fatto che il formaggio,<br />
dopo l’esportazione in determinati Paesi dell’UE, viene spesso rivenduto in altri Paesi europei<br />
e le statistiche doganali non consentono di stabilire in quale Paese alla fine è stato consumato<br />
il formaggio svizzero.<br />
Come era già stato il caso negli anni precedenti, la quota maggiore è rappresentata dal formaggio<br />
a pasta dura con esportazioni pari a 33 762 tonnellate. I consumatori stranieri hanno<br />
prediletto l’Emmentaler DOP del quale ne sono state esportate complessivamente 12 663 tonnellate<br />
(13 994 t nel 2014). Al secondo posto nella classifica di gradimento segue il Gruyère<br />
DOP con 11 956 tonnellate (12 376 t nel 2014).<br />
Nel 2015 le importazioni di formaggio pari complessivamente a 55 432 tonnellate provenivano<br />
praticamente tutte dall'UE, segnatamente, nell'ordine, dall'Italia (19 806 t), dalla Francia (14<br />
053 t) e dalla Germania (12 768 t). Le quote d’importazione più cospicue hanno interessato il<br />
formaggio fresco, con 20 970 tonnellate (20 320 t nel 2014) e il formaggio a pasta molle con<br />
9 965 tonnellate (9 427 t nel 2014).<br />
» A36<br />
Consumo<br />
Con 21,5 chilogrammi pro capite, nel 2015 il consumo di formaggio ha segnato una crescita<br />
dello 0,5 per cento rispetto all’anno precedente. Anche il consumo pro capite di bevande a<br />
base di latte è aumentato, segnatamente di 0,5 chilogrammi, attestandosi a 9,9 chilogrammi,<br />
mentre per il latte di consumo e il latte da bere è stato registrato un valore inferiore, ovvero<br />
59,1 chilogrammi pro capite (-5,1 %).<br />
» A37<br />
Da diversi anni nel consumo pro capite di latte e latticini si segnalano soltanto variazioni di<br />
lieve entità. Da un confronto con il periodo 2000/02 si rileva, invece, una flessione di oltre un<br />
quarto del consumo pro capite di latte di consumo, mentre il consumo di bevande a base di<br />
latte triplica. Nello stesso periodo è sceso il consumo pro capite di burro e panna (risp. -9 % e<br />
-10 %), mentre quello di formaggio è aumentato di un buon 9 per cento.<br />
Prezzi al consumo nel confronto con l'UE<br />
Considerati gli elevati prezzi di produzione del latte, in Svizzera, rispetto a Germania, Francia e<br />
Austria, anche i prezzi al consumo di latte e latticini sono più alti. Nei Paesi confinanti i prezzi<br />
registrano un valore pari al 35-83 per cento del livello svizzero. La principale differenza di<br />
prezzo si osserva per il burro (nel 2015: CH = 14.97 fr./kg, DE = 3.79 fr./kg). Il latte intero<br />
114<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 82 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE<br />
pastorizzato meno costoso si rileva in Germania, con un prezzo di 0.68 franchi il litro (CH =<br />
1.46 fr./l).<br />
Hans Ulrich Leuenberger, UFAG, Settore Prodotti animali e allevamento, hansulrich.leuenberger@blw.admin.ch<br />
» A41<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
115
Il mio Rapporto agricolo 88 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE<br />
Carne e uova<br />
Nell'anno oggetto del rapporto la produzione totale di carne è ammontata a 478 968 tonnellate,<br />
segnando un lieve calo pari allo 0,1 per cento rispetto all'anno precedente.<br />
Secondo l'UST (2015), il valore della produzione di carne si è attestato su 2,6 miliardi di franchi<br />
rappresentando più di un quarto del valore totale della produzione agricola.<br />
Nonostante il calo dei consumi in atto da diversi anni, la carne di suino ha fatto registrare una<br />
quota del 44 per cento rispetto al consumo di carne totale.<br />
Il consumo di carne annuo della popolazione svizzera, nel 2015, è leggermente sceso rispetto<br />
all'anno precedente attestandosi a 51,35 chilogrammi pro capite, pari a un consumo totale di<br />
431 852 tonnellate di carne (pesce e crostacei esclusi).<br />
Produzione<br />
Nell'anno oggetto del rapporto i contadini hanno detenuto circa 1,55 milioni di capi di bovini<br />
(0,5 % in meno rispetto al 2014). L'effettivo di vacche (vacche da latte e madri) ha subito una<br />
flessione di 4000 capi rispetto all'anno precedente.<br />
L'effettivo di suini, composto da circa 1,5 milioni di capi, si è attestato lievemente al di sotto del<br />
valore di un anno fa, subendo un calo dello 0,2 per cento. La flessione piuttosto considerevole<br />
degli effettivi di ovini e caprini registrata nel 2015 è prevalentemente dovuta allo spostamento<br />
del giorno di riferimento da inizio maggio al 1° gennaio.<br />
Grazie alla buona congiuntura sul mercato e alla crescente domanda di uova e carne di pollame,<br />
l'effettivo totale di pollame è nuovamente aumentato, attestandosi a quota 10,75 milioni di<br />
capi; l'incremento maggiore, pari a quasi il 6 per cento, si è registrato per le galline ovaiole<br />
e da allevamento.<br />
Dopo la crescita registrata l'anno precedente, nell'anno oggetto del rapporto la produzione di<br />
tutte le varietà di carne è scesa di circa 500 tonnellate a 345 642 tonnellate di peso alla vendita.<br />
La produzione di carne di pollame (ca. +1600 t) ha segnato un nuovo aumento a differenza di<br />
quella di carne di suino e di quella di carne bovina (entrambe ca. -500 t). In calo è stata anche<br />
la produzione di carne di vitello (-4 %), di pecora (-3,3 %) e di cavallo (-6 %). In cifre assolute,<br />
tuttavia, tale flessione è esigua per la carne equina, considerato che la rispettiva quota di mercato<br />
è relativamente piccola in termini quantitativi. Nel 2015 la produzione di carne di capra<br />
ha segnato un netto aumento pari al 17,7 per cento, dopo aver seguito una tendenza al ribasso<br />
per diversi anni. In cifre assolute, tuttavia, questa crescita è esigua (soltanto 66 t di peso alla<br />
vendita) perché la quota di mercato è relativamente piccola come nel caso della carne equina.<br />
La quota indigena di carne bovina pronta alla vendita è rimasta pressoché invariata rispetto<br />
all'anno precedente segnando l'80,5 per cento. Le macellazioni di vacche hanno subito un calo<br />
attestandosi a 162 558 capi e a 48 685 tonnellate di peso alla macellazione. L'aumento dei<br />
pesi alla macellazione ha comunque permesso di compensare lo scarso approvvigionamento<br />
di carne destinata alla trasformazione. Per i buoi e i manzi si è osservato un aumento delle<br />
macellazioni e del peso alla macellazione, per i tori, invece, una flessione.<br />
Nel 2015 il mercato della carne di suino è passato da un eccesso di offerta a una situazione<br />
di equilibrio, anche se la produzione ha subito un lieve calo e la lunga e bella stagione estiva<br />
ha sgravato il mercato. Gli addetti alla trasformazione e al commercio non hanno effettuato<br />
importazioni di carne di maiale in mezzene e di conseguenza la quota indigena di carne di suino<br />
ha raggiunto il 96,4 per cento.<br />
116<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 89 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE<br />
La crescita costante della domanda di carne di pollame ha determinato un ulteriore aumento<br />
del 3,1 per cento della produzione indigena, che ha superato le 55 600 tonnellate di peso alla<br />
vendita. La quota indigena è lievemente cresciuta attestandosi al 54,8 per cento.<br />
La produzione di carne di agnello è leggermente diminuita a 4780 tonnellate di peso alla macellazione,<br />
la quota indigena è scesa ulteriormente al 35 per cento.<br />
Nel 2015 la produzione di carne di vitello è crollata a 29 100 tonnellate (-1198 t). Ciò è dovuto<br />
anche al fatto che si ricorre maggiormente ad animali di razze da carne e di conseguenza<br />
cresce il numero di vitelli magri destinati all'ingrasso di bestiame grosso. Sul fronte dei consumi,<br />
inoltre, si osserva un ulteriore calo a un livello pari a 2,77 chilogrammi pro capite all'anno<br />
(-3,8 %).<br />
Nel 2015 la produzione di uova è salita a un totale di 868 milioni di pezzi (+3,7 %). Le vendite di<br />
uova indigene sono andate bene, grazie alla crescita demografica piuttosto che a un aumento<br />
del consumo pro capite (173,9 pz., 100,9 dei quali 103,3 di provenienza svizzera). La quota<br />
di uova svizzere sulle vendite di uova di consumo si attesta al 77 per cento. Se nella statistica<br />
dei consumi si considerano anche i prodotti a base di uova, le galline ovaiole indigene hanno<br />
prodotto quasi il 57 per cento delle uova e dei prodotti a base di uova consumati.<br />
Commercio estero<br />
Nell'anno oggetto del rapporto, le esportazioni di carne per l'alimentazione umana hanno registrato<br />
una flessione dell’11,4 per cento rispetto all'anno precedente, raggiungendo un totale<br />
di 7 562 tonnellate di peso alla vendita. L'unico aumento osservato ha interessato le esportazioni<br />
di carne di vitello (56,5 %), che però in termini quantitativi sono rimaste a un livello<br />
basso (56 t). Le esportazioni di carne di pollame, invece, hanno subito un crollo pari al 34,9<br />
per cento e seguono la tendenza al ribasso già osservata l'anno precedente.<br />
A differenza del 2014, nell'anno oggetto del rapporto le esportazioni di carne secca (carne<br />
di manzo) sono diminuite del 7,4 per cento raggiungendo quota 1684 tonnellate di peso alla<br />
vendita.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
117
Il mio Rapporto agricolo 90 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE<br />
Anche le esportazioni di carne di suino hanno subito una flessione, segnatamente del 3,3 per<br />
cento toccando quota 2326 tonnellate di peso alla vendita.<br />
Esportazione di carne, sottoprodotti della macellazione e preparazioni<br />
Denominazione 2012 2013 2014 2015<br />
Carne bovina (vitello<br />
incl.)<br />
Tonnellate nette<br />
Sottoprodotti<br />
della macellazione<br />
Preparazioni a<br />
base di carne<br />
Carne 1975 1811 1936 1789<br />
2936 2403 2350 2026<br />
50 41 33 19<br />
Totale 4961 4255 4320 3834<br />
Carne suina Carne 3146 1334 1819 1832<br />
Tonnellate nette<br />
Carne di pollame<br />
Tonnellate nette<br />
Sottoprodotti<br />
della macellazione<br />
Preparazioni a<br />
base di carne<br />
Carne e sottoprodotti<br />
della macellazione<br />
Preparazioni a<br />
base di carne<br />
17996 17452 16914 16 681<br />
82 107 80 58<br />
Totale 21 224 18 894 18 813 18 571<br />
3415 3845 4255 3438<br />
54 49 81 71<br />
Totale 3468 3894 4335 3509<br />
Altro Insaccati 287 326 329 292<br />
Tonnellate nette<br />
Preparazioni con<br />
meno del 20% di<br />
carne<br />
20 153 20 384 20 751 16 169<br />
Fonti: AFD, Proviande<br />
L'importazione di carne per l'alimentazione umana è diminuita del 3,6 per cento, raggiungendo<br />
93 772 tonnellate di peso alla vendita (escl. pesce, molluschi e crostacei). Le importazioni<br />
di carne di suino hanno subito una forte battuta d'arresto, toccando quota 9174<br />
tonnellate di peso alla vendita (-33 %) perché sul mercato era disponibile un quantitativo sufficiente<br />
di carne di suino svizzera per via dei consumi in calo e della stabilità della produzione<br />
indigena.<br />
Analogamente al 2014, la produzione dei tagli di carne più apprezzati (p.es. lombata di manzo,<br />
di agnello e di cavallo nonché petto di pollo e di tacchino) non è stata in grado di coprire completamente<br />
il fabbisogno.<br />
Sono state inoltre importate 22 563 tonnellate di carne di bestiame grosso, 9174 di carne suina<br />
e 46 872 tonnellate di carne di pollame.<br />
118<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 91 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE<br />
Per la carne di manzo (9674 t/prezzo alla vendita) e di maiale (451 t) il maggior fornitore della<br />
Svizzera resta la Germania, per il pollame il Brasile, con quasi il 40 per cento delle forniture<br />
(19 962 t). La maggior parte della carne ovina (75 %) viene importata da Australia e Nuova<br />
Zelanda.<br />
Le importazioni di uova di consumo sono nuovamente diminuite (-3,8 %) raggiungendo 238,1<br />
milioni di pezzi. Una netta flessione rispetto agli anni precedenti è stata registrata anche per<br />
le uova di trasformazione spezzate in Svizzera (-11,9 %; 194,3 mio. pz.). I principali Paesi che<br />
riforniscono la Svizzera di uova continuano a essere Olanda, Germania e Francia.<br />
Consumo di carne<br />
Nell'anno oggetto del rapporto il consumo pro capite di carne pronta alla vendita è diminuito<br />
del 2 per cento rispetto al 2014 attestandosi a 51,35 kg l'anno (escl. pesce e crostacei, incl.<br />
coniglio e selvaggina). Si tratta di un'inversione di tendenza dopo un triennio al rialzo.<br />
Va osservato che nel calcolo del consumo non viene considerata la carne acquistata nei<br />
Paesi confinanti. Il turismo degli acquisti è cresciuto anche nel 2015 a causa della debolezza<br />
dell'euro. Per questo motivo il calo del consumo pro capite va relativizzato.<br />
Anche il consumo totale di carne è sceso dello 0,8 per cento toccando quota 431 852 tonnellate<br />
di carne pronta al consumo.<br />
L'aumento più marcato relativo alla carne pronta alla vendita ha interessato quella di pollame<br />
che ha guadagnato l'1,3 per cento raggiungendo quota 12,08 kg. Dal 2014 occupa il secondo<br />
posto, preceduta dalla carne di suino (22,77 kg), nella classifica delle preferenze dei consumatori.<br />
La carne di manzo, con 11,24 chilogrammi, si piazza al terzo posto.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
119
Il mio Rapporto agricolo 92 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE<br />
Dal 2000/02 è diminuita la preferenza accordata dalla popolazione svizzera alla carne di cavallo<br />
e a quella di vitello (ca. -30 %), mentre quella accordata alla carne di pollame è aumentata<br />
della stessa percentuale. Nello stesso periodo la preferenza per uova e carne suina è scesa<br />
rispettivamente del 7 e del 10 per cento. Per la carne bovina, il consumo pro capite è comunque<br />
cresciuto del 10 per cento.<br />
Se si fa un salto indietro di sessant'anni, secondo le cifre di Proviande (2015) il consumo di<br />
carne, pesce e crostacei era pari a 37 chilogrammi l'anno. Già allora si consumava soprattutto<br />
carne di suino (16 kg), mentre il consumo di carne di pollame (1,3 kg) era pressoché irrilevante.<br />
Consumo di carne a livello internazionale<br />
Dal confronto internazionale nel 2011 (dati più recenti disponibili) emerge che, con 53,5 chilogrammi<br />
il consumo pro capite di carne in Svizzera si situava nella fascia media superiore.<br />
Tali calcoli sono stati effettuati da Proviande sulla base dei dati FAO del 2011, anno in cui il<br />
consumo andava dai 2,9 chilogrammi del Bangladesh agli oltre 110 chilogrammi di Hong Kong<br />
(USA 84,2 kg/anno). Il consumo medio pro capite nei 180 Paesi oggetto di rilevazione è stato<br />
di 35,6 chilogrammi.<br />
Nel confronto tra i Paesi europei, secondo i calcoli di Agrarmarkt Informations-Gesellschaft<br />
Deutschland (AMI) e di Proviande per il 2013, la Svizzera, con un consumo pro capite di 52,0<br />
chilogrammi l'anno, si situa al penultimo posto della classifica, prima della Repubblica Ceca<br />
(49,5 kg/anno). I maggiori consumatori di carne sono Cipro (85,0 kg/anno), Danimarca (78,3<br />
kg/anno) e Spagna (77,6 kg/anno).<br />
120<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 93 / 93<br />
MERCATO > PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE<br />
Hans Ulrich Leuenberger, UFAG, Settore Prodotti animali e allevamento, hansulrich.leuenberger@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
121
Il mio Rapporto agricolo 2 / 39<br />
AMBIENTE > INTRODUZIONE<br />
Introduzione<br />
Agricoltura e ambiente sono strettamente correlati. Da un lato l'agricoltura utilizza in maniera<br />
mirata le basi vitali naturali per produrre derrate alimentari, dall'altro con le sue attività incide<br />
sui processi naturali e influenza l'ambiente. Oltre un terzo del territorio nazionale è costituito<br />
da superfici coltivate, incluse quelle per la creazione di sottoprodotti come paesaggi curati,<br />
habitat preziosi per la biodiversità o terreni fertili. Queste prestazioni multifunzionali sono richieste<br />
dalla società e promosse attraverso la politica agricola. Tuttavia, tutte le forme di produzione<br />
rappresentano anche un carico per gli ecosistemi, che può essere ridotto accrescendo<br />
l'efficienza della produzione agricola e adeguandone l'intensità alle caratteristiche locali, ovvero<br />
innovando i sistemi di produzione come peraltro si prefigge la politica agricola.<br />
Nella rubrica «Ambiente» del Rapporto agricolo si trattano temi che interessano l'interfaccia<br />
agricoltura e ambiente (ciclo dell'azoto e del fosforo, clima, aria, energia, acqua, suolo e biodiversità).<br />
A cadenza quadriennale, ogni anno vengono approfonditi due o tre temi. Quest'anno<br />
si parla di azoto (flussi, emissioni di ammoniaca, emissioni di protossido d'azoto e nitrati) e<br />
acqua (utilizzo di prodotti fitosanitari e medicamenti per uso veterinario), tematiche già toccate<br />
nelle edizioni del Rapporto agricolo 2004, 2008 e 2012. In questa rubrica vengono inoltre<br />
pubblicati gli indicatori agroambientali del programma di monitoraggio dell'UFAG periodicamente<br />
aggiornati.<br />
122<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 3 / 39<br />
AMBIENTE > MONITORAGGIO AGRO-AMBIENTALE<br />
Indicatori agroambientali (IAA)<br />
Il monitoraggio agroambientale (MAA) dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) fornisce<br />
un quadro sull'evoluzione dell'agricoltura svizzera dal profilo agroambientale. Nelle varie tematiche<br />
agroambientali (cicli dell'azoto e del fosforo, energia, clima, suolo, acqua e biodiversità)<br />
è finalizzato a fornire le informazioni necessarie per osservare e determinare l'influenza<br />
dell'agricoltura sulla qualità ambientale e il modo in cui l'ambiente evolve in relazione alle<br />
pratiche agricole. La base legale del monitoraggio è l'ordinanza concernente l'analisi della<br />
sostenibilità in agricoltura, che specifica che il MAA deve fondarsi su indicatori agroambientali<br />
(IAA) che siano comparabili sul piano internazionale (Eurostat e OCSE) e consentano di valutare<br />
gli effetti quantitativi e qualitativi della politica agricola a livello nazionale (statistiche<br />
e inventari nazionali), regionale e per tipo di azienda (Analisi centralizzata di indicatori agroambientali,<br />
AC-IAA).<br />
Le serie di dati sugli IAA<br />
Il presente rapporto tratta in maniera approfondita gli IAA sull'azoto (L'azoto nell'agricoltura,<br />
Emissioni di ammoniaca, Emissioni di protossido di azoto, Nitrati nell'acqua), sull'utilizzo di<br />
prodotti fitosanitari e sull'impiego di medicamenti veterinari in agricoltura. Tutti i dati del MAA<br />
sono raggruppati nelle tabelle e nei link seguenti:<br />
• livello nazionale: tabella Excel aggiornata<br />
• livello regionale e per tipo di azienda: tabella Excel aggiornata<br />
• livello internazionale: indicatori agroambientali dell'OCSE e indicatori agroambientali di<br />
Eurostat<br />
Bibliografia<br />
Ufficio federale dell'agricoltura (2014), Flyer Monitoraggio agroambientale<br />
Rapporti agricoli 2012, 2013, 2014 e 2015<br />
OCSE 2013, OECD Compendium of Agri-environmental Indicators<br />
Eurostat 2016, Agriculture, forestry and fishery statistics — ed. 2015<br />
Latsch, A., T. Anken. 2015. Landwirtschaftlicher Energieverbrauch in der Schweiz. Agroscope Transfer 56: 1-4.<br />
Latsch, A., T. Anken, F. Hasselmann. 2014. Agrarumweltindikator (AUI) "Energieverbrauch Landwirtschaft" - Methodenbeschreibung<br />
für die nationale Ebene. Schlussbericht, pp. 30.<br />
Latsch, A., T. Anken, F. Hasselmann. 2013. Energieverbrauch der Schweizer Landwirtschaft - Graue Energie schlägt<br />
zunehmend zu Buche. Agrarforschung Schweiz 4(5): 244-247.<br />
de Baan L., S. Spycher, O. Daniel. 2015. Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Schweiz von 2009 bis 2012. Agrarforschung<br />
Schweiz 6 (2): 48-55.<br />
Büchi, L., A. Valsangiacomo, E. Burel, R. Charles. 2015. Integrating simulation data from a crop model in the development<br />
of an agri-environmental indicator for soil cover in Switzerland. European Journal of Agronomy<br />
Documentazione per la CA-IAA: www.agrarmonitoring.ch<br />
Jérôme Frei, UFAG, Settore Sistemi agro-ambientali e sostanze nutritive, jerome.frei@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
123
Il mio Rapporto agricolo 4 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
L'azoto nell'agricoltura<br />
L'intricato percorso dell'azoto<br />
Nell'ambiente, l'azoto (N) subisce diverse trasformazioni. L'agricoltura sfrutta il processo<br />
della fissazione tecnica e biologica dell'azoto per rendere reattivo e quindi disponibile per la<br />
crescita delle piante l'azoto atmosferico non reattivo (N 2 ). L'azoto minerale assorbito dalle<br />
piante viene trasformato in proteine e, assieme al carbonio, in biomassa, sostanzialmente<br />
in forma proteica. All'atto del foraggiamento e durante il processo di digestione le proteine<br />
vegetali vengono trasformate in proteine animali; entrambe hanno una notevole valenza<br />
nell'alimentazione umana. I composti azotati organici presenti nelle parti morte dei vegetali<br />
e negli escrementi animali vengono nuovamente decomposti in forme minerali di azoto.<br />
L'azoto minerale che non giunge nei prodotti agricoli e si disperde nell'ambiente può avere<br />
effetti negativi sugli ecosistemi: sotto forma di ammoniaca (NH 3 ) altera gli ecosistemi sensibili<br />
come le paludi e le foreste, sotto forma di nitrati (NO 3 ) inquina le acque sotterranee e gli ecosistemi<br />
marini e sotto forma di protossido di azoto (N 2 O) concorre al riscaldamento climatico.<br />
L'azoto può quindi compromettere l'ambiente sul piano locale, (sovra)regionale e globale. Un<br />
atomo di azoto è in grado di formare diversi composti chimici prima di trasformarsi nuovamente<br />
in azoto elementare atmosferico innocuo per l'ambiente.<br />
Influsso considerevole dell'agricoltura sui flussi di azoto<br />
Uno studio commissionato dall’UFAG per quantificare e illustrare i flussi di azoto nella filiera<br />
agroalimentare svizzera nel 2005 (Reutimann et al. 2013) evidenzia che dal profilo quanti-<br />
124<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 5 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
tativo i concimi minerali, gli alimenti importati per animali e l'azoto fissato biologicamente<br />
sono le tre principali fonti d’immissione di azoto nel sistema agroalimentare svizzero. Secondo<br />
l'attuale bilancio nazionale dell'azoto (cfr. grafico sull'evoluzione del bilancio e dell'efficienza<br />
dell'azoto), nel frattempo l’apporto di azoto attraverso gli alimenti per animali ha superato<br />
quello attraverso i concimi minerali. I principali flussi di azoto si rilevano tuttavia all’interno<br />
del settore primario, sotto forma di piante foraggere per l'alimentazione animale e di concimi<br />
aziendali utilizzati nella produzione vegetale. L'azoto esce dal sistema agroalimentare principalmente<br />
attraverso gli escrementi umani che finiscono nelle acque di scarico, attraverso l'aria<br />
sotto forma di ammoniaca, protossido di azoto e azoto elementare atmosferico emessi dalle<br />
aziende detentrici di animali e dal suolo, nonché attraverso il dilavamento dei suoli sotto forma<br />
di nitrati. In proporzione, i flussi di azoto di origine agricola verso l'alimentazione umana sono<br />
esigui.<br />
L'UFAM ha commissionato uno studio per calcolare le probabili variazioni dei flussi di azoto in<br />
Svizzera fino al 2020 sulla base di ipotesi sullo sviluppo demografico e sulla Politica agricola<br />
2014–2017 (Heldstab et al. 2013). I risultati mostrano che le importazioni di azoto attraverso<br />
le derrate alimentari e gli alimenti per animali aumentano considerevolmente. L’evoluzione<br />
delle importazioni di derrate alimentari è da ricondurre al maggiore fabbisogno di calorie di<br />
una popolazione in crescita. Secondo lo studio, l'incremento del fabbisogno di alimenti importati<br />
per animali è dovuto al costante aumento della produzione lattiera per animale che compensa<br />
ampiamente gli effetti della soppressione dei contributi per gli animali che consumano<br />
foraggio grezzo decisa nel quadro della Politica agricola 2014–2017. Anche gli sviluppi nel<br />
settore dell'ingrasso di pollame rivestono un ruolo importante. Stando allo studio dell'UFAM,<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
125
Il mio Rapporto agricolo 6 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
l'importazione di azoto attraverso i concimi minerali diminuisce ulteriormente poiché il fabbisogno<br />
di azoto delle piante può essere coperto mediante il volume supplementare di concimi<br />
aziendali risultante dalle importazioni di alimenti per animali. Le perdite gassose di azoto (ammoniaca,<br />
protossido di azoto, ossidi d'azoto, azoto elementare atmosferico) segnano tuttavia<br />
un lieve calo poiché per spandere i concimi aziendali si ricorre sempre più a tecniche a basse<br />
emissioni. Il calo potrebbe essere più consistente se venissero applicate tutte le altre misure<br />
aziendali e tecniche attualmente note (IIASA 2015, IIASA 2011). Siccome le emissioni di NO x<br />
provocate dal traffico sono destinate a diminuire ulteriormente grazie all’inasprimento delle<br />
prescrizioni sui gas di scarico, è minore anche il deposito atmosferico di azoto.<br />
Perdite di azoto e obiettivi in materia di riduzione: una sfida<br />
L'efficienza, ovvero l'output di azoto che l'agricoltura svizzera produce con una unità di input<br />
di azoto, è aumentata costantemente passando dal 22 per cento nel 1990/92 al 30 per cento nel<br />
2012/14. Il bilancio nazionale dell'azoto mostra che l'output di azoto sotto forma di prodotti<br />
vegetali e animali è aumentato del 28 per cento nonostante le immissioni di azoto sotto forma<br />
di concimi minerali, alimenti importati per animali, fissazione biologica dell'azoto e deposito<br />
atmosferico abbiano segnato un calo complessivo del 5 per cento.<br />
Benché ambizioso, l'obiettivo intermedio di un'efficienza dell'azoto pari al 33 per cento entro<br />
il 2017 (cfr. messaggio sulla Politica agricola 2014–2017) dovrebbe poter essere raggiunto.<br />
Anche le perdite di azoto che finiscono nell'ambiente (input di N meno output di N) sono diminuite<br />
passando da 132 000 tonnellate di azoto nel 1990/92 a 116 000 tonnellate di azoto<br />
nel 1999/2001 (-12 %). Da allora non si registrano praticamente più progressi. Stando ai calcoli<br />
di Agroscope, nel 2012/14 le perdite di azoto ammontavano ancora a 113 000 tonnellate.<br />
Molto probabilmente non sarà raggiunto l'obiettivo intermedio per il 2015 di al massimo 95<br />
000 tonnellate di perdite di azoto stabilito nel messaggio sulla Politica agricola 2011 e ripreso<br />
nel messaggio sulla Politica agricola 2014–2017.<br />
I dati sugli indicatori dell’azoto e su altri indicatori agroambientali a livello nazionale sono<br />
disponibili su Servizi.<br />
126<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 7 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
Come ridurre le perdite di azoto<br />
Di base, le perdite di azoto dipendono, da un lato, dall'intensità dell’azoto (ovvero dalla quantità<br />
di azoto utilizzata) e, dall'altro, dall'efficienza dell'azoto (ovvero da come viene impiegato).<br />
Secondo uno studio di Agroscope (cfr. riquadro in basso), nell'agricoltura svizzera la<br />
situazione è molto eterogenea per quanto riguarda l'intensità e l'efficienza dell'utilizzo di<br />
azoto sia tra i diversi tipi di azienda sia all'interno dello stesso tipo di azienda. Lo studio mostra<br />
anche che in tutti i tipi di azienda l'intensità dell'azoto ha ripercussioni positive sulla cifra<br />
d'affari per ettaro, ma non esercita praticamente alcun influsso sul profitto del lavoro per unità<br />
di lavoro annuale della famiglia. Alla luce di tale considerazione si può quindi concludere che<br />
è possibile ridurre le perdite di azoto, da un lato, attraverso il progresso tecnologico teso ad<br />
accrescere l'efficienza e, dall'altro, gestendo l'intensità.<br />
Approccio «efficienza»: per ridurre in maniera efficace le perdite di azoto provocate<br />
dall'agricoltura è opportuno intervenire all'inizio della catena delle perdite. Maggiore sarà il<br />
quantitativo di azoto utilizzato trasformato in prodotti agricoli, meglio sarà per l'agricoltura<br />
e l'ambiente. In quest’ottica sono molto promettenti la selezione di piante e animali in grado<br />
di utilizzare l'azoto in maniera più efficiente e il regime alimentare di animali e vegetali. In<br />
questo ambito è possibile accrescere l'assorbimento dell'azoto da parte di piante e animali e<br />
ridurre le perdite nell'ambiente.<br />
Approccio «intensità»: un altro approccio efficace per ridurre le perdite di azoto è<br />
l'adeguamento dell'intensità al potenziale e alla sopportabilità ecologica del luogo. Ciò implica,<br />
tra l'altro, un maggiore utilizzo delle superfici coltive direttamente per l'alimentazione<br />
umana e il pascolo degli animali su superfici inerbite non altrimenti utilizzabili. Diminuisce così<br />
il volume di prodotti animali, con conseguenze sul consumo e sulle abitudini alimentari, ma<br />
non sulla sicurezza alimentare: un'alimentazione che sostituisce sempre più le proteine animali<br />
con quelle vegetali accresce l'efficienza del sistema alimentare in generale poiché viene<br />
ridotto il passaggio attraverso l'animale che comporta perdite elevate (Schader et al. 2015).<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
127
Il mio Rapporto agricolo 8 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
Quali fattori aziendali determinano eccedenze di azoto troppo elevate?<br />
Sulla base di una statistica descrittiva e comprendente molteplici varianti, Agroscope (Jan et<br />
al. 2013) ha analizzato i dati dell'analisi centralizzata degli indicatori agroambientali (AC-IAA)<br />
e quelli dell'analisi centralizzata dei dati contabili (AC-DC) di circa 200 aziende onde stabilire<br />
quali sono i fattori che determinano le eccedenze di azoto a livello aziendale. I risultati principali<br />
dello studio sono i seguenti:<br />
• a livello di singola azienda l'intensità e l'efficienza dell'azoto rivestono un ruolo analogo<br />
nella formazione delle eccedenze di azoto;<br />
• una maggiore intensità dell'azoto comporta, tendenzialmente, una minore efficienza<br />
dell'azoto;<br />
• nelle aziende specializzate si rilevano eccedenze di azoto inferiori rispetto a quelle non<br />
specializzate (le cosiddette «aziende combinate»). Eccedenze elevate sono frutto, in particolare,<br />
della combinazione con la trasformazione, poiché in questo tipo di aziende a fronte<br />
di un’elevata intensità dell’azoto vi è una bassa efficienza di tale elemento. Sebbene in misura<br />
minore, è il caso anche delle aziende che producono latte commerciale;<br />
• nella regione di pianura e in quella collinare le eccedenze di azoto sono pressoché uguali,<br />
mentre nella regione di montagna sono nettamente inferiori;<br />
• nelle aziende dedite all’agricoltura biologica si rilevano emissioni di azoto inferiori rispetto<br />
a quelle che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER);<br />
• le aziende con una superficie agricola utile estesa presentano, tendenzialmente,<br />
un’intensità dell’azoto lievemente inferiore e quindi eccedenze inferiori rispetto a quelle<br />
con una superficie modesta;<br />
• l’intensità dell’azoto ha effetti positivi sulla cifra d’affari per ettaro, ma non esercita praticamente<br />
alcun influsso sul profitto del lavoro per unità di lavoro annuale della famiglia.<br />
I dati sugli indicatori dell’azoto e su altri indicatori agroambientali a livello aziendale sono<br />
disponibili su Servizi.<br />
La Germania intende ridurre le perdite di azoto che, commisurate alla superficie, sono simili<br />
a quelle rilevate in Svizzera (OCSE 2013). A tal fine ha avviato una revisione del diritto in materia<br />
di concimi i cui elementi principali in discussione sono la creazione di basi legali per<br />
l’introduzione di un bilancio franco azienda che rilevi l’input e l’output di azoto a livello aziendale,<br />
la creazione di basi legali per un confronto automatico dei dati tra le diverse autorità<br />
coinvolte, la disposizione di termini transitori fino all’introduzione dell’obbligo di applicare<br />
tecniche di spandimento a basse emissioni e l’obbligo di fornire consulenza agli agricoltori.<br />
Conclusioni<br />
L’obiettivo intermedio in relazione alle perdite massime di azoto fissato dalla politica agricola<br />
per il 2015 non sarà raggiunto.<br />
La sfida della riduzione delle perdite di azoto va affrontata a più livelli. Siccome l’azoto reattivo<br />
è molto mobile e instabile, gli approcci che prevedono di ridurre l’utilizzo di azoto – sotto forma<br />
sia di alimenti per animali sia di concimi – è particolarmente efficace ed efficiente. Nelle altre<br />
fasi del ciclo dell’azoto è molto più difficile intervenire sulle emissioni e controllare le perdite.<br />
128<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 9 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
È molto probabile che la Politica agricola 2014–2017 determinerà una riduzione delle perdite<br />
di azoto. Sono tuttavia necessari ulteriori sforzi sul piano dell’innovazione tecnologica e aziendale<br />
per accrescere l’efficienza onde raggiungere gli obiettivi prefissati. Laddove ciò non<br />
basti, occorre adeguare l’intensità di produzione alla sopportabilità degli ecosistemi. Per compiere<br />
ulteriori progressi nella riduzione delle perdite di azoto è fondamentale l’impegno di tutti<br />
gli attori, ovvero di agricoltori, politica, imprese private, ricerca e consulenza.<br />
Bibliografia<br />
Heldstab J, Leippert F, Biedermann R, Schwank O (2013) Stickstoffflüsse in der Schweiz 2020. Stoffflussanalyse und<br />
Entwicklungen. Ufficio federale dell’ambiente, UFAM, Berna. Umwelt-Wissen n. 1309: 107 pagg.<br />
IIASA (2011) CIAM Report 4/2011, An Updated Set of Scenarios of Cost-effective Emission Reductions for the Revision<br />
of the Gothenburg Protocol IIASA (2015) Scenarios for further improvements of air quality in Switzerland. FOEN,<br />
Berna, 84 pagg.<br />
Jan P, Calabrese C, Lips M (2013) Bestimmungsfaktoren des Stickstoff-Überschusses auf Betriebsebene. Teil 1: Analyse<br />
auf gesamtbetrieblicher Ebene. Rapporto finale all'attenzione dell'Ufficio federale dell'agricoltura. Stazione di<br />
ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, Ettenhausen<br />
Reutimann J, Heldstab J, Leippert F (2013) Stickstoff in der Land- & Ernährungswirtschaft: Stickstoffflüsse, Verluste<br />
und Reduktionspotentiale, INFRAS, Zurigo<br />
Schader C, Müller A, El-Hage Scialabba N, Hecht J, Isensee A, Erb K-H, Smith P, Makkar H P S, Klocke P, Leiber F, Schwegler<br />
P, Stolze M, Niggli U (2015) Impacts of feeding less food-competing feedstuffs to livestock on global food<br />
system sustainability. Journal of the Royal Society, Interface 12: 20150891<br />
Sutton M A, Howard C M, Erisman J W, Billen G, Bleeker A, Grennfelt P, van Grinsven H, Grizzetti B (2011) European<br />
Nitrogen Assessment. Sources, Effects and Policy Perspectives. European Commission Joint Research Centre<br />
Christine Zundel, UFAG, Settore Sistemi agroambientali e sostanze nutritive, christine.zundel@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
129
Il mio Rapporto agricolo 10 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
Emissioni di ammoniaca<br />
L'ammoniaca altera gli ecosistemi sensibili<br />
L'ammoniaca è un composto azotato (NH 3 ) volatile risultante dalla decomposizione delle proteine<br />
o dell’urea contenute negli escrementi degli animali da reddito. Le emissioni di ammoniaca<br />
non sono auspicate per diversi motivi. Da un lato, all'agricoltura viene sottratto azoto<br />
che non è pertanto più disponibile per la produzione vegetale e animale; negli anni 2012/14<br />
tali perdite in Svizzera ammontavano mediamente a 45 kg N/ha per un totale di 47 500 tonnellate<br />
di azoto. D'altro lato, l'ammoniaca che si disperde nell'ambiente ha ripercussioni negative<br />
sulla salute umana. Concorre infatti alla formazione di polveri fini che possono provocare<br />
malattie delle vie respiratorie. L'impatto è negativo anche sugli ecosistemi: una piccola parte<br />
dell'ammoniaca si trasforma in protossido di azoto (N 2 O) e contribuisce pertanto al riscaldamento<br />
climatico.<br />
L'ammoniaca viene trasportata nell'aria e depositata nuovamente al suolo in forma bagnata<br />
o secca. In ecosistemi naturali sensibili, come foreste, prati magri, paludi e brughiere,<br />
le immissioni troppo elevate di azoto sono all'origine di un carico eccessivo di concimi e<br />
dell'acidificazione che alterano i processi nel suolo, il bilancio delle sostanze nutritive e le biocenosi.<br />
Generalmente, un quarto circa delle concentrazioni di ammoniaca rilevate in un luogo<br />
proviene da fonti distanti al massimo 1 chilometro, un altro quarto da fonti distanti da 1 a 4<br />
chilometri e il resto da fonti più lontane (EKL 2014).<br />
La Büsselimoos – una torbiera alta e intermedia d'importanza nazionale (Fotografia: Christine Zundel)<br />
I diversi ecosistemi reagiscono in maniera differente alle immissioni di azoto. Per valutare se<br />
sono troppo elevate, per i diversi ecosistemi sono state stabilite soglie critiche (Critical Loads<br />
a tutela degli ecosistemi secondo la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni unite,<br />
CEENU). Per alcuni ecosistemi la soglia critica di azoto viene raggiunta già a 5 kg N/ha all'anno,<br />
per altri a 20 kg N/ha all'anno. In Svizzera, nell'Altipiano, nel Giura, sul versante alpino set-<br />
130<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 11 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
tentrionale e meridionale e in Ticino talvolta le soglie critiche vengono superate di 30 kg N/ha<br />
all'anno o più (UFAM, in preparazione).<br />
Quattro livelli di emissioni di ammoniaca<br />
L'ammoniaca può formarsi a diversi livelli del processo di produzione agricolo: in stalla o al<br />
pascolo, quando gli animali urinano e defecano; negli impianti di stoccaggio del liquame e del<br />
letame; all'atto dello spandimento dei concimi aziendali e sui suoli gestiti nel quadro della<br />
produzione vegetale.<br />
Negli ultimi 23 anni le emissioni provenienti dalle stalle sono aumentate (+34 %). Tale evoluzione<br />
è riconducibile alla crescente diffusione di stalle a stabulazione libera e corti nonché<br />
al conseguente aumento delle superfici emittenti. Le emissioni correlate allo spandimento di<br />
concimi aziendali, invece, sono diminuite (-32 %) a causa, da un lato, del calo del numero di<br />
animali, di un migliore foraggiamento, dell'uscita più frequente al pascolo e delle maggiori<br />
perdite in stalla con conseguente diminuzione dell'azoto presente negli impianti di stoccaggio<br />
dei concimi aziendali e, dall'altro, di una maggiore diffusione delle tecniche di spandimento<br />
di liquame a basse emissioni, come ad esempio quella che prevede l'utilizzo di tubi flessibili a<br />
strascico (Kupper et al. 2015). Negli anni 2012/14 le emissioni correlate allo spandimento di<br />
concimi aziendali ammontavano mediamente al 46 per cento, quelle provenienti dalla stalla/<br />
corte al 34 per cento, quelle degli impianti per lo stoccaggio di concimi aziendali al 17 per cento<br />
e quelle sul pascolo al 3 per cento delle emissioni totali riconducibili alla detenzione di animali.<br />
Emissioni di ammoniaca stabili da 15 anni<br />
Secondo i calcoli effettuati con il modello Agrammon (www.agrammon.ch), dal 1990/92 a livello<br />
svizzero le emissioni di ammoniaca provenienti dall'agricoltura sono diminuite del 16 per<br />
cento. Il calo si è verificato prevalentemente tra il 1990 e il 2000 ed è coinciso con la flessione<br />
degli effettivi di animali detenuti in Svizzera. Da allora le emissioni di ammoniaca si sono stabilizzate<br />
su un livello elevato. Negli anni 2012/14 mediamente il 71 per cento delle emissioni<br />
agricole era riconducibile alla detenzione di bestiame bovino, il 13 per cento a quella di suini<br />
e il 4 per cento a quella di pollame. Il 9 per cento delle emissioni agricole di ammoniaca proveniva<br />
dalla produzione vegetale. Negli ultimi 23 anni queste percentuali non hanno subito<br />
variazioni di rilievo.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
131
Il mio Rapporto agricolo 12 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
I dati sulle emissioni di ammoniaca e su altri indicatori agroambientali a livello nazionale sono<br />
disponibili su Servizi.<br />
Lacune considerevoli<br />
Per proteggere gli ecosistemi da apporti troppo elevati di azoto occorre ridurre notevolmente le<br />
emissioni di ammoniaca provenienti dall'agricoltura. L'obiettivo ambientale di al massimo 25<br />
000 tonnellate di NH 3 –N/ha l'anno, per il cui raggiungimento non è stata fissata una scadenza<br />
(UFAM/UFAG 2008), e l'obiettivo intermedio di 41 000 tonnellate di NH 3 –N/ha indicato nel<br />
messaggio sulla Politica agricola 2014/2017 potranno essere raggiunti soltanto intensificando<br />
gli sforzi per la riduzione delle emissioni.<br />
Dall'analisi dei dati rilevati in circa 200 aziende nel quadro del monitoraggio agroambientale,<br />
per il 2014 emerge che le emissioni di ammoniaca per unità di superficie variano considerevolmente<br />
a seconda del tipo di azienda. Ciò è dovuto al fatto che i quantitativi maggiori di ammoniaca<br />
sono emessi nella detenzione di animali. Ma anche tra i diversi tipi di aziende dedite<br />
all'allevamento di animali le differenze sono notevoli. Parte di esse sono riconducibili al fatto<br />
che alcune delle aziende prese in esame applicano tecnologie, sistemi e pratiche di gestione<br />
a basse emissioni, come il foraggiamento scaglionato, la tenuta al pascolo, la copertura degli<br />
impianti per lo stoccaggio del liquame, i tubi flessibili a strascico, lo spandimento di concimi<br />
aziendali nei periodi freschi dell'anno, l'incorporazione del letame nel suolo, eccetera, mentre<br />
altre no.<br />
132<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 13 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
I dati sulle emissioni di ammoniaca e su altri indicatori agroambientali a livello nazionale sono<br />
disponibili su Servizi.<br />
Impegno della Confederazione e dei Cantoni per la riduzione delle<br />
emissioni di ammoniaca<br />
Nell'ottica di contribuire a colmare le lacune, nel 2008 la Confederazione ha lanciato un programma<br />
volto a migliorare la sostenibilità nell'utilizzo delle risorse naturali (art. 77a LAgr). Da<br />
allora gli enti promotori possono presentare alla Confederazione progetti con questa finalità<br />
(«progetti sulle risorse»). Fino al 2014 compreso, la Confederazione ha stanziato complessivamente<br />
77,8 milioni di franchi a favore di 16 progetti sulle risorse volti a ridurre le emissioni<br />
di ammoniaca. Sono stati promossi in particolare l'utilizzo di tecniche di spandimento a basse<br />
emissioni di concimi aziendali, misure nell'ambito del foraggiamento e la copertura di impianti<br />
per lo stoccaggio del liquame. I Cantoni hanno contribuito al finanziamento dei progetti con un<br />
importo di 20,9 milioni di franchi. Dal 2014, inoltre, gli agricoltori, indipendentemente da enti<br />
promotori e progetti, possono richiedere contributi per l'efficienza delle risorse (pagamenti<br />
diretti giusta l'art. 70 LAgr) per l’utilizzo di tecniche di spandimento a basse emissioni.<br />
Gli incentivi statali per le tecniche di spandimento a basse emissioni di liquame ne hanno determinato<br />
una maggiore accettazione da parte degli agricoltori con conseguente notevole incremento<br />
nella loro applicazione. A oggi, un terzo circa delle aziende aventi diritto ai pagamenti<br />
diretti e dedite alla detenzione di animali ha partecipato a un progetto sulle risorse «ammoniaca»<br />
o percepito contributi per l'efficienza delle risorse avendo applicato tecniche di spandimento<br />
a basse emissioni dei concimi aziendali. I contributi della Confederazione sono tuttavia<br />
soltanto un incentivo temporaneo e gli effetti devono proseguire anche dopo tale finanziamento<br />
iniziale. L'applicazione di questo principio ha fatto sì che le tecniche di spandimento<br />
a basse emissioni godano attualmente del favore degli agricoltori e siano conformi allo stato<br />
della tecnica.<br />
Il risultato più positivo osservato tra le aziende campicole è riconducibile alla produzione vegetale<br />
quantitativamente più significativa (e in alcuni casi con un elevato apporto energetico<br />
come per cereali, patate, barbabietola da zucchero e colza). Al contrario, nelle aziende<br />
detentrici di vacche madri e in quelle del tipo «Altri bovini», data la trasformazione di pro-<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
133
Il mio Rapporto agricolo 14 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
dotti vegetali in prodotti animali (carne) viene prodotta comparativamente meno energia per<br />
l'alimentazione umana cosicché l'efficienza energetica risulta bassa nonostante una produzione<br />
a basso impatto sulle risorse.<br />
Situazione all'estero<br />
Rispetto ai Paesi limitrofi (Germania meridionale, Francia meridionale, Austria, Italia), in Svizzera<br />
l'impatto ambientale delle emissioni di ammoniaca è elevato (SRU 2015, AEA 2014). Lo è<br />
anche rispetto ad altri Paesi nel mondo; le regioni meno inquinate sono in Russia, nell'America<br />
del Nord e del Sud, in Africa e nell'Oceania (Steffen et al. 2015). Ciò è dovuto alla combinazione<br />
di effettivi elevati di animali, stalle arieggiate ed ecosistemi sensibili che caratterizzano<br />
la Svizzera.<br />
In Europa, la Svizzera, dopo i Paesi Bassi, presenta le emissioni di ammoniaca per ettaro<br />
di superficie agricola utile più elevate. La Danimarca, con una densità di animali analoga a<br />
quella svizzera, ha adottato una strategia efficace contro le elevate emissioni di ammoniaca;<br />
negli ultimi 25 anni le ha infatti ridotte da 44 a 27 kg di azoto per ettaro all'anno (ca. -40<br />
%) (OCSE 2013). Questo risultato è frutto delle seguenti misure: obbligo di copertura degli<br />
impianti di stoccaggio del liquame, divieto di utilizzo delle barre nello spandimento di liquame,<br />
obbligo di utilizzo di attrezzature per l'iniezione dei concimi nel suolo nelle regioni<br />
ecologicamente sensibili, incorporazione dei concimi aziendali nel suolo entro al massimo sei<br />
ore dallo spandimento, inasprimento delle prescrizioni in materia di aumento della capacità<br />
delle aziende d'allevamento nelle zone tampone che delimitano le regioni sensibili, campagne<br />
d'informazione per un maggiore utilizzo dell'azoto negli alimenti per animali. Le misure fina-<br />
134<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 15 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
lizzate in maniera specifica a ridurre le emissioni di ammoniaca rientrano in una serie di provvedimenti<br />
volti a ridimensionare le eccedenze di azoto (Dalgaard et al. 2014, Kronvang et al.<br />
2011).<br />
Conclusioni<br />
Le lacune in relazione all'obiettivo prefissato in materia di emissioni di ammoniaca sono tuttora<br />
notevoli.<br />
Le emissioni di ammoniaca equivalgono a una perdita di azoto per l'agricoltura e hanno diverse<br />
ripercussioni negative, in particolare sugli ecosistemi naturali e sulla salute umana. Onde evitare<br />
eccessive immissioni di azoto nell'ambiente sono necessari ulteriori sforzi per la riduzione<br />
delle emissioni.<br />
A tal fine è disponibile una vasta gamma di misure tecniche e aziendali dimostratesi idonee<br />
per migliorare l'efficienza aziendale nell'utilizzo dell'azoto. Si sono rivelate particolarmente<br />
efficaci quelle in relazione alla valorizzazione del foraggio da parte dell'animale. Consentono<br />
infatti di ridurre le immissioni nell'ambiente di azoto destinato a trasformarsi in ammoniaca a<br />
uno dei livelli di emissione successivi.<br />
Laddove, nonostante tali misure, si rilevano immissioni elevate in ecosistemi naturali e sensibili<br />
occorre prendere ulteriori provvedimenti. Poiché le emissioni di ammoniaca hanno effetti<br />
soprattutto sul piano locale e (sovra)regionale, l'intensità della produzione deve essere adeguata<br />
al luogo e alla sopportabilità dei rispettivi ecosistemi.<br />
Bibliografia<br />
UFAM (2016) in preparazione<br />
UFAM/UFAG (2008): Obiettivi ambientali per l'agricoltura. Umwelt-Wissen n. 0820. Ufficio federale dell'ambiente,<br />
Berna.<br />
Dalgaard T, Hansen B, Hasler B, Hertel O, Hutchings N J, Jacobsen B H, Jensen L S, Kronvang B, Olesen J E, Schjørring<br />
J K, Kristensen I S, Graversgaard M, Termansen M, Vejre H (2014) Policies for agricultural nitrogen ma-<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
135
Il mio Rapporto agricolo 16 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
nagement—trends, challenges and prospects for improved efficiency in Denmark. Environmental Research Letters<br />
9:115002<br />
European Environment Agency (2014) Effects of air pollution on European ecosystems. Past and future exposure of<br />
European freshwater and terrestrial habitats to acidifying and eutrophying air pollutants. Publications Office of the<br />
European Union, Lussemburgo, pag. 38<br />
Commissione federale d'igiene dell'aria (2014) Immissioni di ammoniaca e immissioni di azoto. Studio della CFIAR<br />
sulla valutazione degli eccessi. Berna. 62 pagg.<br />
Kupper T, Bonjour C, Menzi H (2015) Evolution of farm and manure management and their influence on ammonia<br />
emissions from agriculture in Switzerland between 1990 and 2010. Atmospheric Environment 103:215-221.<br />
Kronvang B, Andersen H E, Børgesen C, Dalgaard T, Larsen S E, Bøgestrand J, Blicher-Mathiasen G (2011) Effects of<br />
policy measures implemented in Denmark on nitrogen pollution of the aquatic environment. Environmental Science<br />
and Policy 11:144-152<br />
OCSE (2013) Compendium of Agri-Environmental Indicators, Pubblicazioni OCSE, Parigi. 182 pagg.<br />
Sachverständigenrat für Umweltfragen (2015) Stickstoff: Lösungsstrategien für ein drängendes Umweltproblem.<br />
Sondergutachten. Erich Schmidt Verlag GmbH, Berlino, 348 pagg.<br />
Steffen W, Richardson K, Rockström J, Cornell S E, Fetzer I, Bennett E M, Biggs R, Carpenter S R, de Vries W, de Wit C<br />
A, Folke C, Gerten D, Heinke J, Mace G M, Persson L M, Ramanathan V, Reyers B, Sörlin S (2015) Planetary Boundaries:<br />
Guiding Human Development on a Changing Planet. Science (347)6223.<br />
Christine Zundel, UFAG, Settore Sistemi agroambientali e sostanze nutritive, christine.zundel@blw.admin.ch<br />
136<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 17 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
Emissioni di protossido di azoto<br />
Il protossido di azoto altera il clima<br />
In ambito agricolo, il protossido di azoto (N 2 O) si forma in diversi processi biochimici a partire<br />
da composti azotati differenti. Viene sprigionato prevalentemente nella detenzione di animali<br />
e nello spandimento di concimi azotati sui terreni. È anche il prodotto indiretto delle perdite di<br />
azoto sotto forma di nitrati e ammoniaca. Il protossido di azoto permane per più di cent'anni<br />
nell'atmosfera e ha un potenziale di riscaldamento climatico circa 300 volte più elevato rispetto<br />
alla CO 2 . Rappresenta circa un terzo degli effetti sul clima provocati dai gas serra provenienti<br />
dall'agricoltura svizzera. Siccome il protossido di azoto si forma sia in campicoltura sia nella<br />
detenzione di animali interessa un gran numero di sistemi agricoli di produzione. A causa del<br />
suo impatto globale, è irrilevante, dal profilo delle scienze naturali, dove, sul piano mondiale,<br />
vengono prodotto o ridotte le emissioni.<br />
Stagnazione anziché riduzione<br />
Secondo l’Inventario nazionale dei gas serra, nel 2012/14 le emissioni di protossido di azoto<br />
sono diminuite del 12 per cento circa rispetto al 1990/92. Ciò è riconducibile al calo degli effettivi<br />
di animali e a un minore utilizzo di concimi minerali negli anni ’90. Da allora le emissioni<br />
ristagnano. La Strategia sul clima per l’agricoltura (UFAG, 2011) si prefigge l’obiettivo di<br />
ridurre le emissioni di gas serra provenienti dall’agricoltura di almeno un terzo entro il 2050.<br />
La quota maggiore di protossido di azoto è prodotta dalla concimazione (45 %); seguono le<br />
emissioni indirette dovute al trasporto di ammoniaca e nitrati (25 %), quelle dei concimi aziendali<br />
(19 %) e quelle delle deiezioni degli animali al pascolo (11 %). Dal 1990 queste percentuali<br />
sono rimaste pressoché stabili.<br />
I dati sulle emissioni di protossido di azoto e su altri indicatori agroambientali a livello nazionale<br />
e aziendale sono disponibili su Servizi.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
137
Il mio Rapporto agricolo 18 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
Grandi incertezze<br />
Le cifre riportate nell’Inventario nazionale dei gas serra sono stime risultanti dall’applicazione<br />
di modelli che considerano prevalentemente il numero di animali detenuti, le superfici gestite<br />
a scopo agricolo, il volume di concimi utilizzato e fattori d’emissione più o meno specifici. Le<br />
incertezze, con una fascia di fluttuazione di +/- 80 %, sono tuttavia grandi. Quella maggiore<br />
riguarda la portata assoluta delle emissioni, mentre i dati sul calo verificatosi dal 1990/92 in<br />
seguito a una gestione meno intensiva dei concimi sono molto attendibili. All’Empa sono in<br />
corso lavori per verificare queste cosiddette stime «bottom-up» mediante metodi atmosferici<br />
«top-down» che prevedono una combinazione tra misurazioni nell’atmosfera e un modello di<br />
trasporto. Se per il gas serra metano nel frattempo sono stati ottenuti buoni risultati (Henne<br />
et al., 2016), per il protossido di azoto sono necessari ulteriori sforzi poiché finora non è disponibile<br />
un numero sufficiente di misurazioni nell’atmosfera.<br />
Sono necessarie misure idonee!<br />
I processi di formazione del protossido di azoto sono influenzati da condizioni ambientali come<br />
precipitazioni, temperatura, tenore di ossigeno, temperatura e pH del suolo nonché da misure<br />
di gestione come concimazione, lavorazione del suolo, avvicendamento delle colture e utilizzazione<br />
degli erbai. La dinamica territoriale e temporale così come la variabilità di tali processi<br />
sono molto elevate e caratterizzate da una grande incertezza (Skinner et al. 2016, Merbold et<br />
al. 2014). È quindi difficile trovare misure idonee per un’efficace riduzione delle emissioni.<br />
Agroscope punta anche su misure volte a ridurre le emissioni di protossido di azoto provenienti<br />
dal suolo. Secondo esperimenti in laboratorio e in pieno campo, l’incorporazione di carbone<br />
vegetale nel suolo potrebbe contribuire a ridurre le emissioni (Hüppi et al. 2015, Felber et al.<br />
2013). Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per capirne i meccanismi. La riduzione potrebbe<br />
essere innescata da una nuova composizione dei batteri del suolo, da specifiche proprietà<br />
elettrocatalitiche del carbone vegetale, da una maggiore aerazione del suolo e/o dall’aumento<br />
del pH del suolo.<br />
Conclusioni<br />
Onde fornire un contributo sostanziale per frenare il riscaldamento climatico e quindi per raggiungere<br />
gli obiettivi della Strategia sul clima per l’agricoltura, sono necessarie misure urgenti<br />
di riduzione delle emissioni di protossido di azoto. La grande sfida è rappresentata dai processi<br />
biochimici complessi e variabili nella formazione di questo composto. Finché non saranno stati<br />
svelati, la riduzione della quantità di azoto emessa nell’ambiente rappresenta la misura più efficace.<br />
A tal fine occorrono forme di organizzazione, pratiche di gestione e tecnologie che permettano<br />
di aumentare l’assimilazione di azoto da parte degli animali (attraverso il foraggio)<br />
e delle piante (attraverso la concimazione), rendendo quindi più efficiente la produzione agricola.<br />
Bibliografia<br />
UFAG (2011) Strategia sul clima per l’agricoltura, Protezione del clima e adattamento ai cambiamenti climatici per<br />
una filiera agroalimentare svizzera sostenibile, 46 pagg.<br />
Felber R, Leifeld J, Horák J, Neftel A (2014) N 2 O emission reduction with greenwaste biochar: comparison of laboratory<br />
and field experiment. European Journal of Soil Science 65:128-138.<br />
Henne S, Brunner D, Oney B, Leuenberger M, Eugster W, Bamberger I, Meinhardt F, Steinbacher M, Emmenegger<br />
L (2016) Validation of the Swiss methane emission inventory by atmospheric observations and inverse modelling.<br />
Atmos. Chem. Phys., 16:3683-3710.<br />
Hüppi R, Felber R, Neftel A, Six J, Leifeld J (2015) Effect of biochar and liming on soil nitrous oxide emissions from a<br />
temperate maize cropping system. Soil 1:707-717<br />
138<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 19 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
Merbold L, Eugster W, Stieger J, Zahniser M, Nelson D, Buchmann N (2014) Greenhouse gas budget (CO 2 , CH 4 and<br />
N 2 O) of intensively managed grassland following restoration. Global Change Biology 20:1913-1928<br />
Skinner C et al (2016) in preparazione<br />
Christine Zundel, UFAG, Settore Sistemi agroambientali e sostanze nutritive, christine.zundel@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
139
Il mio Rapporto agricolo 20 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
Nitrati nell’acqua<br />
Nella produzione vegetale le rese dipendono dalla disponibilità di azoto. La concimazione ha<br />
pertanto un ruolo fondamentale. A causa della complessità dei processi naturali, può capitare,<br />
specialmente nel settore della campicoltura, che nel suolo siano presenti più nitrati di quanti<br />
possano esserne assimilati dalle piante. Per effetto delle precipitazioni e del dilavamento, i<br />
nitrati possono finire nelle acque sotterranee e raggiungere la falda, ovvero la nostra principale<br />
fonte di acqua potabile. In Svizzera, oltre l’80 per cento dell’acqua potabile proviene dalle<br />
acque sotterranee. Attraverso queste ultime o per dilavamento diretto nei corsi d’acqua e nei<br />
laghi, i nitrati raggiungono il mare, alterando gli equilibri di sostanze nutritive, soprattutto<br />
nelle regioni costiere. Aumenta la formazione di alghe e le sostanze tossiche da esse rilasciate,<br />
in combinazione con l’assenza di ossigeno risultante dalla decomposizione delle alghe morte,<br />
hanno conseguenze disastrose per la fauna e la flora marine.<br />
Nei corsi d’acqua non finiscono soltanto le emissioni delle superfici gestite a scopo agricolo,<br />
bensì anche l’azoto reattivo sotto forma di nitrati o ammonio proveniente da altre superfici e<br />
da fonti puntuali come, ad esempio, gli impianti di depurazione delle acque e di regolazione<br />
del deflusso delle acque meteoriche. Le emissioni di nitrati da superfici non agricole vengono<br />
indirettamente influenzate dall’agricoltura tramite il deposito di ammoniaca.<br />
Tenori di nitrati nelle acque sotterranee stabili<br />
In natura le acque sotterranee contengono soltanto pochi milligrammi di nitrati per litro. Per i<br />
corsi d’acqua dai quali viene prelevata l’acqua potabile l’ordinanza sulla protezione delle acque<br />
prescrive un valore numerico di al massimo 25 mg di nitrati il litro. Il diritto sulle derrate alimentari,<br />
prevede un valore di 40 mg di nitrati il litro.<br />
La concentrazione di nitrati è particolarmente elevata nelle falde acquifere sottostanti i terreni<br />
coltivi; in circa la metà delle stazioni di misurazione dell’Osservazione nazionale delle acque<br />
sotterranee (NAQUA) supera il valore di 25 mg il litro.<br />
Attualmente la concentrazione di nitrati si aggira sul livello del 2002. Negli ultimi anni la situazione<br />
è notevolmente migliorata.<br />
140<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 21 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
Concentrazione di nitrati, valore massimo e valore medio per stazione di misurazione NAQUA. Quota di superficie coltiva<br />
aperta rispetto alla superficie comunale.<br />
Fonte: Osservazione nazionale delle acque sotterranee (NAQUA)<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
141
Il mio Rapporto agricolo 22 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
Evoluzione della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee nelle stazioni di misurazione il cui comprensorio è<br />
utilizzato prevalentemente per la campicoltura o la pastorizia e la produzione animale. Valore massimo per stazione<br />
di misurazione NAQUA. Numero di misurazioni per forma principale di utilizzazione del suolo: campicoltura: 95; pastorizia<br />
e produzione animale: 144.<br />
Fonte: Osservazione nazionale delle acque sotterranee NAQUA<br />
Se la concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee da cui è previsto o viene effettuato il<br />
prelievo di acqua potabile supera il valore di 25 mg di nitrati il litro, i Cantoni sono tenuti a<br />
individuarne le cause e a provvedere affinché vengano prese le dovute misure conformemente<br />
alle rispettive prescrizioni. Nell’ambito dei crediti disponibili, possono beneficiare di indennizzi<br />
per le misure attuate in ambito agricolo (cfr. Contributi per la protezione delle acque). Il<br />
processo di rinnovamento delle acque sotterranee è spesso molto lento, ragion per cui passano<br />
anni e in alcuni casi addirittura decenni prima di poter percepire l’effetto delle misure prese.<br />
Il tema del tenore di nitrati nell’acqua è sempre d’attualità. A causa dell’estensione degli insediamenti,<br />
le possibilità di captare acqua potabile scarseggiano. Parallelamente, vi sono indicazioni<br />
secondo cui il cambiamento climatico potrebbe determinare un aumento del tenore di<br />
nitrati nelle acque sotterranee.<br />
Immissioni nell’acqua di nitrati provenienti dall’agricoltura<br />
Nella Convenzione Oslo-Parigi per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale<br />
(OSPAR) e in quella per la protezione del Reno la Svizzera si è impegnata a ridurre le<br />
immissioni di sostanze nutritive nelle acque, segnatamente del 50 per cento (senza scadenza)<br />
rispetto al 1985. Lo stesso obiettivo è stato fissato negli Obiettivi ambientali per l’agricoltura<br />
(UFAM/UFAG 2008) per il settore primario.<br />
Le immissioni di nitrati nei corsi d’acqua provengono da fonti puntuali (soprattutto acque di<br />
scarico degli insediamenti) e diffuse (soprattutto agricole). Il modello MODIFUSS permette di<br />
stimare le immissioni diffuse di nitrati nei corsi d’acqua.<br />
142<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 23 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
Stima delle immissioni diffuse di nitrati nei corsi d’acqua<br />
Fonte d’immissione kg N / ha t N %<br />
Superficie coltiva aperta 47.8 19 449 38<br />
Prati permanenti 11.8 4044 8<br />
Pascoli propri 21.8 3664 7<br />
Superficie utile alpestre 7.7 3964 8<br />
Superficie frutticola, orticola<br />
e viticola<br />
21.3 1087 2<br />
Foresta 5.7 7356 14<br />
Detriti, sabbia, roccia,<br />
ghiacciai<br />
6.9 3983 8<br />
Vegetazione improduttiva 4.1 1221 2<br />
Corsi d’acqua 15.2 2653 5<br />
Insediamenti 21.3 4072 8<br />
Totale 12.5 51 493 100<br />
Fonte: Prasuhn et al., 2016<br />
Secondo i calcoli per il bacino imbrifero del Reno al di sotto dei laghi, in Svizzera le immissioni<br />
di azoto da fonti diffuse sono diminuite del 18 per cento tra il 1985 e il 2001. Su tutto il territorio<br />
elvetico, nel periodo dal 2000 al 2010 vi è stato un ulteriore calo del 3,5 per cento.<br />
Il primario concorre alle immissioni diffuse di azoto tramite le emissioni provenienti dalle superfici<br />
utilizzate a scopo agricolo cui si aggiunge una parte di quelle dalle foreste e dalle superfici<br />
improduttive che aumentano a causa del deposito di ammoniaca emessa dall’agricoltura.<br />
Sul piano nazionale, il carico proveniente dall’agricoltura ammontava a 49 000 tonnellate<br />
di azoto nel 1985 e a 36 500 tonnellate nel 2010. È stata quindi ottenuta una riduzione di<br />
12 500 tonnellate di azoto, ovvero del 26 per cento. Tuttavia, si è ancora nettamente al di sotto<br />
dell’obiettivo ambientale del 50 per cento di riduzione (Prasuhn, 2016).<br />
Come possono essere ridotte le immissioni di azoto nei corsi d’acqua?<br />
Vi sono diverse possibilità di ridurre ulteriormente le immissioni di azoto provenienti<br />
dall’agricoltura. Si potrebbe, ad esempio, convertire la superficie coltiva in superficie inerbita,<br />
considerato che le immissioni di azoto nel sottosuolo dei terreni coltivi sono circa il quadruplo<br />
di quelle riscontrate sotto i prati permanenti. Tuttavia, se vengono tenuti più animali aumentano<br />
anche le emissioni di ammoniaca. Per ridurre le immissioni di azoto nelle acque è possibile<br />
estensivare la campicoltura e la foraggicoltura, limitare le colture dalle quali il dilavamento<br />
dei nitrati è particolarmente elevato, optare per una lavorazione del suolo rispettosa delle sue<br />
caratteristiche, concimare in maniera più mirata, inerbire e preservare la copertura del suolo.<br />
Anche la riduzione delle emissioni di ammoniaca consente di ridurre considerevolmente le immissioni<br />
di azoto nelle acque, poiché una parte rilevante di questo azoto finisce direttamente<br />
nei corsi d’acqua o viene dilavato dopo essersi depositato sulle superfici.<br />
In Svizzera il dimezzamento, rispetto al 1985, delle immissioni di azoto provenienti<br />
dall’agricoltura nell’acqua senza limitare massicciamente la produzione è una grande sfida.<br />
Per poter colmare meglio le lacune sono necessari miglioramenti considerevoli sul piano<br />
dell’efficienza. Le migliorie tecniche ed organizzative che hanno dimostrato di essere efficaci<br />
vanno applicate su tutto il territorio nazionale. Occorre inoltre investire nella ricerca e nella<br />
sperimentazione di altre innovazioni. Gli interventi devono riguardare l’intera catena di pro-<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
143
Il mio Rapporto agricolo 24 / 39<br />
AMBIENTE > AZOTO<br />
duzione, ovvero la selezione, lo sviluppo di nuovi sistemi di produzione chiusi o l’applicazione<br />
dell’agricoltura di precisione. Se l’incremento dell’efficienza non dovesse bastare per raggiungere<br />
gli obiettivi prefissati, si dovrà adeguare l’intensità della produzione animale e vegetale,<br />
riducendola.<br />
Per quanto riguarda il tenore di nitrati nelle acque sotterranee, la necessità d’intervento varia<br />
a seconda del luogo. Se e come il primario debba intervenire dipende dalle condizioni naturali<br />
e dalle esigenze della società. Occorre tuttavia adeguare in maniera ottimale i sistemi di produzione<br />
ai diversi luoghi.<br />
Bibliografia<br />
UFAM, UFAG, 2008: Obiettivi ambientali per l’agricoltura<br />
Prasuhn V., Sieber U., 2005: Changes in diffuse phosphorous and nitrogen inputs into surface waters in the Rhine<br />
watershed in Switzerland. Acquatic Sciences 67: 363-371<br />
Prasuhn V., Kupferschmied P., Spiess E., Hürdler J., 2016: Szenario-Berechnungen für das Projekt zur Verminderung<br />
diffuser Nährstoffeinträge in die Gewässer der Schweiz mit MODIFFUS. Agroscope<br />
Prasuhn V., 2016: Abklärungen zum Umweltziel Landwirtschaft: Reduktion der landwirtschaftsbedingten Stickstoffeinträge<br />
in die Gewässer um 50% gegenüber 1985. Agroscope<br />
Ruth Badertscher, UFAG, Settore Sistemi agroambientali e sostanze nutritive, ruth.badertscher@blw.admin.ch<br />
144<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 25 / 39<br />
AMBIENTE > ACQUA<br />
Acqua e agricoltura<br />
L'agricoltura incide sulla quantità e sulla qualità dell'acqua. Esiste altresì una connessione tra<br />
la gestione delle superfici e la struttura dei corsi d'acqua.<br />
Impatto dell'agricoltura sulla qualità dell'acqua<br />
Il monitoraggio agroambientale comprende indicatori sulla qualità dell'acqua e fattori che incidono<br />
su di essa. Nel Rapporto agricolo 2016 si tocca il tema dell'azoto, soffermandosi sulle<br />
emissioni di nitrati nelle acque e sul tenore di nitrati nelle acque sotterranee, sull' e sull'. Il<br />
tema del fosforo, compreso il rispettivo tenore nei laghi, era stato trattato nel Rapporto agricolo<br />
2014 .<br />
Agricoltura e quantità d'acqua<br />
Per quanto riguarda la quantità d'acqua, a svolgere un ruolo determinante sono il drenaggio<br />
delle superfici con forte accumulo idrico e l'irrigazione.<br />
Il drenaggio ha consentito di coltivare superfici a scopo agricolo o ha migliorato le possibilità<br />
di produrre derrate alimentari. La rete di drenaggi della Svizzera è stata in gran parte realizzata<br />
prima della fine degli anni '80. Un quinto circa delle superfici agricole utili è drenato. Il 70<br />
per cento di esse è rappresentato da superfici per l'avvicendamento delle colture, qualitativamente<br />
più adatte alla campicoltura e basilari per la sicurezza dell'approvvigionamento. Le sfide<br />
che si pongono dal profilo ambientale sono la preservazione e il ripristino di biotopi umidi,<br />
le immissioni di sostanze nutritive e di prodotti fitosanitari attraverso il drenaggio nonché la<br />
protezione dei suoli paludosi.<br />
In Svizzera oggi è irrigata soltanto una piccola percentuale della superficie agricola utile. Con<br />
il cambiamento climatico il fabbisogno irriguo è destinato ad aumentare. Nel Rapporto agricolo<br />
2015 sono stati illustrati gli effetti del cambiamento climatico sulle risorse idriche e sui corsi<br />
d'acqua, entrando anche nel merito della questione di come affrontare la rarefazione delle<br />
risorse.<br />
Agricoltura e spazio per i corsi d'acqua<br />
Oggigiorno i processi dinamici dei corsi d'acqua naturali sono limitati su lunghi tratti dalle<br />
opere edili. Le conoscenze in merito ai danni potenziali delle piene, i costi di realizzazione e la<br />
maggiore valenza attribuita alla biodiversità hanno fatto sì che la protezione contro le piene<br />
non debba necessariamente essere garantita soltanto attraverso opere edili. I Cantoni devono<br />
anche delimitare un spazio lungo i principali corsi d'acqua che sia sufficiente per diverse funzioni<br />
(gestione delle piene, contributo all'immagine del paesaggio, habitat naturale per organismi<br />
acquatici, importanti elementi di interconnessione per la biodiversità anche dal profilo<br />
territoriale, ecc.), da gestire soltanto in modo estensivo.<br />
Bibliografia<br />
BÉGUIN, J., SMOLA, S. (2010): Stato dei drenaggi in Svizzera, Bilancio del sondaggio 2008. Ufficio federale<br />
dell'agricoltura, Settore Migliorie fondiarie.<br />
UST, 2012. Censimento delle aziende agricole: rilevazione complementare 2010. Comunicato stampa. Ufficio federale<br />
di statistica, Neuchâtel.<br />
Ruth Badertscher, UFAG, Settore Sistemi agroambientali e sostanze nutritive, ruth.badertscher@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
145
Il mio Rapporto agricolo 26 / 39<br />
AMBIENTE > ACQUA<br />
Utilizzo di prodotti fitosanitari<br />
I prodotti fitosanitari sono utilizzati per proteggere le colture da organismi nocivi, malattie<br />
o piante concorrenti, allo scopo di assicurare il raccolto e la qualità delle derrate alimentari<br />
e degli alimenti per animali. Oltre agli effetti previsti sugli organismi bersaglio («organismi<br />
nocivi») possono tuttavia avere anche effetti collaterali indesiderati su uomo e ambiente (sui<br />
cosiddetti organismi non bersaglio).<br />
In Svizzera ogni anno sono vendute circa 2200 tonnellate di principi attivi di prodotti fitosanitari.<br />
Nel periodo 2007–2014 il volume di smercio è rimasto relativamente costante. I fungicidi,<br />
impiegati nella lotta alle malattie fungine, e gli erbicidi, utilizzati nella lotta alle malerbe, costituiscono<br />
la quota più alta in termini quantitativi, pari rispettivamente al 40 per cento circa.<br />
Il 16 per cento circa del volume di smercio è rappresentato dagli insetticidi impiegati nella lotta<br />
agli insetti nocivi.<br />
Questi dati relativi allo smercio consentono di fare alcune considerazioni sull'evoluzione generale<br />
dell'utilizzo di determinati gruppi di principi attivi in Svizzera. Al fine di valutare la rilevanza<br />
ambientale e mettere a punto eventuali misure atte a ridurre l'utilizzo e gli eventuali<br />
rischi, è tuttavia fondamentale sapere dove, come e quando vengono impiegati questi principi<br />
attivi. I dati relativi allo smercio contemplano prodotti fitosanitari per diversi campi di applicazione<br />
in agricoltura, come ad esempio campicoltura, frutticoltura, vitivinicoltura, orticoltura,<br />
ma anche per altre applicazioni non agricole in silvicoltura, giardini e orti domestici e lungo<br />
le vie di comunicazione.<br />
Nel quadro del monitoraggio agroambientale, dal 2009 vengono pertanto rilevati e valutati<br />
dati dettagliati sull'utilizzo in agricoltura, calcolando l'indicatore «Impiego di prodotti fitosanitari».<br />
Quest'ultimo fornisce informazioni rilevanti dal profilo agronomico sull'evoluzione<br />
dell'utilizzo di prodotti fitosanitari per singola coltura. Tuttavia ciò non consente di trarre conclusioni<br />
sugli effetti ecologici. Per questa ragione si sta mettendo a punto l'indicatore «Rischi<br />
acquatici», in base a cui saranno valutati i rischi potenziali per gli organismi acquatici.<br />
146<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 27 / 39<br />
AMBIENTE > ACQUA<br />
Indicatore «Impiego di prodotti fitosanitari»<br />
Dai dati sull'impiego di prodotti fitosanitari si calcolano due indicatori: la quantità di principi<br />
attivi utilizzata per ettaro, per coltura e per gruppo di principi attivi nonché il numero di interventi<br />
(trattamenti fitosanitari, metodologia: cfr. de Baan et al. 2015). Tra i singoli gruppi<br />
di principi attivi si delineano differenze notevoli relative alla quantità utilizzata per ettaro.<br />
Questo indicatore si addice pertanto al confronto con i dati nazionali sullo smercio. Il numero<br />
di interventi è l’indicatore più attendibile per quanto riguarda la frequenza dei trattamenti. Dal<br />
profilo agronomico sono interessanti i dati relativi alla distibuzione perché danno un'idea del<br />
modo in cui viene attuata la protezione fitosanitaria di una determinata coltura e del potenziale<br />
per misure di riduzione (cfr. UFAG 2012).<br />
Su frutta a granelli e vite è stata applicata la maggior quantità di prodotti fitosanitari per unità<br />
di superficie e nella maggior parte dei casi si è trattato di fungicidi. Anche le patate e la frutta<br />
a nocciolo sono state trattate principalmente con principi attivi del gruppo dei fungicidi. Nelle<br />
altre principali colture si è ricorso soprattutto agli erbicidi, in particolare per la barbabietola da<br />
zucchero. Per la frutta a granelli, le patate e la frutta a nocciolo sono stati impiegati in quantitativi<br />
considerevoli anche altri principi attivi come l'olio di paraffina ad azione insetticida.<br />
Le quantità di insetticida più elevate sono risultate quelle applicate su patate, frutta a granelli<br />
e a nocciolo.<br />
Se si moltiplica il volume di principio attivo applicato per ettaro di coltura per la superficie di<br />
coltivazione della coltura in Svizzera, si ottiene una stima approssimativa del volume di principio<br />
attivo applicato complessivamente su queste colture a livello nazionale. Da ciò si evince<br />
che in termini di utilizzo dei prodotti fitosanirari rivestono una maggiore importanza determinate<br />
colture che presentano una quantità di prodotto fitosanitario per superficie relativamente<br />
bassa ma che vengono coltivate su una quota estesa rispetto alla superficie totale, come ad esempio<br />
il mais o il frumento autunnale. Altre colture, come la frutta a nocciolo, in questa stima<br />
a livello nazionale hanno segnato una quota piuttosto bassa rispetto all'impiego di prodotti<br />
fitosanitari in Svizzera. Vite, frutta a granelli e patate sono risultate anche in questo frangente<br />
le colture su cui è stato impiegato il maggior quantitativo di prodotti fitosanitari.<br />
Il volume estrapolato dalle applicazioni di prodotti fitosanitari nel monitoraggio agroambientale<br />
coincide abbastanza con i dati sullo smercio se si considerano i principi attivi utilizzati<br />
soltanto in campicoltura, frutticoltura o vitivinicoltura e il cui volume di smercio supera la tonnellata,<br />
sempreché in ogni gruppo di coltura sia stato rilevato un sufficiente numero di applicazioni<br />
di principio attivo. Le differenze osservabili, invece, sono dovute a diversi fattori, come<br />
ad esempio applicazioni non registrate (orticoltura intensiva, ortoflorovivaismo, impiego da<br />
parte di privati, ecc.), tipi di applicazione non registrati (concia delle sementi, trattamenti post<br />
raccolto) e differenze tra le aziende AC-IAA e la media svizzera (Spycher e Daniel, 2013).<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
147
Il mio Rapporto agricolo 28 / 39<br />
AMBIENTE > ACQUA<br />
Sin.: Media annuale (2009–2014) della quantità di principio attivo applicata (in kg/ha) per coltura e gruppo di<br />
principio attivo. Le colture contrassegnate con * non prevedono la produzione estensiva. Ds.: Stima dei volumi di<br />
principio attivo impiegati annualmente in Svizzera (in t) per coltura (media annuale 2009–2014). Le colture contrassegnate<br />
con + includono il totale del principio attivo nella produzione estensiva e non. In entrambi i grafici ci si<br />
riferisce soltanto alla produzione non biologica essendo il numero di aziende bio nel campione troppo basso per rappresentarle<br />
separatamente.<br />
Se si osserva il numero di interventi per coltura, ovvero la frequenza di applicazione, si ha un<br />
quadro relativamente simile a quello del volume di applicazione. Frutta, vite, patate e barbabietola<br />
da zucchero sono risultate le colture trattate con maggior frequenza. Fungicidi ed erbicidi<br />
si sono rivelati i gruppi di principi attivi più spesso utilizzati in molte colture. Su frutta a<br />
granelli, frutta a nocciolo e colza i più impiegati sono risultati gli insetticidi. Visto, però, che<br />
generalmente si tratta di sostanze altamente efficaci già a basso dosaggio, la quantità impiegata<br />
appare comparativamente esigua.<br />
Negli anni 2009–2014 nella maggior parte delle colture non si sono registrate variazioni significative<br />
circa l'impiego medio di prodotti fitosanitari. Analogamente ai dati sullo smercio, in<br />
questo periodo non si è delineata alcuna tendenza generale all'aumento o al calo dell'impiego.<br />
Per singole colture si sono osservate grandi variazioni tra un anno e l'altro, riconducibili con<br />
tutta probabilità alle condizioni meteorologiche. Per quanto riguarda la frutta e la vite, però,<br />
tali variazioni possono essere dovute al fatto che le basi di dati sono piuttosto scarse e non<br />
necessariamente rappresentano le oscillazioni effettive nell'utilizzo di prodotti fitosanitari.<br />
Nel caso delle grandi colture campicole si può osservare una relativa uniformità nel numero di<br />
interventi effettuati dalle aziende partecipanti al monitoraggio agroambientale a differenza di<br />
quanto emerge tra le aziende dedite alla coltivazione di frutta a nocciolo e a granelli, patate<br />
e vite.<br />
148<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 29 / 39<br />
AMBIENTE > ACQUA<br />
Ai fini della rappresentazione sono state escluse le aziende bio e le colture con produzione estensiva. Un intervento<br />
equivale a un passaggio. L'applicazione contemporanea di prodotti appartenenti a diversi gruppi di principi attivi in<br />
miscela estemporanea (p.es. erbicida e fungicida) è stata considerata come un intervento per ciascun gruppo.<br />
Il monitoraggio agroambientale fornisce dati preziosi che permettono, da un lato, di conoscere<br />
gli sviluppi a lungo termine nell'utilizzo di prodotti fitosanitari e, dall'altro, di capire dove e<br />
quando vengono impiegati i prodotti smerciati. Consente di valutare per ogni coltura quale<br />
sarebbe l'effetto sull'impiego di prodotti fitosanitari di determinate misure, ad esempio un<br />
divieto o una nuova autorizzazione di sostanze.<br />
Siccome vi sono notevoli differenze tra le singole colture, è fondamentale che i dati nel monitoraggio<br />
agroambientale coprano adeguatamente tutte le principali colture. Nel caso delle<br />
colture speciali (ortofrutticoltura e vitivinicoltura), che richiedono un intenso intervento fitosanitario,<br />
è fondamentale riuscire in futuro ad ampliare i dati così da avere un quadro attendibile<br />
degli sviluppi a lungo termine. I dati attualmente disponibili per l'orticoltura sono troppo<br />
pochi per effettuare valutazioni realistiche. Per questa ragione questo gruppo di colture non è<br />
rappresentato. Per le colture in pieno campo si dispone, invece, di dati fondati che consentono<br />
di illustrare bene gli sviluppi a lungo termine nell'utilizzo di prodotti fitosanitari.<br />
Indicatore «Rischi acquatici»<br />
L’indicatore «Rischi acquatici» è giunto alla fase finale di elaborazione. Impiega i dati<br />
sull'utilizzo di prodotti fitosanitari per valutare il potenziale rischio ambientale in relazione<br />
alle acque superficiali. Servendosi di modelli si stima la quota dei principi attivi utilizzati che<br />
può infiltrarsi nelle acque superficiali, tenendo in debita considerazione il periodo di applicazione<br />
e le proprietà chimiche quali solubilità e degradabilità. Viene inoltre osservata la portata<br />
dei danni potenziali agli organismi non bersaglio, sulla base delle proprietà ecotossicologiche<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
149
Il mio Rapporto agricolo 30 / 39<br />
AMBIENTE > ACQUA<br />
dei principi attivi utilizzati. Infine, sulla scorta del potenziale di danno e d’infiltrazione viene<br />
calcolato il rischio acquatico.<br />
L'indicatore «Rischi acquatici» fornisce informazioni importanti sullo sviluppo a lungo termine<br />
degli effetti collaterali indesiderati sulle acque superficiali correlati all'utilizzo di prodotti fitosanitari<br />
nell'agricoltura svizzera. Si valuta la rilevanza dal profilo ambientale dell'utilizzo di<br />
prodotti fitosanitari per gli organismi acquatici, osservando le variazioni a livello di principi<br />
attivi impiegati, quantitativi, frequenza degli interventi e di determinate misure volte a ridurre<br />
i rischi. Questo indicatore, perciò, integra in maniera efficace i dati nazionali sullo smercio<br />
di prodotti fitosanitari e l'indicatore «Impiego di prodotti fitosanitari» nell'agricoltura. A sua<br />
volta è integrato da reti di misurazione della qualità delle acque (concentrazioni effettive di<br />
prodotti fitosanitari nelle acque, Braun et al. 2015) e dello stato ecologico dei piccoli corsi<br />
d'acqua (Leib 2015).<br />
Attualmente è in fase di elaborazione un piano d'azione nazionale volto a ridurre i rischi correlati<br />
all'utilizzo di prodotti fitosanitari in Svizzera, ovvero gli effetti collaterali indesiderati,<br />
attraverso una serie di misure. A tal fine, l'indicatore «Rischi acquatici» potrebbe essere particolarmente<br />
importante per valutare i rischi acquatici attuali nelle acque superficiali e la loro<br />
evoluzione a lungo termine.<br />
Bibliografia<br />
de Baan et al., 2015: Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Schweiz von 2009 bis 2012. Agrarforschung Schweiz<br />
6 (2), 48-45<br />
UFAG, 2012, Rapporto agricolo 108-110<br />
Braun et al. 2015: Mikroverunreinigungen in Fliessgewässern aus diffusen Einträgen. Situationsanalyse. Ufficio federale<br />
dell'ambiente, Berna. Umwelt-Zustand n. 1514: 78 pag.<br />
Leib 2015. Makrozoobenthos in kleinen Fliessgewässern, Makrozoobenthos-Untersuchungen:<br />
Schweizweite Auswertung. Aqua&Gas 4: 66-75.<br />
Spycher S., Daniel O. 2013: Agrarumweltindikator Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Stime dei dati dell'analisi centralizzata<br />
degli indicatori agroambientali (AC-IAA) 2009-2010.<br />
Laura de Baan, Agroscope IPB e Ruth Badertscher, UFAG, Settore Sistemi agroambientali e sostanze nutritive,<br />
ruth.badertscher@blw.admin.ch<br />
150<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 31 / 39<br />
AMBIENTE > ACQUA<br />
Impiego di medicamenti veterinari<br />
I medicamenti veterinari di norma sono somministrati per il trattamento di malattie e, con<br />
minor frequenza, a scopo di prevenzione analogamente ai vaccini. La promozione della salute<br />
e del benessere degli animali mira a ridurne l'impiego.<br />
Effetti dei medicamenti veterinari su ambiente e salute<br />
Diversi medicamenti possono giungere nell’ambiente attraverso i concimi aziendali, le acque<br />
di scarico e le polveri e danneggiarlo. In una valutazione del rischio ambientale correlato<br />
all'impiego di medicamenti veterinari in Europa [1], gli antibiotici e gli antiparassitari sono<br />
risultati le sostanze più critiche.<br />
Gli antibiotici sono problematici innanzitutto perché favoriscono la propagazione di batteri<br />
resistenti sia nell'animale sia nell'ambiente e rappresentano dunque un rischio per la salute<br />
umana.<br />
Una parte considerevole degli antibiotici somministrati, infatti, è eliminata dall'animale da<br />
reddito attraverso urina e feci [2]. Attraverso il liquame determinati principi attivi antimicrobici<br />
e i prodotti risultanti dalla loro decomposizione o trasformazione possono infiltrarsi nella<br />
superficie agricola utile. Il suolo è uno degli habitat più estesi ed eterogenei per i batteri. Gli<br />
antibiotici possono influenzare queste comunità batteriche e quindi pregiudicare funzioni del<br />
suolo quali la fornitura di sostanze nutritive [3]. Ciò però non avviene se si considerano gli<br />
usuali carichi di antibiotici, infatti i principi attivi si degradano e si legano alle particelle del<br />
suolo oppure i microrganismi si adeguano. Tenuto conto del consumo e delle loro proprietà, i<br />
sulfamidici sono probabilmente gli antibiotici più critici dal punto di vista dell'inquinamento<br />
idrico. Da misurazioni effettuate nei corsi d'acqua e da dettagliati studi in campo è emerso<br />
che nei piccoli corsi d'acqua in regioni dove l'impiego di antibiotici è elevato, queste sostanze<br />
possono essere rilevate in concentrazioni preoccupanti dal profilo ecotossicologico [4].<br />
I batteri resistenti della flora intestinale degli animali trattati possono giungere anche direttamente<br />
nel suolo e creare o accrescere il serbatoio di geni di resistenza [5]. Questi ultimi potrebbero<br />
eventualmente essere trasmessi a germi patogeni.<br />
Gli antiparassitari vengono utilizzati per proteggere gli animali da parassiti quali vermi e pappataci.<br />
La loro pericolosità per l’ambiente è data dal fatto che agiscono non soltanto sui parassiti<br />
bensì anche su numerosi insetti utili e animali selvatici. A titolo di esempio si citi<br />
l'antibiotico Ivermectin che già a piccolissime dosi può danneggiare insetti e crostacei. Tuttavia,<br />
il fatto che si leghi fortemente alle sostanze solide, fa sì che sia pressoché impossibile<br />
che giunga in acqua [7].<br />
Gli ormoni nell'ambiente possono pregiudicare la capacità di riprodursi dei pesci e causare mutazioni<br />
dell'identità sessuale nella generazione successiva [8]. In Svizzera vengono impiegati<br />
a dosi relativamente basse. Pertanto si può affermare che gli ormoni prodotti naturalmente in<br />
primo luogo dalle vacche sono più rilevanti per l'ambiente di quelli utilizzati in veterinaria [7].<br />
Consumo di antibiotici in ambito veterinario in calo<br />
Dal 2006, in Svizzera viene rilevata e pubblicata annualmente la quantità di antibiotici smerciati<br />
in ambito veterinario (ARCH-Vet). In base a queste informazioni è possibile fare un quadro<br />
del volume di smercio e dello sviluppo dei singoli principi attivi e delle rispettive classi per gli<br />
animali da reddito e da compagnia. Il volume totale dei principi attivi antibiotici negli ultimi<br />
anni ha segnato un calo costante. Tra il 2008 e il 2014 la quantità di principi attivi ha subito<br />
un calo del 32 per cento raggiungendo quota 40 250 chilogrammi [9]. Benché sia un segnale<br />
positivo per quel che riguarda il consumo di antibiotici, sul piano internazionale, la Svizzera<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
151
Il mio Rapporto agricolo 32 / 39<br />
AMBIENTE > ACQUA<br />
si colloca ancora al centro della classifica [10]. In singoli settori, come la quantità di prodotti<br />
endomammari impiegati, la Svizzera si trova addirittura ai primi posti della classifica europea.<br />
Al momento non si dispone di dati comparabili relativi all'impiego di antibiotici nella medicina<br />
umana. Da uno studio sull'impiego di antibiotici nel settore ambulatoriale [11] è emerso che il<br />
consumo pro capite in Svizzera è relativamente basso rispetto ad altri Paesi europei. Il consumo<br />
di antibiotici negli ospedali elvetici, invece, è nella media europea [12].<br />
Rilevazione dei dati sui trattamenti con antibiotici in azienda<br />
I dati sullo smercio consentono soltanto in pochi casi di risalire alle effettive intensità di trattamento,<br />
ossia al numero di animali trattati in riferimento a una determinata popolazione ed<br />
epoca. In Svizzera l'AC-IAA è l'unico rilevamento costante dell'impiego di medicamenti veterinari<br />
a livello aziendale a cura dell'ente pubblico. Anche diverse federazioni di allevamento<br />
rilevano l'impiego di antibiotici da parte dei loro membri.<br />
In molti Paesi europei, come Danimarca, Paesi Bassi o Norvegia, gli agricoltori, i veterinari<br />
e i farmacisti sono tenuti non soltanto a registrare, bensì anche a notificare ogni impiego di<br />
antibiotici. A medio termine ciò è previsto anche in Svizzera con l'attuazione della Strategia<br />
contro le resistenze agli antibiotici STAR [13]. Uno degli obiettivi STAR è sviluppare un sistema<br />
di vigilanza intersettoriale con metodi standardizzati per l'uomo, gli animali, l'agricoltura<br />
e l'ambiente (approccio o principio one health), che fornisca informazioni sullo smercio e<br />
sull'impiego di antibiotici nonché sulla formazione e la diffusione di resistenze. Questi dati servono<br />
da base per misure finalizzate a un impiego più mirato e ridotto degli antibiotici nell'uomo<br />
e negli animali.<br />
Database sull'impiego di medicamenti veterinari nell'AC-IAA<br />
Dal 2009 le aziende coinvolte nell'analisi centralizzata degli indicatori agroambientali (AC-<br />
IAA) registrano i medicamenti veterinari che usano.<br />
La maggior parte di esse detiene bovini, soprattutto vacche da latte. Ogni anno le aziende detentrici<br />
di vacche da latte registrano i dati relativi a circa 4000 capi, che corrisponde allo 0,7<br />
per cento delle vacche presenti in Svizzera. In media un'azienda detiene 23,8 vacche da latte,<br />
quasi l'equivalente della media svizzera di 23,9. L'esiguo numero di aziende detentrici di altre<br />
specie animali quali suini e pollame non permette di fare stime attendibili.<br />
152<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 33 / 39<br />
AMBIENTE > ACQUA<br />
Numero di aziende AC-IAA con una determinata categoria animale<br />
2010 2011 2012 2013<br />
Aziende 237 235 222 209<br />
Tutti bovini 233 224 214 203<br />
Vacche da latte 188 180 173 169<br />
Vacche madri 38 37 41 35<br />
Altri bovini 26 23 17 24<br />
Suini 35 31 27 34<br />
Ovini 4 5 5 5<br />
Caprini 4 5 3 3<br />
Alpaca 1 1 0 1<br />
Equini 4 6 4 3<br />
Bufali 0 1 1 1<br />
Pollame 5 5 4 2<br />
Conigli 1 0 1 0<br />
Fonti: Agroscope e Istituto VPH<br />
Le aziende sono geograficamente distribuite in maniera uniforme tra le regioni dove<br />
l'allevamento è particolarmente diffuso. Nei prossimi anni si punterà ad aumentare il numero<br />
di aziende partecipanti all'AC-IAA.<br />
Miglioramento della qualità dei dati<br />
Nei primi anni di rilevazione si è reso necessario apportare diversi miglioramenti al software<br />
nonché sensibilizzare e informare meglio gli agricoltori partecipanti su come procedere alla<br />
registrazione. Nel corso degli anni è aumentato, così, il numero dei trattamenti registrati. La<br />
percentuale di trattamenti registrati in maniera incompleta è scesa dal 15 per cento nel 2010<br />
all'8 per cento nel 2013. Per le vacche da latte questa percentuale nel 2013 è scesa al 3 per<br />
cento. Ulteriori miglioramenti si impongono nella registrazione dei trattamenti di gruppo per<br />
i suini e i vitelli.<br />
Classi di antibiotici utilizzate<br />
Nelle aziende partecipanti all'AC-IAA i tre quarti dei trattamenti sono a base di penicillina,<br />
tetracicline o amminoglicosidi. In termini quantitativi secondo la statistica sullo smercio [9] gli<br />
antibiotici più impiegati sono i sulfamidici. Questi sono venduti generalmente come premiscele<br />
a uso veterinario e dunque somministrati a dosi maggiori per singolo trattamento su suini e<br />
vitelli, che sono categorie animali sottorappresentate nel presente campione.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
153
Il mio Rapporto agricolo 34 / 39<br />
AMBIENTE > ACQUA<br />
Antibiotici impiegati in quasi la metà dei trattamenti sulle vacche da<br />
latte<br />
I seguenti risultati del monitoraggio si riferiscono principalmente alle vacche da latte e nello<br />
specifico al trattamento di malattie della mammella che offrono basi di dati ottimali.<br />
Nelle aziende detentrici di vacche da latte sono stati somministrati antibiotici in quasi la metà<br />
dei trattamenti, eccezion fatta per il 2010, anno in cui la quota è stata particolarmente alta,<br />
superando il 10 per cento, per via del vaccino obbligatorio contro il virus della lingua blu. Nelle<br />
aziende detentrici di suini la quota di vaccinazioni, che si aggira attorno al 20 per cento di tutti i<br />
trattamenti, è generalmente superiore rispetto ai bovini. In queste aziende gli antibiotici sono<br />
impiegati nel 35 per cento circa dei trattamenti.<br />
154<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 35 / 39<br />
AMBIENTE > ACQUA<br />
Numero di registrazioni: 2010: 15458, 2011: 13413; 2012: 12146; 2013: 13202<br />
In Svizzera esigenze elevate relative alla qualità del latte e alla somministrazione<br />
di antibiotici per trattamenti della mammella<br />
La salute delle mammelle è un aspetto fondamentale nella detenzione di bestiame da latte. In<br />
Svizzera le esigenze relative alla qualità del latte sono molto severe anche perché per produrre<br />
le principali varietà di formaggio si impiega latte crudo. Un criterio è quello del numero di<br />
cellule, che in Svizzera è basso rispetto all’estero (90 000-135 000 cellule/ml/mese) [14; 15].<br />
Parallelamente nel nostro Paese l’impiego di antibiotici per il trattamento della mammella è<br />
più frequente.<br />
Nel 68 per cento dei trattamenti registrati gli antibiotici vengono somministrati per curare malattie<br />
della mammella. Il 90 per cento delle aziende considerate e detentrici di bestiame da latte<br />
usa almeno una volta gli antibiotici per questo scopo. Una vacca su 5 è sottoposta a un trattamento<br />
antibiotico per la messa in asciutta. Negli anni la frequenza di questi trattamenti è<br />
rimasta costante.<br />
I dati sui trattamenti alle mammelle dell’AC-IAA sono facilmente comparabili con quelli sullo<br />
smercio di antibiotici. Ne emerge che le classi di antibiotici utilizzate dalle aziende considerate<br />
per trattare le malattie della mammella rispecchiano abbastanza bene i dati sullo smercio.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
155
Il mio Rapporto agricolo 36 / 39<br />
AMBIENTE > ACQUA<br />
Le aziende partecipanti all’AC-IAA, comunque, effettuano un numero minore di trattamenti<br />
sul bestiame in lattazione rispetto a quanto emerge dai dati nazionali sullo smercio, infatti la<br />
frequenza degli interventi risulta quasi la metà. Anche l’impiego di prodotti per la messa in<br />
asciutta è meno frequente di quanto facciano pensare i dati sullo smercio, anche se in questo<br />
caso la differenza è meno marcata.<br />
Queste discrepanze possono essere spiegate dal fatto che non tutti gli antibiotici venduti vengono<br />
anche utilizzati. Potrebbe anche darsi che la salute delle mammelle nelle aziende partecipanti<br />
è superiore alla media svizzera o che una parte dei trattamenti non è stata registrata.<br />
Bassa frequenza di trattamenti ormonali sul bestiame svizzero<br />
In alcuni Paesi extraeuropei gli ormoni sono utilizzati per aumentare le prestazioni, pratica che<br />
in Svizzera è vietata. Per le vacche da latte negli anni 2010-2013, in totale, sono stati registrati<br />
soltanto 479 trattamenti ormonali. A questi se ne aggiungono 89 sulle scrofe da allevamento.<br />
Il tipo di sostanze utilizzate per le vacche da latte è riportato nel grafico seguente. Quelle somministrate<br />
più di frequente sono i corticosteroidi, antinfiammatori che spesso vengono somministrati<br />
parallelamente a un trattamento antibiotico in caso di infezione acuta.<br />
Gestageno e progesterone sono utilizzati essenzialmente per la sincronizzazione dell’estro<br />
e l’induzione dell’ovulazione. Le prostaglandine vengono impiegate per sincronizzare<br />
l’ovulazione, per trattare i problemi di fertilità e le infiammazioni uterine, nonché per indurre<br />
il parto. L’ossitocina provoca le contrazioni durante il parto e nella fase successiva fa sì che<br />
l’utero ritorni alle sue dimensioni originali. Questo ormone femminile viene impiegato anche<br />
per le vacche da latte prima della mungitura allo scopo di indurre l’eiezione del latte, per favorire<br />
le contrazioni e dopo i parti difficili o cesarei per aiutare l’utero a ritornare alle sue dimensioni<br />
originali.<br />
156<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 37 / 39<br />
AMBIENTE > ACQUA<br />
Antiparassitari<br />
Gli antiparassitari agiscono contro parassiti interni, quali protozoi unicellulari e vermi (elminti),<br />
ed esterni, quali pidocchi, pulci, acari o mosche. Sono impiegati in oltre il 10 per cento<br />
dei trattamenti effettuati. La maggior parte di essi viene impiegata per i bovini (84 %, di cui<br />
71 % bestiame da latte). Il gruppo di principi attivi più utilizzato è quello dei lattoni macrociclici<br />
(LM) che agiscono principalmente contro la trichinella spiralis e i parassiti esterni. Analogamente<br />
agli antibiotici, anche in questo caso esiste un problema legato alla formazione di<br />
resistenze, soprattutto nel caso della trichinella nei bovini. Al secondo posto della classifica<br />
degli antiparassitari più utilizzati si trovano quelli a base di benzimidazolo (BI) (61 % bovini,<br />
22 % suini), attivi contro trichinella spiralis, trematidi e alcuni vermi piatti. Anche in questo<br />
caso si formano resistenze, soprattutto nei ruminanti di piccola taglia [16]. Gli imidazotiazoli<br />
(IT) sono vermifughi ad ampio spettro, utilizzati soprattutto contro la trichinella spiralis. In<br />
veterinaria la sostanza più diffusa è il Levamisol. In molti Paesi sono stati già documentati molti<br />
casi di parassiti resistenti al Levamisol [17].<br />
I piretroidi (PY) sono sostanze simili alle piretrine naturali che possono essere ricavate da diversi<br />
tipi di crisantemi. Sono uno degli insetticidi più potenti in assoluto e vengono utilizzati<br />
contro pulci, zecche, mosche e altri ectoparassiti. Elevate concentrazioni provocano la paralisi<br />
dei parassiti, ma anche di altri insetti utili come le api mellifere.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
157
Il mio Rapporto agricolo 38 / 39<br />
AMBIENTE > ACQUA<br />
Conclusioni<br />
Un monitoraggio dell’impiego di medicamenti veterinari nell’agricoltura svizzera è importante<br />
perché le sostanze somministrate agli animali, attraverso il liquame e il letame, giungono<br />
nell’ambiente dove possono avere effetti nocivi diretti, come nel caso di ormoni e alcuni antiparassitari,<br />
oppure indiretti, come nel caso di antibiotici e antiparassitari. Queste sostanze<br />
inducono la formazione di resistenze nei batteri e nei vermi e di conseguenza diventa più difficile<br />
lottare con efficacia contro le malattie provocate da questi agenti patogeni. Ciò si ripercuote<br />
non soltanto sul trattamento degli animali malati, bensì anche sul trattamenti di pazienti<br />
umani regolarmente a contatto con gli animali. Negli ultimi anni si è registrato un calo complessivo<br />
delle quantità di antibiotici impiegati per gli animali, tuttavia il numero dei trattamenti<br />
in caso di infiammazione della mammella è rimasto costantemente alto.<br />
Bibliografia<br />
1. Kools, S. A. E. et al., 2008: A Ranking of European Veterinary Medicines Based on Environmental Risks. Integrated<br />
Environmental Assessment and Management. 4, Bde. 4, 399–408<br />
2. Halling-Sorensen B., Nielsen SN, Lanzky PF, et al., 1998: Occurence, fate and effects of pharmaceuticals<br />
substance in the environment - A review. Chemosphere. 1998;36: 357–393. doi:http://dx.doi.org/10.1016/<br />
S0045-6535(97)00354-8<br />
3. Ding C, He J.. 2010: Effect of antibiotics in the environment on microbial populations. Appl Microbiol Biotechnol.<br />
2010; 87: 925–41. doi:10.1007/s00253-010-2649-5<br />
4. Stoob K., Singer H., Müller S., Schwarzenbach R.P., Stamm C., 2007: Dissipation and transport of veterinary sulfonamide<br />
antibiotics after manure application to grassland in a small catchment. Environ Sci Technol 41 (21):7349–<br />
7355.<br />
5. Knapp CW, Dolfing J, Ehlert P a I, Graham DW. 2010: Evidence of increasing antibiotic resistance gene abundances<br />
in archived soils since 1940. Environ Sci Technol. 2010;44: 580–587. doi:10.1021/es901221x<br />
6. Whitman WB, Oxides N, Cook a M, Alexander M, Tyson GW, Delong EF, et al., 2012: The Shared Antibiotic Resistome<br />
of. 2012;337: 1107–1111. doi:10.1126/science.1220761<br />
7. Götz, C., 2012: Mikroverunreinigungen aus Nutztierhaltung. Aqua & Gas 11<br />
8. Zeilinger J, Steger-Hartmann T, Maser E, Goller S, Vonk R, Länge R. Effects of synthetic gestagens on fish reproduction.<br />
Environ Toxicol Chem. 2009;28: 2663–2670. doi:10.1897/08-485.1<br />
9. Swissmedic / Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV. 2015: ARCH-Vet Rapporto sulla vendita<br />
di antibiotici in medicina veterianaria e sul monitoraggio della resistenza agli antibiotici negli animali da reddito<br />
in Svizzera 2014.<br />
158<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 39 / 39<br />
AMBIENTE > ACQUA<br />
10. European Medicines Agency, European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption, 2015: Sales of veterinary<br />
antimicrobial agents in 26 EU/EEA countries in 2013. (EMA/387934/2015).<br />
11. Filippini M, Masiero G, Moschetti K., 2006: Socioeconomic determinants of regional differences in outpatient antibiotic<br />
consumption : evidence from Switzerland. Health Policy. 2006; 78(1) :77-92.<br />
12. Plüss-Suard, Pannatier A, Kronenberg A, Mühlemann K, Zanetti G., 2011: Hospital antibiotic consumption in<br />
Switzerland: comparison of a multicultural country with Europe. J Hosp Infect. 2011 Oct;79(2):166-71<br />
13. Consiglio federale, 2015: Strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici<br />
14. TSM Treuhand GmbH., 2011 Allegato alla statistica annuale sul mercato lattiero 2010 confronto pluriennale dal<br />
2000.<br />
15. Sundrum, A., (2010): Eutergesundheitsstatus auf der Betriebsebene – Stand und Perspektiven aus systemischer<br />
Sicht. Berichte über Landwirtschaft 88, 299–321.<br />
16. H. Rose, L. Rinaldi, A. Bosco, F. Mavrot, T. de Waal, P. Skuce, J. Charlier, P. R. Torgerson, H. Hertzberg, G. Hendrickx,<br />
J. Vercruysse, E. R. Morgan. 2015: Widespread anthelmintic resistance in European farmed ruminants: a systematic<br />
review. Veterinary Record 2015 176: 546<br />
17. Lumaret J-P, Errouissi F, Floate K, Römbke J, Wardhaugh K. A, 2012: Review on the Toxicity and Non-Target Effects<br />
of Macrocyclic Lactones in Terrestrial and Aquatic Envi-ronments. Curr Pharm Biotechnol. 2012;13: 1004–1060.<br />
doi:10.2174/138920112800399257<br />
Ioannis Magouras, Veterinary Public Health Institute VPHI e Ruth Badertscher, UFAG, Settore Sistemi agroambientali<br />
e sostanze nutritive, ruth.badertscher@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
159
Il mio Rapporto agricolo 2 / 222<br />
POLITICA > INTRODUZIONE<br />
Introduzione<br />
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) è il centro di competenze della Confederazione per il<br />
settore agricolo, incaricato di eseguire le misure della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura.<br />
Dette misure sono sancite nel rispettivo articolo della Costituzione federale del 1996 (art. 104<br />
Cost.), in base al quale la Confederazione provvede affinché l’agricoltura, tramite una produzione<br />
ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente:<br />
• all’approvvigionamento della popolazione;<br />
• alla salvaguardia delle basi vitali naturali;<br />
• alla cura del paesaggio rurale;<br />
• all'occupazione decentrata del territorio;<br />
• al benessere degli animali.<br />
I fondi della Confederazione a favore dell'agricoltura sono suddivisi nei tre limiti di spesa «Produzione<br />
e smercio», «Pagamenti diretti» e «Miglioramento delle basi di produzione e misure<br />
sociali».<br />
Produzione e smercio<br />
Gli strumenti di politica agricola in questo settore creano le condizioni quadro che consentono<br />
all'agricoltura svizzera di realizzare, mediante una produzione sostenibile e di qualità, un elevato<br />
valore aggiunto sui mercati nazionale e internazionali.<br />
Pagamenti diretti<br />
Il profitto di mercato non consente di indennizzare, o lo fa solo in parte, le prestazioni<br />
pubbliche fornite nell’interesse della collettività, come la cura del paesaggio, la salvaguardia<br />
delle basi vitali naturali e il contributo per l’occupazione decentrata del territorio, nonché le<br />
prestazioni ecologiche particolari. Con i pagamenti diretti la Confederazione garantisce che<br />
l'agricoltura fornisca tali prestazioni a favore della comunità.<br />
Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali<br />
Gli strumenti a disposizione in questo settore mirano soprattutto a ridurre i costi e a migliorare<br />
la competitività. Sostengono indirettamente la produzione agricola e le connesse prestazioni<br />
pubbliche fornite dal settore primario. Nello specifico, si tratta di misure per il miglioramento<br />
strutturale, misure sociali collaterali e di promozione della consulenza nonché di provvedimenti<br />
nell'ambito dell'allevamento e della coltivazione così come delle risorse genetiche.<br />
160<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 3 / 222<br />
POLITICA > INTRODUZIONE<br />
Nel 2015 la Confederazione ha stanziato 3667 milioni di franchi a favore dell'agricoltura e<br />
dell'alimentazione. Ciò corrisponde a una quota del 5,6 per cento sulle sue uscite totali. La<br />
voce «agricoltura e alimentazione» figura al sesto posto dopo l’assistenza sociale (21 987 mio.<br />
fr.), le finanze e le imposte (9533 mio. fr.), i trasporti (8322 mio. fr.), la ricerca e la formazione<br />
(7046 mio. fr.) e la difesa nazionale (4466 mio. fr.).<br />
Uscite della Confederazione per agricoltura e alimentazione divise per settore<br />
Ambito di spesa 2012 2013 2014 2015<br />
Mio. fr. Mio. fr. Mio. fr. Mio. fr.<br />
Produzione e smercio 440 450 431 431<br />
Pagamenti diretti 2809 2799 2815 2795<br />
Miglioramento delle<br />
basi di produzione e<br />
misure sociali<br />
192 189 184 160<br />
Ulteriori uscite 270 268 263 282<br />
Totale agricoltura e<br />
alimentazione<br />
3711 3706 3693 3667<br />
» A42<br />
Fonti: Conto dello Stato, UFAG<br />
Adeguamenti del sistema delle unità standard di manodopera (USM)<br />
Nel quadro del Pacchetto di ordinanze agricole Autunno 2015 sono stati decretati diversi cambiamenti<br />
nel sistema delle unità standard di manodopera (USM). L'USM è stata ridefinita come<br />
unità per la misurazione della dimensione dell’azienda che si basa su coefficienti standardizzati.<br />
Con la revisione i coefficienti sono stati adeguati allo sviluppo tecnico e il normale orario<br />
di lavoro considerato per il calcolo dei coefficienti USM è stato ridotto da 2800 a 2600 ora<br />
all'anno. In tal modo il normale orario di lavoro dell'agricoltura è stato uniformato all'orario<br />
di lavoro usuale negli altri settori, anche per i lavoratori indipendenti. Da tali modifiche risultano<br />
per lo più coefficienti USM inferiori rispetto al passato. Poiché mediante i pagamenti diretti<br />
non deve essere condotta alcuna politica strutturale, la dimensione minima dell'azienda<br />
di 0,25 USM, richiesta per poter beneficiare dei pagamenti diretti, è stata ridotta a 0,2 USM. Il<br />
numero delle aziende aventi diritto ai pagamenti diretti resta pertanto pressoché stabile.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
161
Il mio Rapporto agricolo 4 / 222<br />
POLITICA > INTRODUZIONE<br />
Nei settori del diritto fondiario rurale e dei miglioramenti strutturali sono stati introdotti supplementi<br />
per attività paragricole, concessi basandosi sulla prestazione lorda ottenuta da tali<br />
attività; tuttavia è necessaria una dimensione minima dell'azienda per attività agricole in senso<br />
stretto e il supplemento è limitato.<br />
In analogia alle attività paragricole, sono concessi supplementi USM per le tre attività agricole<br />
in senso stretto preparazione, stoccaggio e vendita di prodotti agricoli ottenuti nella propria<br />
azienda di produzione anche in base alla prestazione lorda ottenuta (finora autodichiarazione<br />
del tempo di lavoro impiegato).<br />
L'UFAG ha redatto una guida al fine di illustrare le norme concernenti i supplementi per le<br />
attività agricole in senso stretto e paragricole. La guida definisce come calcolare i supplementi<br />
USM in base alla prestazione lorda e come distinguere tra di loro e gestire la lavorazione, lo<br />
stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria ed estranei all’esercizio. In<br />
tal modo si crea una base per un’esecuzione uniforme nei Cantoni (cfr. Guida).<br />
Semplificazioni amministrative<br />
L’amministrazione (ovvero l’atto di amministratore) sussiste ad ogni scambio di beni o informazioni.<br />
Oltre alle attività amministrative da svolgere in un'azienda agricola in relazione alla<br />
produzione di beni di mercato, si crea dispendio amministrativo per il capoazienda anche per<br />
le prestazioni d'interesse generale. Lo Stato o la società che sostiene la fornitura di tali prestazioni<br />
mediante i pagamenti diretti necessitano di sapere se i requisiti per il versamento dei<br />
pagamenti diretti sono realmente adempiuti. Ne scaturisce un ulteriore dispendio amministrativo.<br />
Con le riforme della politica agricola e con la crescente importanza attribuita alle prestazioni<br />
ambientali e al rispetto dell'ambiente, questo dispendio è costantemente aumentato. Inoltre<br />
la società è sempre più sensibile a tematiche che potrebbero pregiudicare una vita sana. In tale<br />
contesto è aumentata la necessità di regolamentazione e di informazione in settori quali sicurezza<br />
delle derrate alimentari e degli alimenti per animali, protezione delle acque o epizoozie.<br />
Poiché l'ulteriore dispendio amministrativo andato di pari passo con la riforma della Politica<br />
agricola 2014-2017 è stato percepito come forte carico da parte di alcuni agricoltori, l'UFAG,<br />
nel quadro del progetto Semplificazione amministrativa svoltosi tra febbraio 2015 e febbraio<br />
2016, ha portato avanti un ampio processo. Sono state raccolte ed esaminate proposte di semplificazione<br />
di agricoltori, organizzazioni della categoria, Cantoni e di collaboratori dell'UFAG.<br />
Il progetto ha avuto lo scopo di semplificare l’attuale sistema agro-politico senza incidere sugli<br />
obiettivi o sul loro raggiungimento.<br />
Come primo risultato del progetto sono stati identificati interventi di semplificazione amministrativa<br />
di rapida attuazione.<br />
• Con il pacchetto di ordinanze 2015 sono state attuate/realizzate 24 proposte.<br />
• Con il pacchetto di ordinanze 2016 o in guide e istruzioni sono state attuate/realizzate 18<br />
proposte.<br />
• L'attuazione di altre proposte è in fase di preparazione per il pacchetto di ordinanze 2017.<br />
Inoltre sono stati identificati i seguenti cinque ambiti tematici concernenti le modalità di ulteriore<br />
sgravio dell'agricoltura dal profilo amministrativo in vista della PA 22+.<br />
• Registrazione e flussi di dati tra agricoltore e autorità;<br />
• Registrazioni e controlli;<br />
162<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 5 / 222<br />
POLITICA > INTRODUZIONE<br />
• Prescrizioni sull'ambiente;<br />
• Prestazioni ambientali;<br />
• Informazione e comunicazione.<br />
I risultati del progetto sono stati pubblicati in un rapporto dell'UFAG (cfr. Rapporto di progetto<br />
«Semplificazione amministrativa in agricoltura»).<br />
Thomas Meier, UFAG, Settore Politica agricola, thomas.meier@blw.admin.ch<br />
Susanne Menzel, UFAG, Settore Economia agricola, spazio rurale e strutture<br />
Anton Stöckli, UFAG, Settore Ricerca e consulenza<br />
Doris Werder, UFAG, Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
163
Il mio Rapporto agricolo 7 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
Panoramica<br />
All’articolo 7 LAgr sono definiti i principi in base ai quali la Confederazione fissa le condizioni<br />
quadro per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli. L’agricoltura è tenuta a produrre<br />
in modo sostenibile e vantaggioso, mentre gli agricoltori devono ottenere un profitto possibilmente<br />
elevato dalla vendita dei loro prodotti. L'orientamento al mercato e la gestione sostenibile<br />
si rifanno pertanto al principio sancito nell'articolo costituzionale.<br />
La Confederazione dispone di diversi strumenti orientati a tali principi, atti a sostenere<br />
l'agricoltura svizzera. Si tratta di provvedimenti nei settori delle misure di solidarietà volti<br />
a promuovere la qualità e lo smercio nonché nel settore della caratterizzazione e delle importazioni<br />
di prodotti agricoli. Tali provvedimenti possono essere applicati a tutti i settori di<br />
produzione. Inoltre, la Confederazione sostiene l'agricoltura con strumenti specifici per la produzione<br />
lattiera e animale, la vitivinicoltura e la produzione vegetale.<br />
Mezzi finanziari – 2015<br />
Nel 2015 sono stati stanziati 431 milioni di franchi, ovvero lo stesso importo dell'anno precedente,<br />
per misure a favore della produzione e dello smercio.<br />
Economia lattiera: nel 2015 sono stati impiegati 295,5 milioni di franchi, ovvero 0,5 milioni<br />
di franchi in meno rispetto all'anno precedente. I mezzi finanziari sono erogati sotto forma di<br />
un supplemento per il latte trasformato in formaggio e di un supplemento per il foraggiamento<br />
senza insilati. Il lieve calo delle uscite del 2015 è riconducibile alla diminuzione dei costi dei<br />
mezzi informatici e per la gestione dei dati. Rispetto al 2014 i fondi per i supplementi nel settore<br />
lattiero sono rimasti stabili.<br />
Produzione animale: le uscite nell'ambito del limite di spesa per produzione e smercio hanno<br />
segnato un valore di 12 milioni di franchi nel 2015, restando praticamente invariate rispetto<br />
al 2013.<br />
Produzione vegetale, vitivinicoltura inclusa: nel 2015 le uscite sono ammontate a 62,3 milioni<br />
di franchi, segnando una diminuzione di 1,3 milioni di franchi rispetto all'anno precedente<br />
riconducibile alla flessione dei pagamenti destinati alla campicoltura nonché al calo di<br />
0,7 milioni di contributi per la fabbricazione di prodotti a base di bacche, di frutta a granella<br />
e a nocciolo.<br />
Il 96 per cento dei fondi impiegati per la produzione vegetale nel 2015 è stato destinato alla<br />
promozione di singole colture (contributi per singole colture), il 3 per cento alla trasformazione<br />
e alla valorizzazione della frutta, l'1 per cento a provvedimenti a favore della vitivinicoltura.<br />
Promozione della qualità e delle vendite: nel 2015 sono stati spesi 61,1 milioni di franchi,<br />
ovvero 1,4 milioni di franchi in più rispetto all’anno precedente. Il 2015 è stato caratterizzato<br />
dal cosiddetto shock del franco che ha avuto ripercussioni anche sui progetti di promozione<br />
dello smercio. Nel corso dell’anno, nel quadro del credito dei fondi speciali, sono stati messi a<br />
disposizione a favore di ulteriori misure per formaggio e latte/burro rispettivamente 900 000<br />
franchi e per la campagna “Sei WOW” di Agro-Marketing Suisse 250 000 franchi.<br />
Tuttavia, il credito per la promozione della qualità e delle vendite, di 4,5 milioni di franchi in<br />
più rispetto al Preventivo 2014, non è stato esaurito poiché nel 2015 le domande pervenute<br />
in relazione al settore qualità e sostenibilità sono state ancora al di sotto delle aspettative.<br />
Pertanto il Parlamento ha potuto destinare 3 milioni di franchi all’incremento del credito per i<br />
contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati.<br />
164<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 8 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
Uscite per produzione e smercio<br />
Voce di spesa 2014 2015¹ 2015 2016¹<br />
mio. fr. mio. fr. mio. fr. mio. fr.<br />
Economia lattiera 296 296 296 296<br />
Produzione animale 12 13 12 13<br />
Produzione vegetale<br />
(vitivinicoltura incl.)<br />
64 67 62 68<br />
Promozione della<br />
qualità e delle vendite<br />
60 64.5 61 67.5<br />
Totale 431 440.5 431 444.5<br />
¹ Preventivo<br />
Fonti: Preventivo, Conto dello Stato 2016<br />
Prospettive per il 2016<br />
» A43<br />
» A44<br />
» A45<br />
» A46<br />
» A47<br />
I fondi a disposizione per la produzione e lo smercio restano, nel complesso, stabili. L'unica<br />
variazione di rilievo nel preventivo rispetto all’anno precedente interessa il lieve aumento dei<br />
fondi per la promozione della qualità e delle vendite.<br />
Samantha Rosenke, UFAG, Unità di direzione Mercati e creazione di valore, samantha.rosenke@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
165
Il mio Rapporto agricolo 14 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
Economia lattiera<br />
Nell'anno oggetto del rapporto il quantitativo di latte commercializzato è sceso a 3,49 milioni<br />
di tonnellate, subendo un calo dell’1,5 per cento. Di queste, 29 000 tonnellate circa (0,8 %)<br />
provenivano dal Principato del Liechtenstein e dalle zone franche attorno a Ginevra. La quota<br />
di latte biologico rispetto al quantitativo di latte commercializzato totale ammontava al 6,4<br />
per cento, quella ottenuta con foraggiamento senza insilati al 32,3 per cento. Circa 94 000<br />
tonnellate (2,7 %) del latte commercializzato sono state prodotte in aziende d’estivazione.<br />
Mezzi finanziari e dati statistici – 2015<br />
Anche nel 2015 la Confederazione ha concesso un supplemento per il latte trasformato in formaggio<br />
di 15 centesimi il chilogrammo e un supplemento per il foraggiamento senza insilati di 3<br />
centesimi il chilogrammo. Per entrambi i supplementi sono stati impiegati complessivamente<br />
293 milioni di franchi come l’anno precedente. Per l’amministrazione dei dati sul latte e per i<br />
mezzi informatici in ambito lattiero la Confederazione ha impiegato 2,5 milioni di franchi circa.<br />
L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha concluso con la TSM Fiduciaria Sagl (TSM) un accordo<br />
di prestazione, che scade a fine 2017, in base al quale quest'ultima è incaricata di registrare<br />
e verificare i dati della produzione e della valorizzazione del latte. I valorizzatori del latte<br />
sono tenuti a notificare tali dati a cadenza mensile e la TSM è responsabile dell’ottemperanza<br />
dell’obbligo di notifica. In caso di irregolarità, alle ditte e alle aziende interessate vengono irrogate<br />
sanzioni. Avvalendosi dei dati sulla valorizzazione del latte trasmessile, la TSM elabora i<br />
dati per il versamento dei supplementi. Questi sono trasmessi due volte alla settimana all’UFAG<br />
il quale provvede al versamento dei supplementi ai valorizzatori di latte che successivamente<br />
li erogheranno ai produttori.<br />
Conformemente all'ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (OSL; RS 916.350.2), i valorizzatori<br />
sono tenuti a versare i supplementi entro il termine di un mese ai produttori dai quali<br />
hanno acquistato il latte trasformato in formaggio. Nel conteggio concernente l'acquisto di<br />
latte, i supplementi vanno indicati separatamente per produttore. Anche i valorizzatori del<br />
latte sono tenuti a indicare nella loro contabilità i supplementi ricevuti e pagati. Il grafico seguente<br />
mostra, per l'anno civile 2015, da un lato il numero di valorizzatori di latte che hanno<br />
ricevuto supplementi, dall'altro i supplementi per il latte erogati dai valorizzatori, in base alle<br />
classi di dimensioni dei supplementi ricevuti.<br />
166<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 15 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
Nell’anno oggetto del rapporto hanno beneficiato di supplementi per il latte 2339 valorizzatori,<br />
per un totale di 293 milioni di franchi; l’importo corrisposto mediamente a ciascun valorizzatore<br />
ammontava a 125 000 franchi. Dalla ripartizione emerge che i supplementi sono<br />
concentrati su poche grandi aziende di trasformazione del latte: il 21 per cento dei valorizzatori<br />
ha, infatti, ricevuto il 94 per cento circa dei supplementi per il latte, 1406 aziende di trasformazione<br />
(60 %) hanno invece ricevuto al massimo 10 000 franchi. In questi casi si trattava<br />
prevalentemente di aziende d’estivazione con produzione in proprio di formaggio. Per questa<br />
classe di dimensioni i supplementi erogati per il latte trasformato in formaggio ammontavano<br />
a 4,9 milioni di franchi.<br />
L'Ispettorato dell'UFAG effettua controlli basati sul rischio presso i valorizzatori che notificano<br />
i dati sul latte e richiedono supplementi. Nell’anno oggetto del rapporto sono state controllate<br />
circa 250 aziende. Per circa un terzo, l’Ispettorato ha sollevato contestazioni. La maggior parte<br />
di queste ha comportato un’ammonizione a causa, ad esempio, di lievi errori di registrazione o<br />
lacune riscontrate per la prima volta. I valorizzatori che hanno ricevuto supplementi in eccesso<br />
sulla scorta di notifiche scorrette dei dati sulla valorizzazione del latte sono tenuti a restituirli.<br />
» A44<br />
Uscite nel settore dell'economia lattiera<br />
Nell’anno oggetto del rapporto in Svizzera le aziende produttrici di latte erano 11 581 nella<br />
regione di pianura (incl. zona collinare) e 10 270 nella regione di montagna. Rispetto al 2014,<br />
il loro numero è sceso del 3,3 per cento, ossia di 746 unità. Praticamente, ogni giorno più di<br />
due aziende hanno abbandonato la produzione lattiera. Inoltre, nel periodo dell’alpeggio, le<br />
aziende d’estivazione dedite alla produzione di latte sono state 2541, per un quantitativo di<br />
latte commercializzato pari mediamente a circa 37 125 chilogrammi per azienda.<br />
Nel 2015 la quantità di latte commercializzata ammontava mediamente a 196 992 chilogrammi<br />
per azienda di pianura e a 105 503 chilogrammi per azienda di montagna. Nella regione di<br />
pianura sono stati forniti soltanto 15 064 chilogrammi in più rispetto al 2014 contro i circa<br />
4319 chilogrammi in più nella regione di montagna. Negli ultimi dieci anni si sono registrati<br />
incrementi delle forniture del 60,1 per cento per le aziende di pianura e del 41,7 per cento<br />
per quelle di montagna. La diversa evoluzione palesa le migliori opportunità di crescita nella<br />
regione di pianura. Anche nel 2015 l'aumento in percentuale del quantitativo medio di latte<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
167
Il mio Rapporto agricolo 16 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
paragonato all'anno precedente è stato superiore nella regione di pianura rispetto alla regione<br />
di montagna.<br />
Rispetto all’anno lattiero 2000/01 la quantità di latte commercializzata è aumentata quasi del<br />
24,5 per cento per vacca e del 40,5 per cento per ettaro di superficie agricola utile, toccando<br />
nel 2015 rispettivamente 6216 chilogrammi per vacca e 6012 chilogrammi per ettaro.<br />
Il calo rispetto all’anno precedente ammonta a 108 chilogrammi per vacca (-1,7 %) e a 24<br />
chilogrammi per ettaro (-0,4 %).<br />
Nel 2015 le aziende produttrici di latte gestite tutto l’anno hanno commercializzato 3,36 milioni<br />
di tonnellate di latte, quelle d’estivazione circa 94 000 tonnellate. Il 40,8 per cento dei<br />
produttori di latte ne ha commercializzato meno di 100 000 chilogrammi all’anno. La loro quota<br />
rispetto alla produzione totale è stata soltanto del 15,5 per cento. Le aziende produttrici di<br />
latte con un quantitativo annuo superiore a 350 000 chilogrammi hanno raggiunto una quota<br />
del 24,6 per cento del quantitativo totale di latte commercializzato. Nell’anno oggetto del rapporto<br />
585 aziende hanno commercializzato più di 500 000 chilogrammi di latte rispetto alle<br />
558 dell'anno precedente.<br />
168<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 17 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
Organizzazione di categoria Interprofessione Latte<br />
L’Interprofessione Latte (IP Latte) è la piattaforma dell'economia lattiera svizzera. Con la decisione<br />
dell’11 dicembre 2015 il Consiglio federale ha dichiarato vincolanti fino al 31 dicembre<br />
2017 anche per i non membri le disposizioni del contratto standard dell'IP Latte e del regolamento<br />
sulla segmentazione del mercato lattiero. Per i non membri, dunque, vige l'obbligo di<br />
concludere contratti scritti per tutte le vendite e gli acquisti di latte con una durata minima<br />
di un anno. Nei contratti di acquisto, inoltre, il quantitativo di latte deve essere classificato<br />
nei segmenti A, B e C in base al relativo scopo di utilizzo. Nei conteggi dei pagamenti del latte<br />
occorre indicare separatamente i quantitativi e i prezzi per segmento.<br />
Classificazione del latte nei vari segmenti, secondo lo scopo di utilizzo<br />
Segmento A<br />
Prodotti a elevato valore aggiunto con protezione doganale<br />
o sostegno (supplementi per latte trasformato<br />
in formaggio, compensazione del prezzo della materia<br />
prima).<br />
Per il latte del segmento A viene pagato un prezzo superiore<br />
rispetto a quello dei segmenti B e C.<br />
Segmento B<br />
Segmento C<br />
Prodotti con limitato valore aggiunto senza protezione<br />
doganale o sostegno per il mercato interno e per<br />
l’esportazione.<br />
Prodotti a basso valore aggiunto per il mercato mondiale.<br />
Per il latte del segmento C viene corrisposto il prezzo più<br />
basso.<br />
I valorizzatori sono tenuti a notificare alla TSM a cadenza mensile i quantitativi di latte venduti<br />
e acquistati per segmento nonché i latticini prodotti ed esportati con latte dei segmenti B e C.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
169
Il mio Rapporto agricolo 18 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
Nel 2015, secondo la valutazione del primo acquisto di latte, l'85,0 per cento di latte è stato<br />
commercializzato nel segmento A, il 13,1 per cento in quello B e l'1,9 per cento nel segmento<br />
C. Le quote restano quindi praticamente invariate rispetto all’anno precedente.<br />
A fine anno, la TSM verifica se i quantitativi di latte acquistati nei segmenti B e C coincidono<br />
con i quantitativi venduti o con i latticini prodotti ed esportati in questi stessi segmenti. Nel<br />
caso di differenze superiori al 5 per cento per segmento nell'arco di un anno l'IP Latte può<br />
irrogare sanzioni. Nell’anno oggetto del rapporto la TSM ha verificato presso 21 valorizzatori<br />
del latte se nel 2014 avevano utilizzato latte dei segmenti B e C soltanto per la fabbricazione<br />
dei prodotti consentiti. Due casi, in cui la TSM ha riscontrato lacune, sono stati inoltrati per<br />
verifica alla Segreteria dell’IP Latte che non ha individuato alcun abuso per quanto riguarda<br />
la segmentazione.<br />
Hans Ulrich Leuenberger, UFAG, Prodotti animali e allevamento, hansulrich.leuenberger@blw.admin.ch<br />
Rudolf Büschlen, UFAG, Prodotti animali e allevamento<br />
Monika Meister, UFAG, Prodotti animali e allevamento<br />
170<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 20 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
Produzione animale<br />
Mezzi finanziari 2015<br />
Per i provvedimenti nel settore della produzione animale (promozione dell’allevamento e contributi<br />
per i costi di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale incl.) nell’anno oggetto<br />
del rapporto sono stati erogati, in totale, 94,5 milioni di franchi.<br />
» A45<br />
Uscite nel settore della produzione animale<br />
Provvedimenti sul mercato del bestiame da macello e della carne<br />
Sulla base di un accordo di prestazione, l’UFAG ha delegato alla cooperativa Proviande compiti<br />
esecutivi nel settore del mercato del bestiame da macello e della carne.<br />
Classificazione neutrale della qualità<br />
In virtù dell'ordinanza sul bestiame da macello, Proviande provvede alla classificazione della<br />
qualità delle carcasse nei macelli di grandi dimensioni (27 aziende alla fine dell'anno oggetto<br />
del rapporto), ovvero in quelle aziende in cui vengono macellati mediamente più di 120 suini<br />
o circa 23 capi di bestiame grosso a settimana. Per gli animali delle specie bovina, ovina, caprina<br />
ed equina la muscolatura e il grado di ingrasso vengono determinati otticamente, applicando<br />
la cosiddetta CH-TAX. Per gli animali della specie suina, invece, la muscolatura (la<br />
quota di carne magra) viene stabilita utilizzando apparecchi appositi. I risultati della classificazione<br />
neutrale della qualità sono registrati in maniera centralizzata in un server di Identitas<br />
AG. Salvo poche eccezioni, la qualità degli animali macellati va determinata anche in tutti gli<br />
altri macelli; in questi casi, tuttavia, la classificazione viene effettuata dagli impiegati di tali<br />
strutture. La classificazione neutrale della qualità contribuisce ad aumentare la trasparenza,<br />
a migliorare la qualità delle carcasse, a finalità statistiche e a conteggiare correttamente gli<br />
animali da macello.<br />
I fornitori e gli acquirenti possono contestare il risultato della classificazione neutrale della<br />
qualità. La contestazione deve avvenire per animali della specie suina al massimo sei ore dopo,<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
171
Il mio Rapporto agricolo 21 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
per le altre razze al massimo 24 ore dopo la macellazione. Nell’anno oggetto del rapporto sono<br />
stati classificati secondo la CH-TAX 686 413 animali delle specie bovina e ovina. Di questi sono<br />
state contestate le classificazioni di 16 547 animali (2,41 % di tutti gli animali classificati rispetto<br />
al 2,02 % nello stesso periodo dell’anno precedente). Le contestazioni sono avvenute<br />
per l’88 per cento dei casi su richiesta dei fornitori e per il 12 per cento su richiesta degli acquirenti.<br />
Nel complesso nell’anno oggetto del rapporto è stato riclassificato il 95,5 per cento<br />
degli animali contestati.<br />
Nell’anno oggetto del rapporto, il risultato della riclassificazione per quanto riguarda la muscolatura<br />
è rimasto invariato per il 31,1 per cento degli animali. Con la riclassificazione il 45,0<br />
per cento degli animali ha guadagnato mezza classe e il 17,1 per cento ne ha persa metà. Il 4,6<br />
per cento delle carcasse ha guadagnato una classe piena e il 2,1 per cento ne ha persa una.<br />
Per la copertura di grasso, nella riclassificazione i dati restano invariati per il 63,2 per cento<br />
degli animali. Con la riclassificazione il 21,2 per cento degli animali ha guadagnato mezza<br />
classe e il 15,5 per cento ne ha persa metà. Lo 0,1 per cento degli animali ha perso una classe<br />
piena nella riclassificazione.<br />
Negli ultimi anni si è osservato un aumento della muscolatura degli animali macellati riconducibile<br />
al maggior livello di conoscenza degli allevatori: nel 2015 sono stati classificati come<br />
bene in carne e molto bene in carne quasi il 66 per cento dei torelli, il 30 per cento dei vitelli e<br />
il 64 per cento degli agnelli. Nel 2005 erano stati rispettivamente, il 43, il 17 e il 43 per cento.<br />
Per le vacche, invece, nello stesso periodo la muscolatura è rimasta la stessa: negli ultimi anni<br />
è rientrata nelle classi scarnate e molto scarnate una percentuale compresa tra il 40 e il 47 per<br />
cento delle vacche macellate. Questa evoluzione è riconducibile alla grande quantità di vacche<br />
da latte e alla detenzione di speciali razze da latte.<br />
Sorveglianza dei mercati pubblici e organizzazione dei provvedimenti<br />
di sgravio del mercato<br />
Prima dell’inizio dell’anno civile Proviande, in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni<br />
contadine, allestisce un programma annuale nel quale sono definiti i mercati pubblici per bes-<br />
172<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 22 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
tiame da macello e ovini. Tale programma indica il luogo e la data dei singoli mercati, nonché<br />
le categorie di animali che possono esservi presentate.<br />
Nonostante il calo degli effettivi di bestiame e un esiguo numero di mercati per bestiame grosso<br />
(-26 mercati per bestiame grosso), nell’anno oggetto del rapporto sono stati acquistati all’asta<br />
1014 animali in più (+1,8 %) rispetto all’anno precedente. Il numero di pecore acquistate<br />
all'asta, invece, è sceso rispetto al 2014 segnatamente di 5103 animali (-7,0 %). Nell’anno<br />
oggetto del rapporto il numero di mercati per ovini è diminuito a 320 (-5 mercato ovini).<br />
Nei periodi di eccedenze stagionali, o comunque temporanee, sui mercati gli animali non vendibili<br />
sono assegnati ai titolari di quote di contingenti che sottostanno all’obbligo di ritiro. Nel<br />
quadro di tale sgombero del mercato, Proviande ha assegnato 433 capi della specie ovina e 114<br />
della specie bovina a commercianti titolari di una quota di contingente doganale, che, per tali<br />
assegnazioni, devono pagarle il prezzo settimanale stabilito.<br />
Cifre inerenti ai mercati pubblici sorvegliati – 2015<br />
Caratteristica Unità Bestiame grosso Ovini<br />
Mercati pubblici sorvegliati Numero 683 320<br />
Animali acquistati all'asta Numero 56 735 68 280<br />
Numero medio di animali<br />
per mercato<br />
Quota degli animali presentati<br />
rispetto alle macellazioni<br />
totali<br />
Animali assegnati (sgombero<br />
del mercato)<br />
Numero 83 213<br />
% 14 32<br />
Numero 114 433<br />
Fonte: Proviande<br />
Come di consueto, anche nella primavera ed estate 2015 l’offerta di vitelli da macello ha superato<br />
la domanda. A sostegno dei prezzi, 60 macelli hanno immagazzinato 523 tonnellate di<br />
carne di vitello, che sono poi state smaltite in autunno. L’UFAG ha contribuito, stanziando 2,7<br />
milioni di franchi (ca. 5 fr. il kg), a ridurre i costi di stoccaggio e la perdita di valore causata<br />
dal congelamento.<br />
Provvedimenti sul mercato delle uova<br />
La domanda di uova cala considerevolmente soprattutto dopo Pasqua. Onde attutire le ripercussioni<br />
delle fluttuazioni di mercato stagionali, dopo aver sentito le cerchie interessate,<br />
nell’ambito dei crediti stanziati nel 2015, sono stati messi a disposizione 1,8 milioni di franchi<br />
circa per il finanziamento di misure di valorizzazione. Nel quadro della cosiddetta "azione di<br />
spezzatura" i fabbricanti di prodotti a base di uova nell’anno oggetto del rapporto hanno valorizzato<br />
nell’industria alimentare svizzera gli albumi e i tuorli di più di 15,9 milioni di uova di<br />
consumo indigene, sgravando quindi il mercato delle uova di consumo in guscio. Sul fronte del<br />
commercio al dettaglio è stato ridotto il prezzo di 8 milioni di uova di consumo a beneficio dei<br />
consumatori. La Confederazione ha versato un contributo di 9 centesimi per ogni uovo spezzato<br />
e di 5 centesimi per ogni uovo ribassato; la categoria ha contribuito allo sgravio del mercato<br />
con circa lo stesso importo. In totale, alle azioni di spezzatura e di riduzione del prezzo hanno<br />
partecipato rispettivamente 11 e 8 aziende.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
173
Il mio Rapporto agricolo 23 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
Provvedimenti per la valorizzazione della lana di pecora indigena<br />
In virtù dell'ordinanza concernente la valorizzazione della lana di pecora indigena, nel 2015<br />
l'UFAG ha sostenuto progetti innovativi di valorizzazione della lana di pecora, dando priorità<br />
alle organizzazioni di solidarietà che, al fine di valorizzarla, hanno perlomeno il compito di<br />
cernire, lavare e vendere per la trasformazione in prodotti finiti la lana indigena raccolta. Eccezionalmente,<br />
il lavaggio può essere effettuato all’estero. In tale contesto l'UFAG nel 2015 ha<br />
sostenuto 8 progetti innovativi stanziando un importo totale di ben 0,4 milioni di franchi.<br />
6 organizzazioni di solidarietà hanno raccolto, cernito, lavato e venduto per la trasformazione<br />
in prodotti finiti all’interno del Paese 216 057 tonnellate di lana di pecora. Il contributo della<br />
Confederazione per chilogrammo di lana lavata è stato di 2 franchi, per un importo totale di<br />
ben 0,4 milioni di franchi.<br />
Promozione dell’allevamento<br />
Secondo l’articolo 144 LAgr, i contributi federali per la promozione dell’allevamento possono<br />
essere versati solo a organizzazioni di allevamento riconosciute. Queste sono pubblicate sul<br />
sito Internet dell’UFAG (organizzazioni di allevamento). Le disposizioni d’esecuzione sono<br />
sancite nell’ordinanza sull’allevamento del bestiame (OAlle; RS 916.310). Quest'ultima stabilisce<br />
le condizioni che deve adempiere un'organizzazione di allevamento di animali delle specie<br />
bovina, suina, ovina e caprina, nonché di equidi, conigli, pollame, api mellifere e camelidi del<br />
nuovo mondo per ottenere dall'UFAG un riconoscimento della durata di al massimo dieci anni.<br />
Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del testo rivisto dell’OAlle, i contributi per animale<br />
iscritto nel libro genealogico possono essere assegnati soltanto per animali: a) i cui genitori<br />
e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza e b) la cui percentuale<br />
di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento. Inoltre, le misure zootecniche<br />
possono essere computate soltanto per gli animali il cui proprietario è domiciliato in<br />
Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e, durante l’anno di contribuzione, è membro attivo<br />
di un’organizzazione di allevamento riconosciuta. Una misura zootecnica dà diritto a un unico<br />
contributo per animale e per anno.<br />
» A46<br />
Nel 2015 sono stati erogati contributi a 24 organizzazioni di allevamento per un importo complessivo<br />
di circa 34,2 milioni di franchi in favore della tenuta del libro genealogico, della conduzione<br />
di esami funzionali e della conservazione delle razze svizzere. In quest’ultimo ambito<br />
si conducono, nella maggior parte dei casi, progetti pluriennali. Non sono stati erogati versamenti<br />
a organizzazioni di allevamento il cui contributo totale risultava inferiore a 50 000<br />
franchi. Fanno eccezione i contributi alle organizzazioni di allevamento di razze svizzere.<br />
Uscite nel settore dell'allevamento di animali<br />
Ripartizione dei fondi - 2015<br />
Il settore dell’allevamento di bovini ha beneficiato di circa 24,5 milioni di franchi, ovvero<br />
del 72 per cento dei fondi a disposizione per l’allevamento, due terzi dei quali stanziati per<br />
l’esecuzione di esami funzionali del latte. I contributi federali per l’allevamento consentono<br />
di ridurre i costi delle prestazioni zootecniche delle organizzazioni. Gli allevatori ne traggono<br />
beneficio, ad esempio, pagando tariffe inferiori per gli esami funzionali del latte.<br />
174<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 24 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
Verifica delle organizzazioni di allevamento<br />
Onde controllare l’impiego dei fondi per la promozione dell’allevamento di animali si effettuano<br />
verifiche presso le organizzazioni di allevamento riconosciute svolgendo in tutte almeno<br />
un controllo in loco nell’arco di cinque anni. Nel 2015 sono state condotte ispezioni presso<br />
5 organizzazioni riconosciute, stilando i rispettivi rapporti, nei quali sono state menzionate<br />
eventuali lacune e fornite indicazioni per colmarle.<br />
Conservazione delle razze svizzere minacciate<br />
Le risorse zoogenetiche sono di fondamentale importanza per l’alimentazione e l’agricoltura e<br />
possiedono ulteriori importanti valori di natura economica e sociale. Inoltre hanno un elevato<br />
valore di opzione. Per poter reagire, in futuro, a nuove condizioni quadro come cambiamenti<br />
climatici, nuove malattie, aspettative della società o mutevoli esigenze per particolari prodotti,<br />
le antiche razze acquisiranno maggiore importanza. Sono elevati anche il loro valore di lascito<br />
di cui potrebbero beneficiare le generazioni future e il loro valore di sostentamento che forniscono<br />
in genere. Per questo motivo l’UFAG sostiene diversi provvedimenti per la conservazione<br />
e la promozione delle razze svizzere a rischio di estinzione. Il sostegno di tipo finanziario, logistico<br />
e scientifico concesso finora dalla Confederazione si ripercuote positivamente sugli effettivi.<br />
Al momento vi sono 23 razze di diverse specie animali (bovini, equini, ovini, caprini, suini,<br />
api, conigli e polli) a rischio di estinzione a causa delle dimensioni ridotte degli effettivi, di<br />
un grado di consanguineità troppo elevato o di motivi tradizionali. Organizzazioni di allevamento<br />
riconosciute, ONG e istituti di ricerca possono inoltrare progetti per la conservazione<br />
e la promozione di razze minacciate. Tali progetti comprendono misure di salvaguardia specifiche,<br />
provvedimenti coordinati con prodotti particolari di specie minacciate orientati al mercato<br />
o progetti di ricerca volti a rilevare e a migliorare la varietà genetica. In collaborazione con<br />
l’Associazione svizzera per la produzione animale, l'UFAG organizza un workshop annuale sulle<br />
risorse zoogenetiche che comprende una parte zootecnica e una pratica. Insieme ai diretti interessati,<br />
si continua a sviluppare il pool genetico nazionale per bovini, suini, equini e caprini<br />
(provvedimento ex-situ). L’UFAG si impegna molto anche a livello internazionale nel settore<br />
delle risorse zoogenetiche. Ad esempio collabora attivamente con la European Regional Focal<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
175
Il mio Rapporto agricolo 25 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
Point, un’associazione di oltre 45 Stati europei, e in diverse commissioni e gruppi di lavoro<br />
della FAO.<br />
Contributo d'eliminazione<br />
Con la Politica agricola 2014-2017 (PA 14-17) i contributi per i costi di eliminazione dei sottoprodotti<br />
di origine animale (cosiddetti contributi d'eliminazione) sono stati estesi agli animali<br />
macellati delle specie equina e pollame (art. 45a cpv. 2 legge sulle epizoozie, LFE; RS 916.40).<br />
Per l'attuazione di tale provvedimento, in analogia al vigente sistema per bovini, suini, ovini<br />
e caprini è stata introdotta la BDTA. Il contributo di 25 franchi per animale della specie equina<br />
macellato con notifica alla BDTA ha un effetto positivo sulla disciplina di notifica dei macelli.<br />
Per il pollame è stato introdotto un nuovo sistema. Su domanda, sono versati 12 franchi la tonnellata<br />
di peso vivo al macello come contributo d'eliminazione.<br />
Nell’anno oggetto del rapporto 15 strutture dedite alla macellazione di pollame (nessuna variazione<br />
rispetto all’anno precedente) hanno inoltrato alla BDTA una richiesta di contributi<br />
d’eliminazione per 125 600 tonnellate di peso vivo. Complessivamente hanno percepito 1,5<br />
milioni di franchi di contributi d'eliminazione. L’incremento di circa il 25 per cento rispetto<br />
all’anno precedente è riconducibile in primo luogo all’inoltro più sistematico delle richieste.<br />
Le 5 maggiori aziende hanno ricevuto il 99.6 per cento dei contributi, di cui oltre il 42 per cento<br />
è stato erogato a un'azienda.<br />
Banca dati sul traffico di animali<br />
La banca dati sul traffico di animali (BDTA) costituisce la base per la tracciabilità delle epizoozie<br />
e per la sicurezza alimentare. È stata istituita nel 1999 in occasione della problematica della<br />
BSE (encefalopatia spongiforme bovina, la cosiddetta malattia della "mucca pazza") e da allora<br />
costantemente ampliata per l’esecuzione e altre esigenze agricole.<br />
Nell’anno oggetto del rapporto la principale modifica nella BDTA consiste nell’adeguamento<br />
riguardante gli equidi. Dal 1° gennaio 2015 i servizi preposti al rilascio del passaporto devono<br />
richiedere al gestore della BDTA un cosiddetto passaporto di base. Il modello di passaporto<br />
è integrato con i seguenti dati della BDTA: nome e indirizzo del proprietario di equidi, UELN<br />
176<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 26 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
(Universal Equiden Life Number), nome, data e luogo di nascita, sesso, categoria e numero di<br />
microchip dell’equide.<br />
Contemporaneamente per gli animali non iscritti nel libro genealogico si rinuncia alla<br />
segnalazione. Il proprietario dell’equide può concedere un’autorizzazione al servizio preposto<br />
al rilascio affinché questi, prima dell’ordine del passaporto di base, possa modificare, nella<br />
BDTA, i dati precedentemente indicati nonché il colore. Dopo l’ordine del passaporto di base<br />
non possono più essere apportate modifiche. Il passaporto di base può essere ordinato come<br />
PDF o in versione cartacea; la maggior parte degli ordini è consegnata in versione cartacea.<br />
I movimenti pendolari nel traffico di animali dei bovini sono ormai abbinati alle permanenze,<br />
migliorando la leggibilità della storia dell’animale.<br />
Sono scomparse le oscillazioni stagionali osservate per anni in relazione ai bovini riguardo al<br />
numero delle storie dell’animale corrette.<br />
La qualità della tracciabilità per le estivazioni e i mercati dei bovini è buona.<br />
Inoltre, nel 2015, per la prima volta sono stati rilevati i dati per una parte dei contingenti<br />
d’importazione della carne sulla base delle macellazioni di un intero anno e sono stati trasmessi<br />
alle persone interessate.<br />
La modalità di calcolo del calcolatore UBG per i detentori di animali è ormai identica ai calcolatori<br />
dei valori UBG dei bovini che sono forniti ai Cantoni.<br />
Sebbene nel 2015 in media siano pervenute alla BDTA 50 prime registrazioni di equidi alla settimana,<br />
non sono ancora stati registrati tutti gli equidi. Tuttavia a causa delle correzioni delle<br />
registrazioni multiple in corso, gli effettivi di equidi non aumentano nella stessa misure delle<br />
prime registrazioni. Una serie di adeguamenti funzionali ha ulteriormente potenziato la facilità<br />
di accesso per l’utente della BDTA.<br />
Il primo trimestre, con l’allestimento degli elenchi UBG, i rilevamenti dei dati cantonali, la<br />
chiusura dell’anno dei concimi aziendali e le correzioni dei dati sugli animali, ha comportato<br />
un elevato numero di richieste da parte dei clienti presso l’help desk. Tuttavia il numero di<br />
richieste nel corso dell’anno resta inferiore a quello<br />
dell’anno precedente.<br />
Effettivi massimi<br />
In virtù dell’articolo 46 LAgr, il Consiglio federale stabilisce gli effettivi massimi di ogni azienda<br />
per l'allevamento e l'ingrasso dei suini, la detenzione di ovaiole, l'ingrasso di polli, tacchini<br />
e vitelli. In tal modo si mira a tutelare le aziende familiari vincolate al suolo. In caso di<br />
superamento delle soglie stabilite, l’azienda deve pagare una tassa su ogni animale in eccesso.<br />
L'ammontare delle tasse è fissato in modo che la detenzione di animali in eccesso non risulti<br />
economicamente vantaggiosa. Nell’anno oggetto del rapporto sono stati svolti diversi controlli<br />
a questo proposito, irrogando le rispettive sanzioni.<br />
L'UFAG può autorizzare, su domanda, effettivi più elevati. Possono inoltrare una richiesta di<br />
autorizzazione di effettivi più elevati le seguenti aziende:<br />
• le aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) senza<br />
cedere concime aziendale a terzi;<br />
• le aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti della trasformazione del<br />
latte e di derrate alimentari nell'interesse pubblico che coprono almeno il 25 per cento del<br />
fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione del latte o<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
177
Il mio Rapporto agricolo 27 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico con sottoprodotti di derrate alimentari<br />
non provenienti dalla trasformazione del latte;<br />
• le aziende sperimentali nonché le stazioni di ricerca della Confederazione.<br />
Nel 2015 hanno usufruito di una simile autorizzazione 22 aziende che foraggiavano gli animali<br />
con sottoprodotti della trasformazione del latte e di derrate alimentari. Inoltre hanno potuto<br />
mantenere un elevato effettivo 10 aziende che adempivano la PER e spandevano i concimi aziendali<br />
sulle proprie superfici. Anche 2 aziende per attività sperimentali e di ricerca hanno usufruito<br />
di un’autorizzazione.<br />
Hans Ulrich Leuenberger, UFAG, Prodotti animali e allevamento, hansulrich.leuenberger@blw.admin.ch<br />
Hanspeter Lüthi, UFAG, Settore Prodotti animali e allevamento<br />
Corinne Boss, UFAG, Settore Prodotti animali e allevamento<br />
Marcel Zingg, UFAG, Settore Prodotti animali e allevamento<br />
Catherine Marguerat, UFAG, Settore Prodotti animali e allevamento<br />
Yves Schleppi, UFAG, Settore Prodotti animali e allevamento<br />
Colette Schmid, UFAG, Settore Prodotti animali e allevamento<br />
Fabian Zwahlen, UFAG, Settore Prodotti animali e allevamento<br />
178<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 30 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
Produzione vegetale<br />
Con 4,0 miliardi di franchi, la quota della produzione vegetale sulla produzione agricola totale<br />
svizzera (8,9 mia. fr.) è leggermente inferiore a quella animale (4,9 mia. fr.). In questo settore,<br />
l’ortofloricoltura è il ramo più importante, seguita dalla foraggicoltura. La Confederazione promuove<br />
la produzione vegetale oltre che mediante la protezione doganale con contributi specifici<br />
per singole colture in campicoltura e contributi per la trasformazione della frutta svizzera.<br />
Mezzi finanziari 2015<br />
Rispetto all'anno precedente, nel 2015 i mezzi finanziari erogati nel settore della produzione<br />
vegetale sono diminuiti leggermente, passando 63,6 a 62,3 milioni di franchi. Il 96 per cento<br />
dei fondi impiegati è stato destinato alla promozione di singole colture, il 3 per cento alla trasformazione<br />
e alla valorizzazione della frutta, l'1 per cento a provvedimenti a favore della vitivinicoltura.<br />
» A47<br />
Uscite nel settore della produzione vegetale<br />
La diminuzione delle uscite è riconducibile al lieve calo dei fondi stanziati per le colture campicole<br />
e alla riduzione, pari a 0,7 milioni di franchi, dei contributi per la fabbricazione di prodotti<br />
di bacche, nonché di frutta a granella e a nocciolo.<br />
Contributi per singole colture in campicoltura<br />
In virtù dell'articolo 54 della legge sull'agricoltura (LAgr), sono versati contributi per singole<br />
colture a favore di semi oleosi, leguminose a granelli, barbabietola da zucchero, sementi<br />
di patate, mais e graminacee da foraggio. Con l'attuazione della Politica agricola<br />
2014-2017 (PA 14-17) i contributi per singole colture (OCSC) hanno sostituito i contributi<br />
alla campicoltura (OCCamp). Questi contributi incentivano determinate colture importanti per<br />
l'approvvigionamento della popolazione, che altrimenti non sarebbero coltivate in quantità<br />
sufficiente data la loro scarsa redditività. Vengono pertanto versati solo se le colture vengono<br />
raccolte quando sono mature. Per ragioni pratiche (stessi processi), l'esecuzione della misura<br />
avviene insieme ai pagamenti diretti.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
179
Il mio Rapporto agricolo 31 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
Contributi principali (OCSC) - 2015<br />
Coltura Superficie 1 Contributo Totale<br />
ha fr./ha in 1000 fr.<br />
Barbabietola da zucchero 19 134 1600 30 482<br />
Colza 22 793 700 15 955<br />
Girasoli 4421 700 3094<br />
Soia 1652 1000 1652<br />
Favette 526 1000 526<br />
Piselli proteici 4259 1000 4259<br />
Lupini 105 1000 105<br />
Totale 55 073<br />
¹ Stima<br />
Fonte: UFAG<br />
Prospettiva sui contributi per singole colture per la barbabietola da<br />
zucchero<br />
I prezzi persistentemente bassi dello zucchero in Europa incidono sul prezzo dello zucchero<br />
svizzero. La Svizzera ha concordato con l'UE di non attuare più, nel quadro della protezione<br />
doganale, misure di compensazione dei prezzi per lo zucchero nei prodotti agricoli trasformati.<br />
Dato il calo dei ricavi dallo zucchero, Schweizer Zucher AG ha ridotto i prezzi pagati per le barbabietole.<br />
Già nel 2015, vista la notevole perdita di redditività della coltivazione di barbabietola<br />
da zucchero, il Consiglio federale ha aumentato il rispettivo contributo per singole colture a<br />
1600 franchi l'ettaro. In vista della soppressione delle quote zucchero decretata dall’UE per<br />
fine settembre 2017 e considerato l'atteso andamento dei prezzi, il Consiglio federale ha aumentato<br />
il contributo per singole colture per la barbabietola da zucchero anche per il 2016,<br />
portandolo a 1800 franchi l’ettaro. La priorità è garantire la competitività del settore zuccheriero<br />
svizzero, incrementando l’efficienza a tutti i livelli. Il Consiglio federale ritiene che a titolo<br />
sussidiario il contributo per singole colture sia uno strumento di sostegno adeguato, poiché<br />
non incide sul prezzo dello zucchero e assicura pertanto la competitività dell’industria alimentare<br />
svizzera a valle sui mercati svizzero e dell'UE.<br />
Misure nel quadro della protezione doganale per i cereali panificabili<br />
In seguito agli scarsi raccolti di cereali panificabili nel 2014, nel quadro del contingente doganale<br />
ordinario di 70 000 tonnellate l'UFAG ha aumentato i quantitativi liberati nel primo<br />
semestre di 20 000 tonnellate detraendole da quelli liberati nel secondo semestre. In una seconda<br />
fase il Consiglio federale, su richiesta della categoria, ha temporaneamente aumentato il<br />
contingente doganale per il 2015 di 20 000 tonnellate. Come richiesto della categoria, l'UFAG<br />
ha liberato un quantitativo di 20 000 tonnellate per inizio luglio e uno di 10 000 tonnellate<br />
per inizio ottobre. Per il 2016 i quantitativi da liberare nei quattro trimestri sono stati riportati<br />
rispettivamente a 20 000, 20 000, 15 000 e 15 000 tonnellate.<br />
180<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 32 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
Misure nel quadro della protezione doganale per i cereali grezzi destinati<br />
all'alimentazione umana<br />
Nell’ottica della semplificazione amministrativa, l'ordinanza sulle importazioni agricole è stata<br />
modificata snellendo i requisiti per l'importazione di orzo, avena e mais nel quadro del contingente<br />
doganale. Dal 2016 non è più soltanto chi dispone di impianti di trasformazione ad avere<br />
diritto a importare all'aliquota di dazio del contingente. Se, però, non si rispettano le rese minime<br />
stabilite o gli obblighi di utilizzo, ai quantitativi in eccesso continua a essere applicata<br />
l'aliquota di dazio fuori contingente.<br />
Provvedimenti per la valorizzazione della frutta<br />
Conformemente all'articolo 58 capoverso 1 LAgr, la Confederazione stanzia contributi a favore<br />
dei provvedimenti per la valorizzazione della frutta.<br />
L’ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente provvedimenti per la valorizzazione della frutta<br />
(ordinanza sulla frutta; RS 916.131.11) disciplina l’esecuzione dei due provvedimenti attualmente<br />
sostenuti mediante contributi.<br />
• Immagazzinamento della riserva di mercato per il concentrato di succo di mela e di pera<br />
La riserva di mercato a livello d'azienda delle fabbriche di sidro serve a compensare le fluttuazioni<br />
del raccolto dovute all’alternanza dei meli e dei peri. L'immagazzinamento del<br />
concentrato di succo di mela e di pera negli anni in cui il raccolto è abbondante permette<br />
di mantenere il volume di produzione nelle annate più scarse. I contributi costituiscono<br />
un indennizzo dei costi per le scorte e gli interessi del capitale. Vengono stanziati per una<br />
parte del concentrato che la fabbrica di sidro immagazzina oltre alle consuete scorte necessarie<br />
(max. 40 per cento dell'approvvigionamento normale della fabbrica). L'importo<br />
dei contributi è verificato e fissato di anno in anno dall'UFAG. Hanno diritto ai contributi<br />
le fabbriche di sidro industriali. Nel 2015 è stato immagazzinato come riserva di mercato<br />
e sovvenzionato un quantitativo pari a 2794 tonnellate di concentrato di succo di mela e a<br />
484 tonnellate di concentrato di succo di pera. Nel 2015 i contributi alla riserva di mercato<br />
sono ammontati a 0,8 milioni di franchi contro 0,7 milioni di franchi dell'anno precedente.<br />
• Fabbricazione di prodotti di bacche, nonché di frutta a granella e a nocciolo<br />
A seconda del prodotto e dello scopo di utilizzo vigono diversi livelli di protezione doganale.<br />
I contributi della Confederazione per la fabbricazione di prodotti di frutta sono tesi<br />
a compensare parzialmente tali differenze. Parallelamente promuovono lo smercio della<br />
frutta svizzera destinata alla trasformazione creando i presupposti per spuntare prezzi alla<br />
produzione migliori. Vengono stanziati per la fabbricazione di prodotti che non sono gravati<br />
dall’imposta sull’alcool e la cui aliquota di dazio corrisponde al massimo al 10 per cento<br />
del loro prezzo franco dogana svizzera. L'importo dei contributi compensa parzialmente<br />
(50 %) la differenza fra il prezzo alla produzione della materia prima all’estero e quello in<br />
Svizzera. Hanno diritto ai contributi le aziende di trasformazione del primo livello di trasformazione.<br />
Vengono versati contributi per la fabbricazione di prodotti di<br />
- bacche: fragole, lamponi, more e ribes;<br />
- frutta a granella: mele e pere;<br />
- frutta a nocciolo: albicocche, ciliegie e prugne.<br />
Nel 2015, nel complesso, sono stati versati contributi per la fabbricazione di prodotti da<br />
3905 tonnellate di frutta: 2856 tonnellate di frutta a granella (compreso il concentrato<br />
usato per la fabbricazione di aceto, convertito in frutta fresca), 852 tonnellate di frutta a<br />
nocciolo e 198 tonnellate di bacche. I contributi per la fabbricazione di prodotti di bacche,<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
181
Il mio Rapporto agricolo 33 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
nonché di frutta a granella e a nocciolo nel 2015 sono ammontati a 1 milione di franchi<br />
con un calo di 0,9 milioni rispetto all'anno precedente. Siccome i contributi per la valorizzazione<br />
della frutta possono essere richiesti e versati per i raccolti dei due anni precedenti,<br />
a seconda del periodo in cui vengono inoltrate le domande, si possono verificare notevoli<br />
fluttuazioni rispetto ai quantitativi e ai contributi totali, indipendentemente dai rispettivi<br />
raccolti.<br />
Contributi per il controllo della vendemmia<br />
Nel settore della vitivinicoltura, in virtù dell'articolo 64 capoverso 3 LAgr, la Confederazione<br />
partecipa al controllo della vendemmia eseguito dai Cantoni, che segue l'uva dal vigneto<br />
all'azienda di vinificazione e vigila sul rispetto delle disposizioni di produzione (rese massime,<br />
tenore minimo in zucchero). Il contributo consta di un contributo di base di 1000 franchi e<br />
di un contributo di 55 franchi l'ettaro vincolato alle dimensioni della superficie viticola cantonale.<br />
Nel 2015 per il controllo della vendemmia sono stati erogati complessivamente 833 000<br />
franchi.<br />
Link al sito Internet dell'UFAG:<br />
Produzione e smercio: Prodotti campicoli<br />
Produzione e smercio: Frutta<br />
Produzione e smercio: Verdura<br />
Produzione e smercio: Vini e distillati<br />
Peter Schwegler, UFAG, Settore Prodotti vegetali, peter.schwegler@blw.admin.ch<br />
David Raemy, UFAG, Settore Prodotti vegetali<br />
Arnaud de Loriol, UFAG, Settore Prodotti vegetali<br />
Marianne Glodé, UFAG, Settore Prodotti vegetali<br />
182<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 35 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
Promozione dello smercio<br />
Ripartizione dei fondi - 2015<br />
La Confederazione può sostenere misure di comunicazione e di marketing per lo smercio dei<br />
prodotti agricoli svizzeri partecipando al massimo al 50 per cento dei costi computabili. Almeno<br />
la metà dei costi deve essere finanziata con fondi propri delle organizzazioni interessate o delle<br />
associazioni di categoria. La determinazione degli obiettivi in materia di comunicazione, dei<br />
gruppi target e dell’impegno concernente i fondi propri nonché il controllo dell’efficacia competono<br />
prevalentemente ai rispettivi attori di categoria. Il sostegno della Confederazione ha<br />
carattere sussidiario.<br />
I fondi federali disponibili sono ripartiti una volta l'anno tra i diversi prodotti e gruppi di<br />
prodotti in funzione di un'analisi del portafoglio. In tal modo si tiene conto, da un lato,<br />
dell'attrattiva d’investimento dei diversi settori di produzione agricoli per quanto concerne le<br />
misure di marketing e, dall'altro, dei fondi propri investiti dalle rispettive categorie.<br />
Il 2015 è stato caratterizzato dal cosiddetto shock del franco che ha avuto ripercussioni anche<br />
sui progetti di promozione dello smercio. Nel corso dell’anno, nel quadro del credito dei fondi<br />
speciali, sono stati messi a disposizione a favore di ulteriori misure per formaggio e latte/<br />
burro rispettivamente 900’000 franchi e per la campagna “Sei WOW” di Agro-Marketing Suisse<br />
250’000 franchi.<br />
Iniziative legate all'esportazione<br />
Le conoscenze acquisite nell'ambito dei “Progetti pilota per la creazione di nuovi sbocchi”<br />
sono confluite nella Politica agricola 2014-2017 e quindi nell'ordinanza sulla promozione<br />
dello smercio (OPSAgr). Dal 2014 le iniziative legate all'esportazione vengono cofinanziate<br />
nell'ambito dell’ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti<br />
agricoli. Per cinque anni al massimo è possibile cofinanziare provvedimenti di comunicazione<br />
e di analisi di mercato per lo smercio di prodotti svizzeri all'estero fino al 50 per cento dei costi<br />
computabili.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
183
Il mio Rapporto agricolo 36 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
Nel 2015 sono state inoltrate e autorizzate cinque iniziative legate all'esportazione provenienti<br />
dai settori formaggio, carne, prodotti biologici, allevamento bovino e piante ornamentali.<br />
Il nuovo strumento è molto apprezzato e utilizzato in quanto fornisce alle categorie e alla Confederazione<br />
importanti conoscenze sull’accesso a nuovi mercati. Le esperienze dei primi due<br />
anni mostrano il potenziale e le sfide della prospezione di nuovi mercati.<br />
» A43<br />
Uscite promozione della qualità e delle vendite<br />
Martin Weber, UFAG, Settore Promozione della qualità e delle vendite, martin.weber2@blw.admin.ch<br />
184<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 38 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
Promozione della qualità e della sostenibilità<br />
Per migliorare la competitività dell’agricoltura e della filiera alimentare svizzere ci sono diverse<br />
possibilità. Particolarmente importante per la competitività sono i costi quanto più possibile<br />
bassi per i mezzi di produzione agricoli. Anche la qualità convincente e il posizionamento dei<br />
prodotti agricoli sul mercato sono decisivi. Non si tratta di semplici nozioni poiché a causa<br />
dell’attuale situazione economica sono diventate molto attuali e la loro realizzazione è più impellente<br />
che mai. C’è bisogno di innovazione per sfruttare i potenziali che migliorano la competitività.<br />
L’innovazione continua a essere il fattore chiave del successo economico. Affinché<br />
possa fiorire, devono esserci condizioni quadro statali idonee. Da un lato vanno creati dei margini<br />
di manovra, dall’altro, laddove possibile e utile, deve essere offerto sostegno. Quest’ultimo<br />
è fornito dalla Politica agricola della Confederazione (PA 14-17) con l'articolo 11 LAgr, e lo<br />
strumento relativamente nuovo dell'ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità<br />
nell’agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo).<br />
In virtù dell’OQuSo è possibile sostenere attraverso aiuti finanziari programmi e progetti innovativi<br />
in grado di ripercuotersi positivamente sulla sostenibilità o sulla qualità dei prodotti<br />
agricoli e di accrescere il valore aggiunto dell’agricoltura. L’OQuSo assicura un finanziamento<br />
iniziale a condizione che al massimo il 50 per cento dei costi computabili siano cofinanziati<br />
sull’arco di 4 anni. Sono sostenuti gli accertamenti preliminari, la fase iniziale e i costi dei<br />
produttori per la partecipazione a un progetto. Un ulteriore obiettivo dell’OQuSo è il potenziamento<br />
della collaborazione nella catena di valore. I progetti giusta l’OQuSo devono pertanto<br />
essere supportati da almeno due livelli della catena di valore, ossia l'ente promotore deve essere<br />
costituito da un'unione degli agricoltori con addetti alla trasformazione, commercianti o<br />
consumatori.<br />
Progetti promossi - 2014/15<br />
» A43<br />
Nei primi due anni sono state inoltrate 68 domande di aiuto finanziario. Dei progetti presentati,<br />
34 adempiono le condizioni dell’ordinanza e possono beneficiare di un finanziamento iniziale.<br />
Si tratta di 17 progetti che contribuiscono ad accrescere il valore aggiunto dell’agricoltura<br />
grazie all’innovazione nel settore della qualità o della sostenibilità. In 14 provvedimenti sono<br />
contemplati standard di produzione che fissano esigenze severe per i processi di produzione e<br />
i prodotti. 3 progetti sono stati sostenuti ancora nel quadro della disposizione transitoria secondo<br />
l’articolo 13 capoverso 1. Mediante l’OQuSo vengono promossi i progetti più svariati, riguardanti<br />
la produzione animale, quella vegetale o le prestazioni di servizio. In comune hanno<br />
soltanto lo stretto legame con l’agricoltura.<br />
Uscite promozione della qualità e delle vendite<br />
Priska Dittrich, UFAG, Settore Promozione della qualità e delle vendite,priska.dittrich@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
185
Il mio Rapporto agricolo 40 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
Caratterizzazione dei prodotti agricoli<br />
L’accertamento e il perseguimento delle frodi in relazione alle denominazioni protette dei<br />
prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (bio, DOP/IGP, Montagna e Alpe, caratterizzazione<br />
di carne di pollame, vino) acquisiscono sempre più importanza in un contesto<br />
di maggior apertura del mercato. Da un lato i produttori esigono misure efficienti che impediscano<br />
un’insostenibile distorsione della concorrenza da parte di aziende che violano le prescrizioni,<br />
traendone, generalmente, vantaggi finanziari. Dall’altro i consumatori, soprattutto<br />
in seguito a diversi scandali alimentari, rivendicano un’elevata protezione ed efficaci strumenti<br />
per la lotta alle infrazioni in relazione alla designazione, all’importazione ed esportazione, al<br />
transito e alla caratterizzazione di prodotti agricoli.<br />
Migliore protezione di consumatori e produttori contro le frodi<br />
Il Rapporto, varato dal Consiglio federale il 4 marzo 2016 in risposta al postulato 13.3837<br />
(CS Savary) «Tutela dei consumatori e dei produttori. Qual è la situazione riguardo alle denominazioni<br />
protette dei prodotti agricoli?», illustra le pertinenti basi legali in materia di<br />
disciplinamento ed esecuzione. Inoltre fornisce una panoramica sul coordinamento tra le diverse<br />
autorità interessate e tra i singoli Cantoni nonché sull’attività di vigilanza delle autorità<br />
federali sugli organi di controllo coinvolti. Sulla base di tale analisi, nel rapporto sono<br />
valutate e proposte misure concrete per migliorare l’attuale sistema di lotta alle infrazioni per<br />
quanto riguarda le designazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati. Attraverso<br />
le misure proposte nel rapporto (obbligo di notifica di irregolarità constatate, informazioni<br />
sui risultati dei controlli nel settore della caratterizzazione di prodotti agricoli nonché<br />
sull’applicazione delle disposizioni penali) s’intende colmare le lacune nel sistema di controllo<br />
e di esecuzione. Il rapporto è disponibile sulla pagina Internet dell'UFAG.<br />
Perseguimento delle infrazioni<br />
Nel 2015 un gruppo di lavoro interno alla Confederazione (UFAG, USAV, AFD e IPI) è stato incaricato<br />
di elaborare possibili varianti per l’attuazione dell’articolo 182 LAgr, il quale esige il<br />
coordinamento con la legislazione sulle derrate alimentari e con la legge sulle dogane e prescrive<br />
l’istituzione, da parte del Consiglio federale, di un ente centrale per l’accertamento di<br />
infrazioni. Dal varo dell’articolo 182 LAgr sono state adottate diverse misure a livello legislativo<br />
e organizzativo che promuovono la sicurezza alimentare e potenziano la protezione contro<br />
un utilizzo fraudolento o fuorviante di denominazioni protette o altre caratterizzazioni delle<br />
derrate alimentari. Il rapporto presenta, tra le altre cose, le possibilità giuridiche connesse<br />
all’articolo 182 LAgr. Poiché i temi in questione sottostanno a diverse normative e l’esecuzione<br />
è di competenza di varie autorità federali e cantonali, in una prima fase si propone una piattaforma<br />
comune sulla quale siano disponibili informazioni e risultati dei controlli.<br />
Stato attuale del Registro DOP/IGP<br />
Nel 2015 sono state inserite tre nuove denominazioni nel registro federale delle DOP e delle<br />
IGP, segnatamente Zuger Kirschtorte e i prodotti Jambon cru du Valais e Lard sec du Valais come<br />
indicazioni geografiche protette.<br />
» A48<br />
Negli ultimi mesi sono state inoltrate all’UFAG altre domande di registrazione: dalla Svizzera<br />
orientale per il St. Galler Alpkäse (come DOP) e le tre specialità appenzellesi Appenzeller Mostbröckli,<br />
Appenzeller Siedwurst e Appenzeller Pantli (come IGP) e dal Canton Friburgo per la Cuchaule<br />
(come DOP).<br />
Registro DOP / IGP al 31 dicembre 2015<br />
Il registro svizzero contiene 34 registrazioni: 21 denominazioni di origine protetta (DOP) e 13<br />
indicazioni geografiche protette (IGP), tra cui Café de Colombia (IGP), che è la prima denominazione<br />
estera. La documentazione è disponibile sulla pagina Internet dell'UFAG.<br />
186<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 41 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
Commissione federale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche<br />
La Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche consiglia<br />
l'UFAG nell'esecuzione dell'ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni<br />
di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati<br />
(ordinanza DOP/IGP; RS 910.12). Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina<br />
Internet dell'UFAG.<br />
Nel 2015 la Commissione si è espressa in merito alle due domande di registrazione Jambon<br />
cru du Valais e Lard sec du Valais (IGP) e alle modifiche dell’elenco degli obblighi di Formaggio<br />
d’alpe ticinese (DOP), Gruyère (DOP), Raclette du Valais (DOP), Emmentaler (DOP) e Sbrinz (DOP).<br />
Inoltre si è espressa in merito al ricorso concernente la modifica dell’elenco degli obblighi Emmentaler<br />
(DOP).<br />
La Commissione ha trattato anche la tematica dei requisiti minimi per la registrazione di una<br />
DOP o IGP. Nella guida dell’UFAG per il deposito di una domanda di registrazione o di una domanda<br />
di modifica dell'elenco degli obblighi è stato inserito un elenco di criteri per formaggi<br />
e prodotti carnei che stabilisce in quale misura può esserci un influsso naturale sulla qualità<br />
e sulle proprietà di un prodotto DOP. Oltre a un’analisi dettagliata dei criteri, la Commissione<br />
ha discusso sui requisiti relativi alla provenienza delle materie prime per le indicazioni geografiche<br />
protette. Nel 2016 dovrebbe varare le sue raccomandazioni all’attenzione dell’UFAG che,<br />
successivamente, rivedrà ed eventualmente integrerà la guida.<br />
Paolo Degiorgi, UFAG, Settore Promozione della qualità e delle vendite, paolo.degiorgi@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
187
Il mio Rapporto agricolo 43 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
Disposizioni sulle norme d’importazione ed esecuzione<br />
Le norme d’importazione costituiscono uno strumento importante per l’agricoltura elvetica<br />
nell’ambito del commercio estero. Le principali disposizioni in materia, come, ad esempio,<br />
quelle sui permessi generali d’importazione, sulla determinazione delle aliquote di dazio o<br />
sulla ripartizione dei contingenti doganali, sono contenute nell'ordinanza sulle importazioni<br />
agricole (OIAgr). Molti importatori e consumatori ritengono opinabili le numerose norme<br />
d'importazione, considerato che esistono sempre più accordi di libero scambio. Pertanto,<br />
l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) s'impegna, laddove possibile, per semplificarle e per<br />
ridurre il dispendio amministrativo. Nel 2015 il Consiglio federale, su proposta dell'UFAG,<br />
ha preso una decisione importante a tal riguardo, abrogando le disposizioni concernenti<br />
l'importazione prima del pagamento del prezzo di aggiudicazione nell'ambito della vendita<br />
all'asta di quote di contingente doganale.<br />
La disposizione in base alla quale, nella vendita all'asta di quote di contingente, la merce poteva<br />
essere importata all'aliquota di dazio (ADC) soltanto ad avvenuto pagamento dell'intero<br />
prezzo di aggiudicazione aveva lo scopo di evitare che le quote di contingente vendute all'asta<br />
fossero esaurite prima del pagamento del prezzo di aggiudicazione. Nel frattempo, i termini<br />
di pagamento ordinari di 30-150 giorni, a seconda del tipo di quote di contingente doganale<br />
e della durata dell'assegnazione, sono stati in parte considerevolmente ridotti. Fino a<br />
quel momento, se la merce veniva importata nel quadro del contingente doganale prima di<br />
aver pagato il prezzo di aggiudicazione, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) fatturava<br />
all'importatore la differenza tra l'ADC e l'aliquota di dazio fuori contingente. In pratica<br />
la merce veniva trattata come se fosse stata importata al di fuori del contingente doganale.<br />
Gli importatori potevano essere esonerati dall'obbligo di pagare il prezzo di aggiudicazione<br />
prima di effettuare l'importazione fornendo una garanzia (garanzia bancaria o fideiussione).<br />
Nella sua sentenza del 24 gennaio 2014, il Tribunale federale ha ritenuto sproporzionata la<br />
richiesta di versare la differenza tra le aliquote di dazio in caso di mancato pagamento del<br />
prezzo di aggiudicazione prima dell'importazione. Di conseguenza si è dovuto procedere alla<br />
modifica delle pertinenti disposizioni. Nell’ottica di sgravare gli importatori, quelle contenute<br />
nell'OIAgr sono state abrogate con effetto al 1° gennaio 2016. Le disposizioni relative al pagamento<br />
del prezzo di aggiudicazione, ai termini e ai solleciti non sono invece state modificate.<br />
Un'altra semplificazione amministrativa decisa dal Consiglio federale riguarda l'importazione<br />
di orzo, avena e mais nel quadro del contingente doganale n. 28 (Cereali grezzi destinati<br />
all'alimentazione umana). Fino a quel momento, i cereali in questione potevano essere importati<br />
soltanto da chi disponeva di adeguati impianti di trasformazione, trasformava nella propria<br />
azienda le merci importate, garantiva, con rese minime stabilite, la fabbricazione di prodotti<br />
idonei all'alimentazione umana e si impegnava a pagare posticipatamente la differenza di<br />
dazio qualora i valori di resa stabiliti non fossero stati raggiunti. Il contrasto con un disciplinamento<br />
del mercato liberale ed efficiente dal profilo amministrativo era palese e pertanto le<br />
disposizioni sono state snellite. Dal 2016 chi intende importare cereali grezzi nel quadro del<br />
contingente doganale deve soltanto confermare all'AFD che si impegnerà a utilizzare la merce<br />
per l'alimentazione umana e che nella trasformazione sarà raggiunta una resa minima. In tal<br />
modo il controllo è garantito e ci si assicura che non venga destinata all'alimentazione degli<br />
animali una quota troppo grande di cereali grezzi.<br />
Nel 2015 è stato nuovamente necessario aumentare temporaneamente alcuni contingenti doganali<br />
e contingenti doganali parziali per coprire il fabbisogno nazionale. Tutti e tre i contingenti<br />
doganali parziali di patate (da semina, da tavola e destinate alla trasformazione) sono<br />
stati temporaneamente aumentati una volta. Nell'anno oggetto del rapporto sono, inoltre,<br />
state prese decisioni per un sufficiente approvvigionamento del mercato di patate nel 2016. I<br />
raccolti scarsi e la presenza di un numero superiore alla media di tuberi di piccole dimensioni,<br />
hanno determinato un maggior fabbisogno d’importazione, soprattutto da parte dell'industria<br />
di trasformazione. Per far fronte alle maggiorazioni di contingenti doganali, effettuate a più ri-<br />
188<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 44 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
prese negli ultimi anni, l'UFAG ha chiesto al Consiglio federale di aumentare permanentemente<br />
da 2500 a 4000 tonnellate, a partire dal 2017, per lo meno il contingente doganale parziale<br />
delle patate da semina.<br />
L'UFAG è responsabile anche dell'adeguamento periodico dei tributi doganali su zucchero,<br />
cereali, alimenti per animali e semi oleosi. Il Consiglio federale ha delegato all'UFAG questo<br />
compito fissando norme severe. I tributi doganali contemplano i dazi e i contributi al fondo di<br />
garanzia. Per i cereali panificabili i tributi non hanno subito variazioni nel 2015. Quelli per lo<br />
zucchero sono stati modificati con effetto al 1° febbraio 2015, quelli per gli alimenti per animali<br />
e i semi oleosi, come di consueto, mensilmente, poiché nell'ampia gamma di prodotti si<br />
è sempre reso necessario adeguarne qualcuno.<br />
Una sintesi dettagliata di queste modifiche è contenuta nel rapporto del Consiglio federale<br />
concernente le misure tariffali prese nel 2015 nel quale sono pubblicati anche l’attribuzione<br />
e l'utilizzo delle quote dei contingenti doganali. Informazioni in proposito e su altri temi concernenti<br />
le importazioni agricole sono disponibili sul sito Internet dell’UFAG sotto Temi > Importazione<br />
di prodotti agricoli o direttamente sotto www.import.ufag.admin.ch.<br />
Ripartizione dei contingenti doganali per la carne rossa in base al numero<br />
di macellazioni<br />
Il 2015 è stato il primo anno in cui il 40 per cento delle quote di contingente doganale di carne<br />
bovina, ovina, caprina ed equina è stato ripartito in base al nuovo metodo del numero di animali<br />
macellati. Le quote sono state calcolate sulla scorta delle domande inoltrate dai cosiddetti<br />
beneficiari della cessione alla banca dati sul traffico di animali (BDTA) entro il 31 agosto 2014.<br />
Il beneficiario della cessione è la persona autorizzata dal macello nell'ambito della notifica di<br />
macellazione e mediante registrazione del rispettivo numero BDTA a presentare domanda per<br />
ottenere quote di contingente. Naturalmente anche il macello stesso può essere il beneficiario<br />
della cessione. Persino il modulo elettronico è impostato in maniera tale che nella maschera<br />
per la registrazione della notifica di macellazione nel campo “beneficiario della cessione” la<br />
prima indicazione che compare è il numero BDTA del macello. Le domande di quote di contingente<br />
del 2016 erano basate sul periodo di calcolo (periodo di macellazione) dal 1° luglio 2014<br />
al 30 giugno 2015. A differenza del periodo di calcolo per le quote di contingente del 2015, che<br />
andava soltanto dal 1° gennaio al 30 giugno 2014, nell'anno oggetto del rapporto, ai fini del<br />
calcolo delle quote per l’anno seguente ci si è basati per la prima volta sul numero delle macellazioni<br />
di un anno intero. Di conseguenza le cifre utilizzate per il calcolo nel caso di ovini ed<br />
equini sono più che raddoppiate. Per i bovini e soprattutto per i caprini, macellati prevalentemente<br />
in primavera, l'aumento non è stato così marcato, ed ammontava rispettivamente all’80<br />
e al 46 per cento. Si constata che le quote di macellazioni fatte valere sono alte, commisurate<br />
al numero di animali effettivamente macellati. Per tutte e quattro le specie animali, in media,<br />
sono ammontate al 97,7 per cento, il che equivale a una crescita di quasi il 7 per cento rispetto<br />
al primo periodo di calcolo, riconducibile soprattutto al forte incremento delle macellazioni di<br />
bovini; infatti, per l'assegnazione di quote di contingente è stato fatto valere il 98,4 per cento<br />
delle 640 872 macellazioni. Nella tabella seguente sono riportati altri valori e cifre.<br />
La tabella contiene anche dati relativi alla concentrazione delle quote correlata al nuovo metodo<br />
di ripartizione. Le ripartizioni sono molto ampie per tutti e quattro i tipi di carne. Nel<br />
complesso, 279 persone (2014: 244) hanno ricevuto quote sulla scorta della macellazione di<br />
almeno una specie animale. Le ripartizioni sono tuttavia anche molto unilaterali. Il totale delle<br />
5 maggiori quote per tutte le specie animali è aumentato attestandosi su una percentuale compresa<br />
tra il 52 e il 64 per cento. Parallelamente è cresciuto il numero dei titolari di quote inferiori<br />
all'1 per cento, eccezion fatta per i bovini dove il numero è rimasto invariato a 210.<br />
L’incremento del numero dei titolari di piccole quote potrebbe indurre a pensare che il totale di<br />
quelle inferiori all'1 per cento sia aumentato. Tuttavia ciò si è verificato soltanto per i caprini<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
189
Il mio Rapporto agricolo 45 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
dove si è registrato un massiccio aumento, pari al 5 per cento. Per bovini ed equini il totale è<br />
rimasto invariato, mentre per gli ovini è diminuito addirittura di quasi il 3 per cento.<br />
Risultati delle vendite all’asta per il periodo di contingentamento<br />
2015<br />
La ripartizione dei contingenti doganali rappresenta una parte considerevole dell’esecuzione<br />
delle norme d’importazione. Per quelli che non possono essere assegnati tramite la procedura<br />
più semplice, ovvero in base all’ordine di entrata delle dichiarazioni doganali («procedura<br />
progressiva»), si effettua spesso la vendita all’asta. Per il periodo di contingentamento 2015<br />
l’UFAG ha indetto 95 bandi per assegnare diversi contingenti doganali parziali. Il numero delle<br />
vendite all'asta è sceso leggermente al di sotto di 100 perché nel settore della carne sono stati<br />
venduti all'asta soltanto 84 contingenti doganali parziali, tra cui nessuno per la carne suina.<br />
Anche i quantitativi messi all'asta sono diminuiti. Ciò è riconducibile in primo luogo al nuovo<br />
sistema di ripartizione dei contingenti doganali per l'importazione di carne. Per la liberazione<br />
di carne bovina, ovina, caprina ed equina, dal 2015 il 40 per cento delle quote di contingente<br />
doganale è ripartito in base al numero di animali macellati. Ciò ha determinato un calo del 18<br />
per cento circa, rispetto al 2014, dei quantitativi di contingenti doganali messi all'asta che<br />
sono passati da 87 553 a 71 919 tonnellate. Il ricavo nel settore della carne è calato del 14,9<br />
per cento (-35,3 mio. fr.) attestandosi a 201,1 milioni di franchi. Il calo percentuale segnato<br />
dai quantitativi è stato maggiore rispetto a quello del ricavo e ciò indica che i prezzi d'asta per i<br />
contingenti doganali di carne sono generalmente aumentati. Per quanto riguarda le categorie<br />
di carne ripartite in base al nuovo sistema, si è registrato un calo di oltre il 40 per cento sia del<br />
quantitativo (-51 %; 15 358 t) sia del ricavo (-41,3 %; 38,5 mio. fr.). Il prezzo d'aggiudicazione<br />
medio è tuttavia aumentato di 10 centesimi attestandosi a 2.80 fr./kg per tutte le categorie<br />
di carne. Per quelle assegnate nella misura del 40 per cento in base al nuovo metodo di ripartizione<br />
si è osservato addirittura un rincaro di 60 centesimi a 3.56 fr./kg.<br />
Gli offerenti usufruiscono praticamente per tutti i bandi della possibilità di presentare le<br />
offerte mediante l’applicazione Internet Vendita all’asta elettronica. Più dell'80 per cento<br />
delle oltre 8000 offerte è stato inoltrato in questa maniera. La percentuale è rimasta praticamente<br />
invariata anche se avrebbe potuto essere maggiore se l'unico problema degno di nota<br />
nell'applicazione web non si fosse verificato proprio alcune ore prima della scadenza del termine<br />
di presentazione delle offerte per una liberazione semestrale di contingenti doganali per<br />
l'importazione di carne.<br />
Nella tabella seguente sono riportati i risultati dettagliati delle vendite all’asta di contingenti<br />
del 2015.<br />
» A49<br />
Risultati delle vendite all'asta per il periodo di contingentamento 2015<br />
Emanuel Golder, UFAG, Settore Importazioni ed esportazioni, emanuel.golder@blw.admin.ch<br />
190<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 47 / 222<br />
POLITICA > PRODUZIONE E SMERCIO<br />
Legge sul cioccolato<br />
La legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (cosiddetta<br />
«legge sul cioccolato») crea un sistema di compensazione del prezzo alla frontiera svizzera<br />
per i prodotti agricoli trasformati: all'atto dell'importazione il prezzo delle materie prime<br />
in essi contenute viene innalzato al livello di quello applicato in Svizzera mediante dazi (elementi<br />
parziali mobili); al momento dell'esportazione la Confederazione può concedere contributi<br />
all'esportazione per determinate materie prime in modo da ridurre il loro prezzo al<br />
livello di quello estero. Tale sistema mira a compensare il divario di prezzo delle materie prime<br />
dell'industria agroalimentare svizzera riconducibile alla politica agricola.<br />
Contributi all’esportazione nell'anno di contribuzione 2015<br />
Nell'anno di contribuzione 2015 (dicembre 2014-novembre 2015) nell'ambito della legge sul<br />
cioccolato erano a disposizione per i contributi all'esportazione 95,6 milioni di franchi. Di<br />
questi, 79,471 milioni di franchi sono stati impiegati per i latticini di base e 16,128 milioni per<br />
i cereali di base.<br />
Nonostante le riduzioni, neanche nell'anno di contribuzione 2015 si sono potute soddisfare<br />
tutte le richieste di contributi all’esportazione. Il disavanzo ammonta a 6,821 milioni di<br />
franchi, tenendo conto che per il burro non compensato alle aziende interessate sono stati attribuiti<br />
diritti d’importazione del controvalore di 0,778 milioni di franchi.<br />
Nel 2015 la quota di materie prime agricole esportate attraverso la legge sul cioccolato è stata,<br />
rispetto alla produzione totale, del 6 per cento circa per il latte e dell'11 per cento circa per<br />
il frumento.<br />
Tim Kränzlein, UFAG, Settore Politica commerciale internazionale, tim.kraenzlein@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
191
Il mio Rapporto agricolo 48 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Sistema dei pagamenti diretti<br />
Il 23 ottobre 2013, il Consiglio federale ha varato le disposizioni d'esecuzione sulla Politica<br />
agricola 2014-2017 (PA 14-17). Dal 1° gennaio 2014 esistono sette tipi di contributi nel quadro<br />
dei pagamenti diretti, i cui indirizzi di fondo si rispecchiano nella loro denominazione.<br />
• Contributi per il paesaggio rurale<br />
• Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento<br />
• Contributi per la biodiversità<br />
• Contributo per la qualità del paesaggio<br />
• Contributi per i sistemi di produzione<br />
• Contributi per l'efficienza delle risorse<br />
• Contributo di transizione<br />
I mezzi finanziari vengono impiegati a favore di prestazioni dell'agricoltura non remunerate<br />
dal mercato:<br />
• preservazione di un paesaggio rurale variato e attrattivo per la popolazione;<br />
• preservazione di un approvvigionamento sicuro della popolazione in derrate alimentari;<br />
• promozione e preservazione della biodiversità nell'ambito del primario;<br />
192<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 49 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
• promozione di metodi di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettosi<br />
delle risorse e del benessere degli animali preservando la produttività.<br />
Mezzi finanziari<br />
Fino al 2013 veniva fatta una distinzione essenzialmente tra pagamenti diretti generali ed ecologici,<br />
mentre dal 2014 vi sono 7 tipi di contributi.<br />
Uscite per i pagamenti diretti<br />
Ambito di spesa 2012 2013 2014 2015 2016¹<br />
mio. fr. mio. fr. mio. fr. mio. fr.<br />
Pagamenti diretti<br />
generali<br />
Pagamenti diretti<br />
ecologici<br />
2 163 2 146<br />
641 667<br />
Contributi per il<br />
paesaggio rurale<br />
Contributi per<br />
la sicurezza<br />
dell'approvvigionamento<br />
Contributi per la<br />
biodiversità<br />
Contributi per la<br />
qualità del paesaggio<br />
Contributi per i<br />
sistemi di produzione<br />
Contributi per<br />
l’efficienza delle<br />
risorse<br />
Contributi per<br />
programmi sulla<br />
protezione delle<br />
acque<br />
e sulle risorse<br />
(LPAc e LAgr art.<br />
77a/b)<br />
Contributo/i di<br />
transizione<br />
Riduzioni / acconti<br />
e pagamenti<br />
suppletivi<br />
ecc.<br />
496 504 505<br />
1 096 1 094 1 095<br />
364 387 400<br />
70 125 130<br />
439 450 455<br />
6 17 45<br />
31 26<br />
308 178 179<br />
13 15 6 2<br />
Totale 2 791 2 798 2 804 2 784 2 809<br />
N.B.: Non è possibile effettuare un paragone diretto con i dati del Conto dello Stato. I valori si riferiscono all’intero<br />
anno di contribuzione, mentre il Conto dello Stato riporta le spese sostenute durante un anno civile.<br />
¹ Preventivo 2016 secondo il Decreto del Consiglio federale del 09.12.2015<br />
Fonte: UFAG<br />
Ripartizione dei mezzi finanziari<br />
Le aziende agricole si sono rapidamente adeguate al nuovo sistema dei pagamenti diretti e<br />
notificano le prestazioni che forniscono per la società. Per questo motivo, nel 2015 le uscite per<br />
i programmi dei pagamenti diretti (biodiversità, qualità del paesaggio, sistemi di produzione,<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
193
Il mio Rapporto agricolo 50 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
efficienza delle risorse) sono state superiori rispetto all'anno precedente. Di conseguenza, i<br />
mezzi finanziari disponibili per il contributo di transizione sono passati da 308 a 178 milioni<br />
di franchi.<br />
Panoramica sui tipi di contributi<br />
» A50<br />
» A51<br />
» A52<br />
Per maggiori indicazioni sui singoli tipi di contributi e sugli importi versati nel 2015 si rimanda<br />
alla seguente tabella.<br />
Pagamenti diretti a livello aziendale per classe di dimensioni<br />
(zona di pianura e collinare)<br />
» A53<br />
Pagamenti diretti a livello aziendale per classe di dimensioni<br />
(zona di montagna I e II)<br />
» A54<br />
Pagamenti diretti a livello aziendale per classe di dimensioni (zona di<br />
montagna III e IV)<br />
» A55<br />
Pagamenti diretti a livello aziendale per regione (pianura, collinare,<br />
montagna)<br />
Doris Werder, UFAG, Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale, doris.werder@blw.admin.ch<br />
194<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 57 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Condizioni per il versamento di pagamenti diretti<br />
Per poter ricevere pagamenti diretti i gestori devono rispettare numerose condizioni, tra cui<br />
ne rientrano alcune di natura generale quali forma giuridica, formazione e domicilio di diritto<br />
civile, ma anche criteri strutturali e sociali determinanti come ad esempio volume di lavoro minimo<br />
o età del gestore. A ciò si aggiungono condizioni specifiche di carattere ecologico in base<br />
al concetto della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER). Gli oneri della PER<br />
comprendono: un bilancio di concimazione equilibrato, una quota adeguata di superfici per la<br />
promozione della biodiversità, una gestione di superfici in inventari d'importanza nazionale<br />
conforme alle prescrizioni, un avvicendamento disciplinato delle colture, una protezione adeguata<br />
del suolo, un'utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari e una detenzione degli animali<br />
da reddito agricoli rispettosa delle loro esigenze. La PER è finalizzata a promuovere una produzione<br />
agricola rispettosa dell'ambiente, sostenibile e conforme alla protezione degli animali. È<br />
sancita nella Costituzione federale quale presupposto per l'ottenimento di pagamenti diretti.<br />
Lacune in relazione alle prescrizioni determinanti ne comportano riduzioni o il diniego.<br />
I pagamenti diretti sono riservati ai gestori delle aziende contadine che coltivano il suolo.<br />
Fanno eccezione i contributi per la biodiversità e quello per la qualità del paesaggio, visto che<br />
entrambi questi tipi di pagamenti diretti possono essere concessi anche a persone giuridiche<br />
con sede in Svizzera, a Cantoni e Comuni. In tal modo è possibile evitare aree scoperte nei progetti<br />
di interconnessione e per la qualità del paesaggio.<br />
Il limite d'età resta invariato. I pagamenti diretti sono versati per l'ultima volta nell'anno in<br />
cui il gestore compie 65 anni. Il diritto al contributo decade nell'anno in cui ne compie 66. Il<br />
limite d'età mira a contrastare il rinvio ad oltranza della cessione della fattoria e a promuovere<br />
il mutamento strutturale e il ricambio generazionale. A maggior ragione, perché le prestazioni<br />
dell'AVS e di altre eventuali casse di previdenza vanno a sostituire il reddito da attività lucrativa<br />
indipendente nel primario.<br />
Le esigenze relative alla formazione vengono mantenute anche nella PA 14-17. L'unica modifica<br />
è costituita dal fatto che, al momento dell'inoltro della domanda, la formazione continua<br />
deve essere terminata. Tale disposizione consente di evitare problemi nel rimborso in caso di<br />
interruzione della formazione continua o di mancato conseguimento del rispettivo diploma.<br />
Affinché le prestazioni possano essere fornite in modo efficiente e sostenibile e sia garantita<br />
la buona pratica agricola, sono necessarie solide conoscenze.<br />
Le esigenze relative alla formazione non vanno adempiute se il gestore cede l'azienda al coniuge<br />
essendo prossimo il raggiungimento del limite d'età. In tal caso è posta la condizione<br />
di una collaborazione almeno decennale. Ciò consente di evitare casi di rigore se, ad esempio,<br />
non vi è alcun successore.<br />
Nel caso di società di persone i contributi sono ridotti proporzionalmente per ogni persona che<br />
ha superato il limite d'età. Considerato un importo dei pagamenti diretti di 60 000 franchi, in<br />
una società con tre soci i contributi sono ridotti di un terzo, cioè a 40 000 franchi, se un socio<br />
raggiunge il limite di età.<br />
Fino al 2015 i pagamenti diretti venivano erogati soltanto se l'azienda disponeva di almeno<br />
0,25 unità standard di manodopera (USM). In seguito all'adeguamento dei coefficienti USM<br />
con effetto al 1° gennaio 2016, la dimensione minima dell'azienda è stata ridotta da 0,25 a<br />
0,2 USM. Questo limite minimo consente di escludere aziende di esigue dimensioni e quindi di<br />
ridurre il dispendio amministrativo poiché si evitano sovvenzioni irrisorie.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
195
Il mio Rapporto agricolo 58 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Per USM dell'azienda vengono versati 70 000 franchi al massimo. Questa disposizione fa da<br />
deterrente a estendere eccessivamente le superfici per la promozione della biodiversità (SPB)<br />
in singole aziende, soprattutto nella regione di pianura. L'incremento delle SPB generalmente<br />
comporta una riduzione degli effettivi di animali. Anche le USM dell'azienda, dunque, diminuiscono<br />
e pertanto può essere efficace porre un limite. Da questa limitazione sono esclusi i<br />
contributi per l'interconnessione, per la qualità del paesaggio, per l'efficienza delle risorse e di<br />
transizione. A causa del cofinanziamento da parte dei Cantoni dei contributi per la qualità del<br />
paesaggio e per l'interconnessione, l'esecuzione sarebbe sproporzionatamente più difficile se<br />
per questi contributi si applicasse il limite USM. Anche i contributi per l'efficienza delle risorse,<br />
ad esempio per l'acquisto di attrezzature fitosanitarie, non sono soggetti al limite USM, così<br />
come il contributo di transizione per non comprometterne l'effetto ammortizzante nella transizione<br />
al nuovo sistema.<br />
Efficacia delle limitazioni dei pagamenti diretti per USM<br />
Limitazione per unità<br />
standard di manodopera<br />
(USM)<br />
Aziende interessate Riduzioni Quota rispetto al<br />
contributo delle aziende<br />
interessate<br />
Quota rispetto<br />
all'importo totale dei<br />
PD<br />
Numero fr. % %<br />
2014 30 173 622 8,13 0,01<br />
2015 35 190 718 6,20 0,01<br />
Fonte: UFAG<br />
Inoltre, almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda deve essere svolto<br />
con manodopera propria dell'azienda. Le aziende gestite con manodopera prevalentemente<br />
esterna non ricevono pagamenti diretti.<br />
Delle 51 939 (2014: 52 838) aziende attive tutto l'anno, al di sopra del limite di rilevazione<br />
federale e registrate in AGIS nel 2015, 46 811 (2014: 47 600) hanno ricevuto pagamenti diretti.<br />
Le considerazioni precedenti di riferiscono alle condizioni poste alle aziende attive tutto<br />
l'anno. Per ottenere pagamenti diretti nella regione d'estivazione il gestore deve gestire<br />
l'azienda d'estivazione per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e avere domicilio<br />
in Svizzera (cfr. art. 10 OPD). Devono altresì essere adempiute le esigenze in materia di<br />
gestione dell'azienda (cfr. art. 26-34 OPD e la sezione del presente rapporto sulle aziende<br />
d'estivazione).<br />
Daniel Meyer, UFAG, Settore Pagamenti diretti Basi, daniel.meyer@blw.admin.ch<br />
196<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 59 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Esecuzione<br />
Controlli<br />
La pianificazione, l'esecuzione e la documentazione dei controlli nelle aziende agricole sono<br />
di competenza dei Cantoni (cfr. art. 104 OPD). Essi possono delegare determinati controlli a<br />
organizzazioni di diritto privato a condizione che le verifichino per campionatura.<br />
Conformemente all'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC),<br />
ogni azienda va controllata a cadenza almeno quadriennale, onde appurare se osserva le prescrizioni<br />
per beneficiare dei pagamenti diretti. Una parte considerevole di tali prescrizioni è<br />
rappresentata dalla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER). In deroga a tale<br />
principio, per i programmi «Qualità del paesaggio» e «Biodiversità, livello qualitativo II» si applica<br />
una frequenza di 8 anni. Anche nelle aziende d'estivazione e in quelle con pascoli comunitari<br />
vanno eseguiti controlli ogni 8 anni, al fine di appurare se sono adempiute le prescrizioni<br />
in materia di gestione. Oltre a queste frequenze minime per i cosiddetti controlli di base, vanno<br />
effettuati controlli supplementari in funzione dei rischi presenti nelle singole aziende nonché<br />
controlli aleatori su campione. A tal fine sono stati definiti punti di controllo standardizzati che<br />
si fondano sulle esigenze delle pertinenti ordinanze. Anche le riduzioni dei pagamenti diretti<br />
sono disciplinate, segnatamente nell'OPD. Le aziende vengono quindi controllate su tutto il<br />
territorio nazionale applicando gli stessi principi e in caso di lacune vengono irrogate sanzioni,<br />
applicando riduzioni dei pagamenti diretti uguali per tutte.<br />
In virtù dell'OCoC, I Cantoni sono tenuti a coordinare i controlli in ambito veterinario e in quello<br />
della protezione delle acque con i controlli prescritti nel settore agricolo. L'obiettivo è che ogni<br />
azienda non venga sottoposta a più di un controllo di base l'anno. Le aziende in cui sono state<br />
riscontrate lacune, invece, presentano un rischio più elevato e di conseguenza possono venir<br />
controllate con maggiore frequenza.<br />
In caso di mancato adempimento delle prescrizioni determinanti per i pagamenti diretti, i Cantoni<br />
riducono i contributi come stabilito nell'OPD. Nel 2015, complessivamente 46 800 aziende<br />
agricole hanno ricevuto pagamenti diretti. Nell'11 per cento di esse i servizi di controllo hanno<br />
riscontrato lacune, che hanno comportato riduzioni dei pagamenti diretti per un importo totale<br />
di 6,2 milioni di franchi circa.<br />
Autorizzazioni speciali nel settore della protezione fitosanitaria<br />
Nell'ambito della PER l'impiego di prodotti fitosanitari è sottoposto a determinate restrizioni.<br />
In circostanze particolari e in casi motivati, gli agricoltori possono richiedere<br />
un'autorizzazione speciale ai sensi del numero 6.4 dell'allegato OPD presso il servizio fitosanitario<br />
cantonale per poter trattare le colture con prodotti fitosanitari supplementari. Nel 2015<br />
ne sono state rilasciate 2570 per circa 9 184 ettari di superficie agricola utile, registrando un<br />
aumento relativamente sensibile. Ciò è riconducibile da un lato alle condizioni meteorologiche<br />
(lungo periodo caldo in autunno) che in alcune situazioni ha reso indispensabile una lotta tardiva<br />
alle malerbe. Dall’altro sono stati autorizzati nuovi prodotti (p.es. contro gli elateridi nella<br />
coltivazione di patate) e altri sono stati ritirati (p.es. la concia delle sementi, in parte sostituita<br />
da applicazioni tramite irroratrici). I prodotti previsti a tal scopo possono tuttavia essere<br />
utilizzati soltanto previa autorizzazione speciale e questo spiega in parte il numero elevato di<br />
rilasci nel 2015.<br />
In frutticoltura e in viticoltura è stato in parte necessario proteggere i raccolti anche contro il<br />
parassita drosofila del ciliegio (Drosophila suzukii). La forte infestazione è stata anche causata<br />
da condizioni meteorologiche particolari. Nelle regioni colpite sono state rilasciate autorizzazioni<br />
speciali regionali.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
197
Il mio Rapporto agricolo 60 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Autorizzazioni speciali rilasciate nel settore fitosanitario 2015<br />
Totale Autorizzazioni Superficie<br />
Categoria Numero di aziende % delle aziende con<br />
autorizzazioni speciali<br />
ha<br />
% della superficie interessata<br />
Applicazione di prodotti<br />
fitosanitari<br />
durante il periodo<br />
di divieto di trattamento<br />
vigente<br />
d'inverno<br />
Impiego di granulati<br />
insetticidi e nematocidi<br />
Cereali: lotta contro<br />
la criocera del frumento<br />
Patate: lotta contro<br />
la dorifora<br />
Leguminose, girasole,<br />
tabacco: lotta<br />
contro gli afidi<br />
Lotta contro altri<br />
organismi nocivi in<br />
campicoltura<br />
Terreni permanentemente<br />
inerbiti:<br />
trattamento delle superfici<br />
Applicazione di erbicidi<br />
totali<br />
261 10,16 1 085,15 11,82<br />
335 13,04 1 302,82 14,19<br />
113 4,40 556,34 6,06<br />
168 6,54 815,49 8,88<br />
33 1,28 114,91 1,25<br />
1 263 49,14 4 484,7 48,83<br />
62 2,41 252,72 2,75<br />
247 9,61 456,36 4,97<br />
Orticoltura 0 0,00 0 0,0<br />
Frutticoltura 68 2,65 99,41 1,08<br />
Vitivinicoltura 20 0,78 16,06 0,17<br />
Totale 2 570 100,00 9 183,96 100,00<br />
Peter Zbinden, UFAG, Settore Pagamenti diretti Programmi, peter.zbinden@blw.admin.ch<br />
Laurent Nyffenegger, UFAG, Settore Pagamenti diretti Programmi<br />
laurent.nyffenegger@blw.admin.ch<br />
198<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 61 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Contributi per il paesaggio rurale<br />
Mediante i contributi per il paesaggio rurale viene promossa la preservazione dell’apertura di<br />
tale paesaggio. Sono finalizzati a garantire una gestione globale delle superfici agricole e alpestri<br />
onde impedire l’avanzamento del bosco, segnatamente in regioni e zone caratterizzate<br />
da difficoltà climatiche o topografiche. Un paesaggio rurale aperto funge da base per la fornitura<br />
delle altre prestazioni d’interesse generale.<br />
I contributi per il paesaggio rurale si compongono di sei contributi parziali:<br />
• contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio,<br />
• contributo di declività,<br />
• contributo per le zone in forte pendenza,<br />
• contributo di declività per i vigneti,<br />
• contributo di alpeggio,<br />
• contributo d’estivazione.<br />
Il 76 per cento dei contributi per il paesaggio rurale è versato ad aziende attive tutto l'anno,<br />
sotto forma di contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio, contributo di declività,<br />
contributo per le zone in forte pendenza, contributo di declività per i vigneti e contributo<br />
di alpeggio. Il restante 24 per cento dei contributi per il paesaggio rurale è versato ad aziende<br />
d'estivazione sotto forma di contributo d'estivazione.<br />
Contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio<br />
Il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio è graduato secondo la zona al<br />
fine di tenere adeguatamente conto delle difficoltà di gestione nelle zone ad altitudine più elevata.<br />
Per difficoltà di gestione si intendono, in particolare, il periodo di vegetazione più breve a<br />
causa delle condizioni climatiche, le vie di comunicazione e l'accesso (dal villaggio o dal centro<br />
più vicino) nonché la conformazione del terreno. Poiché nella regione di pianura l'apertura<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
199
Il mio Rapporto agricolo 62 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
del paesaggio è garantita senza contributi, non viene versato alcun contributo specifico. Nella<br />
regione di montagna e in quella collinare viene corrisposto un contributo per ettaro crescente<br />
in funzione delle zone.<br />
Aliquote del contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio 2015<br />
Zona<br />
fr./ha<br />
Zona di pianura 0<br />
Zona collinare 100<br />
Zona di montagna I 230<br />
Zona di montagna II 320<br />
Zona di montagna III 380<br />
Zona di montagna IV 390<br />
Contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio 2015<br />
Caratteristica Unità Regione di pianurtagna<br />
Regione collinare Regione di mon-<br />
Totale<br />
Superficie ha 22 517 237 311 282 584 542 412<br />
Azienda Numero 4 272 12 836 14 052 31 160<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
Contributo per<br />
azienda<br />
ha 5,27 18,49 20,11 17,41<br />
fr. 808 3 106 6 938 4 519<br />
Totale contributi 1 000 fr. 3 453 39 863 97 499 140 815<br />
Fonte: UFAG<br />
Anche le aziende nella regione di pianura ricevono un contributo per la preservazione<br />
dell'apertura del paesaggio se gestiscono superfici nella regione collinare o in quella di montagna.<br />
Visto che la porzione principale delle loro superfici è situata nella regione di pianura,<br />
queste aziende ricevono comunque un contributo più basso rispetto alle aziende che gestiscono<br />
superfici situate prevalentemente nella regione di montagna.<br />
Contributi di declività<br />
Mediante i contributi di declività vengono compensate le difficoltà connesse alla gestione delle<br />
superfici nelle zone declive delle regioni di collina e di montagna. Tali contributi sono versati<br />
soltanto per prati, terreni da strame, superfici coltive e colture perenni. I prati devono essere<br />
falciati almeno una volta l’anno mentre i terreni da strame a intervalli da uno a tre anni. Le<br />
zone declive sono suddivise in due categorie.<br />
Dal 2017 i contributi di declività saranno stanziati anche nella zona di pianura e verrà introdotto<br />
un terzo livello di declività per le superfici in forte pendenza con una declività superiore<br />
al 50 per cento, in funzione del quale saranno erogati contributi più alti. Il nuovo livello di declività<br />
consentirà di preservare l'apertura di queste superfici particolarmente minacciate sostenendone<br />
meglio la gestione.<br />
200<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 63 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Aliquote del contributo di declività 2015<br />
Terreno declivo<br />
fr./ha<br />
Declività 18-35 % 410<br />
Declività > 35 % 700<br />
Contributo di declività 2015<br />
Caratteristica Unità Regione di pianura<br />
Superfici aventi<br />
diritto al contributo<br />
con:<br />
- declività<br />
18-35% (in ha)<br />
- declività >35%<br />
(in ha)<br />
Regione collinare<br />
Regione di montagna<br />
Totale<br />
ha 5 107 58 970 69 171 133 247<br />
ha 1 584 16 590 58 230 76 404<br />
Totale ha 6 690 75 560 127 401 209 652<br />
Numero di aziende<br />
Contributo per<br />
azienda (in fr.)<br />
Numero 2 337 11 662 13 325 27 324<br />
fr. 1 370 3 069 5 187 3 957<br />
Totale contributi 1 000 fr. 3 202 35 791 69 121 108 114<br />
Fonte: UFAG<br />
Dei 210 000 ettari di SAU di superfici declive, quasi 2/3 rientrano nella categoria con declività<br />
del 18-35 per cento. L’estensione delle superfici notificate è anche dovuta alle condizioni meteorologiche<br />
che incidono sul tipo di gestione (più o meno pascoli o prati da sfalcio).<br />
Contributo per le zone in forte pendenza<br />
Il contributo per le zone in forte pendenza è erogato alle aziende con una quota elevata di<br />
superfici scoscese. Tiene conto del dispendio aggiuntivo per le aziende, risultante dalla gestione<br />
di prati da sfalcio in forte pendenza (spandimento del concime aziendale, sfalcio più frequente).<br />
Aumenta linearmente in funzione della quota di zone in forte pendenza rispetto alla<br />
superficie aziendale. La soglia minima per beneficiare dei contributi è una quota del 30 per<br />
cento di superfici declive.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
201
Il mio Rapporto agricolo 64 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Aliquote del contributo per le superfici in forte pendenza* 2015<br />
Quota di superficie con contributo di declività con declività<br />
>35 % rispetto alla SAU<br />
avente diritto al contributo<br />
fr./ha<br />
30 % 100<br />
40 % 229<br />
50 % 357<br />
60 % 486<br />
70 % 614<br />
80 % 743<br />
90 % 871<br />
100 % 1 000<br />
* Le aliquote sono indicate per quote crescenti di volta in volta del 10 per cento. Comunque aumentano costantemente<br />
in funzione della quota delle superfici con declività >35 per cento.<br />
Contributo per le zone in forte pendenza 2015<br />
Caratteristica Unità Regione di pianura<br />
Superfici aventi<br />
diritto a contributi<br />
(declività<br />
>35%)<br />
Numero di aziende<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
Contributo per<br />
azienda (in fr.)<br />
Regione collinare<br />
Regione di montagna<br />
Totale<br />
ha 45 3 313 35 091 38 448<br />
Numero 10 706 4 769 5 485<br />
ha 4,47 4,69 7,36 7,01<br />
fr. 623 1 286 2 630 2 453<br />
Totale contributi 1 000 fr. 6 908 12 540 13 454<br />
Fonte: UFAG<br />
I fondi dei contributi per le zone in forte pendenza vanno a beneficio soprattutto della regione<br />
di montagna. Il 65 per cento va ad aziende con superfici inferiori a 20 ettari.<br />
Contributo di declività per i vigneti<br />
Mediante questi contributi s’intende conservare i vigneti situati nelle zone in forte pendenza<br />
e terrazzate. Per tenere conto delle condizioni dei vigneti degni di essere sostenuti finanziariamente,<br />
si distingue tra vigneti in pendenza e in forte pendenza da un lato e vigneti terrazzati<br />
sorretti da muri di sostegno dall’altro. I contributi per i vigneti in zone in forte pendenza e<br />
terrazzate vengono concessi soltanto a favore delle superfici con una declività di almeno il 30<br />
per cento. Le aliquote di contribuzione non sono stabilite in base alle zone.<br />
202<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 65 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Aliquote del contributo di declività per i vigneti 2015<br />
Terreno declivo<br />
fr./ha<br />
Declività 30-50% 1 500<br />
Declività > 50% 3 000<br />
Zone terrazzate declività > 30% 5 000<br />
Contributi di declività per i vigneti 2015<br />
Unità<br />
Totale delle superfici aventi diritti a<br />
contributi<br />
Zone in forte pendenza declività<br />
30-50 %<br />
Zone in forte pendenza declività > 50<br />
%<br />
ha 3 920<br />
ha 1 969<br />
ha 381<br />
Zone terrazzate ha 1 569<br />
Numero di aziende numero 2 375<br />
Superficie per azienda ha 1,65<br />
Contributo per azienda fr. 5 029<br />
Totale contributi 1 000 fr. 11 945<br />
Fonte: UFAG<br />
La quota di vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate aventi diritto ai contributi corrisponde<br />
al 30 per cento circa della superficie vitata totale. Meno del 10 per cento di queste superfici è in<br />
zone in forte pendenza con declività superiore al 50 per cento, mentre il 40 per cento si trova<br />
in zone terrazzate, per un totale di 1 569 ettari.<br />
Contributo d'alpeggio<br />
Per la gestione e la cura dei pascoli d'estivazione, le aziende d'estivazione devono poter contare<br />
su un numero sufficiente di animali. Il contributo d'alpeggio incentiva le aziende annuali<br />
a estivare i propri animali e viene loro versato direttamente per carico normale (CN) estivato.<br />
Il contributo d'alpeggio, introdotto nel 2014, mira in maniera più diretta all'obiettivo di un<br />
carico adeguato della regione d'estivazione rispetto alla promozione indiretta con i contributi<br />
riferiti agli animali (supplemento d'estivazione).<br />
Aliquote del contributo d'alpeggio 2015<br />
fr./CN<br />
Contributo d'alpeggio 370<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
203
Il mio Rapporto agricolo 66 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Contributo d'alpeggio 2015<br />
Unità<br />
Regione di<br />
pianura<br />
Regione<br />
collinare<br />
Regione di<br />
montagna<br />
Totale<br />
Carico normale CN 51 455 65 276 174 427 291 158<br />
Numero di aziende<br />
Numero 5 060 5 834 10 595 21 489<br />
CN per azienda CN 10,17 11,19 16,46 13,55<br />
Contributo per<br />
azienda<br />
fr. 3 762 4 140 6 091 5 013<br />
Totale contributi 1 000 fr. 19 038 24 152 64 538 107 728<br />
Fonte: UFAG<br />
I CN destinati all’estivazione provenienti dalla regione di montagna sono quasi il quadruplo<br />
di quelli originari della regione di pianura. Le aziende nella regione di montagna estivano il<br />
maggior numero di animali per azienda, pari a 16,46 CN.<br />
» A56<br />
La tabella seguente riporta i contributi versati per zona agricola e Cantone.<br />
Contributo d'estivazione<br />
Mediante il contributo d’estivazione s’intende garantire la gestione e la cura dei vasti pascoli<br />
d’estivazione nelle Alpi, nelle Prealpi e nel Giura. La regione d’estivazione viene gestita e curata<br />
con circa 300 000 CN. Il carico di bestiame viene definito secondo i principi di una gestione<br />
sostenibile ed è indicato come carico usuale. Sulla base del carico usuale sono versati i contributi<br />
per CN. Per CN s’intende l’estivazione di un’unità di bestiame grosso (UBG) durante 100<br />
giorni (cfr. capitolo sulle aziende d'estivazione nel presente Rapporto agricolo).<br />
Aliquote del contributo d’estivazione 2015<br />
Categoria di animali<br />
Vacche munte, pecore lattifere e capre lattifere con una<br />
durata tradizionale d'estivazione<br />
di 56-100 giorni, per UBG<br />
fr.<br />
400<br />
Ovini, senza le pecore lattifere, per CN<br />
per gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da<br />
rotazione con provvedimenti<br />
di protezione del gregge<br />
400<br />
per pascoli da rotazione 320<br />
per altri pascoli 120<br />
Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo,<br />
per CN<br />
400<br />
204<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 67 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Contributo d’estivazione 2015<br />
Categoria di animali Parametro Contributi Aziende UBG o CN<br />
Unità 1 000 fr. Numero Numero<br />
Vacche munte, pecore<br />
lattifere e capre<br />
lattifere con una durata<br />
tradizionale<br />
d'estivazione di<br />
56-100 giorni, UBG<br />
Ovini, senza le pecore<br />
lattifere, CN<br />
Altri animali da reddito<br />
che consumano<br />
foraggio grezzo, CN<br />
12 844 900 32 277<br />
6 486 774 20 874<br />
102 979 6 276 258 255<br />
Totale 122 309 6 745<br />
Fonte: UFAG<br />
Le incoerenze tra la presente tabella e quella seguente sono dovute al fatto che per 4 aziende sono stati forniti dati<br />
errati.<br />
Contributo d'estivazione per l'estivazione di ovini secondo il sistema di pascolo 2015<br />
Sistema di pascolo Parametro Azienda Animali con contributi<br />
Contributi<br />
Unità Numero CN 1 000 fr.<br />
Sorveglianza permanente<br />
163 11 720 4 674<br />
Pascoli da rotazione 189 3 495 1 119<br />
Altri pascoli 428 5 660 677<br />
Totale 772 20 876 6 470<br />
Fonte: UFAG<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
205
Il mio Rapporto agricolo 68 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Evoluzione dell'estivazione 2013–2015<br />
Categoria di animali Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015<br />
Vacche da latte Azienda 3 873 4 735 4 741<br />
CN 97 964 107 205 109 640<br />
Vacche madri e nutrici<br />
e altre vacche<br />
Azienda 2 578 3 322 3 104<br />
CN 35 608 42 064 43 381<br />
Altri bovini Azienda 6 061 6 175 6 167<br />
CN 112 340 118 533 119 567<br />
Animali della specie<br />
equina<br />
Azienda 923 917 873<br />
CN 4 393 4 396 4 273<br />
Ovini Azienda 926 904 902<br />
CN 23 378 23 191 24 095<br />
Caprini Azienda 1 347 1 331 1 331<br />
CN 5 971 5 856 5 969<br />
Altri animali estivati Azienda 228 346 437<br />
CN 533 750 1 140<br />
Fonte: UFAG<br />
» A57<br />
» A58<br />
» A59<br />
Contributi d’estivazione per Cantone e categoria di animali<br />
Statistica sull’estivazione: aziende e carichi normali per Cantone<br />
Pagamenti diretti alle aziende d’estivazione per Cantone<br />
Jonas Plattner, UFAG, Settore Pagamenti diretti Basi, jonas.plattner@blw.admin.ch<br />
Denis Morand, UFAG, Settore Pagamenti diretti Basi, denis.morand@blw.admin.ch<br />
206<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 73 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento<br />
Mediante i contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento s’intende mantenere la capacità<br />
produttiva per far fronte a crisi di approvvigionamento. Ciò è fondamentale per riuscire a<br />
garantire l'approvvigionamento della popolazione in caso di crisi a medio e lungo termine. La<br />
capacità produttiva (suolo, know-how, capitale) può essere salvaguardata mediante una produzione<br />
nell’ordine di grandezza attuale e utilizzando in modo possibilmente ottimale le risorse<br />
naturali. Come sancito dalla Costituzione, la produzione deve innanzitutto adeguarsi alle<br />
esigenze del mercato ed essere pilotata il meno possibile.<br />
Vanno promosse la produzione sulla superficie coltiva aperta e le colture perenni così come la<br />
produzione sulla superficie inerbita, considerato che oltre il 60 per cento della superficie agricola<br />
utile (SAU) della Svizzera non può essere utilizzato per la campicoltura, bensì soltanto per<br />
la produzione di foraggio grezzo. I foraggi prodotti su queste superfici vengono trasformati<br />
in derrate per l’alimentazione umana mediante la detenzione di animali da reddito che consumano<br />
foraggio grezzo. Per il versamento di contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento<br />
a favore della superficie inerbita è richiesta una densità minima di animali da reddito che consumano<br />
foraggio grezzo (UBGFG).<br />
I contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento si compongono di tre contributi parziali:<br />
• contributo di base,<br />
• contributo per le difficoltà di produzione,<br />
• contributo per le superfici coltive aperte e le colture perenni.<br />
La maggior parte dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento viene versata attraverso<br />
il contributo di base (75 %). Il resto è ripartito tra il contributo per le difficoltà di produzione<br />
(15 %) e quello per le superfici coltive aperte e le colture perenni (10 %).<br />
Contributo di base<br />
Il contributo di base induce a ottimizzare l’intensità della produzione nella zona di pianura<br />
e a mantenere quindi la capacità produttiva. L'importo è uguale in tutte le zone. Non vi è al-<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
207
Il mio Rapporto agricolo 74 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
cuna differenziazione tra superficie inerbita e superficie coltiva. Dato che le superfici inerbite<br />
estensive e poco intensive presentano un rendimento inferiore e che anche la densità minima<br />
di animali richiesta è più bassa, il contributo di base erogato a loro favore ammonta alla metà<br />
di quello versato per le superfici produttive.<br />
Aliquote del contributo di base 2015<br />
fr./ha<br />
Superfici permanentemente inerbite gestite come superfici<br />
per la promozione della biodiversità<br />
450<br />
Altra superficie che dà diritto ai contributi 900<br />
Contributo di base 2015<br />
Unità<br />
Regione di<br />
pianura<br />
Regione<br />
collinare<br />
Regione di<br />
montagna<br />
Totale<br />
Superficie ha 466 223 251 022 282 551 999 797<br />
- di cui SPB ha 46 878 28 299 67 102 142 279<br />
Numero di aziende<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
Contributo per<br />
azienda<br />
Numero 19 681 12 782 14 019 46 482<br />
ha 24 20 20 22<br />
fr. 19 705 16 463 15 873 17 658<br />
Totale contributi 1 000 fr. 387 823 210 428 222 521 820 772<br />
Fonte: UFAG<br />
La quota di superfici per la promozione della biodiversità (SPB), a favore delle quali vengono<br />
stanziati contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento più bassi, è più alta nella regione<br />
collinare e in quella di montagna rispetto alla regione di pianura. Inoltre, le aziende nella regione<br />
di pianura sono in media le più grandi (24 ha), quelle nella regione collinare le più piccole<br />
(20 ha), anche se la differenza rispetto a quelle di montagna (in media 20 ha) è minima.<br />
Per questi motivi (quota SPB e superficie per azienda), il contributo medio per azienda registra<br />
il valore più alto, ovvero 19 705 franchi, nella regione di pianura e quello più basso, ovvero 15<br />
873, nella regione di montagna. Il contributo versato nella regione collinare si situa a metà tra<br />
questi due valori ed è pari a 16 463 franchi.<br />
Il contributo di base per le aziende con una superficie superiore a 60 ettari viene graduato,<br />
ovvero per la quota di aziende con superfici superiori a 60 ettari e inferiori a 140 ettari il contributo<br />
viene ridotto. Se la superficie supera 140 ettari, il contributo di base decade. Nel caso<br />
delle comunità aziendali, i limiti per la graduazione sono moltiplicati per il numero di aziende<br />
associate.<br />
208<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 75 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Riduzioni applicate a causa delle graduazioni del contributo di base per le aziende più<br />
grandi 2015<br />
Superficie Aziende Riduzioni Riduzione per azienda<br />
Unità Numero fr. fr.<br />
Oltre 60–80 ha 686 837 595 1 221<br />
Oltre 80–100 ha 147 854 497 5 813<br />
Oltre 100–120 ha 46 614 470 13 358<br />
Oltre 120–140 ha 28 454 007 16 215<br />
Oltre 140 ha 21 1 001 456 47 688<br />
Totale 928 3 762 025 4 054<br />
Fonte: UFAG<br />
Le riduzioni del contributo di base interessano 928 aziende e ammontano complessivamente<br />
a 3 762 025 franchi. In 21 aziende con contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento la<br />
superficie era superiore a 140 ettari. Solo in queste aziende le riduzioni del contributo di base<br />
sono state pari a 1 milione di franchi.<br />
Contributo per le difficoltà di produzione<br />
Visto che neanche la metà della SAU è ubicata nella zona di pianura, per garantire la sicurezza<br />
dell’approvvigionamento anche la regione di montagna e quella collinare devono fornire un<br />
contributo sostanziale. Gran parte della SAU di tali zone può essere gestita soltanto come superficie<br />
inerbita e ciò limita considerevolmente le possibilità di scelta delle aziende. Occorre<br />
pertanto tener adeguatamente conto delle difficoltà di produzione nelle zone ad altitudine più<br />
elevata. Il contributo per le difficoltà di produzione è graduato in base alla zona. L’importo<br />
dei contributi tiene conto delle difficoltà di gestione e del minore rendimento riscontrabili nel<br />
quadro di un’utilizzazione adeguata al luogo rispetto alla zona di pianura.<br />
Aliquote del contributo per le difficoltà di produzione 2015<br />
Zona<br />
fr./ha<br />
Zona di pianura 0<br />
Zona collinare 240<br />
Zona di montagna I 300<br />
Zona di montagna II 320<br />
Zona di montagna III 340<br />
Zona di montagna IV 360<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
209
Il mio Rapporto agricolo 76 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Contributo per le difficoltà di produzione 2015<br />
Unità<br />
Regione di<br />
pianura<br />
Regione<br />
collinare<br />
Regione di<br />
montagna<br />
Totale<br />
Superficie ha 22 149 234 988 278 299 535 435<br />
Numero di aziende<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
Contributo per<br />
azienda<br />
Numero 4 139 12 776 14 013 30 928<br />
ha 5,35 18,39 19,86 17,31<br />
fr. 1 372 4 918 6 564 5 189<br />
Totale contributi 1 000 fr. 5 677 62 829 91 979 160 485<br />
Fonte: UFAG<br />
Anche le aziende nella regione di pianura ricevono un contributo per le difficoltà di produzione<br />
se gestiscono superfici nella regione collinare o in quella di montagna. L'importo del contributo<br />
per le difficoltà di produzione per azienda sale con l'aumentare delle difficoltà; nella regione<br />
di pianura ammonta a 1372 franchi, in quella collinare a 4918 e in quella di montagna<br />
a 6564 franchi.<br />
Contributo per le superfici coltive aperte e le colture perenni<br />
Sulle superfici coltive aperte la produzione di calorie è più elevata rispetto a quella sulle superfici<br />
inerbite. Per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento è quindi fondamentale mantenere<br />
pressoché sul livello attuale il volume di produzione nei settori della campicoltura e delle<br />
colture perenni. Il contributo alle superfici coltive aperte e alle colture perenni è identico in<br />
tutte le zone (400 fr./ha) e viene versato anche per le superfici situate nel territorio estero<br />
della zona di confine coltivate per tradizione familiare (cfr. art. 35 cpv. 5 OPD). Si applicano le<br />
medesime condizioni valide per il contributo di base, ma l’esigenza relativa alla densità minima<br />
di animali è superflua.<br />
Aliquote del contributo per le superfici coltive aperte e le colture perenni 2015<br />
fr./ha<br />
Contributo per le superfici coltive aperte e le colture perenni<br />
400<br />
Contributo per le superfici coltive aperte e le colture perenni 2015<br />
Unità<br />
Regione di<br />
pianura<br />
Regione<br />
collinare<br />
Regione di<br />
montagna<br />
Totale<br />
Superficie ha 234 492 41 718 4 475 280 685<br />
Numero di aziende<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
Contributo per<br />
azienda<br />
Numero 17 941 7 730 2 363 28 034<br />
ha 13,07 5,40 1,89 10,01<br />
fr. 5 228 2 159 758 4 005<br />
Totale contributi 1 000 fr. 93 797 16 687 1 790 112 274<br />
Fonte: UFAG<br />
Le superfici coltive e le colture perenni si trovano soprattutto nella regione di pianura e in<br />
quella collinare e ciò si rispecchia anche nella superficie per azienda. Perciò, in queste regioni,<br />
210<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 77 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
e soprattutto in quella di pianura, si registra l'importo più elevato del contributo, pari a 5228<br />
franchi per azienda.<br />
» A60<br />
La seguente tabella riporta nel dettaglio i dati sui contributi per la sicurezza<br />
dell'approvvigionamento versati, secondo i tre tipi di contributi, suddivisi per Cantone e zona<br />
agricola.<br />
Jonas Plattner, UFAG, Settore Pagamenti diretti Basi, jonas.plattner@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
211
Il mio Rapporto agricolo 79 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Contributi per la qualità del paesaggio<br />
Obiettivo della misura<br />
La cura del paesaggio rurale finora è stata promossa tramite il versamento di pagamenti diretti<br />
soltanto con l'obiettivo di preservare l'apertura del paesaggio (contributi di declività, contributi<br />
d'estivazione) o la diversità degli spazi vitali (contributi per l'interconnessione). Non è<br />
stato quindi possibile prendere in considerazione gli interessi regionali e i valori culturali del<br />
paesaggio, come ad esempio il mantenimento dei pascoli boschivi, la cura di selve castanili o la<br />
promozione della campicoltura di montagna. Queste lacune sono colmate dai contributi per la<br />
qualità del paesaggio introdotti con la Politica agricola 2014-2017 (PA 14-17). Questo nuovo<br />
strumento consente la promozione mirata della varietà del paesaggio in Svizzera. I contributi<br />
per la qualità del paesaggio (CQP) sono assegnati sulla base di progetti. In tal modo, i Cantoni<br />
mantengono un margine di manovra che consente loro di tener conto delle esigenze regionali.<br />
Le varie regioni della Svizzera racchiudono paesaggi rurali tradizionali che ne riflettono<br />
l'immagine caratteristica. I tradizionali pascoli delle Prealpi, ad esempio, si presentano in<br />
modo tutt’altro che uniforme nonostante le condizioni naturali lo siano. Dal Pays d’Enhaut<br />
all’Appenzellerland il paesaggio è forgiato dalle forme tradizionali di gestione.<br />
I paesaggi rurali attrattivi si distinguono per la loro varietà, che per la società riveste<br />
un'enorme valenza in quanto, oltre alle funzioni ecologiche, ne svolge molte altre dal profilo<br />
socioeconomico. Nelle regioni a vocazione turistica e negli agglomerati, l'agricoltura contribuisce<br />
in modo considerevole alla cura del paesaggio rurale. In queste regioni i paesaggi rurali<br />
curati sono spazi ricreativi che rappresentano un importante fattore per la competitività di una<br />
località. La popolazione che vive negli agglomerati usa questi spazi rurali vicini per numerose<br />
attività, ad esempio per passeggiate a piedi, in bicicletta o a cavallo. I paesaggi rurali curati<br />
nelle regioni montane e alpine sono un capitale determinante per il turismo svizzero, danno<br />
un'identità a una regione e forniscono un importante contributo nella commercializzazione<br />
di prodotti regionali. Nel pubblicizzare i prodotti regionali, ad esempio, si fa molto spesso un<br />
riferimento diretto al paesaggio in cui essi sono ottenuti.<br />
Il cambiamento strutturale nel settore agricolo, però, genera uno sviluppo bipolare del paesaggio:<br />
nelle regioni più favorite la gestione viene intensivata, mentre le superfici declive, discoste<br />
e difficilmente gestibili vengono abbandonate. Questa evoluzione ha un impatto negativo<br />
sulla varietà del paesaggio, che diminuisce sia in caso di abbandono della gestione (avanzamento<br />
delle sterpaglie e del bosco), sia in caso di intensivazione (taglio di singoli alberi, ingrandimento<br />
dei campi). La varietà del paesaggio è un bene pubblico, che viene promosso<br />
attraverso i pagamenti diretti segnatamente con i CQP volti a salvaguardare, promuovere e sviluppare<br />
paesaggi rurali variati con le loro peculiarità regionali specifiche. Per questo il contributo<br />
dell'agricoltura a favore della cura del paesaggio si orienta verso esigenze regionali.<br />
Gli obiettivi paesaggistici e il contributo dell'agricoltura per raggiungere l'obiettivo vengono<br />
fissati a livello locale e non prestabiliti dalla Confederazione, la quale, però, ha il compito di<br />
controllarli. Le risposte a domande come «Quali sono le qualità del nostro paesaggio?», «Che<br />
cosa è caratteristico e meritevole di essere tutelato nella nostra regione?», «Cosa è scomparso<br />
e vogliamo promuovere?» devono essere trovate a livello regionale. Alla preservazione e alla<br />
cura di elementi esistenti nonché alla creazione di nuovi elementi paesaggistici è garantito un<br />
sostegno sotto forma di contributo annuale o singolo.<br />
Dall'elaborazione alla realizzazione di progetti per la qualità del paesaggio<br />
I CQP sono pagamenti diretti regionali e vincolati a progetti. Un promotore regionale o il<br />
Cantone elabora un progetto per la qualità del paesaggio che interessa un determinato comprensorio<br />
(vallata, parco naturale, distretto, ecc.) coinvolgendo gli agricoltori. Innanzitutto<br />
212<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 80 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
si fissano gli obiettivi paesaggistici per il comprensorio del progetto. A tal fine si possono utilizzare<br />
le molte basi a disposizione (p.es. piani di sviluppo del paesaggio, fascicoli relativi ai<br />
parchi nazionali regionali). Successivamente si stabiliscono le misure finalizzate agli obiettivi<br />
paesaggistici regionali che chiamano in causa il primario. I Cantoni propongono aliquote di<br />
contribuzione, che tengono conto del dispendio generato dalle misure e che possono prevedere<br />
anche un bonus quale incentivo per la fornitura delle prestazioni. Anche la realizzazione<br />
dei progetti QP rientra nella sfera di competenze dei Cantoni. Questi finanziano il 10 per cento<br />
dei contributi e concludono con le aziende accordi di gestione della durata di otto anni. La Confederazione<br />
autorizza i progetti. Ne appura la coerenza, elimina potenziali conflitti di obiettivi<br />
e respinge le misure che non hanno un legame diretto con la produzione agricola.<br />
Per ogni progetto il Cantone ha a disposizione al massimo 360 franchi per ettaro di superficie<br />
agricola utile (SAU) o 240 franchi per carico normale (CN) dell'azienda con accordi di gestione.<br />
In base all’impostazione del contratto (numero di provvedimenti, spese), variano i contributi<br />
per la qualità del paesaggio erogati per azienda. Per i mezzi finanziari della Confederazione che<br />
sono stati ripartiti tra i Cantoni è stato fissato un limite massimo in funzione della SAU (120 fr./<br />
ha) e del carico usuale (80 fr./CN) fino al 2017, onde limitare le risorse necessarie per i progetti<br />
QP alle uscite presentate nel messaggio del Consiglio federale sulla PA 14-17 e per garantire ai<br />
Cantoni condizioni quadro stabili per lo sviluppo di progetti QP.<br />
Nel settimo e ultimo anno del contratto si valuta la realizzazione. Se non si riscontrano lacune,<br />
il progetto può entrare nel periodo di realizzazione seguente e gli accordi possono essere<br />
prorogati.<br />
Elaborazione di progetti QP: informazioni utili sul sito Internet dell'UFAG.<br />
Esempi di progetti<br />
A titolo di esempio dei 111 progetti QP attuati dal 2014, di seguito ne vengono presentati due<br />
che sono stati realizzati in contesti diversi dal profilo paesaggistico. Tutti i rapporti dei progetti<br />
QP autorizzati dall'UFAG sono pubblicati sul suo sito Internet.<br />
Valle di Binn<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
213
Il mio Rapporto agricolo 81 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
La coltivazione o il mantenimento di colture campicole e speciali (p.es. erbe montane come nella foto) percepiscono<br />
contributi QP nelle regioni in cui le colture stanno scomparendo a causa della loro valenza marginale. (© UFAG)<br />
Sugli alpi, i diversi settori di pascoli presentano una notevole eterogeneità per quanto concerne strutture, topografia<br />
o qualità del foraggio. È quindi opportuno detenere diverse specie o categorie di animali il cui comportamento<br />
al pascolo è differente. Questa filosofia è sostenuta mediante i CQP. (© UFAG)<br />
214<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 82 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Nel progetto QP della Valle di Binn, ogni anno si procede a uno sfalcio di pulizia dei pascoli onde evitare<br />
l'avanzamento del bosco. La cura differenziata contribuisce alla formazione di un mosaico di paesaggi. (© UFAG)<br />
Comprensorio 181 km 2<br />
Agricoltura<br />
Ente promotore<br />
51 aziende, 4190 ha SAU<br />
964 CN<br />
Parco paesaggistico della Valle di Binn<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
215
Il mio Rapporto agricolo 83 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
La Carta del parco paesaggistico della Valle di Binn è stata una valida base per l’elaborazione<br />
del progetto QP Binntal. Elaborata nel quadro di un processo partecipativo, essa comprende<br />
un’accurata descrizione degli spazi paesaggistici e della visione del paesaggio 2025, dalle quali<br />
sono scaturiti gli obiettivi del progetto QP.<br />
Il punto di forza del comprensorio è la varietà dei suoi paesaggi naturali e rurali, che gli conferisce<br />
un elevato valore ricreativo: dagli alberi da frutto ai campi, passando per le superfici<br />
inerbite ricche di strutture, sono numerosi gli elementi paesaggistici che si possono incontrare<br />
nella Valle di Binn. La regione d'estivazione è relativamente incontaminata, senza infrastrutture<br />
fisse per il turismo invernale (sci). Un tempo il tratto caratteristico del paesaggio erano i<br />
campi di cereali, oggi quasi scomparsi. Sui versanti meridionali della Valle di Binn viene ancora<br />
praticata la campicoltura di montagna.<br />
Il carico di lavoro delle aziende rimaste è elevatissimo e le superfici nelle zone periferiche<br />
nonché i terreni declivi, difficili da gestire, rischiano di essere abbandonati. Dall’altro lato,<br />
nelle località gestibili in maniera facile e intensiva le strutture paesaggistiche tipiche vengono<br />
rimosse o trascurate.<br />
Il Progetto QP Binntal mira alla conservazione del carattere paesaggistico aperto e ricco di<br />
strutture e del piccolo, variegato mosaico di utilizzazione. La preservazione dell’apertura del<br />
paesaggio è un obiettivo importante. Laddove necessario, vi è una promozione puntuale di elementi<br />
strutturali come campi e recinzioni in legno.<br />
Nel parco naturale regionale della Valle di Binn la protezione di preziosi habitat e di paesaggi<br />
particolarmente belli è legata allo sviluppo economico. Quest’obiettivo si sposa perfettamente<br />
con quelli del progetto QP: il turismo a basso impatto e l’artigianato della Valle di Binn approfittano<br />
dell’impegno profuso dagli agricoltori nella cura del paesaggio.<br />
Rapperswil-Jona / Eschenbach<br />
Un tempo le recinzioni vive erano utilizzate come strutture di demarcazione tra le singole particelle gestite a scopo<br />
agricolo oppure per garantirne la circoscrizione. Oggi sono elementi paesaggistici caratteristici e per questo motivo<br />
vengono promosse e preservate. (© UFAG)<br />
216<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 84 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Nel progetto QP Rapperswil-Jona / Eschenbach è stata delimitata una fascia larga 50 metri lungo il comprensorio urbano.<br />
Le misure messe in atto in queste regioni, che rientrano tra le aree di svago più belle, vengono così sostenute<br />
mediante un contributo supplementare. (© UFAG)<br />
Gli alberi indigeni contribuiscono alla struttura delle superfici inerbite e campicole e fungono da punti di riferimento<br />
nel paesaggio. Per questo motivo la piantagione e la cura di queste essenze sono sostenute mediante contributi QP.<br />
(© UFAG)<br />
Comprensorio<br />
Agricoltura<br />
Ente promotore<br />
86 km 2 , 2 Comuni<br />
251 aziende, 3675 ha SAU<br />
Città di Rapperswil-Jona e Comune di Eschenbach<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
217
Il mio Rapporto agricolo 85 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Il paesaggio e l’agricoltura del comprensorio del progetto sono influenzati dalle caratteristiche<br />
geomorfologiche del territorio. Tra i laghi si intravvedono campi coltivati e vigneti. Prati, pascoli,<br />
boschi e piccole conche paludose conferiscono al paesaggio il suo tipico aspetto. Piccole<br />
superfici inerbite che penetrano nel bosco e la regione d’estivazione si stagliano sul paesaggio<br />
molassico prealpino.<br />
Le peculiarità paesaggistiche del comprensorio sono le recinzioni vive e quelle di noccioli.<br />
Queste ultime, che crescono rapidamente, in altri tempi venivano piantate ai confini territoriali<br />
dei diversi proprietari e sfruttate per la legna, mentre le recinzioni vive, soprattutto di biancospino,<br />
servivano a delimitare i pascoli. Con il progetto QP si mira a restituire maggiore valenza<br />
e a conservare questi elementi storico-culturali.<br />
Un altro elemento caratteristico del paesaggio del comprensorio sono i margini boschivi,<br />
che si estendono per 535 chilometri, creando una tipica struttura compenetrante bosco-pascolo-prato.<br />
Il progetto QP Rapperswil-Jona / Eschenbach vuole conservare le tipiche strutture di piccole<br />
dimensioni mediante modalità e intensità di utilizzo adeguate. Gli elementi della varietà strutturale<br />
margini boschivi, superfici campicole, vigneti, pascoli, prati, corsi d’acqua, superfici<br />
palustri da strame, alpi e periferie degli agglomerati sono una parte importante dello spazio<br />
ricreativo multifunzionale.<br />
Nel progetto si affronta la tematica delle periferie degli agglomerati, mal integrate nel paesaggio,<br />
cercando di creare, mediante un sistema di bonus, incentivi mirati affinché in queste<br />
zone vengano mantenuti o inseriti nuovi elementi paesaggistici ben definiti.<br />
L’ente promotore prevede di promuovere mediante azioni annuali provvedimenti mirati durante<br />
la fase di attuazione. Nel 2016 ci si concentrerà, ad esempio, sulle recinzioni vive e sulle<br />
siepi. Si prevede una giornata durante la quale si spiegherà come piantare e curare le recinzioni<br />
vive. Parallelamente si svolgerà un’attività di pubbliche relazioni.<br />
Mezzi finanziari e dati statistici 2015<br />
Nel 2015 l'UFAG ha autorizzato 40 nuovi progetti QP, che, con quelli autorizzati nel 2014,<br />
portano il numero di progetti QP in corso a 111, per un totale di 125 milioni di franchi. Dal 2015<br />
in ogni Cantone si riscontra almeno un progetto QP cui possono partecipare le aziende.<br />
218<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 86 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
» A61<br />
» A62 – 63<br />
La seguente tabella funge da legenda alla tabella che figura sopra.<br />
Il seguente link rimanda a una tabella riassuntiva su tutti i dati relativi ai progetti per la qualità<br />
del paesaggio menzionati di seguito.<br />
Contributi per la qualità del paesaggio, per regione 2015<br />
Dal 2014, 31 083 aziende annuali e 3 953 aziende d'estivazione hanno concluso un accordo<br />
per provvedimenti QP. Si tratta rispettivamente del 66 e del 57 per cento delle aziende. Per le<br />
misure attuate, alle aziende partecipanti la Confederazione ha stanziato un importo medio di<br />
3 723 franchi per azienda e 149 franchi per ettaro di SAU. I contributi per ettaro di SAU sono<br />
leggermente più alti nella regione di montagna che in quelle di pianura e collinare. Per quanto<br />
riguarda alcuni progetti, i provvedimenti nella regione d'estivazione vengono attuati soltanto<br />
in un secondo momento.<br />
Contributi per la qualità del paesaggio, per regione 2015<br />
Unità<br />
Regione di<br />
pianura<br />
Regione collinare<br />
Regione di<br />
montagna<br />
Regione<br />
d'estivazione<br />
Totale<br />
Azienda/e Numero 11 731 8 841 10 523 3 941 35 036<br />
Contributo per<br />
ha¹<br />
Contributo per<br />
azienda<br />
Totale contributi<br />
Numero 136 145 172 149<br />
fr. 3 846 3 289 3 974 2 471 3 581<br />
1 000 fr. 45 122 29 080 41 534 9 740 125 476<br />
¹ Soltanto aziende gestite tutto l'anno<br />
Fonte: UFAG<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
219
Il mio Rapporto agricolo 87 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Contributi per la qualità del paesaggio, per Cantone 2015<br />
» A64<br />
In media, l'importo versato a ciascun Cantone per CQP è stato pari a 5 milioni di franchi. Visto<br />
che nel 2014 non tutti i Cantoni hanno realizzato lo stesso numero di progetti, i contributi variano<br />
notevolmente da un Cantone all'altro. Gli importi più elevati sono stati versati nei Cantoni<br />
Berna (28 mio. fr.) e Vaud (16 mio. fr.). Nel Canton Vaud è stato erogato l'importo più alto<br />
a favore della regione d’estivazione. Entrambi i Cantoni già nel primo anno hanno realizzato<br />
progetti QP su vasta scala. Nei Cantoni meno estesi, come Appenzello Interno, e in quelli che<br />
fino al 2015 avevano realizzato soltanto pochi progetti QP, come Argovia o Ticino, i CQP versati<br />
hanno raggiunto un valore decisamente inferiore.<br />
La Confederazione ha erogato un importo medio di 1 milione di franchi circa per progetto sotto<br />
forma di CQP. L'importo totale più elevato è stato stanziato per i progetti Emmental (BE) e Altipiano<br />
bernese (BE), quello più basso, invece, per i progetti Parco nazionale del Locarnese (TI)<br />
e Mendrisiotto (TI). L'ammontare dei contributi da stanziare per progetto dipende fortemente<br />
dalla superficie agricola utile e dal numero di aziende nel comprensorio del progetto nonché<br />
dalla loro partecipazione. Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati per progetto.<br />
220<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 88 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
» A65 – 66<br />
Per questa analisi (sulla partecipazione delle aziende annuali) è determinante la sede dell’azienda e non<br />
l'ubicazione della superficie gestita. Ciò significa che se il comprensorio del progetto A include molte superfici gestite<br />
da aziende con sede nel comprensorio B o C, al momento dell’analisi la loro partecipazione al progetto A sarà<br />
considerata in misura minore.<br />
» A67 – 68<br />
In media ha preso parte a un progetto QP il 51 per cento delle aziende annuali di ciascun<br />
comprensorio. La partecipazione più elevata è stata raggiunta nel quadro dei progetti Lumneza-Vals<br />
(GR) ed Entlebuch (LU) superando il 94 per cento. Nelle tabelle seguenti sono riportati<br />
maggiori informazioni sulla partecipazione delle aziende annuali e d'estivazione.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
221
Il mio Rapporto agricolo 89 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Per questi dati per azienda non viene fatta alcuna differenza tra provvedimenti annuali o unici (investimenti): gli investimenti<br />
unici di grande portata hanno un impatto notevole nella statistica di quest'anno, ma l'anno prossimo non<br />
vi figurano più.<br />
Contributi per categoria di provvedimenti attuata 2015<br />
Alcuni provvedimenti nell'area dell'azienda, come lo stoccaggio ordinato delle balle d'insilato<br />
o la cura dell'orto, sono stati oggetto di aspre critiche nei media. Da una prima analisi quantitativa<br />
dei dati del 2015 emerge che i pagamenti per provvedimenti di questo genere o simili<br />
rappresentano soltanto il 4 per cento circa dei CQP. Circa due terzi dei CQP vanno a favore della<br />
salvaguardia e della cura di strutture come alberi, siepi e muri a secco e della promozione di paesaggi<br />
campicoli e terreni inerbiti variati. Con il 16 per cento dei CQP sono stati sostenuti elementi<br />
tradizionali del paesaggio rurale come pascoli boschivi, selve castanili, terreni da fieno<br />
selvatico o fienili.<br />
Contributi per categoria di provvedimenti 2015<br />
Categoria di provvedimenti Esempi di provvedimenti Contributi Quota<br />
mio. fr. %<br />
Strutture<br />
Varietà nella campicoltura<br />
Varietà nella superficie inerbita<br />
Elementi tradizionali del<br />
paesaggio rurale<br />
Preservazione mirata<br />
dell’apertura del paesaggio,<br />
recupero di terreni<br />
Altro<br />
Area dell'azienda, valore<br />
culturale<br />
Fonte: UFAG<br />
Alberi isolati importanti,<br />
alberi da frutto ad alto<br />
fusto nei campi, siepi, muri<br />
a secco, scarpate lungo i<br />
corsi d'acqua, ecc.<br />
Avvicendamento delle colture<br />
variato, colture fiorite<br />
colorate, flora segetale dei<br />
campi, ecc.<br />
Diversi tipi di prati, coltivazione<br />
di foraggi scaglionata,<br />
strisce fiorite, strisce<br />
su superficie coltiva, ecc.<br />
Pascoli boschivi, selve castanili,<br />
terreni da fieno selvatico,<br />
campicoltura di<br />
montagna, fienili, ecc.<br />
Decespugliamento, preservazione<br />
dell'apertura<br />
del paesaggio tramite il<br />
pascolo di razze animali<br />
adatte, ecc.<br />
Varietà nei vigneti, accessibilità<br />
del paesaggio, ecc.<br />
Stoccaggio ordinato delle<br />
balle d'insilato, orti, detenzione<br />
di animali variata,<br />
pulizia ai piedi delle<br />
croci sulle strade, ecc.<br />
37,7 30 %<br />
26,6 21 %<br />
19,6 16 %<br />
20,5 16 %<br />
7,8 6 %<br />
8,1 6 %<br />
5,0 4 %<br />
Prospettiva<br />
Il mio Rapporto agricolo 90 / 222<br />
Nel 2016 saranno realizzati altri 23 progetti QP. Le uscite per i CQP aumenteranno ulteriormente.<br />
I mezzi finanziari sono tuttora assicurati grazie alla diminuzione del contributo di<br />
transizione. Inoltre, vige un limite ai CQP per Cantone. Se tutti i Cantoni raggiungessero questo<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
limite, per i CQP servirebbero fondi federali pari a circa 150 milioni di franchi. Un primo bilancio<br />
del nuovo programma verrà tratto nel 2016 nel quadro di una valutazione.<br />
Rebecca Knoth, UFAG, Settore Pagamenti diretti Programmi<br />
Matthieu Raemy, UFAG, Settore Pagamenti diretti Programmi, matthieu.raemy@blw.admin.ch<br />
222<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 99 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Contributi per la biodiversità<br />
I contributi per la biodiversità sono erogati per promuovere e preservare la naturale diversità<br />
delle specie e degli habitat. La biodiversità è la varietà della vita e consente numerosi servizi<br />
ecosistemici quali la conservazione delle risorse genetiche, la regolazione naturale dei parassiti<br />
o la creazione di uno spazio ricreativo a beneficio di tutta la società. Nei terreni agricoli,<br />
a causa della crescente meccanizzazione del lavoro e dell'intensivazione della gestione delle<br />
superfici le condizioni ecologiche si sono uniformate con conseguente calo della biodiversità.<br />
I contributi per la biodiversità sono finalizzati a contrastare questa perdita di specie prioritarie<br />
e preziosi habitat attraverso l'impianto e l'interconnessione delle cosiddette superfici per la<br />
promozione della biodiversità. I contributi per la biodiversità comprendono i contributi per la<br />
qualità e il contributo per l'interconnessione. Vengono versati per l'impianto e la cura di superfici<br />
per la promozione della biodiversità (SPB) nonché per la loro interconnessione. Alcuni<br />
degli obiettivi fissati nella Politica agricola 2014-2017 (PA 14-17) relativi alla promozione della<br />
biodiversità erano già stati raggiunti a fine 2015.<br />
Obiettivi relativi alla biodiversità per il 2017 e stato nel 2015<br />
Obiettivo per il 2017 Stato nel 2015<br />
Livello qualitativo I<br />
65 000 ha SPB nella regione di pianura<br />
73 000 ha<br />
Livello qualitativo II 40 % delle SPB con qualità 35 %<br />
Interconnessione 50 % delle SPB interconnesse 71 %<br />
Fonte: UFAG<br />
Fonte: UFAG<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
223
Il mio Rapporto agricolo 100 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Contributi per la qualità<br />
I contributi per la qualità vengono erogati per la gestione delle superfici per la promozione<br />
della biodiversità a due livelli qualitativi. Il livello qualitativo I (Q I) corrisponde a quello<br />
dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) vigente fino al 2014, il livello qualitativo II (Q II) a<br />
quello della precedente ordinanza sulla qualità ecologica (OQE). Oltre agli elementi ecologici<br />
promossi finora, nel 2015 sono stati introdotti contributi a favore di strisce fiorite per impollinatori<br />
e altri organismi utili. L'impianto di SPB è finalizzato a creare superfici variate e ricche<br />
di specie che offrono un habitat naturale per flora e fauna. I contributi per la qualità per diversi<br />
tipi di SPB sono erogati in maniera graduata in base al livello qualitativo e alla zona. Sono integralmente<br />
finanziati dalla Confederazione.<br />
Livello qualitativo I<br />
I contributi per il livello qualitativo I hanno l'obiettivo di preservare la varietà della flora e della<br />
fauna autoctone nelle aree agricole e di aumentarla laddove possibile, nonché di sostenere la<br />
preservazione delle strutture e degli elementi paesaggistici tipici.<br />
Le condizioni del livello qualitativo I sono le seguenti.<br />
• Su alcune SPB, come i prati sfruttati in modo estensivo o i prati da strame, non devono<br />
essere utilizzati concimi perché ciò favorisce la preservazione e la promozione delle specie<br />
bersaglio e faro nei terreni magri.<br />
• Le piante problematiche vanno combattute per evitare che le specie dannose per<br />
l'agricoltura e la biodiversità, quali romice o neofite invasive, si diffondano in maniera incontrollata.<br />
• È vietato usare prodotti fitosanitari, perché la loro applicazione su vasta scala pregiudicherebbe<br />
anche le specie bersaglio e faro da promuovere. Sono comunque ammessi<br />
trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempreché<br />
queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole, nonché<br />
l'applicazione di determinati prodotti fitosanitari nelle colture di alberi da frutto ad alto<br />
fusto nei campi e sulle superfici viticole con biodiversità naturale.<br />
• La vegetazione tagliata deve essere rimossa, onde evitare un carico indesiderato di sostanze<br />
nutritive. Si possono tuttavia formare mucchi di rami e di strame se indicati per motivi<br />
legati alla protezione della natura o nell’ambito di progetti di interconnessione. Sono infatti<br />
un nascondiglio ideale per diversi animali di piccola taglia e anche un ottimo rifugio<br />
dove deporre le uova per bisce e altri rettili.<br />
• Non è consentito pacciamare e impiegare macchine frantumatrici perché così si distruggerebbero<br />
piccole strutture utili, ad esempio, per preservare le api selvatiche.<br />
• Per la semina possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi raccomandate<br />
dall'UFAG, per far sì che vengano seminate soltanto specie adeguate alle condizioni locali<br />
e favorevoli per la biodiversità.<br />
• Le piccole strutture improduttive su pascoli sfruttati in modo estensivo, terreni da strame e<br />
prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua danno diritto ai contributi fino a concorrenza di una<br />
quota del 20 per cento al massimo della superficie. Le piccole strutture servono a promuovere<br />
molte specie bersaglio e faro della fauna.<br />
224<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 101 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Livello qualitativo II<br />
Attraverso i contributi per il livello qualitativo II, la Confederazione promuove le SPB di qualità<br />
biologica superiore. Sulle SPB di livello qualitativo II sono presenti determinate specie indicatrici<br />
e caratteristiche strutturali.<br />
Per queste superfici si applicano anche le seguenti esigenze, oltre a quelle vigenti per il livello<br />
qualitativo I.<br />
• Le SPB devono avere qualità botanica o presentare strutture favorevoli alla biodiversità.<br />
L'obiettivo è garantire una promozione speciale per le superfici che sono particolarmente<br />
pregiate per raggiungere gli obiettivi legati alla biodiversità.<br />
• Non è ammesso l'utilizzo di falciacondizionatrici perché ciò riduce sensibilmente il tasso di<br />
sopravvivenza degli animali di piccola taglia.<br />
Contributi per l'interconnessione<br />
La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per la promozione dell'interconnessione e<br />
della gestione adeguata delle SPB. L'interconnessione di spazi vitali è indispensabile per preservare<br />
e promuovere le diverse specie di flora e fauna. Per questo le SPB vengono impiantate<br />
nelle vicinanze di e/o a poca distanza da oggetti di protezione della natura. Le superfici vengono<br />
inoltre gestite in base alle esigenze relative all'habitat delle cosiddette specie bersaglio<br />
e faro. Le specie mobili possono diffondersi e insediarsi in nuovi siti. Le SPB interconnesse<br />
possono fungere da corridoio tra diversi spazi vitali per i mammiferi.<br />
Sono versati contributi per l'interconnessione soltanto se le superfici sono disposte e gestite<br />
conformemente alle disposizioni di un progetto per l'interconnessione regionale, approvato<br />
dal Cantone. Questi deve cofinanziare i contributi nella misure di almeno il 10 per cento. Un<br />
progetto di interconnessione dura 8 anni.<br />
» A69<br />
La tabella seguente fornisce una panoramica delle superfici per l'interconnessione secondo i<br />
tipi di biodiversità e le zone agricole.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
225
Il mio Rapporto agricolo 102 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
La tabella seguente fornisce una panoramica della ripartizione dei contributi per la biodiversità<br />
secondo Q I, Q II e interconnessione nei Cantoni e nelle zone agricole (senza distinzione<br />
secondo il tipo di SPB).<br />
» A70<br />
Per una panoramica sulla ripartizione dei contributi per la biodiversità nei Cantoni e nelle zone<br />
agricole (con distinzione secondo il tipo di SPB) vedasi la rubrica «Servizi».<br />
Prati sfruttati in modo estensivo<br />
I prati sfruttati in modo estensivo rappresentano la superficie inerbita più ricca di specie della<br />
Svizzera e sono promossi in maniera mirata mediante i contributi per la qualità. I prati più caratteristici<br />
sono quelli semisecchi e quelli di forasacco che possono ospitare oltre 50 specie<br />
vegetali per ara. I prati sfruttati in modo estensivo devono essere falciati almeno una volta<br />
l'anno e la vegetazione tagliata deve essere rimossa. A seconda della zona, le superfici possono<br />
essere utilizzate da metà giugno a metà luglio. Lo sfalcio tardivo assicura infatti la completa<br />
maturazione dei semi e promuove la biodiversità attraverso l’inseminazione naturale. Inoltre,<br />
invertebrati, uccelli che nidificano al suolo e mammiferi di piccola taglia dispongono di un periodo<br />
di tempo sufficiente per riprodursi.<br />
Sulle superfici del livello qualitativo II sono regolarmente presenti piante indicatrici e si denota<br />
una composizione povera di sostanze nutritive e ricca di specie.<br />
Contributi per la qualità per prati sfruttati in modo estensivo 2015<br />
QI<br />
fr. / ha<br />
QII<br />
fr. / ha<br />
Zona di pianura 1 500 1 500<br />
Zona collinare 1 200 1 500<br />
ZM I e II 700 1 500<br />
ZM III e IV 550 1 000<br />
Aziende e superfici con prati sfruttati in modo estensivo 2015<br />
Livello qualitativo<br />
I<br />
Unità Regione di pianurnartagna<br />
Regione colli-<br />
Regione di mon-<br />
Totale<br />
Aziende Numero 18 400 10 855 10 973 40 228<br />
Superficie ha 38 678 16 971 25 105 80 754<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
ha 2,10 1,56 2,29 2,01<br />
Unità<br />
Livello qualitativo<br />
II<br />
Regione di pianura<br />
Regione collinare<br />
Regione di montagna<br />
Totale<br />
Aziende Numero 7 265 5 088 7 402 19 755<br />
Superficie ha 9 152 6 381 14 842 30 374<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
ha 1,26 1,25 2,01 1,54<br />
226<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 103 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Fonte: UFAG<br />
» A71<br />
La tabella seguente fornisce una panoramica dei contributi versati per prati sfruttati in modo<br />
estensivo secondo i Cantoni e le zone agricole.<br />
Prati sfruttati in modo poco intensivo<br />
Nella definizione del tipo di habitat i prati sfruttati in modo poco intensivo sono spesso prati di<br />
avena altissima (regione di pianura) o prati di avena bionda (regione di montagna). Il contributo<br />
promuove prati di questo tipo che, secondo Schlup et al. (2013), ospitano una quarantina<br />
di specie vegetali. La loro ricca fioritura attira molte farfalle e altri insetti. Sui prati sfruttati in<br />
modo poco intensivo è autorizzato spandere quantitativi molto limitati di letame o compost.<br />
Per la gestione si applicano le stesse prescrizioni vigenti per i prati sfruttati in modo estensivo.<br />
Sulle superfici del livello qualitativo II sono regolarmente presenti piante indicatrici e si denota<br />
una composizione ricca di specie.<br />
Contributi per la qualità per prati sfruttati in modo poco intensivo 2015<br />
QI<br />
fr. / ha<br />
QII<br />
fr. / ha<br />
Zona di pianura e collinare,<br />
ZM I e II<br />
450 1 200<br />
ZM III e IV 450 1 000<br />
Aziende e superfici con prati sfruttati in modo poco intensivo 2015<br />
Unità<br />
Livello qualitativo<br />
I<br />
Regione di pianura<br />
Regione collinare<br />
Regione di montagna<br />
Totale<br />
Aziende Numero 2 546 3 485 6 826 12 857<br />
Superficie ha 2 060 3 502 13 658 19 220<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
ha 0,81 1,00 2,00 1,49<br />
Unità<br />
Livello qualitativo<br />
II<br />
Regione di pianura<br />
Regione collinare<br />
Regione di montagna<br />
Totale<br />
Aziende Numero 166 531 2 950 3 647<br />
Superficie ha 132 408 3 075 3 615<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
ha 0,79 0,77 1,04 0,99<br />
Fonte: UFAG<br />
» A72<br />
La tabella seguente fornisce una panoramica dei contributi versati per prati sfruttati in modo<br />
poco intensivo secondo i Cantoni e le zone agricole.<br />
Pascoli e pascoli boschivi sfruttati in modo estensivo<br />
I pascoli sfruttati in modo estensivo hanno generalmente una composizione povera di sostanze<br />
nutritive, sono per lo più estesi e su terreni non pianeggianti. I contributi vanno indirettamente<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
227
Il mio Rapporto agricolo 104 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
a beneficio di molte specie animali che sono legate a piante tipiche dei pascoli o che si sono<br />
adattate agli habitat a mosaico creati dagli animali al pascolo. Le superfici dei pascoli sfruttati<br />
in modo estensivo devono essere adibite al pascolo almeno una volta l'anno. Sono ammessi<br />
sfalci di pulizia e la concimazione con le deiezioni degli animali al pascolo. Sul pascolo non<br />
devono essere apportati foraggi, ovvero non devono essere apportati foraggi esterni al pascolo.<br />
Sulle superfici del livello qualitativo II devono essere regolarmente presenti piante indicatrici<br />
che denotano una composizione del suolo povera di sostanze nutritive e strutture favorevoli<br />
per la biodiversità.<br />
I pascoli boschivi sono una forma tradizionale di utilizzo combinato di pascolo e bosco, particolarmente<br />
diffusi nel Giura e a sud delle Alpi. Il contributo è finalizzato alla promozione di specie<br />
che beneficiano di questo mosaico di habitat boschivi e con vegetazione erbacea. Per i pascoli<br />
boschivi si applicano fondamentalmente le stesse disposizioni di quelli sfruttati in modo estensivo.<br />
In più è possibile spandere concime aziendale, compost e concimi minerali non azotati<br />
solo previa autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti. Solo la quota del<br />
pascolo è computabile e dà diritto ai contributi.<br />
Sulle superfici del livello qualitativo II per i pascoli boschivi si applicano le stesse disposizioni<br />
di quelle del livello qualitativo II per i pascoli sfruttati in modo estensivo.<br />
Contributi per la qualità per pascoli struttati in modo estensivo, per livello qualitativo e<br />
zona<br />
QI<br />
fr. / ha<br />
QII<br />
fr. / ha<br />
Tutte le zone 450 700<br />
Aziende e superfici con pascoli e pascoli boschivi sfruttati in modo estensivo 2015<br />
Unità<br />
Livello qualitativo<br />
I<br />
Regione di pianura<br />
Regione collinare<br />
Regione di montagna<br />
Totale<br />
Aziende Numero 4 493 4 621 8 526 17 640<br />
Superficie ha 6 717 8 147 28 475 43 339<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
ha 1,50 1,76 3,34 2,46<br />
Unità<br />
Livello qualitativo<br />
II<br />
Regione di pianura<br />
Regione collinare<br />
Regione di montagna<br />
Totale<br />
Aziende Numero 678 1 131 4 260 6 069<br />
Superficie ha 1 052 2 103 10 690 13 845<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
ha 1,55 1,86 2,51 2,28<br />
Fonte: UFAG<br />
» A73<br />
La tabella seguente fornisce una panoramica dei contributi versati per pascoli e pascoli boschivi<br />
sfruttati in modo estensivo secondo i Cantoni e le zone agricole.<br />
228<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 105 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Terreni da strame<br />
Alcune specie che figurano nella lista rossa sono presenti soltanto su terreni da strame, come ad<br />
esempio la genziana pneumonanthe o alcune specie di ortotteri (Agridea 2015). A causa della<br />
razionalizzazione delle forme di gestione, però, queste superfici non vengono più utilizzate e il<br />
loro numero diminuisce. L'obiettivo è contrastare questa evoluzione attraverso un contributo.<br />
Per terreni da strame s’intendono le superfici inerbite sfruttate in modo estensivo in luoghi paludosi<br />
e umidi che vengono falciate al massimo una volta all’anno e almeno ogni due o tre anni<br />
e il cui raccolto viene utilizzato solo eccezionalmente come foraggio all’interno dell’azienda.<br />
Sulle superfici del livello qualitativo II sono regolarmente presenti piante indicatrici e si denota<br />
una composizione povera di sostanze nutritive e ricca di specie.<br />
Contributi per la qualità per i terreni da strame 2015<br />
QI<br />
fr. / ha<br />
QII<br />
fr. / ha<br />
Zona di pianura 2 000 1 500<br />
Zona collinare 1 700 1 500<br />
ZM I e II 1 200 1 500<br />
ZM III e IV 950 1 500<br />
Aziende e superfici con terreni da strame 2015<br />
Livello qualitativo<br />
I<br />
Unità Regione di pianurtagna<br />
Regione collinare Regione di mon-<br />
Totale<br />
Aziende Numero 2 005 1 949 3 518 7 472<br />
Superficie ha 2 278 1 576 4 068 7 922<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
ha 1,14 0,81 1,16 1,06<br />
Unità<br />
Livello qualitativo<br />
II<br />
Regione di pianura<br />
Regione collinare<br />
Regione di montagna<br />
Totale<br />
Aziende Numero 1 378 1 474 2 618 5 470<br />
Superficie ha 1 878 1 340 3 198 6 416<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
ha 1,36 0,91 1,22 1,17<br />
Fonte: UFAG<br />
» A74<br />
La tabella seguente fornisce una panoramica dei contributi versati per terreni da strame secondo<br />
i Cantoni e le zone agricole.<br />
Siepi, boschetti campestri e rivieraschi<br />
Per siepi e boschetti campestri o rivieraschi s’intendono siepi basse, arbustive o arboree, siepi<br />
frangivento, gruppi di alberi, scarpate boscate e boschetti rivieraschi a forma di siepe. Queste<br />
superfici offrono cibo e rifugio a molti animali e pertanto sono promosse attraverso un contri-<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
229
Il mio Rapporto agricolo 106 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
buto. Il boschetto deve essere opportunamente curato almeno ogni 8 anni. Su entrambi i lati di<br />
siepi, boschetti campestri e rivieraschi deve essere predisposta una fascia di superficie inerbita<br />
o da strame, che deve essere falciata almeno ogni 3 anni. Se confina con un pascolo, questa<br />
superficie può essere adibita a pascolo per un determinato periodo.<br />
Nei boschetti del livello qualitativo II devono essere presenti soltanto specie autoctone di arbusti<br />
e alberi. Siccome diversi boschetti ospitano una grande varietà di specie animali, quelli<br />
del livello qualitativo II devono presentare almeno 5 specie diverse di arbusti e alberi ogni 10<br />
metri. Una quota minima della fascia di arbusti deve essere composta da arbusti spinosi. Questi,<br />
infatti, rispetto ai noccioli o alle betulle, sono luoghi ideali per gli uccelli dove nidificare, trovare<br />
rifugio e cibo, come nel caso dello spin cervino e della rosa canina. In alternativa, il boschetto<br />
può presentare anche una quota minima di alberi tipici del paesaggio. Per le siepi, i<br />
boschetti campestri e rivieraschi che danno diritto a contributi è fissata una larghezza minima.<br />
La gestione del margine erboso avviene in maniera scaglionata.<br />
Contributi per la qualità per siepi, boschetti campestri e rivieraschi 2015<br />
QI<br />
fr. / ha<br />
QII<br />
fr. / ha<br />
Tutte le zone 3 000 2 000<br />
Aziende e superfici con siepi, boschetti campestri e rivieraschi 2015<br />
Livello qualitativo<br />
I<br />
Unità Regione di pianurtagna<br />
Regione collinare Regione di mon-<br />
Totale<br />
Aziende Numero 7 453 4 523 2 571 14 547<br />
Superficie ha 2 065 1 224 519 3 807<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
ha 0,28 0,27 0,20 0,26<br />
Unità<br />
Livello qualitativo<br />
II<br />
Regione di pianura<br />
Regione collinare<br />
Regione di montagna<br />
Totale<br />
Azienda/e Numero 2 857 1 756 625 5 238<br />
Superficie ha 764 476 122 1 363<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
ha 0,27 0,27 0,20 0,26<br />
Fonte: UFAG<br />
» A75<br />
La tabella seguente fornisce una panoramica dei contributi versati per siepi, boschetti campestri<br />
e rivieraschi secondo i Cantoni e le zone agricole.<br />
Maggesi fioriti<br />
I maggesi fioriti svolgono numerose importanti funzioni. Servono per proteggere i fiori selvatici<br />
minacciati e, durante tutto l'anno, ospitano una notevole varietà di animali, compresi organismi<br />
utili come sirfidi, coccinelle, carabidi o ragni (Agridea 2015). Inoltre offrono rifugio<br />
a lepri e uccelli. In autunno fungono da sito di svernamento e vie di spostamento per la fauna<br />
nella regione di pianura. Garantiscono inoltre una protezione contro l'erosione e il riposo del<br />
suolo. Il contributo è finalizzato a preservare tutte queste funzioni. Per maggesi fioriti si inten-<br />
230<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 107 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
dono le superfici che prima della semina erano state utilizzate come superfici coltive o occupate<br />
da colture perenni. Per la semina devono essere utilizzate sementi autorizzate per le SPB. Devono<br />
essere mantenuti nello stesso luogo per almeno 2 ma al massimo 8 anni cosicché si possa<br />
sviluppare un habitat naturale ricco di specie e strutture in grado di vivere intatto per diversi<br />
anni. Dopo l'aratura la stessa particella può essere nuovamente messa a maggese al più presto<br />
nel quarto periodo di vegetazione per evitare che nella superficie coltiva si accumulino semi di<br />
fiori selvatici e che di conseguenza le colture successive presentino un'infestazione eccessiva<br />
di malerbe. Sul maggese vanno rispettate diverse norme di sfalcio.<br />
Contributi per la qualità per i maggesi fioriti 2015<br />
QI<br />
fr. / ha<br />
Zona di pianura e collinare 3 800<br />
Aziende e superfici con maggesi fioriti 2015<br />
Livello qualitativo<br />
I<br />
Unità Regione di pianurtagna<br />
Regione collinare Regione di mon-<br />
Totale<br />
1<br />
Aziende Numero 1 818 371 37 2 226<br />
Superficie ha 1 931 261 16 2 207<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
ha 1,06 0,70 0,43 0,99<br />
Fonte: UFAG<br />
1<br />
Le aziende situate nella regione di montagna ricevono contributi per i maggesi fioriti se queste superfici sono ubicate<br />
nella zona di pianura o collinare.<br />
» A76<br />
La tabella seguente fornisce una panoramica dei contributi versati per maggesi fioriti secondo<br />
i Cantoni e le zone agricole.<br />
Maggesi da rotazione<br />
I maggesi da rotazione vengono promossi in particolare perché offrono protezione e cibo a lepri<br />
e uccelli che nidificano al suolo. Inoltre ospitano una notevole varietà di animali, compresi organismi<br />
utili come sirfidi, coccinelle, carabidi o ragni (Agridea 2015). Per maggesi da rotazione<br />
si intendono aree di superfici di avvicendamento delle colture che vengono mantenute da uno<br />
fino a tre periodi vegetativi e che prima della semina erano gestite come superfici coltive o<br />
ricoperte da colture perenni. Sono generate da biocenosi spontanee (solo con autorizzazione<br />
speciale) o sono composte da erbe campicole selvatiche e leguminose autoctone. Per la semina<br />
devono essere utilizzate sementi autorizzate per le SPB. Come nel caso dei maggesi fioriti, dopo<br />
l'aratura la stessa particella può essere nuovamente messa a maggese al più presto nel quarto<br />
periodo di vegetazione. I maggesi da rotazione possono essere falciati soltanto in determinati<br />
periodi.<br />
Contributi per la qualità per i maggesi da rotazione 2015<br />
QI<br />
fr. / ha<br />
Zona di pianura e collinare 3 300<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
231
Il mio Rapporto agricolo 108 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Aziende e superfici con maggesi da rotazione 2015<br />
Unità<br />
Livello qualitativo<br />
I<br />
Regione di pianura<br />
Regione collinare<br />
Regione di montagna<br />
1<br />
Totale<br />
Aziende Numero 406 68 3 477<br />
Superficie ha 534 76 0,3 610<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
ha 1,32 1,12 0,1 1,28<br />
Fonte: UFAG<br />
1<br />
Le aziende situate nella regione di montagna ricevono contributi per i maggesi da rotazione se queste superfici<br />
sono ubicate nella zona di pianura o collinare.<br />
» A77<br />
La tabella seguente fornisce una panoramica dei contributi versati per maggesi da rotazione<br />
secondo i Cantoni e le zone agricole.<br />
Strisce su superficie coltiva<br />
Le strisce su superficie coltiva, intese come elemento permanente, servono da fonte di nutrimento<br />
nonché luogo di riparo e di svernamento per molti organismi utili e come elemento lineare<br />
sono importanti per l'interconnessione degli habitat naturali (Agridea 2015). Per questi<br />
motivi vengono promosse con un contributo. La striscia su superficie coltiva è una striscia, seminata<br />
con sementi di erbe selvatiche autoctone, su una superficie campicola o su una superficie<br />
con colture perenni. Per la semina devono essere utilizzate sementi autorizzate per le SPB.<br />
La striscia deve essere mantenuta nello stesso luogo per almeno 2 periodi di vegetazione. Nel<br />
primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a sfalci di pulizia.<br />
Contributi per la qualità per le strisce su superficie coltiva 2015<br />
QI<br />
fr. / ha<br />
Zona di pianura e collinare, ZM I e II 3 300<br />
Aziende e superfici con strisce su superficie coltiva 2015<br />
Livello qualitativo<br />
I<br />
Unità Regione di pianurtagna<br />
Regione collinare Regione di mon-<br />
Totale<br />
Aziende Numero 582 185 5 772<br />
Superficie ha 139 32 1 172<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
ha 0,24 0,17 0,21 0,22<br />
Fonte: UFAG<br />
» A78<br />
La tabella seguente fornisce una panoramica dei contributi versati per strisce su superficie coltiva<br />
secondo i Cantoni e le zone agricole.<br />
232<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 109 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Fasce di colture estensive in campicoltura<br />
Le fasce di colture estensive in campicoltura ospitano specie tradizionali di flora segetale come<br />
papavero, fiordaliso, agrostemma e per questo vengono promosse. Per fasce di colture estensive<br />
in campicoltura si intendono fasce marginali di colture campicole sfruttate in modo estensivo,<br />
seminate con cereali, colza, girasoli, leguminose a granelli o lino. I semi della flora<br />
segetale sono disponibili in loco e non possono essere seminati. Non possono essere utilizzati<br />
concimi azotati. Onde salvaguardare la flora segetale, è vietato combattere le malerbe con<br />
mezzi meccanici su vaste porzioni della superficie. Le fasce di colture estensive in campicoltura<br />
devono prevedere sulla stessa superficie almeno 2 colture principali susseguenti cosicché<br />
i semi della flora segetale abbiano tempo a sufficienza per spuntare.<br />
Contributi per la qualità per le fasce di colture estensive in campicoltura 2015<br />
QI<br />
fr./ha<br />
Tutte le zone 2 300<br />
Aziende e superfici con fasce di colture estensive in campicoltura 2015<br />
Livello qualitativo<br />
I<br />
Unità Regione di pianurtagna<br />
Regione collinare Regione di mon-<br />
Totale<br />
Aziende Numero 90 32 9 131<br />
Superficie ha 116 71 1 188<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
ha 1,29 2,21 0,11 1,43<br />
Fonte: UFAG<br />
» A79<br />
La tabella seguente fornisce una panoramica dei contributi versati per fasce di colture estensive<br />
in campicoltura secondo i Cantoni e le zone agricole:<br />
Strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili<br />
Le strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili sono state introdotte nel 2015. Sono<br />
una fonte importante di polline e nettare per api selvatiche e mellifere, bombi, altri organismi<br />
utili come sirfidi o cimici predatrici, in particolare nei mesi estivi scarsi di vegetazione da bottinare.<br />
Per strisce fiorite si intendono le superfici che prima della semina erano state utilizzate<br />
come superfici coltive o occupate da colture perenni. Devono essere seminate con sementi autorizzate<br />
per le SPB prima del 15 maggio. Le strisce fiorite devono essere mantenute per almeno<br />
100 giorni e la rispettiva superficie non deve essere superiore a 50 are.<br />
Contributi per la qualità per le strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili 2015<br />
QI<br />
fr./ha<br />
Zona di pianura e collinare 2 500<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
233
Il mio Rapporto agricolo 110 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Aziende e superfici con strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili 2015<br />
Unità<br />
Livello qualitativo<br />
I<br />
Regione di pianura<br />
Regione collinare<br />
Regione di montagna<br />
1<br />
Totale<br />
Aziende Numero 346 73 30 449<br />
Superficie ha 98 17 1,4 116<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
ha 0,28 0,23 0,04 0,26<br />
Fonte: UFAG<br />
1<br />
Le aziende situate nella regione di montagna ricevono contributi per le strisce fiorite se queste superfici sono ubicate<br />
nella zona di pianura o collinare.<br />
» A80<br />
La tabella seguente fornisce una panoramica dei contributi versati per strisce fiorite per impollinatori<br />
e altri organismi secondo i Cantoni e le zone agricole:<br />
Prati rivieraschi lungo i corsi d’acqua<br />
A differenza dei prati sfruttati in modo estensivo, per i prati rivieraschi non vigono norme<br />
sull'epoca dello sfalcio. Alle aziende viene pertanto concessa maggiore flessibilità nella gestione<br />
di queste superfici, spesso difficile a causa della topografia. Analogamente a tutti gli altri<br />
tipi di prato, anche quelli rivieraschi lungo i corsi d'acqua devono essere falciati almeno una<br />
volta l'anno e possono essere adibiti al pascolo in determinati periodi se le condizioni del suolo<br />
sono favorevoli. Le superfici non possono avere una larghezza superiore a 12 metri per poter<br />
mantenere questo tipo di SPB più vicino possibile al corso d'acqua.<br />
Contributi per la qualità per i prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua 2015<br />
QI<br />
fr./ha<br />
Tutte le zone 450<br />
Aziende e superfici con prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua 2015<br />
Livello qualitativo<br />
I<br />
Unità Regione di pianurtagna<br />
Regione collinare Regione di mon-<br />
Totale<br />
Aziende Numero 164 88 59 311<br />
Superficie ha 38 22 6 66<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
ha 0,23 0,25 0,10 0,21<br />
Fonte: UFAG<br />
» A81<br />
La tabella seguente fornisce una panoramica dei contributi versati per prati rivieraschi lungo i<br />
corsi d'acqua secondo i Cantoni e le zone agricole.<br />
234<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 111 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione<br />
d'estivazione<br />
Nelle Alpi la biodiversità è ancora molto marcata. Ciononostante cresce la minaccia rappresentata,<br />
da un lato, dall'intensivazione e, dall'altro, dalla cessazione della gestione (ovvero<br />
avanzamento delle sterpaglie e del bosco e abbandono). Per far fronte a questo rischio, vengono<br />
versati contributi del livello qualitativo II per prati, pascoli e terreni da strame utilizzati<br />
a scopo alpestre nella regione d'estivazione. Su queste superfici devono essere regolarmente<br />
presenti piante indicatrici che denotano una composizione povera di sostanze nutritive e ricca<br />
di specie. È consentito concimarle purché se ne salvaguardi la qualità botanica.<br />
Contributi per la qualità per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella<br />
regione d'estivazione 2015<br />
QII<br />
fr. / ha<br />
Regione d'estivazione 150<br />
Aziende e superfici con superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione<br />
d'estivazione 2015<br />
Livello qualitativo II<br />
Unità<br />
Regione d'estivazione<br />
Aziende Numero 4 377*<br />
Superficie ha 141 486*<br />
Superficie per azienda ha 32,32<br />
Fonte: UFAG<br />
* Dati solo parzialmente disponibili elettronicamente.<br />
» A82<br />
La tabella seguente fornisce una panoramica dei contributi versati per superfici inerbite e terreni<br />
da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione secondo i Cantoni e le zone agricole.<br />
Vigneti con biodiversità naturale<br />
I vigneti vengono spesso impiantati in aree con un potenziale biologico elevato. Se questo potenziale<br />
e le condizioni di coltivazione non sono pregiudicati, si possono sviluppare habitat<br />
variati e ricchi (Agridea 2015). Per promuovere le specie di flora e fauna specifiche di siti relativamente<br />
secchi e caldi, la concimazione dei vigneti è consentita soltanto sotto i ceppi. Vigono<br />
norme sulla frequenza e sul modello di sfalcio delle superfici alla base dei ceppi. La concimazione<br />
con materiale organico e l'uso di prodotti fitosanitari sono consentiti soltanto in pochi<br />
casi.<br />
Nei vigneti del livello qualitativo II sono regolarmente presenti piante indicatrici ed elementi<br />
strutturali che promuovono la biodiversità. Sulla base delle piante indicatrici si denota una<br />
composizione povera di sostanze nutritive e ricca di specie.<br />
Contributi per la qualità per vigneti con biodiversità naturale 2015<br />
QII<br />
fr. / ha<br />
Tutte le zone 1 100<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
235
Il mio Rapporto agricolo 112 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Aziende e superfici con vigneti con biodiversità naturale 2015<br />
Unità<br />
Livello qualitativo<br />
II<br />
Regione di pianura<br />
Regione collinare<br />
Regione di montagna<br />
Totale<br />
Aziende Numero 282 110 58 450<br />
Superficie ha 556 191 69 816<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
ha 1,97 1,74 1,19 1,81<br />
Fonte: UFAG<br />
» A83<br />
La tabella seguente fornisce una panoramica dei contributi versati per vigneti con biodiversità<br />
naturale secondo i Cantoni e le zone agricole.<br />
Alberi da frutto ad alto fusto nei campi<br />
Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi sono un habitat ideale per animali quali uccelli,<br />
pipistrelli e insetti (Agridea 2015). Per alberi da frutto ad alto fusto nei campi si intendono<br />
alberi da frutto a nocciolo e a granella, castagni e noci in selve curate. I contributi sono versati<br />
a partire da 20 alberi per azienda e soltanto fino a un determinato numero di alberi per ettaro.<br />
Gli alberi devono essere piantati a una distanza adeguata che garantisca uno sviluppo e una<br />
capacità di resa normali. Il tronco deve raggiungere un'altezza minima e al culmine di esso gli<br />
alberi devono presentare almeno tre tralci laterali legnosi. Gli alberi da frutto ad alto fusto nei<br />
campi possono essere concimati. Non è autorizzato l'impiego di erbicidi ai piedi del tronco,<br />
fatta eccezione per gli alberi di meno di 5 anni.<br />
Sulle superfici con alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo II devono essere<br />
regolarmente presenti strutture favorevoli alla biodiversità. La superficie del frutteto deve<br />
essere di almeno 20 are e contenere almeno 10 alberi da frutto ad alto fusto. Vigono norme per<br />
la densità di alberi con un valore minimo e uno massimo, così come per la distanza massima<br />
tra i singoli alberi. Gli alberi vanno potati a regola d'arte. Il frutteto ad alto fusto deve essere<br />
combinato localmente con un'altra SPB (superficie computabile) che si trova nelle vicinanze.<br />
Queste disposizioni fanno sì che la superficie con alberi da frutto ad alto fusto nei campi sia un<br />
habitat naturale pregiato.<br />
Contributi per la qualità per alberi da frutto ad alto fusto nei campi 2015<br />
QI<br />
fr./albero<br />
QII<br />
fr./albero<br />
Tutte le zone 15 30<br />
Aziende e superfici con alberi da frutto ad alto fusto nei campi 2015<br />
Livello qualitativo<br />
I<br />
Unità Regione di pianurtagna<br />
Regione collinare Regione di mon-<br />
Totale<br />
Aziende Numero 14 142 10 647 5 269 30 058<br />
Alberi Numero 1 107 791 826 026 291 122 2 224 939<br />
Alberi per azienda<br />
ha 78,33 77,58 55,25 74,02<br />
236<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 113 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Unità<br />
Livello qualitativo<br />
II<br />
Regione di pianura<br />
Regione collinare<br />
Regione di montagna<br />
Totale<br />
Aziende Numero 5 556 4 891 1 637 12 084<br />
Alberi Numero 399 984 300 629 70 247 770 860<br />
Alberi per azienda<br />
ha 71,99 61,47 42,91 63,79<br />
Fonte: UFAG<br />
» A84<br />
La tabella seguente fornisce una panoramica dei contributi versati per alberi da frutto ad alto<br />
fusto nei campi secondo i Cantoni e le zone agricole.<br />
Contributi di qualità per i noci 2015<br />
QI<br />
fr./albero<br />
QII<br />
fr./albero<br />
Tutte le zone 15 15<br />
Aziende e numero di noci 2015<br />
Unità<br />
Livello qualitativo<br />
I<br />
Regione di pianura<br />
Regione collinare<br />
Regione di montagna<br />
Totale<br />
Aziende Numero 3 600 2 260 1 091 6 951<br />
Alberi Numero 31 254 11 815 6 259 49 328<br />
Alberi per azienda<br />
ha 6,68 5,23 5,74 7,10<br />
Unità<br />
Livello qualitativo<br />
II<br />
Regione di pianura<br />
Regione collinare<br />
Regione di montagna<br />
Totale<br />
Aziende Numero 987 652 188 1 827<br />
Alberi Numero 9 314 2 991 675 12 980<br />
Alberi per azienda<br />
ha 9,44 4,59 3,59 7,10<br />
Fonte: UFAG<br />
» A85<br />
La tabella seguente fornisce una panoramica dei contributi versati per i noci secondo i Cantoni<br />
e le zone agricole.<br />
Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati<br />
Gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati contribuiscono alla preservazione della<br />
biodiversità perché gli uccelli e i pipistrelli possono trovar riparo nelle cavità, i rapaci, come il<br />
gheppio comune, possono posarsi sui rami e gli insetti trovano il loro habitat naturale nel legno<br />
morto (Agridea 2015). La distanza tra due alberi che danno diritto ai contributi è di almeno 10<br />
metri. Il terreno ai piedi degli alberi non deve essere concimato in un raggio di almeno 3 metri.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
237
Il mio Rapporto agricolo 114 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Per gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati non vengono erogati contributi per<br />
la qualità, bensì soltanto contributi per l'interconnessione.<br />
» A86<br />
La tabella seguente fornisce una panoramica dei contributi versati per alberi indigeni, isolati<br />
e viali alberati secondo i Cantoni e le zone agricole.<br />
Superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione<br />
Per superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione s'intendono habitat<br />
naturali pregiati dal profilo ecologico che non corrispondono ad alcun altro elemento SPB. Le<br />
condizioni relative a queste superfici sono fissate dai Servizi cantonali per la protezione della<br />
natura d'intesa con i Servizi cantonali d'agricoltura e con l'UFAG.<br />
Per superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione non vengono erogati<br />
contributi per la qualità, bensì soltanto contributi per l'interconnessione.<br />
» A87<br />
La tabella seguente fornisce una panoramica dei contributi versati per superfici per la promozione<br />
della biodiversità specifiche di una regione secondo i Cantoni e le zone agricole.<br />
Bibliografia<br />
Schlup, B., Stalling, T., Plattner, M., Weber, D. (2013): Die Artenvielfalt des durchschnittlichen Dauergrünlands der<br />
Schweiz - Ein Vergleich zu naturschutzfachlich wertvollen Wiesen und Weiden. Abgerufen am 16.04.2015 von http://<br />
www.hintermannweber.ch/public/pdf/papers_schlupetal.2013nul.pdf<br />
Schmid, W., Wiedemeier, P., Stäubli, A. (2001): Extensive Weiden und Artenvielfalt – Synthesebericht. Abgerufen am<br />
16.04.2015 von http://poel.ch/pdf/Weidebericht_BUWAL.pdf<br />
Agridea (2015): Biodiversitätsförderung in der Schweizer Landwirtschaft. Abgerufen am 20.04.2015 von http://<br />
www.bff-spb.ch/de/biodiversitaetsfoerderflaechen/<br />
Judith Ladner Callipari, UFAG, Settore Pagamenti diretti Programmi, judith.ladner@blw.admin.ch (contributi per la<br />
qualità)<br />
Maya Imfeld, UFAG, Settore Pagamenti diretti Programmi, maya.imfeld@blw.admin.ch (contributo per<br />
l'interconnessione)<br />
238<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 134 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Contributi per i sistemi di produzione<br />
I contributi per i sistemi di produzione sono concessi a favore di 5 programmi diversi. Attraverso<br />
un contributo aziendale globale viene promossa l'agricoltura biologica, con contributi<br />
parziali vengono incentivate la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette<br />
e colza nonché la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI), nonché<br />
il benessere degli animali (sistemi di stabulazione e uscita all'aperto).<br />
» A88<br />
La tabella seguente fornisce una panoramica della ripartizione dei diversi tipi di contributi per<br />
i sistemi di produzione (bio, produzione estensiva, PLCSI) secondo i Cantoni e le zone agricole.<br />
Contributo per l'agricoltura biologica<br />
A complemento del maggior ricavo che può essere ottenuto sul mercato attraverso l'agricoltura<br />
biologica, la Confederazione promuove questa forma di produzione in quanto particolarmente<br />
in sintonia con la natura e rispettosa dell'ambiente. Nell’agricoltura biologica si rinuncia completamente<br />
all’utilizzo di mezzi di produzione ottenuti mediante sintesi chimica come concimi<br />
commerciali o pesticidi. Ciò consente di risparmiare energia e di proteggere l'acqua, l'aria e<br />
il suolo. Inoltre, viene promossa la biodiversità. L'agricoltura biologica, nel complesso, raggiunge<br />
un'efficienza maggiore nell'impiego delle risorse disponibili e incide positivamente sulla<br />
varietà delle specie. Questi sono indicatori importanti della sostenibilità del sistema di produzione.<br />
Per gli agricoltori biologici è particolarmente importante tener conto dei processi e dei<br />
cicli naturali nonché adattare l’intensità di produzione al potenziale locale.<br />
Per poter beneficiare dei contributi i gestori devono rispettare, sull’insieme delle superfici<br />
dell’azienda, le esigenze dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Questa condizione non si<br />
applica per la vitivinicoltura e i frutteti nonché in caso di conversione a tappe all'agricoltura<br />
biologica.<br />
Nel 2015 sono stati coltivati secondo i principi dell'agricoltura biologica 131 419 ettari, ovvero<br />
il 12,5 per cento della SAU totale.<br />
Per la promozione dell'agricoltura biologica sono stati versati complessivamente 42 milioni di<br />
franchi circa. Maggiori informazioni sono contenute nella tabella seguente.<br />
Contributo per l'agricoltura biologica 2015<br />
Unità Regione di<br />
Regione Regione di<br />
Totale<br />
pianura<br />
collinare montagna<br />
Aziende Numero 1 452 1 400 3 296 6 148<br />
Superficie ha 32 170 26 816 72 433 131 419<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
Contributo per<br />
azienda<br />
ha 22,16 19,15 21,98 21,38<br />
ha 13 158 5 941 4 564 6 907<br />
Totale contributi 1 000 fr. 19 105 8 318 15 043 42 466<br />
Fonte: UFAG<br />
Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie<br />
inerbita<br />
Attraverso il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita<br />
(PLCSI) s'intende promuovere una forma di produzione adeguata al potenziale locale specifico<br />
dell'azienda. Rispetto a molti Paesi vicini, la Svizzera presenta il grande vantaggio di avere<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
239
Il mio Rapporto agricolo 135 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
luoghi adatti alla produzione di erba. L'accento è posto sull'utilizzo efficiente del foraggio ottenuto<br />
da prati e pascoli per la trasformazione in latte e carne.<br />
Il contributo è versato se la razione annua di tutti gli animali che consumano foraggio grezzo<br />
detenuti nell'azienda è composta nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca<br />
(SS) da foraggio di base. Inoltre, è prescritta una quota minima di foraggio ottenuto da prati<br />
e pascoli: nella regione di pianura del 75 per cento e in quella di montagna dell'85 per cento<br />
della razione annuale. Si tiene altresì conto delle diverse condizioni locali. Il fatto che il foraggio<br />
provenga dalla superficie aziendale o no è irrilevante ai fini della concessione dei contributi.<br />
Nel bilancio foraggero viene computato come foraggio ottenuto da prati e pascoli anche<br />
l'apporto di foraggio di prato.<br />
La PLCSI è considerata un sistema di produzione globale dell'azienda. Ne consegue che tutti<br />
gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo tenuti nell'azienda devono adempiere le<br />
condizioni. Viene pertanto allestito un unico bilancio foraggero con tutti gli animali che consumano<br />
foraggio grezzo, nel quale si mette a confronto offerta e consumo di foraggio. Se la<br />
razione media adempie le condizioni, sono ammesse razioni che si scostano dalle esigenze in<br />
materia di foraggiamento.<br />
La PLCSI è sostenuta con un contributo di 200 franchi per ettaro di superficie inerbita.<br />
Nella tabella seguente sono indicati i contributi versati nel 2015 e le aziende partecipanti.<br />
Contributi per la PLCSI 2015<br />
Unità<br />
Regione di<br />
pianura<br />
Regione<br />
collinare<br />
Regione di<br />
montagna<br />
Totale o media<br />
Aziende Numero 8 461 9 289 12 344 30 094<br />
Superficie ha 129 616 160 096 254 190 543 901<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
Contributo per<br />
azienda<br />
ha 15,32 17,24 20,59 18,07<br />
fr. 3 009 3 412 4 108 3 584<br />
Totale contributi in 1 000 fr. 25 463 31 698 50 705 107 866<br />
Fonte: UFAG<br />
Nel 2015 la partecipazione ha raggiunto mediamente il 76 per cento circa della superficie inerbita<br />
e il 64 per cento delle aziende. L'adesione è più alta nei Cantoni di montagna (regioni<br />
inerbite) che in quelli di pianura (coltivazione di mais).<br />
Sulla scorta di un'analisi approfondita presso le aziende con bestiame da latte è possibile esprimere<br />
le seguenti considerazioni.<br />
• Le quote di foraggio concentrato e di mais sono i fattori limitanti nel bilancio foraggero.<br />
Per questo motivo nella regione di pianura il numero di aziende aventi diritto a contributi<br />
PLCSI è più basso. In questa regione la quota di aziende lattiere con una strategia di high<br />
input (con un impiego di alimenti concentrati relativamente elevato) è superiore rispetto<br />
alla regione di montagna.<br />
• Maggiore è la produzione media di latte per vacca minore è la partecipazione al programma<br />
PLCSI. Per le aziende con una produzione media di circa 5 000 kg di latte per vacca, la partecipazione<br />
ammonta all'87 per cento. In quelle con una produzione di latte per vacca molto<br />
più elevata (9 000-10 000 kg), la partecipazione scende al 23 per cento. Nella categoria<br />
240<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 136 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
con una produzione di 7 000-8 000 kg di latte per vacca, la partecipazione ammonta al 51<br />
per cento.<br />
Nel gennaio 2016 l'UFAG ha deciso di valutare il programma PLCSI. Il rispettivo mandato è stato<br />
affidato ad Agroscope. Dalla valutazione emergerà quali impatto ha il programma PLCSI e se è<br />
possibile raggiungere gli obiettivi prefissati. I primi risultati sono attesi per fine 2016.<br />
Contributo per la produzione estensiva di colture campicole (produzione<br />
estensiva)<br />
Il contributo sostiene la coltivazione di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza senza<br />
l'uso di fungicidi e insetticidi. Attraverso questo incentivo s'intende ridurre l'impiego di prodotti<br />
fitosanitari in campicoltura, onde evitare potenziali effetti negativi causati dai residui nel<br />
raccolto e nell'ambiente. Gli agricoltori che optano per la produzione estensiva sono disposti<br />
ad assumersi un determinato rischio in termini di calo delle rese o addirittura di perdite del<br />
raccolto. Questo rischio è compensato attraverso il contributo per la produzione estensiva.<br />
Questo viene concesso per coltura, se nell'intera azienda non vengono impiegati regolatori<br />
della crescita, fungicidi, stimolanti chimico-sintetici delle difese naturali e insetticidi. Il gestore<br />
deve decidere anticipatamente per quali colture intende rispettare queste condizioni a livello<br />
aziendale.<br />
Con la Politica agricola 2014-2017 (PA 14-17), il diritto al contributo è stato esteso anche a<br />
girasoli, piselli proteici e favette. Per queste colture è stato possibile dimostrare che l'uso di<br />
prodotti fitosanitari fa aumentare in modo significativo le rese rispetto alla produzione estensiva.<br />
Quelle per cui il livello di resa resta, invece, praticamente identico con o senza impiego di<br />
prodotti fitosanitari non vengono inserite nel programma di produzione estensiva. Per dare ai<br />
produttori la maggior flessibilità possibile nel coltivare i cereali e nello scegliere il metodo di<br />
coltivazione, il frumento panificabile e quello da foraggio possono essere coltivati attenendosi<br />
o no alle condizioni della produzione estensiva.<br />
Grazie a questo provvedimento, il 50 per cento circa della superficie cerealicola totale della<br />
Svizzera è coltivato secondo i criteri della produzione estensiva.<br />
Il relativo contributo ammonta a 400 franchi l'ettaro per tutte le colture e in tutte le zone.<br />
Nella tabella seguente sono indicati i contributi versati nel 2015 e le aziende partecipanti.<br />
Contributi per la produzione estensiva 2015<br />
Unità<br />
Regione<br />
Regione<br />
Regione<br />
Totale<br />
di pianura<br />
collinare di montagna<br />
Aziende Numero 9 163 4 554 594 14 311<br />
Superficie ha 62 803 19 485 1 414 83 702<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
Contributo per<br />
azienda<br />
ha 6,85 4,28 2,38 5,85<br />
fr. 2 742 1 711 952 2 340<br />
Totale contributi in 1 000 fr. 25 121 7 794 566 33 481<br />
Fonte: UFAG<br />
La produzione estensiva di colture campicole interessa prevalentemente la regione di pianura<br />
(aree campicole). La superficie media per azienda ammonta a circa 5,85 ettari. I contributi<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
241
Il mio Rapporto agricolo 137 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
versati nella regione di pianura, pari a 2 742 franchi per azienda, sono quasi il triplo di quelli<br />
versati nella regione di montagna pari a circa 950 franchi per azienda.<br />
Contributi per il benessere degli animali (contributi URA e SSRA)<br />
Il benessere degli animali è un tema molto sentito dalla popolazione svizzera e al sua promozione<br />
è sancita anche nella Costituzione federale: «[la Confederazione] Promuove mediante<br />
incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la<br />
natura e rispettose dell'ambiente e degli animali.» (cfr. art. 104 cpv. 3 lett. b). Nella legge<br />
sull'agricoltura è sancito il principio seguente: «Per promuovere forme di produzione particolarmente<br />
in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali sono versati contributi<br />
per i sistemi di produzione. I contributi comprendono: ... un contributo per unità di bestiame<br />
grosso, graduato secondo le categorie di animali, per forme di produzione particolarmente rispettose<br />
degli animali.» (cfr. art. 75).<br />
Spetta all'Ufficio federale dell'agricoltura decidere concretamente come impostare la promozione<br />
delle forme di produzione particolarmente rispettose degli animali. La strategia di promozione<br />
che ha messo a punto prevede quanto segue.<br />
Attraverso incentivi finanziari vengono promossi l'uscita regolare all'aperto degli animali da<br />
reddito (programma URA; dal 1993) e i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi delle<br />
esigenze degli animali (programma SSRA; dal 1996).<br />
Eccezion fatta per gli agricoltori dediti all'agricoltura biologica per i quali la partecipazione al<br />
programma URA è obbligatoria (cfr. art. 15 ordinanza sull'agricoltura biologica), ogni singolo<br />
agricoltore è libero di decidere con quali e quante categorie di animali (p.es. vacche da latte,<br />
bovini da allevamento, vitelli) partecipare a uno o a entrambi i programmi.<br />
Le esigenze specifiche per ciascuna categoria di animali vigenti per entrambi i programmi sono<br />
stabilite nell'ordinanza sui pagamenti diretti varata dal Consiglio federale.<br />
Programma URA 2015<br />
Aliquote URA<br />
Categorie di animali<br />
Animali della specie bovina e bufali di età superiore a<br />
160 giorni, animali della specie equina, animali delle<br />
specie caprina e ovina di età superiore a 1 anno, agnelli<br />
magri e conigli<br />
Animali della specie bovina e bufali di età inferiore a 160<br />
giorni<br />
fr./UBG<br />
190<br />
370<br />
Scrofe da allevamento non in lattazione 370<br />
Altri suini, suinetti esclusi 165<br />
Galline produttrici di uova da cova e di consumo e galli,<br />
pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova,<br />
polli da ingrasso e tacchini<br />
290<br />
Le aliquote SSRA applicate nel 2015 non hanno subito variazioni rispetto all'anno precedente.<br />
Nella tabella seguente sono indicate le aziende partecipanti al programma URA.<br />
» A89<br />
Cifre per il 2015<br />
242<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 138 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Cifre per il 2014<br />
» A90<br />
Nel 2015 la partecipazione al programma URA ha superato i valori del 2014 per la maggior<br />
parte delle categorie di animali. La crescita più marcata ha interessato le galline e i galli da<br />
allevamento (produzione di uova da cova per le razze ovaiole e da ingrasso), la cui partecipazione<br />
è aumentata di 6,6 punti attestandosi al 22,2 per cento. Siccome le aliquote URA non<br />
sono state aumentate, la crescita è da ricondurre agli sforzi intrapresi da determinate label che<br />
hanno esteso le prescrizioni in materia di detenzione di polli da ingrasso agli animali riproduttori.<br />
Un incremento si registra anche per i vitelli di sesso maschile di età inferiore a 160 giorni,<br />
segnatamente di 3,6 punti al 36,9 per cento. Esso è dovuto al notevole aumento dell'aliquota<br />
di contribuzione con effetto al 1° gennaio 2014 e al maggior impegno di una label in questo<br />
ambito. Il calo maggiore (differenza: #2,2 %) si è registrato per pollastrelle, galletti e pulcini<br />
(polli da ingrasso esclusi).<br />
Contributo URA 2015<br />
Unità<br />
Regione di<br />
pianura<br />
Regione<br />
collinare<br />
Regione di<br />
montagna<br />
Totale<br />
Aziende Numero 13 021 10 518 11 839 35 378<br />
UBG Numero 411 593 292 205 256 201 959 999<br />
UBG per azienda Numero 31,61 27,78 21,64 27,14<br />
Contributo per<br />
azienda<br />
fr. 6 240 5 438 4 203 5 320<br />
Totale contributi 1 000 fr. 81 250 57 195 49 758 188 203<br />
Fonte: UFAG<br />
Programma SSRA 2015<br />
Aliquote SSRA<br />
Categorie di animali<br />
Animali della specie bovina e bufali di età superiore a<br />
160 giorni di età, animali della specie equina di età superiore<br />
a 30 mesi e animali della specie caprina di età<br />
superiore a 1 anno<br />
fr. / UBG<br />
90<br />
Suini, suinetti esclusi 155<br />
Galline produttrici di uova da cova e di consumo e galli,<br />
pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova,<br />
polli da ingrasso e tacchini nonché conigli<br />
280<br />
Le aliquote SSRA applicate nel 2015 non hanno subito variazioni rispetto all'anno precedente.<br />
Nella tabella seguente sono indicate le aziende partecipanti al programma SSRA.<br />
» A91<br />
» A92<br />
Cifre per il 2015<br />
Cifre per il 2014<br />
La crescita maggiore ha interessato i conigli, con un aumento di 8,5 punti al 50,8 per cento<br />
per le riproduttrici e di 14,9 punti all'82,0 per cento per i conigli da ingrasso. Le aliquote SSRA<br />
non sono state adeguate, ragion per cui l'incremento è da ricondurre al successo di mercato<br />
delle label in relazione alla carne di coniglio. Gli altri aumenti variano tra 0,1 e 2,6 punti. Un<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
243
Il mio Rapporto agricolo 139 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
calo è stato riscontrato soltanto per pollastrelle, galletti e pulcini (differenza: -1,9 %) e per le<br />
rimonte dei suini d'ingrasso d'età inferiore a 6 mesi (differenza: #0,1%)<br />
Contributo SSRA 2015<br />
Unità<br />
Regione di<br />
pianura<br />
Regione<br />
collinare<br />
Regione di<br />
montagna<br />
Totale<br />
Aziende Numero 9 845 6 810 5 243 21 898<br />
UBG Numero 359 984 193 734 112 608 666 326<br />
UBG per azienda Numero 36,57 28,45 21,48 30,43<br />
Contributo per<br />
azienda<br />
fr. 4 503 3 289 2 172 3 567<br />
Totale contributi 1 000 fr. 44 332 22 399 11 385 78 116<br />
Fonte: UFAG<br />
» A93<br />
La tabella seguente offre una panoramica sui contributi per il benessere degli animali secondo<br />
i Cantoni e le zone agricole.<br />
Rapporto tra protezione degli animali e contributi per il benessere<br />
degli animali<br />
Le prescrizioni della legislazione in materia di protezione degli animali devono essere rispettate<br />
da tutti i detentori di animali in Svizzera e quindi da agricoltori e non. Perciò gli agricoltori<br />
non ricevono pagamenti diretti specifici se rispettano queste condizioni.<br />
I contributi per il benessere degli animali rappresentano un indennizzo parziale per gli agricoltori<br />
che forniscono prestazioni maggiori vincolate a esigenze in materia di detenzione degli<br />
animali più severe rispetto a quelle sancite dalla legislazione sulla protezione degli animali.<br />
• Nell'ambito del programma URA comportano soprattutto una maggiore mole di lavoro, per<br />
esempio per la conduzione degli animali dalla stalla al pascolo e viceversa, per la recinzione<br />
del pascolo e la cura dello stesso.<br />
• Nell'ambito del programma SSRA comportano costi aggiuntivi (p.es. per superfici di stabulazione<br />
più estese), maggior carico di lavoro e costi superiori del materiale, in particolare<br />
per le lettiere.<br />
Le maggiori prestazioni non indennizzate dalla Confederazione vengono compensate dagli<br />
agricoltori ricavando sul mercato un prezzo di vendita superiore per le derrate alimentari derivanti<br />
da una produzione particolarmente rispettosa degli animali.<br />
Peter Zbinden, UFAG, Settore Pagamenti diretti Programmi, peter.zbinden@blw.admin.ch<br />
Laurent Nyffenegger, UFAG, Settore Pagamenti diretti Programmi, laurent.nyffenegger@blw.admin.ch<br />
244<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 146 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Contributi per l'efficienza delle risorse<br />
Onde migliorare l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali e l’efficienza nell’impiego di mezzi<br />
di produzione, a livello nazionale vengono promosse tecniche di comprovata efficacia per un<br />
periodo limitato a 6 anni. Dal 2014 vengono sostenuti i procedimenti di spandimento a basse<br />
emissioni, la lavorazione rispettosa del suolo e l’impiego di una tecnica d’applicazione precisa<br />
in relazione ai prodotti fitosanitari. Restano, seppure rivisti, la promozione volta a migliorare<br />
l’impiego delle risorse naturali in agricoltura (progetti sulle risorse giusta l'art. 77 a/b LAgr) e<br />
i contributi ai sensi dell’articolo 62a della legge sulla protezione delle acque per provvedimenti<br />
dell’agricoltura volti a evitare il convogliamento e il dilavamento di sostanze nelle acque superficiali<br />
e sotterranee (cfr. sottorubrica sui "Programmi regionali e settoriali").<br />
Procedimenti di spandimento a basse emissioni<br />
In Svizzera, il 92 per cento delle emissioni di ammoniaca proviene dall'agricoltura (stato<br />
2010). Esse si verificano nella stalla, nello stoccaggio di concimi aziendali nonché nello<br />
spandimento di letame o liquame oppure nella concimazione con prodotti minerali azotati.<br />
L'ammoniaca viene trasportata con l'aria e, quando si deposita, inquina ecosistemi come<br />
boschi, torbiere e prati ricchi di specie che necessitano di bassi tenori di azoto. La Confederazione<br />
eroga contributi a favore dei procedimenti di spandimento di liquame a basse emissioni,<br />
che prevedono l’utilizzo di tubi flessibili a strascico o di assolcatori oppure l’interramento del<br />
liquame.<br />
Contributi per l'efficienza delle risorse per procedimenti di spandimento a basse emissioni<br />
2015<br />
Unità<br />
Regione di<br />
pianura<br />
Regione<br />
collinare<br />
Regione di<br />
montagna<br />
Totale<br />
Aziende Numero 3 370 1 956 917 6 243<br />
Superficie totale ha 121 724 63 369 21 900 206 993<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
Contributo per<br />
azienda<br />
ha 36,12 32,40 23,88 33,16<br />
fr. 1 084 972 716 995<br />
Totale contributi 1 000 fr. 3 652 1 901 657 6 210<br />
Fonte:UFAG<br />
Negli anni 2014 e 2015 i procedimenti di spandimento a basse emissioni sono stati indennizzati<br />
soltanto parzialmente attraverso i pagamenti diretti. In vari Cantoni questi provvedimenti sono<br />
stati finanziati nel quadro dei progetti per le risorse finalizzati alla riduzione delle emissioni di<br />
ammoniaca. A fine 2017 saranno portati a termine gli ultimi progetti di questo tipo.<br />
I contributi per l'efficienza delle risorse pari a circa 6,2 milioni di franchi versati nel 2015 vanno<br />
pertanto considerati un importo parziale dei mezzi finanziari totali destinati alla promozione<br />
di procedimenti di spandimento a basse emissioni.<br />
I procedimenti di spandimento a basse emissioni come i tubi flessibili sono impiegati soprattutto<br />
nella regione di pianura. Nelle zone declive è più difficile utilizzare queste attrezzature.<br />
Lavorazione rispettosa del suolo<br />
Il suolo fertile è una delle principali basi per la produzione di derrate alimentari e alimenti per<br />
animali nonché il principale fattore di produzione dell’agricoltura. Una ridotta lavorazione del<br />
suolo aumenta il tenore di humus nel suo strato superficiale e ne sostiene la struttura pedolo-<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
245
Il mio Rapporto agricolo 147 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
gica e l’attività biologica, garantendogli una migliore capacità di ritenzione dell’acqua fruibile<br />
per le piante. Vi sono studi che attestano che sulle superfici con semina diretta si ottiene una<br />
riduzione media dell'erosione dell'86 per cento (Prashun 2012).<br />
La Confederazione incentiva i sistemi di lavorazione rispettosi del suolo, come la semina diretta,<br />
a bande e a lettiera, che consentono di ridurre l’erosione, la compattazione e l’accumulo<br />
di inquinanti nel suolo, preservandone a lungo termine la fertilità. Anche il consumo di diesel<br />
diminuisce perché si riducono i passaggi dei macchinari. Un altro vantaggio è dato dalla diminuzione<br />
delle perdite di azoto sotto forma di nitrati.<br />
Una sfida può essere rappresentata dalla difficoltà di lottare contro le malerbe correlata al sistema.<br />
Per contenere l'utilizzo di erbicidi, nell’ordinanza sui pagamenti diretti sono state introdotte<br />
misure collaterali. Da un lato, il quantitativo autorizzato di glifosato (erbicida) sulle<br />
superfici che danno diritto al contributo viene limitato a 1,5 chilogrammi di principio attivo per<br />
ettaro e anno. Ciò fa sì che il sostegno per tecniche di coltivazione senza l’uso dell’aratro sia<br />
concesso soltanto per particelle idonee su cui la presenza di malerbe è contenuta. Dall'altro,<br />
la gestione senza erbicidi è retribuita con un contributo supplementare.<br />
Contributi per l'efficienza delle risorse per la lavorazione rispettosa del suolo 2015<br />
Contributo per<br />
l’efficienza delle<br />
risorse<br />
Unità<br />
Regione di pianura<br />
Regione collinare<br />
Regione di montagna<br />
Totale<br />
Aziende Numero 5 627 1 725 135 7 487<br />
Superficie totale ha 42 927 7 127 439 50 493<br />
Superficie senza<br />
rinuncia agli erbicidi<br />
ha 39 963 6 244 330 46 537<br />
Semina diretta ha 5 676 1 884 165 7 725<br />
Semina a bande ha 6 272 1 333 41 7 646<br />
Semina a lettiera<br />
Superficie con<br />
rinuncia agli erbicidi<br />
ha 28 016 3 026 123 31 166<br />
ha 2 964 883 110 3 956<br />
Semina diretta ha 640 272 59 970<br />
Semina a bande ha 67 20 5 92<br />
Semina a lettiera<br />
Superficie per<br />
azienda<br />
Contributo per<br />
azienda<br />
ha 2 257 591 45 2 894<br />
ha 7,63 4,13 3,25 6,74<br />
fr. 1 524 989 995 1 391<br />
Totale contributi 1 000 fr. 8 573 1 705 134 10 413<br />
Fonte: UFAG<br />
La partecipazione al programma di lavorazione rispettosa del suolo riportata nella tabella non<br />
corrisponde alla superficie coltiva totale della Svizzera lavorata con tecniche rispettose del<br />
suolo. Tale discrepanza è dovuta al fatto che in alcuni Cantoni vengono versati contributi per<br />
i progetti sulle risorse e sulla protezione delle acque che contemplano provvedimenti per la<br />
lavorazione rispettosa del suolo.<br />
246<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 148 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Le tecniche che non prevedono l'utilizzo di erbicidi vengono prevalentemente combinate con<br />
la semina a lettiera. La semina a bande su superfici senza rinuncia all'utilizzo di erbicidi viene<br />
applicata praticamente in ugual misura alla semina diretta. Sulle superfici con rinuncia agli<br />
erbicidi la semina a bande è insignificante.<br />
Impiego di una tecnica di applicazione precisa<br />
Tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia<br />
Le convenzionali barre irroranti sono dotate di ugelli che irrorano la coltura o la flora segetale<br />
dall'alto. Mediante tale tecnica il principio attivo raggiunge soprattutto la pagina superiore<br />
della foglia e i germogli più in alto delle colture, mentre la pagina inferiore della foglia e i germogli<br />
più in basso sono irrorati poco o per niente. Per trattare meglio tali parti della pianta difficilmente<br />
raggiungibili, spesso colpite da organismi nocivi e malattie, è necessaria una tecnica<br />
d'applicazione più adeguata alle piante. Questa tecnica consente di applicare i principi attivi<br />
in maniera più mirata ed efficiente. Per questo la Confederazione la promuove. Essa consiste in<br />
un dispositivo supplementare per gli apparecchi convenzionali utilizzati nella protezione delle<br />
piante, che consente di impiegare almeno il 50 per cento degli ugelli per il trattamento delle<br />
parti inferiori delle piante e delle pagine inferiori delle foglie. In questo modo, a seconda della<br />
coltura e dell'attrezzatura, si può arrivare a risparmiare addirittura l'80 per cento dei prodotti<br />
fitosanitari applicati.<br />
Irroratrici dotate di sistemi antideriva in colture perenni<br />
Mediante la deriva, dai terreni agricoli i prodotti fitosanitari possono giungere nelle acque superficiali<br />
o sotterranee. Le irroratrici dotate di sistemi antideriva sono equipaggiate in modo<br />
da ridurla di almeno il 50 per cento.<br />
Per la tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia e per le irroratrici dotate di sistemi<br />
antideriva in colture perenni, la Confederazione versa un contributo unico per l'acquisto<br />
di nuove attrezzature che consentono l'applicazione precisa dei prodotti fitosanitari.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
247
Il mio Rapporto agricolo 149 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Contributi per l'efficienza delle risorse per l'impiego di una tecnica di applicazione precisa<br />
2015 (contributi unici)<br />
Contributo per<br />
l’efficienza delle<br />
risorse<br />
Unità<br />
Regione di pianura<br />
Regione collinare<br />
Regione di montagna<br />
Totale<br />
Aziende Numero 154 30 9 193<br />
Tecnica<br />
d'irrorazione<br />
della pagina inferiore<br />
della foglia<br />
Numero di barre<br />
irroranti<br />
Numero 53 11 1 65<br />
Contributo fr. 200 950 46 834 850 248 634<br />
Irroratrici dotate<br />
di sistemi antideriva<br />
Numero di irroratrici<br />
Numero 101 20 8 129<br />
Contributo fr. 378 810 56 733 19 779 455 322<br />
Contributo per<br />
azienda<br />
fr. 3 765 3 452 2 292 3 647<br />
Totale contributi 1 000 fr. 580 104 21 704<br />
Fonte: UFAG<br />
» A94<br />
Sono prevalentemente le aziende di pianura con colture speciali che ricevono questi contributi.<br />
Il pagamento di un contributo unico per un investimento nella tecnica è una novità nell'ambito<br />
dei pagamenti diretti. In questo modo è possibile promuovere l'innovazione auspicata semplificando<br />
l'esecuzione.<br />
Contributi per l’efficienza delle risorse per tipo di contributo, Cantone e zona agricola<br />
Bibliografia<br />
Prashun, V. 2012 On-farm effects of tillage and crops on soil erosion measured over 10 years in Switzerland. Soil and<br />
Tillage Research, 120: 137–146.<br />
Eva Wyss, UFAG, Settore Pagamenti diretti Programmi, eva.wyss@blw.admin.ch<br />
248<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 151 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Contributo di transizione<br />
Con la Politica agricola 2014-2017, nel 2014 è stato introdotto il contributo di transizione, finalizzato<br />
ad attenuare le variazioni dei pagamenti diretti percepiti dalle singole aziende in seguito<br />
al cambio di sistema e a garantire una transizione socialmente sostenibile versa la nuova<br />
politica agricola. L'obiettivo è dare il tempo di adattarsi alle nuove condizioni quadro alle aziende<br />
che si sono viste ridurre i pagamenti diretti. Il contributo di transizione è previsto fino<br />
al 2021.<br />
Nel 2014 i Cantoni hanno calcolato un valore di base unico per ogni azienda, che è il risultato<br />
della differenza tra i pagamenti diretti generali del vecchio sistema e la somma dei contributi<br />
per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell'approvvigionamento del nuovo sistema. Per i pagamenti<br />
diretti generali è stato scelto l'anno con i valori più elevati nel periodo 2011-2013. Per<br />
il calcolo dei contributi in base al nuovo sistema sono stati utilizzati i dati strutturali (superfici,<br />
animali) dell'anno selezionato.<br />
I mezzi finanziari a disposizione per il contributo di transizione corrispondono al credito dei<br />
pagamenti diretti al netto delle uscite per tutti i programmi facoltativi nell'ambito dei pagamenti<br />
diretti e dei progetti relativi all'efficienza delle risorse e alla protezione delle acque. Il<br />
totale dei valori di base di tutte le aziende viene rapportato a questi mezzi finanziari ottenendo<br />
un coefficiente. Quest'ultimo indica l'aliquota del valore di base da versare alle aziende come<br />
contributo di transizione. Nel 2015 il coefficiente, pari a 0,2796, è stato decisamente più basso<br />
di quello del 2014 (0,4724). La crescente partecipazione ai programmi facoltativi nel quadro<br />
dei pagamenti diretti determina una riduzione dei mezzi finanziari a disposizione per il contributo<br />
di transizione e quindi anche del coefficiente e degli importi versati per azienda.<br />
Contributo di transizione 2015<br />
Unità<br />
Regione di<br />
pianura<br />
Regione<br />
collinare<br />
Regione di<br />
montagna<br />
Totale<br />
Aziende Numero 18 708 12 125 13 149 43 982<br />
Contributo per<br />
azienda<br />
fr. 4 324 3 979 3 710 4 045<br />
Totale 1 000 fr. 80 899 48 246 48 783 177 928<br />
Fonte: UFAG<br />
» A95<br />
La tabella seguente offre una panoramica sui contributi versati secondo i Cantoni e le zone<br />
agricole.<br />
Il versamento dei contributi di transizione è svincolato da fattori di produzione quali la superficie<br />
o il numero di animali ed è anche escluso dalla limitazione dei pagamenti diretti per unità<br />
standard di manodopera (USM). L'obiettivo è che non venga compromesso l'effetto ammortizzante<br />
del contributo di transizione. Quest'ultimo viene ridotto soltanto in caso di reddito o<br />
patrimonio elevato nonché di una flessione delle USM del 50 per cento e oltre rispetto all'anno<br />
di riferimento (anno con i pagamenti diretti generali più alti nel periodo 2011–2013).<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
249
Il mio Rapporto agricolo 152 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Effetto della limitazione del contributo di transizione 2015<br />
Aziende interessate Riduzione Riduzione per azienda<br />
Unità Numero fr. fr.<br />
Riduzioni a causa della diminuzione<br />
delle dimensioni<br />
aziendali (USM) di<br />
oltre il 50 per cento (rispetto<br />
all’anno di riferimento)<br />
Riduzioni a causa del reddito<br />
o del patrimonio<br />
505 1 153 756 2 285<br />
2 359 5 773 882 2 448<br />
Totale delle riduzioni 6 927 638<br />
Fonte: UFAG<br />
Philipp Meyer, UFAG, Settore Pagamenti diretti Basi, philipp.meyer@blw.admin.ch<br />
250<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 154 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Variazioni dei pagamenti diretti a livello aziendale e regionale<br />
In seguito alla revisione del sistema dei pagamenti diretti, entrato in vigore nel 2014, sono stati<br />
introdotti diversi programmi facoltativi. Segnatamente si tratta dei contributi per la qualità del<br />
paesaggio, per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita, per l'efficienza<br />
delle risorse e per le superfici per la biodiversità nella regione d'estivazione. Onde ammortizzare<br />
il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, sono inoltre stati introdotti contributi di transizione<br />
temporanei. Si è invece proceduto alla soppressione di misure nel quadro dei pagamenti<br />
diretti generali. Il sistema rivisto non prevede più il versamento di un contributo generale di<br />
superficie e i contributi per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo (contributo<br />
UBGFG) nonché per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione (contributo<br />
DACDP) sono stati trasferiti nei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento riferiti alla<br />
superficie.<br />
Il cambio di sistema ha comportato una ridistribuzione dei mezzi finanziari. Di seguito si spiega<br />
l’impatto della ripartizione dei pagamenti diretti tra il 2013 e il 2015 a livello aziendale e territoriale.<br />
Pagamenti diretti per azienda<br />
Se si considerano i pagamenti diretti erogati mediamente per azienda (cfr. grafico seguente),<br />
si constata che sono più cospicui nelle aziende ad alta quota. Da un'analisi dell’evoluzione<br />
dei pagamenti diretti si rileva che negli ultimi 3 anni quelli versati nelle zone collinare e di<br />
montagna I sono rimasti praticamente stabili. Nel 2015, le aziende delle zone di montagna<br />
II-IV, e in particolare quelle d'estivazione hanno ricevuto mediamente più pagamenti diretti<br />
rispetto al 2013. Le aziende di pianura hanno percepito meno pagamenti diretti rispetto a quelli<br />
di cui beneficiavano prima del cambio del sistema. Si noti che si tratta di valori medi e che i<br />
valori delle singole aziende possono discostarsi notevolmente.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
251
Il mio Rapporto agricolo 155 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Aziende con oltre 150 000 franchi di pagamenti diretti e rispettive caratteristiche<br />
Dal 2013 il numero di aziende che ogni anno ricevono più di 150 000 franchi di pagamenti<br />
diretti è aumentato passando da 1 029 a 1 310 unità (2014) per infine attestarsi a quota 1 366<br />
nel 2015. Ha quindi segnato una crescita del 33 per cento. Nonostante il notevole incremento,<br />
soltanto il 3 per cento circa delle aziende è direttamente interessato.<br />
Alla luce della variazione del numero di aziende per classi di pagamenti diretti versati per azienda,<br />
da un confronto degli anni 2013-2015 emerge il seguente quadro.<br />
Numero di aziende per classi di pagamenti diretti ricevuti<br />
Pagamenti diretti<br />
per azienda<br />
(in fr.)<br />
2013 2014 2015<br />
Aziende Quota Aziende Quota Aziende Quota<br />
300 000 34 0,1 % 48 0,1 % 61 0,1 %<br />
Totale 48 719 100 % 47 600 100 % 46 825 100 %<br />
Fonte: UFAG<br />
Dalla tabella si evince che il numero delle aziende non è aumentato soltanto nelle tre classi<br />
con pagamenti diretti superiori a 150 000 franchi, bensì, per lo meno in proporzione, anche<br />
in altre classi.<br />
Se si analizzano le aziende con oltre 150 000 franchi di pagamenti diretti dal profilo del tipo,<br />
si constata che quasi tutte hanno beneficiato della crescita, fatta eccezione per le aziende di<br />
trasformazione.<br />
252<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 156 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Numero delle aziende con oltre 150 000 franchi di pagamenti diretti per azienda e anno e<br />
variazione percentuale negli anni 2013–2015, secondo i tipi di azienda<br />
Tipo di azienda 2013 2014 2015 Entwicklung<br />
2013-2015<br />
110 Campicoltura 30 43 56 +86 %<br />
110 Colture speciali 26 32 34 +46 %<br />
120 Altra trasformazione<br />
120 Altro bestiame<br />
bovino<br />
1 0 1 0 %<br />
34 56 51 +47 %<br />
120 Vacche madri 98 178 180 +84 %<br />
120 Equini / ovini /<br />
caprini<br />
33 49 48 +54 %<br />
120 Trasformazione 25 10 9 -64 %<br />
120 Latte commerciale<br />
150 Aziende combinate,<br />
altre<br />
150 Aziende combinate,<br />
vacche madri<br />
150 Aziende combinate,<br />
non classificabili<br />
150 Aziende combinate,<br />
trasformazione<br />
348 480 482 +38 %<br />
188 204 226 +20 %<br />
55 64 71 +26 %<br />
62 59 65 +5 %<br />
129 135 143 +11 %<br />
Totale 1 029 1 310 1 366 +33 %<br />
Fonte: UFAG<br />
Si è registrata una crescita delle aziende nel gruppo che beneficia di oltre 150 000 franchi di<br />
pagamenti diretti (di seguito «aziende >150 000») in particolare per quelle dedite alla campicoltura<br />
o alla detenzione di vacche madri nonché per quelle con equini, ovini e caprini. Seppure<br />
in maniera diversa, tutti i tipi di aziende combinate ne hanno approfittato.<br />
Di seguito sono riportate le «aziende >150 000» alla luce di determinate caratteristiche strutturali.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
253
Il mio Rapporto agricolo 157 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
Numero delle aziende con oltre 150 000 franchi di pagamenti diretti per azienda e anno e<br />
variazione percentuale negli anni 2013–2015, secondo determinate caratteristiche strutturali<br />
Tipo di azienda 2013 2014 2015 Evoluzione 2013–<br />
2015<br />
Tutte le aziende 1 029 1 310 1 366 33 %<br />
USM medie di tali<br />
aziende<br />
di cui meno di 40 ha<br />
SAU<br />
di cui comunità aziendali<br />
6 5,8 5,8 -3 %<br />
22 56 56 155 %<br />
307 290 297 -3 %<br />
di cui bio 235 388 390 66 %<br />
di cui con riduzioni<br />
USM<br />
di cui nella regione<br />
di pianura<br />
di cui nella regione<br />
di montagna<br />
di cui con oltre il 50<br />
% di SPB<br />
di cui con oltre il 25<br />
% di SPB<br />
pianura, non bio,<br />
non CA,
Il mio Rapporto agricolo 158 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
facoltativi nel quadro dei pagamenti diretti si è tradotta in un aumento del numero delle aziende<br />
che percepiscono più di 150 000 franchi di pagamenti diretti.<br />
Un altro motivo è dato dal mutamento strutturale che ha comportato una flessione del numero<br />
di aziende e la crescita della superficie delle aziende. Nel 2015 il numero di aziende gestite<br />
tutto l'anno, che hanno ricevuto pagamenti diretti, è sceso dell'1,6 per cento rispetto al 2014;<br />
l'anno precedente il calo era stato del 2,3 per cento. La dimensione media delle aziende aventi<br />
diritto ai pagamenti diretti è passata da 22,29 ettari di SAU nel 2013 a 24,91 ettari di SAU<br />
nel 2015 (+ 12 %). Considerato che il preventivo rimane stabile e che i fondi devono essere<br />
ripartiti tra un numero sempre minore di aziende, aumenta l'importo dei pagamenti diretti<br />
versato mediamente per azienda.<br />
Se si osservano le variazioni dei pagamenti diretti per azienda, è evidente che, oltre al preventivo<br />
della Confederazione e all'impostazione dei pagamenti diretti, sull'evoluzione ha influito<br />
in misura considerevole il mutamento strutturale.<br />
Evoluzione della ripartizione territoriale dei pagamenti diretti<br />
Sulla scorta dei dati relativi ai pagamenti diretti versati alle singole aziende nel 2013 e nel<br />
2015, il grafico seguente illustra come è cambiata, in percentuale, la ripartizione dei fondi<br />
secondo il nuovo sistema nei Comuni svizzeri:<br />
» A96<br />
Tendenzialmente si osserva che sono stati erogati più pagamenti diretti alle aziende dei Comuni<br />
dell'arco alpino e giurassiano. La maggior parte delle aziende dei Comuni dell'Altipiano,<br />
invece, riceve meno pagamenti diretti rispetto al 2013. Un quadro analogo si riscontra anche<br />
confrontando le variazioni dei pagamenti diretti versati per zona.<br />
Il trasferimento dei contributi dalla regione di pianura e da quella collinare alla regione di montagna<br />
era stato auspicato. Le variazioni territoriali nella ripartizione dei pagamenti diretti sono<br />
riconducibili ai cambiamenti intervenuti a livello di strumenti.<br />
• Il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio e quello per le difficoltà di<br />
produzione aumentano in funzione della zona.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
255
Il mio Rapporto agricolo 159 / 222<br />
POLITICA > PAGAMENTI DIRETTI<br />
• Contributi, quali il contributo d'estivazione o il contributo di declività maggiorato, che<br />
vanno in primo luogo a beneficio della regione di montagna, sono stati aumentati.<br />
• Il contributo per le zone in forte pendenza, introdotto con la PA 14-17, va praticamente<br />
a beneficio soltanto delle regioni collinare e di montagna dove sono ubicate le aziende<br />
con superfici molto ripide. Lo stesso vale per il contributo per la biodiversità per superfici<br />
inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione.<br />
• I contributi per la biodiversità a favore della regione di montagna sono stati aumentati. Ciò<br />
riguarda i contributi per il livello qualitativo II e il contributo per l'interconnessione.<br />
• Il contributo per la qualità del paesaggio versato per ettaro di superficie agricola utile nella<br />
regione di montagna è leggermente superiore a quello erogato nella regione di pianura.<br />
• La partecipazione al programma di produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita<br />
è decisamente superiore nella regione di montagna rispetto alla regione di pianura.<br />
Anche all'interno delle zone si rilevano delle ridistribuzioni. Ciò è dovuto al fatto<br />
che i contributi riferiti agli animali sono stati trasferiti nei contributi per la sicurezza<br />
dell'approvvigionamento erogati in funzione della superficie. Ne approfittano le aziende delle<br />
regioni in cui viene praticata un'agricoltura estensiva (p.es. arco giurassiano, Vallese, Alpi orientali).<br />
Simon Lanz, UFAG, Economia agricola, spazio rurale e strutture, simon.lanz@blw.admin.ch<br />
Susanne Menzel, UFAG, Economia agricola, spazio rurale e strutture, susanne.menzel@blw.admin.ch<br />
256<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 161 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
Miglioramenti strutturali<br />
I provvedimenti nel settore dei miglioramenti strutturali consentono di migliorare le condizioni<br />
di vita ed economiche nelle aree rurali, segnatamente nella regione di montagna e nelle<br />
regioni periferiche. L'attenzione non è puntata soltanto sull'agricoltura, bensì vengono perseguiti<br />
anche altri obiettivi fondamentali per le aree rurali. I provvedimenti collettivi seguono<br />
sempre il concetto di multifunzionalità perché non ne beneficia soltanto l'agricoltura, bensì<br />
anche la collettività, gli amanti della natura, le persone in cerca di spazi ricreativi e altri interessati<br />
nelle aree rurali. I contributi per i miglioramenti strutturali sono a favore dell'agricoltura,<br />
della pianificazione del territorio, della biodiversità e della natura in generale.<br />
Al fine di rilevare le esigenze di questo settore, da alcuni anni, si ricorre alla cosiddetta pianificazione<br />
agricola (PAgr). Grazie a questa procedura standardizzata e mirata si rilevano e si ponderano<br />
i vari interessi. Ciò consente di ottenere una visione d'insieme equilibrata, che serve<br />
da base per soluzioni ampiamente sostenute e condivise dai diversi interessati. I deficit provocati,<br />
ad esempio, dal cambiamento climatico in atto sotto forma di carenza idrica possono<br />
così essere affrontati tempestivamente. Allo stesso modo, è possibile porre per tempo le basi<br />
di progetti sulle infrastrutture di più ampia portata e delimitare le aree necessarie.<br />
I provvedimenti individuali oltre a perseguire obiettivi economici per gli agricoltori ne perseguono<br />
altri relativi alla protezione degli animali e dell'ambiente, come la costruzione di sistemi<br />
di stabulazione particolarmente rispettosi delle esigenze degli animali o provvedimenti<br />
per la produzione a basse emissioni. Anche in questo caso il raggiungimento degli obiettivi è<br />
nell'interesse non soltanto dell'agricoltura, bensì anche dell'ambiente, del benessere degli<br />
animali e della collettività.<br />
Gli aiuti agli investimenti per i miglioramenti strutturali vengono concessi quali incentivi<br />
all’autosostegno a favore di provvedimenti individuali o collettivi. Sono disponibili due strumenti:<br />
• contributi con partecipazione dei Cantoni, prevalentemente per provvedimenti collettivi;<br />
• crediti d’investimento sotto forma di mutui rimborsabili ed esenti da interessi, prevalentemente<br />
per provvedimenti individuali.<br />
Gli aiuti agli investimenti sostengono le infrastrutture agricole e rendono possibile<br />
l’adeguamento delle aziende ai costanti cambiamenti delle condizioni quadro. Riducendo i<br />
costi di produzione e promuovendo lo sviluppo ecologico è possibile migliorare la competitività<br />
di un’agricoltura dedita alla produzione sostenibile. Anche in altri Paesi, in particolare nell’UE<br />
(2° pilastro della PAC), gli aiuti agli investimenti agricoli sono provvedimenti importanti volti<br />
a promuovere le aree rurali. Tuttavia, nell’UE tali aiuti, detti sovvenzioni, sono erogati esclusivamente<br />
sotto forma di contributi che quindi non devono essere rimborsati.<br />
Mezzi finanziari per i contributi<br />
Nel 2015 per le bonifiche fondiarie e gli edifici rurali sono stati erogati contributi per un totale<br />
di 94,7 milioni di franchi. Inoltre, l’UFAG ha approvato nuovi progetti con contributi federali<br />
per un importo complessivo di 91,7 milioni di franchi. Il volume degli investimenti totali<br />
è stato di 513,2 milioni di franchi. L’ammontare dei contributi federali relativi ai progetti approvati<br />
non corrisponde all’importo iscritto nella rubrica del preventivo «Miglioramenti strutturali<br />
agricoli», in quanto l’assicurazione di un contributo e il relativo versamento avvengono<br />
soltanto eccezionalmente nello stesso anno. Per un progetto approvato viene spesso assicurata<br />
soltanto una tranche.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
257
Il mio Rapporto agricolo 162 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
» A97<br />
» A98<br />
Mezzi finanziari per i crediti d’investimento<br />
Nel 2015 i Cantoni hanno autorizzato crediti d’investimento per un ammontare complessivo<br />
di 303,3 milioni di franchi da destinare a 1822 casi. L’82,8 per cento di tale importo è stato<br />
riservato al finanziamento di provvedimenti individuali, il 10,8 per cento al sostegno di provvedimenti<br />
collettivi. A favore dei progetti collettivi nella regione di montagna possono venir<br />
concessi anche crediti di transizione, ossia crediti di costruzione con una decorrenza di tre anni<br />
al massimo.<br />
Crediti d’investimento 2015<br />
Numero In milioni di franchi Quota %<br />
Provvedimenti individuali 1 602 251,2 82,8<br />
Provvedimenti collettivi,<br />
crediti di costruzione esclusi<br />
183 32,8 10,8<br />
» A99<br />
» A100<br />
Crediti di costruzione 37 19,3 6,4<br />
Totale 1 822 303,3 100<br />
258<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 163 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
Fonte: UFAG<br />
I crediti per i provvedimenti individuali hanno riguardato principalmente l’aiuto iniziale, la<br />
diversificazione nonché la costruzione o la trasformazione di edifici d’abitazione e di edifici<br />
rurali. Vengono rimborsati mediamente sull’arco di 13,2 anni.<br />
Nel settore dei provvedimenti collettivi sono stati stanziati crediti soprattutto per le bonifiche<br />
fondiarie, gli edifici e le installazioni per l’economia lattiera nonché per la lavorazione, lo stoccaggio<br />
e lo smercio di prodotti agricoli come pure per l’acquisto in comune di macchine o veicoli.<br />
Nel 2015 la Confederazione ha assegnato ai Cantoni nuovi mezzi finanziari pari a 15,3 milioni di<br />
franchi che, unitamente agli importi costantemente rimborsati, vengono utilizzati per la concessione<br />
di nuovi crediti. In virtù dell’articolo 85 capoverso 3 LAgr, sono stati trasferiti 7 milioni<br />
di franchi dal Fonds de roulement per gli aiuti aziendali a quello per i crediti d’investimento.<br />
L’attivo circolante del Fonds de roulement, istituito nel 1963, ammonta a 2,534 miliardi di<br />
franchi.<br />
» A101<br />
Samuel Reusser, UFAG, Settore Sviluppo delle aziende, samuel.reusser@blw.admin.ch<br />
Willy Riedo, UFAG, Settore Sviluppo delle aziende<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
259
Il mio Rapporto agricolo 169 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
Misure sociali collaterali<br />
Aiuti per la conduzione aziendale<br />
Gli aiuti per la conduzione aziendale sono concessi sotto forma di mutui esenti da interessi e<br />
servono a evitare o a superare ristrettezze finanziarie temporanee non imputabili al gestore.<br />
Gli effetti degli aiuti per la conduzione aziendale corrispondono a quelli dello sdebitamento<br />
indiretto della singola azienda.<br />
Nel quadro degli aiuti per la conduzione aziendale, nel 2015 sono stati concessi mutui per un<br />
importo totale di 16,9 milioni di franchi a favore di 134 casi. Ciascun mutuo ammonta mediamente<br />
a 126 118 franchi e viene rimborsato sull’arco di 11,3 anni.<br />
Mutui nel quadro dell’aiuto per la conduzione aziendale – 2015<br />
Numero<br />
In milioni di franchi<br />
Rifinanziamento di debiti esistenti 59 9,73<br />
Superamento di una difficoltà finanziaria<br />
eccezionale<br />
Mutuo in caso di cessazione<br />
dell'attività<br />
74 7,09<br />
1 0,08<br />
Totale 134 16,90<br />
Fonte: UFAG<br />
» A102<br />
Nel 2015 ai Cantoni sono stati assegnati nuovi fondi federali pari a 0,15 milioni di franchi. In<br />
seguito all’entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria (NPC), la partecipazione cantonale<br />
ammonta per lo meno all’importo di questi nuovi fondi federali. I nuovi mezzi finanziari<br />
della Confederazione e dei Cantoni, unitamente agli importi costantemente rimborsati, vengono<br />
utilizzati per concedere nuovi mutui. L’attivo circolante del Fonds de roulement, istituito<br />
nel 1963 con nuovi mezzi finanziari della Confederazione e con importi rimborsati, ammonta,<br />
unitamente alle quote dei Cantoni, a 222 milioni di franchi circa.<br />
Aiuti per la riqualificazione<br />
Gli aiuti per la riqualificazione agevolano la conversione a una professione non agricola delle<br />
persone indipendenti attive nel settore primario. Tale misura comprende contributi ai costi di<br />
riqualificazione e di sostentamento per capiazienda che non hanno ancora compiuto il 52esimo<br />
anno di età. La concessione di un simile aiuto presuppone l’abbandono dell’azienda agricola.<br />
Nell’anno oggetto del rapporto in un caso sono stati assicurati aiuti per la riqualificazione per<br />
un importo di 123 564 franchi. Considerati gli aiuti per la riqualificazione concessi negli anni<br />
precedenti, a due persone in fase di riqualificazione sono stati versati 39 750 franchi. La durata<br />
della riqualificazione varia, a seconda della formazione, da 1 a 3 anni e la gamma delle professioni<br />
è ampia e spazia da quelle in campo sociale a quelle artigianali e commerciali. Il suddetto<br />
aiuto è stato versato per la formazione presso una scuola universitaria professionale.<br />
» A103<br />
I motivi all’origine della bassa partecipazione a questo programma possono essere stati, in<br />
un primo tempo, la sua scarsa notorietà e, in certi periodi, anche le prospettive economiche<br />
sfavorevoli in altri campi professionali. Anche gli oneri imposti per l’ottenimento degli aiuti<br />
potrebbero costituire un ostacolo, soprattutto quello della definitiva cessazione dell’attività.<br />
Samuel Reusser, UFAG, Settore Sviluppo delle aziende, samuel.reusser@blw.admin.ch<br />
Willy Riedo, UFAG, Settore Sviluppo delle aziende<br />
260<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 172 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
Ricostruzione della funivia sull'Alpe Sigel<br />
Il crollo della funivia avvenuto nell’estate 2008 ha messo a repentaglio la gestione dell’Alpe<br />
Sigel, nell’Alpstein, nell’Appenzello Interno, se non altro precludendo la possibilità di pascolarvi<br />
le vacche. L’eventualità di creare un allacciamento alternativo con una strada è stata<br />
esclusa a priori poiché l’Alpe Sigel è ubicato in un sito protetto dall'Inventario federale dei paesaggi,<br />
siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (sito IFP) e, inoltre, i costi sarebbero<br />
stati troppo elevati. Il fatto di sfruttare la nuova funivia anche a scopo turistico ha permesso<br />
di trovare una soluzione sostenibile nonostante le limitazioni di gestione a livello stagionale<br />
e giornaliero e la riduzione di un terzo delle capacità di trasporto disponibili. La funivia è un<br />
esempio ben riuscito della simbiosi tra economia alpestre e turismo<br />
Il consorzio alpestre Sigel<br />
L'Alpe Sigel, ubicato sulla prima montagna della catena montuosa dell'Alpstein, si estende su<br />
una superficie di 113 ettari, è esposto a sud-est e spazia da un'altitudine di 1760 metri s.l.m.<br />
a 1210 metri s.l.m. Oltre a 9 ettari di bosco e 5 di rocce, l'alpe comprende quasi 100 ettari di<br />
pascoli d'estivazione.<br />
Le sei cascine, di cui è proprietario il Cantone, sono organizzate in una società cooperativa di<br />
diritto privato e gestite da cinque famiglie contadine. Gli edifici alpestri si ergono in posizione<br />
centrale, a mo’ di borgo, a 1585 metri s.l.m. e sugli alpeggi vengono estivate mediamente 170<br />
unità di bestiame grosso per 85 giorni; nel 2015 erano, segnatamente, 106 vacche, 101 manzi<br />
e 37 vitelli. Ogni estate, le famiglie alpigiane dell’Alpe Sigel mungono 80 000 chilogrammi di<br />
latte. In passato, nella cascina «Haseblatte» vi era una centrifuga comune per la produzione di<br />
panna, oggi tutti gli alpigiani consegnano il latte come latte commerciale.<br />
Carta geografica dell’Alpe Sigel<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
261
Il mio Rapporto agricolo 173 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
L’ubicazione dell'Alpe Sigel nel sito IFP «Säntisgebiet» vincola le possibilità di rinnovamento<br />
degli edifici alpestri: non vengono autorizzate stalle nuove, più grandi, che potrebbero accogliere<br />
animali di più alpi. Questo è quanto è emerso durante la costruzione della nuova cascina<br />
sull’alpe «Langmelster» (2013/14). Lo stesso Cantone non vuole che il carattere dell'Alpe<br />
cambi profondamente.<br />
19 ettari della superficie d'estivazione sono delimitati come pascoli secchi d'importanza nazionale,<br />
segno di un problema latente: lo scarso approvvigionamento idrico. Dalla roccia calcarea,<br />
attraversata da fessure e fori causati dagli agenti atmosferici, non sgorga alcuna sorgente.<br />
Per tale motivo, l'acqua piovana viene raccolta in diversi serbatoi. Inoltre, per l'abbeveraggio<br />
degli animali si usano le «Söören», stagni d'origine naturale o rivestiti con pellicola. L'ascesa<br />
all'alpe avviene percorrendo la ripidissima Brüeltobelstrasse fino al ristorante «Plattenbödeli»<br />
e salendo quindi attraverso il «Chrutzog» fino alle stalle alpestri. Dall'accesso a Brüeltobel si<br />
deve superare un dislivello di 660 metri in 3 chilometri: si direbbe un’odissea!<br />
Associazione sindacale per la bonifica fondiaria dell’Alpe Sigel<br />
Oltre al consorzio alpestre, nel 1963 è stata fondata anche un’associazione di diritto pubblico<br />
per la bonifica fondiaria, i cui statuti hanno come obiettivo:<br />
la costruzione e la manutenzione<br />
• di una funivia con limitato trasporto di viaggiatori,<br />
• di una rete viaria dalla stazione a monte agli edifici alpestri,<br />
• di casse per la raccolta del liquame con impianto di spandimento,<br />
• di una centrale del latte,<br />
• di un impianto telefonico e, infine,<br />
• l’acquisto di un monoasse Rapid per il trasporto e l’utilizzo dell’impianto di spandimento.<br />
L’Associazione si è data da fare e già a maggio del 1964 è stata messa in servizio una funivia a<br />
va e vieni su binario unico: era lunga 1115 metri per un dislivello di 660 metri e un carico utile<br />
di 250 chilogrammi. I costi di costruzione ammontavano a 135 000 franchi.<br />
30 anni dopo la funivia ha dovuto essere ristrutturata: sono stati sostituiti l’argano e le bobine<br />
e il dispositivo meccanico è stato rimpiazzato da uno elettronico, con costi totali di 400 000<br />
franchi. Contrariamente al Cantone, per via del previsto trasporto di turisti l'UFAG aveva ridotto<br />
del 25 per cento i costi sussidiabili, portandoli a 300 000 franchi. Grazie ai lavori si è potuta<br />
ridurre la durata del tragitto, portandola da 11 minuti a 7½, ma non si è riusciti ad aumentare<br />
il carico utile.<br />
Kurz danach kam die Idee einer Alpkäserei beim „Plattenbödeli“ auf. Die Sigelsennen und -<br />
sennerinnen wollten sich diesem Projekt anschliessen. Die Produktion von Vollrahm wurde als<br />
nicht zukunftsträchtig beurteilt, die Vollmilchablieferung wegen der langen Transportdauer<br />
mit der Seilbahn, deren Kapazität und befürchteter Folgekosten (Tankanlage bei der Talstation)<br />
als ebenso schwierig wie aufwändig eingeschätzt.<br />
Poco dopo era nata l'idea di realizzare un caseificio alpestre presso il «Plattenbödeli». Gli alpigiani<br />
avrebbero voluto aderire a tale progetto, ma la produzione di panna intera non era stata<br />
considerata promettente e la consegna di latte era ritenuta difficile e dispendiosa a causa dei<br />
lunghi tempi di trasporto con la funivia, della capacità di quest'ultima e del timore di costi correlati<br />
(installazione di cisterne presso la stazione a valle).<br />
262<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 174 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
Il 30 giugno 1998, l'esperto dell'UFAG effettuava un sopralluogo sull'Alpe Sigel; il progetto<br />
prevedeva la costruzione di un lattodotto dal «Plattenbödeli» verso valle, lungo 750 metri circa,<br />
su un dislivello di 350 metri. La tubazione, però, non sarebbe servita solo al trasporto di latte<br />
a valle, bensì anche a quello a monte di acqua e siero per i suini. Si prevedevano costi per<br />
un ammontare di 130 000 franchi. Il caseificio, che durante la stagione d'estivazione avrebbe<br />
trasformato latte sia dell'Alpe Sigel sia di altri alpi per un totale di circa 200 000 chilogrammi,<br />
sarebbe costato 670 000 franchi. Nonostante l'UFAG si fosse espresso a favore e il forte interesse<br />
fosse tangibile, questo progetto si arenò al momento del finanziamento. Gli alpi interpellati<br />
non potevano o non volevano fornire i necessari fondi propri.<br />
Nel quadro di un progetto successivo, l'Alpe avrebbe dovuto essere allacciato alla rete di distribuzione<br />
di energia elettrica. Il 29 agosto 2007, però, il Consiglio distrettuale di Schwende<br />
respinse un sostegno adducendo che l'elettricità era destinata, di base, al comprensorio con<br />
insediamenti sparsi abitato tutto l'anno e non alla regione d'estivazione.<br />
Crollo e ricostruzione della funivia dell'Alpe Sigel<br />
Il 9 giugno 2008, alle 19.30, durante una risalita crollò la cabina. Fortunatamente a bordo<br />
non vi erano passeggeri, ma solo bidoni del latte vuoti. Dalla perizia dell'organo di controllo<br />
del Concordato intercantonale per teleferiche ed impianti di risalita era emerso che forti raffiche<br />
di vento e il freno azionatosi automaticamente avevano generato delle vibrazioni che, a<br />
loro volta, avevano causato una collisione tra la fune di avvolgimento e la cabina. Il carrello<br />
della cabina era stato sollevato dalla fune portante. Malgrado ciò, si era potuto far ripartire la<br />
funivia, ma la fune traente si lacerò a monte e la cabina crollò. La causa dell’incidente non fu<br />
una violazione dell'obbligo di diligenza, ma la combinazione tra il sistema della funivia e le<br />
condizioni topografiche e meteorologiche sfavorevoli.<br />
Ciononostante, non si prese in considerazione né una riparazione della funivia (dopo il rinnovamento<br />
le prescrizioni erano diventate più severe) né un allacciamento dell’Alpe con una<br />
strada. L’Associazione optò per il seguente progetto:<br />
• costruzione di una funivia bifune a va e vieni con due cabine o, più precisamente, con una<br />
cabina e una barella,<br />
• in ognuna delle stazioni una fune portante saldamente ancorata come carreggiata,<br />
• una fune traente ad anello chiuso, alla quale sono fissate le cabine.<br />
La stazione a valle sarebbe stata ricostruita nello stesso posto, quella a monte un po’ più verso<br />
valle. Il nuovo carico utile sarebbe stato aumentato a 640 chilogrammi per consentire, in caso<br />
d'emergenza, anche il trasporto di animali, mentre la durata del tragitto si sarebbe ridotta a<br />
6 minuti. Stima dei costi: 2 800 000 franchi.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
263
Il mio Rapporto agricolo 175 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
Stazione a valle della nuova funivia dell’Alpe Sigel<br />
Contro il progetto si schierarono il Bergwirteverein Alpstein, pro natura e un privato. Anche<br />
dal sopralluogo di UFAG e Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio<br />
CNFP del 22 luglio 2009 emersero esigenze simili, segnatamente: limitazioni a livello stagionale<br />
e giornaliero dell'utilizzo a scopo turistico e nessun ristorante. A queste si aggiunsero richieste<br />
riguardanti la struttura delle facciate e del tetto.<br />
Dopo tre difficili estati senza funivia, l’Associazione accettò le seguenti limitazioni:<br />
• trasporto turistico solo da maggio a ottobre, dalle 8 alle 18,<br />
• nessun trasporto di attrezzature sportive (parapendio, mountain bike),<br />
• prezzo della corsa inferiore di 7 franchi al massimo a quello degli impianti a fune del Cantone<br />
di Appenzello Interno con concessione federale,<br />
• concessione per soli quattro dei sei posti a sedere per cabina,<br />
• demolizione della vecchia stazione a monte, nessun utilizzo come rimessa.<br />
L'UFAG riconobbe costi sussidiabili per un milione di franchi e stanziò anche un credito<br />
d'investimento. Il Cantone e il Distretto di Schwende fornirono la necessaria controprestazione.<br />
Il 14 giugno 2010 iniziarono i lavori e il 1° maggio 2011 la funivia dell'Alpe Sigel compì il suo<br />
primo viaggio.<br />
264<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 176 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
Barella per il trasporto merci sull’Alpe Sigel<br />
La capacità di trasporto è stata sì aumentata grazie alle due cabine e all'accorciamento della<br />
durata del tragitto, ma l'Alpe Sigel non è stato, come si temeva, preso d'assalto dai turisti.<br />
La funivia, tuttavia, può sopravvivere finanziariamente solo mediante un'efficiente sinergia<br />
tra economia alpestre e turismo: senza possibilità di trasporto del latte niente vacche, senza<br />
vacche niente mantenimento delle tradizioni con il carico degli alpi, senza tradizioni vive meno<br />
turisti che, tra l'altro, usano anche la funivia: uno scambio reciproco.<br />
Persone trasportate/viaggi 2015 (cifre arrotondate)<br />
Economia alpestre:<br />
Turismo:<br />
1 700 persone trasportate (proprietari delle cascine e<br />
gestori)<br />
13 800 persone trasportate<br />
Numero di viaggi: 6000<br />
» Pagina Internet della funivia dell'Alpe Sigel<br />
Albert Elmiger, Meliorationsamt/Investitionskreditkasse, Cantone Appenzello Interno<br />
Samuel Reusser, UFAG, Settore Sviluppo delle aziende, samuel.reusser@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
265
Il mio Rapporto agricolo 177 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
Manutenzione delle strade agricole<br />
Per l’agricoltura è essenziale disporre di una rete di strade agricole funzionale. Spesso, però,<br />
i responsabili della loro manutenzione non riescono a far fronte a questo compito complesso<br />
e costoso per mancanza di conoscenze tecniche e organizzazione. La Confederazione e il Cantone<br />
hanno deciso pertanto di sostenere lo spazio rurale con un servizio di consulenza e con<br />
contributi economici. Siccome molti Comuni non lo sanno, il Cantone Basilea Campagna, nel<br />
2015, ha organizzato una riunione informativa e ha pubblicato un opuscolo sul tema della manutenzione.<br />
Cause dei danni alle strade<br />
I danni alle strade possono avere svariate cause. Oltre a lacune di natura edile e alla naturale<br />
usura dei materiali di costruzione, vi sono molti altri fattori che possono essere prevenuti mediante<br />
una buona organizzazione dei lavori di manutenzione.<br />
Un elemento importante, che può causare rapidamente danni di grave entità, è l'acqua. Le<br />
acque superficiali provenienti da precipitazioni o scioglimento delle nevi che defluiscono senza<br />
controllo causano erosione, dilavamento e smottamenti. Unito all'effetto del gelo e del disgelo,<br />
l'afflusso d'acqua nello strato portante provoca l’apertura di fessure, fornendo così terreno<br />
fertile all'erosione e alla perdita di portanza. In questo modo si possono danneggiare<br />
anche ponti o altri ripari.<br />
Decisivo è anche il comportamento degli utenti delle strade. È impossibile evitare che, con il<br />
tempo, la gestione agricola e silvicola così come il traffico privato comportino usura, buche,<br />
tracce di pneumatici e fessure, compressioni e affossamenti nel corpo stradale e nelle banchine.<br />
Tuttavia, le strade possono avere vita più lunga, se si osservano i seguenti punti:<br />
266<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 178 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
Carenze nell’evacuazione delle acque sulle strade: causa frequente di danni.<br />
• non transitare sempre sulla stessa tratta, altrimenti le corsie nelle quali ristagna acqua e si<br />
infiltra materiale diventano sempre più profonde;<br />
• evitare carichi pesanti e velocità eccessiva, soprattutto in caso di condizioni climatiche sfavorevoli<br />
(gelo/disgelo);<br />
• nello sgomberare la neve assicurarsi di non danneggiare lo strato di copertura e la banchina;<br />
inoltre, le strade di marna non andrebbero cosparse di sale;<br />
• durante i lavori nei campi non fare inversione sulla strada, bensì sulla testata, affinché il<br />
rivestimento e il ciglio stradale non vengano compressi;<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
267
Il mio Rapporto agricolo 179 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
• non arare troppo vicino alla banchina, altrimenti la carreggiata potrebbe subire gravi danni.<br />
In caso di rivestimento duro, la distanza di aratura dalla carreggiata deve essere di almeno<br />
un metro, poiché lo strato di fondazione non visibile in genere è più largo del rivestimento.<br />
In caso di rivestimento con marna è sufficiente lasciare una distanza di 0,5 metri;<br />
• rimuovere immediatamente lo sporco, che altrimenti penetra nello strato di copertura offrendo<br />
terreno fertile per le piante.<br />
La carreggiata può essere sporcata anche dalla vegetazione sul ciglio stradale, tramite la caduta<br />
di foglie e aghi. Le piante invadono la strada e le radici degli alberi si spingono fin nello strato<br />
di fondazione, negli impianti di drenaggio e nei manufatti di sostegno. Inoltre, gli alberi e gli<br />
arbusti restringono il profilo stradale. Se i veicoli devono deviare a causa di tali ostacoli, il<br />
tracciato si sposta sul terreno coltivo e i bordi stradali vengono danneggiati.<br />
Importanza della manutenzione corrente<br />
La manutenzione corrente garantisce la funzionalità della strada. Essa comprende le seguenti<br />
misure:<br />
• controllo periodico degli impianti;<br />
• pulizia e cura di carreggiate, pozzetti e impianti di drenaggio;<br />
• manutenzione invernale accurata;<br />
• riparazione corrente di danni locali di piccola entità con mezzi semplici.<br />
Questi interventi vanno eseguiti in caso di necessità, tuttavia almeno una volta l'anno.<br />
Periodo ed effetto delle diverse misure di manutenzione (fonte: UFAG)<br />
Ogni 8 anni circa per le strade di marna e ogni 12 per quelle con rivestimento bisogna inoltre<br />
effettuare la cosiddetta manutenzione periodica, volta a mantenere la sostanza e il valore delle<br />
strade e comprendente lavori completi di riparazione e rinnovo con attrezzature e macchinari<br />
pesanti. Essa include, segnatamente:<br />
268<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 180 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
• riprofilatura;<br />
• rinnovo dello strato di copertura (p.es. strato d'usura per le strade di marna, trattamento<br />
della superficie per le strade con rivestimento)<br />
• riparazione degli impianti di drenaggio (p.es. spurgo, controllo tramite telecamere, rimozione<br />
di depositi di calcare), sostituzione di tubi di pozzetti e armature difettosi;<br />
• riparazione di manufatti (muri, gabbioni, cassoni in legno, ponti, eccetera).<br />
Se non è più possibile mantenere lo stato richiesto mediante lavori periodici di ripristino, la<br />
strada ha raggiunto la fine del proprio ciclo di vita tecnico e va sostituita.<br />
Con il tempo, inoltre, una strada può dover essere ampliata, per poter soddisfare meglio nuove<br />
esigenze, in genere più elevate. Può anche succedere che, a causa di eventi naturali, un tratto<br />
di strada venga distrutto e, a seconda dei casi, può risultare equivalente intervenire con misure<br />
di ripristino o con una sostituzione.<br />
Pianificazione della manutenzione<br />
La manutenzione di una strada dovrebbe iniziare subito dopo la sua costruzione, al fine di riconoscere<br />
i danni allo stadio iniziale ed eliminarli. Onde eseguire al meglio la manutenzione<br />
di tutte le strade all'esterno della zona urbana, si consiglia ai Comuni di allestire un regolamento<br />
per la manutenzione, con il quale disciplinarne l'organizzazione e il finanziamento e<br />
renderla vincolante per gli utenti delle strade. Risulta inoltre opportuno raccogliere dati importanti<br />
sulla progettazione, la realizzazione e lo stato dei lavori di manutenzione eseguiti.<br />
Va altresì osservato che già prima della costruzione di una strada vengono prese delle decisioni<br />
che avranno ripercussioni sulla manutenzione e sui relativi costi. Sulla base delle funzioni<br />
delle strade, descritte nella mappa della rete viaria dell'intero Comune, come vie d'accesso<br />
alle aziende o strade per il trasporto di legname, si definiscono i tipi di strada e gli standard<br />
d'esecuzione. Nella scelta dello strato di copertura bisogna tener conto che la manutenzione<br />
corrente delle strade di marna è più dispendiosa, ma quella periodica delle strade con rivestimento<br />
è più cara. Sul lungo termine, pertanto, le prime possono spesso risultare decisamente<br />
più convenienti delle seconde. Nello scegliere lo strato di copertura, tuttavia, è importante<br />
anche tener conto della situazione in loco.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
269
Il mio Rapporto agricolo 181 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
Perfezionamento professionale: riunione informativa e opuscolo<br />
sulla manutenzione<br />
Costruzione di una strada nella miglioria integrale Blauen.<br />
Il 15 settembre 2015, la Divisione Migliorie del Centro agricolo Eberein ha organizzato una riunione,<br />
nel Comune di Brislach, sul tema «Corretta manutenzione di strade agricole». L'evento<br />
ha suscitato enorme interesse: vi hanno partecipato numerosi consiglieri comunali e collaboratori<br />
comunali del settore del genio civile, membri di corporazioni cittadine e alcuni ingegneri.<br />
I primi interventi hanno trattato le basi di tematiche come la procedura di miglioria e il finanziamento,<br />
il regolamento per la manutenzione e la pianificazione della rete viaria nonché i<br />
principi della manutenzione stradale. Quindi, sulla scorta di foto di danni su una strada asfaltata<br />
e una di marna, si è discusso delle cause e delle possibili misure nonché della corretta manutenzione<br />
di questi tipi di strada. I collaboratori comunali di Brislach hanno esposto diverse<br />
modalità di rimozione della vegetazione lungo le strade e spiegato la problematica del tenore<br />
di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) nei rivestimenti di catrame<br />
Durante la riunione, la Divisione Migliorie ha inoltre presentato il nuovo opuscolo sulla manutenzione,<br />
nel quale si spiega in che modo le strade possono subire danni, cosa si intende per<br />
«manutenzione» e come la si può organizzare. Inoltre, alcune casistiche di danni sono corredate<br />
di una spiegazione con le possibili cause e misure. L'opuscolo è già consultabile sui siti<br />
Internet del Centro agricolo Eberein e di Suissemelio e a breve sarà disponibile anche su Wikimelio.<br />
Barbara Meier, Centro agricolo Ebenrain<br />
Samuel Reusser, UFAG, Settore Sviluppo delle aziende, samuel.reusser@blw.admin.ch<br />
270<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 182 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
Intervento ecologico minimo nella costruzione di strade<br />
Nell’ambito della miglioria integrale di St. Peter-Pagig/Peist nella valle grigionese di Schanfigg,<br />
nel 2015, al di sopra dei confini del bosco, è stato realizzato un nuovo accesso principale<br />
ai prati montani. La strada si snoda per un lungo tratto tra prati secchi, ai margini di una zona<br />
palustre di importanza nazionale. Per tutto il tratto stradale le scarpate sono state rivestite<br />
da reticolato erboso; fin dall’epoca dei lavori il nuovo tracciato è stato adattato in maniera ottimale<br />
al territorio, praticamente senza intaccare la vegetazione circostante. Il metodo offre<br />
altri vantaggi decisivi e può pertanto essere utilizzato efficacemente anche in siti meno sensibili<br />
dal profilo ecologico.<br />
Esame approfondito dell’impatto ambientale<br />
Durante la fase di approvazione, la miglioria integrale di St. Peter-Pagig/Peist nella valle grigionese<br />
di Schanfigg è stata sottoposta, come tutti i progetti di ampia portata nel quadro dei<br />
miglioramenti strutturali, a un esame approfondito dell'impatto ambientale. Una parte considerevole<br />
dei prati da sfalcio del comprensorio si trova al di sopra dei confini del bosco in siti<br />
sensibili dal profilo paesaggistico ed ecologico, nei quali è prescritto un particolare rispetto<br />
per l'ambiente. La decisione di approvazione, pertanto, comprende anche l'onere di rinverdimento<br />
degli spazi vitali di cui all'articolo 18 capoverso 1bis LPN mediante zolle erbose, fiori di<br />
fieno o materiale autoctono e adatto al luogo.<br />
Nel 2015, con la strada agricola da Zarzull a Zalüenja è stato realizzato un asse di accesso principale<br />
alla Peister Heuberg, sostituendo la vecchia e ripida strada sterrata con una moderna<br />
carreggiata di calcestruzzo con un nuovo tracciato. La strada si snoda per 965 metri, due terzi<br />
dei quali attraverso prati magri o pianori, con un dislivello tra 1942 e 2078 metri s.l.m. Inoltre,<br />
i suoi ultimi metri rientrano nella zona palustre di importanza nazionale "Faninpass" e il percorso<br />
è molto apprezzato per le escursioni a piedi o in mountain bike. Considerati tali presupposti,<br />
le parti coinvolte erano consapevoli che tutte le esigenze potevano essere soddisfatte<br />
solo mediante una realizzazione estremamente accurata.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
271
Il mio Rapporto agricolo 183 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
Scoticamento di zolle erbose di spessore di almeno 10 cm da stoccare per un massimo di 14 giorni prima della posa.<br />
Rivestimento delle scarpate nella pratica<br />
D’intesa con lo studio d'ingegneria incaricato del progetto, l'ufficio di consulenza ambientale<br />
e il committente si era deciso di rivestire le scarpate lungo tutto il tracciato mediante scoticamento<br />
e posa di zolle erbose. Inoltre, ai fini della compatibilità con il paesaggio, le carreggiate<br />
in calcestruzzo sarebbero state tinteggiate con un additivo di colore scuro.<br />
Nel preventivo dei costi di realizzazione il taglio, lo stoccaggio adeguato, il trasporto e la posa<br />
nonché l'eventuale irrigazione delle zolle erbose erano stati inseriti in un'unica voce e, nella<br />
fattispecie, l'offerta dell'impresa ammontava a 4.60 franchi al m 2 . I responsabili della consulenza<br />
ambientale avevano richiesto che le zolle avessero uno spessore di almeno dieci centimetri<br />
e venissero stoccate per 14 giorni al massimo prima della posa.<br />
L'impresa doveva quindi organizzare i lavori considerando tali prescrizioni. Bisognava tener<br />
conto, in particolare, che le zolle erbose non possono essere conservate in un deposito centrale,<br />
poiché nel trasporto verrebbero danneggiate e che possono essere accatastate solo entro<br />
certi limiti. Erano stati quindi creati dei depositi lungo tutto il tracciato, nel raggio di azione<br />
della scavatrice.<br />
Nel presente caso è emersa un'ulteriore difficoltà: a causa dell'accumulo di acqua nel sottosuolo<br />
sarebbe stato vantaggioso, dal profilo tecnico, aspettare più a lungo prima di ricoprire<br />
le scarpate e chiudere gli scavi affinché il materiale potesse asciugarsi meglio. Grazie al clima<br />
secco dell'estate 2015, la situazione non è, quantomeno, peggiorata.<br />
La difficoltà di prelievo delle zolle varia a seconda delle caratteristiche della cotica erbosa. Di<br />
base, è più facile scoticare strati superficiali argillosi e poco profondi che non quelli ricchi di<br />
humus e granulosi. In caso di cotica erbosa compatta il prelievo del terreno, radici comprese,<br />
riesce meglio se le zolle sono asportate con la benna in dimensioni di un metro quadrato e<br />
adeguatamente accatastate.<br />
Terminate le operazioni di asporto e riporto, le zolle erano state posate nuovamente con la<br />
benna, pezzo per pezzo, sulle scarpate. A tale operazione di posa hanno lavorato due operai,<br />
aiutando i macchinisti a posizionare al meglio le zolle e riempiendo quindi a mano gli spazi<br />
vuoti. Se nel periodo di conservazione e di posa il clima permane a lungo secco, le zolle devono<br />
essere irrigate affinché restino abbastanza compatte. In prati ricchi di humus le cotiche erbose<br />
sono meno compatte e spesso si sgretolano, quindi la posa del reticolato erboso è più dispendiosa.<br />
Per l'impresa non è facile fare un preventivo della realizzazione sulla base delle prescrizioni<br />
citate all'inizio. Le tappe e lo svolgimento dei lavori devono essere adeguati alla durata e allo<br />
spazio a disposizione per lo stoccaggio delle zolle erbose. Per l’impresa è insolito che non si<br />
possa precedentemente asportare l'humus dall'intero tracciato e in terreni impraticabili il dispendio<br />
per un'eventuale irrigazione delle zolle può essere elevato. Un periodo di clima secco<br />
può comportare un significativo aumento delle spese.<br />
272<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 184 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
Deposito delle zolle erbose lungo tutto il tracciato, nel raggio di azione della scavatrice.<br />
Metodo di inerbimento valido<br />
La posa delle zolle erbose richiede una notevole abilità del macchinista… e anche un certo lavoro manuale.<br />
Il metodo di inerbimento scelto presenta esigenze elevate per l'impresa e per la pianificazione,<br />
ma offre vantaggi decisivi sotto diversi punti di vista.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
273
Il mio Rapporto agricolo 185 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
In primo luogo, va sicuramente citato l'"impatto ottico" della strada, notevolmente inferiore<br />
rispetto a come sarebbe stato con metodi di inerbimento convenzionali. La durata del pregiudizio<br />
è notevolmente ridotta da un lato grazie al più breve tempo di apertura, dall'altro poiché<br />
decadono i termini di germinazione e di attecchimento di una nuova varietà seminata, il che<br />
è particolarmente importante nelle zone alpine. Inoltre, considerato che vengono insediate<br />
esattamente le stesse biocenosi, la differenza tra la vegetazione della scarpata e quella circostante<br />
è impercettibile. Di conseguenza, l'inserimento della nuova opera nell'ambiente circostante<br />
risulta molto più rapido e naturale, e viene quindi accolto meglio soprattutto in aree<br />
esposte, in zone con paesaggi degni di tutela e in siti ad altitudini elevate a vocazione turistica.<br />
Dal profilo ecologico sono degni di nota, da un lato, l'assenza dei rischi legati all’introduzione<br />
di ecotipi o varietà vegetali estranei alla regione e l'esclusione della perdita di genotipi tipici<br />
del luogo mediante incrocio o soppiantamento. Dall'altro lato, fatta eccezione per l'effettiva<br />
larghezza del tracciato, possono essere mantenuti intatti tipi di vegetazione degni di protezione,<br />
con effetti percettibili anche sull'obbligo di provvedimenti di sostituzione.<br />
Se la declività non cambia notevolmente, i gestori possono usufruire immediatamente della<br />
scarpata secondo la sua utilizzazione originaria e non devono ricorrere a eventuali tagli di mantenimento<br />
o alla dispendiosa eliminazione di specie indesiderate come la cresta di gallo o il<br />
romice.<br />
Scarpata completamente rivestita subito dopo la conclusione dei lavori.<br />
Un effetto collaterale positivo per l'impresa e per il committente è il fatto che le nuove scarpate<br />
si ricopriranno stabilmente di vegetazione in poco tempo, comportando una notevole riduzione<br />
del rischio di dilavamento e smottamento in caso di precipitazioni abbondanti. Ciò<br />
compensa in parte lo svantaggio del lento avanzamento dei lavori causato dal rivestimento. In<br />
caso di scarpate con declività superiore a 45°, però, il reticolato erboso può anche scivolare e<br />
richiedere dei ritocchi.<br />
Affinché il rivestimento di una scarpata con reticolato erboso avvenga a regola d’arte è necessario<br />
che l'impresa pianifichi i lavori in maniera lungimirante e flessibile e, da non sot-<br />
274<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 186 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
tovalutare, che il macchinista sia particolarmente abile. Inoltre, deve essere disponibile la<br />
necessaria quantità di cotica erbosa del giusto spessore. Quest'ultimo criterio è più facile da<br />
adempiere, in genere, in caso di un nuovo tracciato che non per la sistemazione di strade esistenti.<br />
Conclusioni<br />
In siti sensibili dal profilo ecologico e paesaggistico il rivestimento di scarpate con reticolato<br />
erboso è un metodo efficace, che riduce al minimo l’impatto causato dalla costruzione di<br />
strade agricole. Se sono adempiuti i necessari presupposti, considerati i suoi numerosi vantaggi,<br />
questo metodo potrebbe risultare estremamente utile anche in situazioni meno esigenti.<br />
Kaspar Bernet, Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione, Coira<br />
Samuel Reusser, UFAG, Settore Sviluppo delle aziende, samuel.reusser@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
275
Il mio Rapporto agricolo 187 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
Irrigazione nella regione Seeland-Broye<br />
Per la regione Seeland-Broye è stato proposto uno strumento online di previsione del fabbisogno<br />
irriguo e delle risorse idriche. La piattaforma isb.swissrivers.ch fornisce le previsioni,<br />
giornalmente aggiornate, dei prossimi 10 giorni. Questo strumento offre una visione globale<br />
che consente di anticipare e ottimizzare l’utilizzo idrico a scopo agricolo nel pieno rispetto<br />
della protezione dei corsi d’acqua. In previsione di una situazione di penuria, scatta l’allerta<br />
per le autorità competenti e gli utenti.<br />
L'irrigazione a garanzia della produzione agricola<br />
Nei prossimi decenni, la produzione agricola della regione dei tre laghi potrebbe risentire degli<br />
effetti dei cambiamenti climatici. Si prevede, in particolare, un aumento della probabilità di<br />
siccità estive e di periodi di canicola. In questo contesto si inserisce il progetto «Irrigation<br />
Seeland-Broye (ISB)», il cui obiettivo è favorire metodi e interventi che consentano una produzione<br />
agricola più efficace e sicura.<br />
È stato sviluppato uno strumento online di previsione del fabbisogno irriguo e delle risorse idriche<br />
in modo che gli agricoltori ottimizzino l'utilizzo dell'acqua, proteggendo i corsi d'acqua.<br />
Tale strumento offre all'autorità competente una visione globale delle risorse idriche presenti<br />
e future, allo scopo di gestire meglio le autorizzazioni di prelievo. Sviluppato da un gruppo costituito<br />
da e-dric.ch (studio d'ingegneria), Agroscope ISS e dall'associazione Pro Agricultura<br />
Seeland, tale progetto è attuato nel quadro del Programma pilota Adattamento ai cambiamenti<br />
climatici, sostenuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e condotto dai Cantoni Vaud,<br />
Friborgo e Berna.<br />
Utilità delle previsioni del fabbisogno irriguo in tempo reale<br />
Il sito Internet isb.swissrivers.ch fornisce previsioni sulla domanda irrigua a livello comunale<br />
e sui corsi d'acqua e i laghi della regione Seeland-Broye. Le informazioni ivi contenute sono<br />
aggiornate quotidianamente.<br />
Questo progetto ha i seguenti tre obiettivi principali:<br />
• ottimizzare le restrizioni d'utilizzo dell'acqua mediante l'anticipazione delle condizioni<br />
meteorologiche: attraverso simulazioni, si fanno previsioni fino a 10 giorni della richiesta<br />
d'acqua per l'irrigazione, così come della disponibilità di tale risorsa nei corsi d'acqua e<br />
nei laghi;<br />
• ottimizzare l'utilizzo dell'acqua da parte degli agricoltori: conoscendo lo stato attuale<br />
dell'umidità del suolo e la sua evoluzione, oltre che il fabbisogno delle piante, è possibile<br />
regolare la quantità e il momento dell'irrigazione. Si tratta di confidare che il singolo, disponendo<br />
di un'informazione quantitativa supplementare, ottimizzi il proprio consumo di<br />
acqua;<br />
• formare gli attori del settore agricolo, allo scopo di promuovere un utilizzo efficiente<br />
dell'acqua.<br />
Sviluppo di uno strumento di previsione online<br />
Lo strumento operativo di previsione è sviluppato sulla base del know-how tecnologico e<br />
delle conoscenze scientifiche dei partner del progetto. Si concentra sulla condivisione dei<br />
progressi già realizzati per ottenere un prodotto funzionale e utile al mondo dell'agricoltura<br />
e all'amministrazione della regione Seeland-Broye, valorizzando gli elementi riportati di seguito.<br />
276<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 188 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
• Rappresentazione del contenuto idrico del suolo mediante il modello di simulazione messo<br />
a punto nel quadro del progetto europeo ACQWA e di altri progetti sul fabbisogno irriguo<br />
(Agroscope ISS).<br />
• Stima del potenziale fabbisogno idrico, presente e futuro, delle principali colture (Agroscope<br />
ISS); integrazione dei modelli di calcolo in quello Routing System (e-dric.ch).<br />
• Previsione della disponibilità idrica futura mediante la simulazione afflussi-deflussi del<br />
modello Routing System. Il modello di previsione sviluppato da e-dric.ch (swissrivers.ch)<br />
funge da base per prevedere i deflussi dei corsi d'acqua.<br />
• Gestione dei dati e dei modelli di calcolo, collocazione di un sistema automatico e diffusione<br />
delle informazioni mediante l'utilizzo dell'infrastruttura e-dric.ch, operativa già da diversi<br />
anni, che integra l'acquisizione dei dati e la simulazione e la diffusione delle informazioni<br />
sull'interfaccia CartoWeb<br />
• Formazione degli attori e divulgazione dei nuovi metodi di lavoro, allo scopo di promuovere<br />
l'utilizzo di tali informazioni e utilizzare in maniera ottimale le risorse idriche. Un posto di<br />
rilievo è dato agli attori regionali (Pro Agricultura Seeland)<br />
isb.swissrivers.ch<br />
Questa nuova interfaccia web consente di accedere alle informazioni mediante una mappa dinamica.<br />
Selezionando una zona o un'icona sulla mappa, appare un grafico con i seguenti dati<br />
dettagliati: i deflussi misurati e quelli previsti nei 10 giorni successivi (icona «goccia d'acqua»),<br />
il fabbisogno irriguo, le risorse idriche e il deficit totale a livello comunale (poligoni).<br />
Confronto tra disponibilità idrica (corsi d’acqua) e fabbisogno idrico (irrigazione). La situazione di penuria si verifica<br />
se il fabbisogno supera la disponibilità.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
277
Il mio Rapporto agricolo 189 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
Piattaforma isb.swissrivers.ch. Stato al 1° agosto 2015.<br />
Se il fabbisogno supera le risorse disponibili scatta l'allerta. Viene calcolato un coefficiente di<br />
utilizzo e sono usati i seguenti criteri di colorazione per le diverse zone d'irrigazione:<br />
• verde => le risorse idriche sono sufficienti per coprire l'intero fabbisogno irriguo<br />
• arancione => la situazione è critica, le risorse disponibili si esauriranno a breve<br />
• rosso => situazione di penuria: le risorse idriche non sono più sufficienti per coprire il fabbisogno<br />
irriguo totale.<br />
Oltre a fornire informazioni utili per la valutazione quotidiana del fabbisogno irriguo e delle risorse<br />
idriche, l'interfaccia contiene simulazioni pluriennali che consentono di valutare la portata<br />
della penuria d'acqua.<br />
Sintesi e prospettive<br />
La piattaforma isb.swissrivers.ch fornisce soprattutto informazioni quantitative: ogni giorno si<br />
valuta, per i 10 giorni successivi, l'adeguamento futuro tra risorse idriche e fabbisogno irriguo<br />
a livello comunale. In previsione di una situazione di penuria, scatta l'allerta per le autorità<br />
competenti. Ciò fornisce una base scientifica quantitativa, che può essere usata per regolare i<br />
prelievi d'acqua nei fiumi. Per ogni corso d'acqua vengono quantificati i deficit o le eventuali<br />
riserve.<br />
Questo stesso sistema può essere impiegato anche per la pianificazione. Basandosi su continue<br />
simulazioni, consente di riprodurre i periodi passati e di testare diverse varianti di interventi e<br />
di colture. Così facendo, è possibile valutare il fabbisogno irriguo per ogni regione nelle annate<br />
secche e medie.<br />
278<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 190 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
La modellizzazione è, per definizione, incerta e non consente di riprodurre esattamente tutti<br />
i processi naturali. L'incertezza è riconducibile, in primo luogo, alla rappresentatività dei modelli<br />
comportamentali che sono una semplificazione della realtà. L'incertezza delle previsioni<br />
meteorologiche, per esempio, è riconosciuta e nota a tutti. Infine, la risoluzione del modello<br />
non consente di integrare tutti i dettagli, quindi non sono delimitate né parametrate tutte le<br />
particelle. Ciononostante, la rappresentatività del sistema può essere considerata da buona a<br />
ottima. La convalida del modello permette di ritenerlo estremamente affidabile nel calcolo dei<br />
deflussi dei corsi d'acqua e dei livelli dei laghi. L'incertezza è più rilevante per il calcolo del<br />
fabbisogno irriguo della coltura, poiché il tipo di suolo e le sue caratteristiche non sono perfettamente<br />
noti né uniformi e lo sviluppo della pianta e il livello di umidità nel suolo non vengono<br />
monitorati. Di conseguenza, si sono potute effettuare solo verifiche globali del fabbisogno irriguo,<br />
controllate mediante indicatori quali le fatture di pompaggio d'acqua annuali o le estrazioni<br />
di sonde di misurazione della pressione idrica. In conclusione, mediante il modello si<br />
sono ottenuti dati con un buon livello di approssimazione (margine d'errore del 10-30%) ed è<br />
stato possibile anche evidenziare i periodi delicati.<br />
Questo strumento presenta un enorme potenziale per la gestione delle risorse idriche, poiché<br />
consente un approccio sia globale sia a livello del bacino idrografico. Il sistema può essere<br />
applicato anche in altre regioni svizzere.<br />
Murielle Thomet, e-dric.ch, Losanna<br />
Frédéric Jordan, e-dric.ch, Losanna<br />
Jürg Fuhrer, Agroscope ISS, Zurigo<br />
Johnny Fleury, UFAG, Settore Sviluppo delle aziende, johnny.fleury@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
279
Il mio Rapporto agricolo 191 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
PSR «Genussregion»<br />
A ovest di Sciaffusa, allontanandosi dal capoluogo, sorge l’area di Klettgau, paesaggio campicolo<br />
e urbano, in cui vitigni e terre coltive aperte si alternano armoniosamente. Le sue<br />
condizioni di produzione, favorevoli dal profilo climatico, hanno conferito all’area il nome di<br />
«granaio». Oltre a una campicoltura e a una viticoltura variate, nell’ultimo secolo per una cinquantina<br />
d’anni anche le coltivazioni di bacche o frutta a nocciolo hanno svolto un ruolo importante.<br />
Ma sono state presto sostituite da una viticoltura sempre più professionale con vino<br />
esigente dal profilo qualitativo. Tuttavia per molto tempo sono mancate le strutture necessarie<br />
per rispondere alle esigenze del mercato attuale del vino. A questo punto i promotori<br />
dell’iniziativa hanno visto nello strumento dei progetti per lo sviluppo regionale (PSR) la chiave<br />
per un futuro migliore.<br />
Fattore scatenante per un PSR<br />
I motivi dello sviluppo economico insoddisfacente nel settore viticolo, soprattutto nel ristretto<br />
comprensorio del progetto Wilchingen, Osterfingen e Trasadingen, ai confini sud occidentali<br />
del Canton Sciaffusa, erano noti da tempo. Fino a quel momento esistevano soltanto pochi<br />
viticoltori-cantinieri e commercianti autonomi o diretti. La maggior parte del prodotto della<br />
vendemmia era venduto come vino giovane da grandi cantinieri a prezzi bassi, per lo più con<br />
margini esigui. I produttori di uva non si riconoscevano nel prodotto finale e quasi non recuperavano<br />
i costi di produzione. A causa della bassa percentuale di commercianti autonomi,<br />
la regione vinicola era poco attrattiva. Al di fuori di eventi tradizionali, come le domeniche<br />
autunnali, l’offerta turistica era praticamente inesistente. Le nuove generazioni non avevano<br />
prospettive economiche nella vitivinicoltura. L’invecchiamento dei gestori dei vigneti e quindi<br />
anche degli impianti viticoli era prevedibile.<br />
Pertanto per preservare a lungo termine la vitivinicoltura e l’imponente paesaggio viticolo era<br />
necessario cambiare qualcosa. La filiera del vino poteva fiorire soltanto con una produzione di<br />
uva che coprisse le spese e con migliori possibilità di smercio per il vino. La regione vinicola<br />
doveva concentrarsi maggiormente sull’affinamento locale dei suoi vini e sulla commercializzazione<br />
dei suoi prodotti in loco. Tali elementi sono stati il fattore scatenante di questo progetto<br />
collettivo di sviluppo regionale con i suoi ambiziosi obiettivi, avviato già nel 2008 con<br />
il titolo di «PREWO». Il progetto, destinato a svilupparsi ulteriormente, nel frattempo è stato<br />
ribattezzato «GENUSSREGION» secondo gli obiettivi dei promotori dell’iniziativa.<br />
280<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 192 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
Obiettivi in breve<br />
In generale creazione di valore aggiunto nell’agricoltura.<br />
Rinnovo del locale «Bergtrotte» a Osterfingen come faro ed elemento di richiamo per il pubblico,<br />
come mercato per i vini locali di elevata qualità e come locale di ristoro e centro culturale<br />
con prodotti regionali.<br />
Adeguamenti edilizi nelle cantine per interessanti visite guidate e degustazioni.<br />
Potenziamento dell’offerta e della commercializzazione di prodotti regionali nonché delle possibilità<br />
di pernottamento.<br />
Offerta di specialità regionali nelle cantine e durante manifestazioni nella regione da parte di<br />
un gruppo di catering.<br />
Collaborazione con il Parco naturale regionale di Sciaffusa, con l’ente cantonale per il turismo<br />
e con la categoria vitivinicola di Sciaffusa «Blauburgunderland».<br />
Potenziamento dell’offerta culturale e per il tempo libero nell’interesse pubblico anche attraverso<br />
la cura delle offerte tradizionali, privilegiando il traffico lento o i percorsi avventura.<br />
Bottom up – e un pizzico di fortuna<br />
Per passare dall’idea a un progetto realizzabile c’è stato bisogno di argomenti solidi, personalità<br />
convincenti, tempo e un processo ben moderato che coinvolgesse le persone implicate o<br />
anche la popolazione interessata nonché la politica e le autorità comunali. A volte anche un<br />
pizzico di fortuna aiuta. In questo progetto ad aiutare sono state le sinergie, in fase di consolidamento,<br />
con il Parco naturale regionale di Sciaffusa in procinto di essere sviluppato, con<br />
la categoria vitivinicola di Sciaffusa «Blauburgunderland», con l’ente cantonale per il turismo<br />
e con il fondo cantonale delle generazioni recentemente istituito grazie a particolari fonti finanziarie.<br />
Infine è stato possibile garantire la partecipazione richiesta del Cantone nella misura<br />
dell’80 per cento dei fondi federali. Il progetto principale in questo PSR, il rinnovo del<br />
vecchio «Bergtrotte» a Osterfingen, ha visto una simbiosi tra la «Cooperativa vitivinicola di Osterfingen»,<br />
proprietaria del locale, e una fondazione creata appositamente per la realizzazione<br />
di questo progetto parziale. Entrambe hanno spianato la strada all’opera del secolo in questi<br />
Comuni protagonisti, pochi anni fa, di un’aggregazione.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
281
Il mio Rapporto agricolo 193 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
Bergtrotte, Osterfingen: il locale di vinificazione, ristrutturato e ampliato secondo criteri moderni, è assurto a nuovo<br />
centro della cultura vinicola di Sciaffusa.<br />
Ospitalità con prodotti regionali: servizio di catering delle donne contadine di Sciaffusa, mediatrici tra consumatore<br />
e produttore e tra città e campagna.<br />
282<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 194 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
Per l’aperitivo naturalmente: prodotti regionali.<br />
Slancio per la regione<br />
Alla base del successo dello sviluppo regionale vi sono molteplici fattori. Soltanto quando si<br />
mettono insieme i diversi pezzi di un puzzle si delinea l’immagine. La pianificazione e la realizzazione<br />
di un così ampio PSR necessita di spirito pionieristico e di piccole continue conquiste<br />
per mantenere alta la motivazione delle persone coinvolte. Nel caso concreto, ciò è stato possibile<br />
attraverso la rapida creazione di un gruppo di catering ben affiatato, costituito da donne<br />
contadine che hanno fondato una start up, nonché mediante l’elaborazione in tempi brevi di<br />
piani per il rinnovo di spazi per degustazioni o locali di ristoro presso viticoltori-cantinieri e<br />
di offerte agrituristiche e culturali. Un primo segnale è stato il «Fasstastische Hotel» a Trasadingen<br />
cui, nel 2012, è stato conferito un premio di una giuria specializzata. I PSR di successo si<br />
contraddistinguono per organizzazioni partner che collaborano in modo intenso e sfruttano le<br />
sinergie. In tal modo provvedono, a lungo termine, a uno sviluppo sostenibile con risultati che<br />
possono andar oltre gli obiettivi del progetto originario. In questi casi i fondi impiegati dalla<br />
Confederazione e dal Cantone sono ben investiti. Il PSR Genussregion Wilchingen, Osterfingen,<br />
Trasadingen e il Parco naturale regionale di Sciaffusa, insieme ai partner dell’economia e del<br />
turismo, costituiscono a tal proposito un modello di successo per lo sviluppo regionale.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
283
Il mio Rapporto agricolo 195 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
La cultura vitivinicola nella cantina Rötiberg a Wilchingen: rinnovo dei locali per ricevimenti e degustazioni.<br />
Programma culturale: «Wöschwiiber». Storie, dispute, sorrisi e schiamazzi alla fontana del paese di Wilchingen.<br />
284<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 196 / 222<br />
POLITICA > MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E MISURE SOCIALI COLLATERALI<br />
Il «Fasstastische Hotel» a Trasadingen: innovazione agrituristica con camere a forma di botte, spazi di soggiorno e<br />
ristoro nel cuore del villaggio.<br />
Fatti sul progetto<br />
Inizio della realizzazione del progetto: 20.12.2011<br />
Durata della realizzazione concordata: 6 anni, entro il 31.12.2017<br />
Importo degli investimenti pianificati: 13 455 200 franchi<br />
Di cui aventi diritto a contributi giusta l’OMSt: 10 307 700 franchi<br />
Contributo federale max. 3 504 600 franchi in caso di totale attuazione delle misure<br />
Regione del progetto: Comuni di Wilchingen/Osterfingen e Trasadingen<br />
Lo strumento PSR<br />
I PSR sono progetti collettivi per lo sviluppo regionale (PSR). Sono sostenuti dalla Confederazione<br />
e dal Cantone nel quadro delle misure di miglioramento strutturale mediante contributi<br />
federali e cantonali. Importanti condizioni a tal proposito sono, tra le altre cose, il valore aggiunto<br />
per l’agricoltura nonché una stretta collaborazione dei partner all’interno del progetto e<br />
tra l’ente promotore e le categorie della regione. Per la realizzazione di un PSR, generalmente<br />
su un arco di tempo di sei anni, è stipulata una convenzione tra l’ente promotore, il Cantone<br />
responsabile e la Confederazione. Lo strumento del PSR è stato inserito dal Parlamento nella<br />
legge sull’agricoltura (art. 93 cpv. 1 lett. C) nel quadro della Politica agricola 2007.<br />
Gustav Munz, UFAG, Economia agricola, spazio rurale e strutture, gustav.munz@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
285
Il mio Rapporto agricolo 197 / 222<br />
POLITICA > RICERCA, CONSULENZA, FORMAZIONE PROFESSIONALE<br />
Piano direttore della ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare<br />
La ricerca condotta nell’interesse pubblico, i cui risultati sono necessari all’Amministrazione<br />
federale per adempiere i propri compiti, è definita ricerca pubblica. I suoi programmi pluriennali<br />
sono elaborati sotto forma di piani direttori trasversali. Il Consiglio federale ha conferito<br />
all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) il mandato di redigere un piano direttore della ricerca<br />
per il settore politico dell’agricoltura, concretizzatosi, nel frattempo, nel Piano direttore<br />
della ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare per gli anni 2017-2020. Sulla base di diversi<br />
elementi, tale piano descrive la collocazione della ricerca pubblica nel panorama della ricerca<br />
in generale.<br />
Su incarico dell’UFAG, il World Food System Center del Politecnico federale di Zurigo ha elaborato<br />
un quadro completo dei futuri sviluppi mondiali e nazionali della produzione agricola e<br />
dell’alimentazione della popolazione, dal quale è possibile dedurre le sfide significative per la<br />
ricerca pubblica. Inoltre un’analisi delle strategie internazionali mostra che i punti focali della<br />
ricerca internazionale e nazionale coincidono ampiamente. Pertanto, da un lato le eccellenti<br />
competenze della ricerca svizzera possono essere integrate in programmi di ricerca internazionali<br />
come Orizzonte 2020, dall’altro la Svizzera, nel quadro di cooperazioni internazionali nel<br />
campo della ricerca, ha accesso alle conoscenze e ai più recenti sviluppi scientifici.<br />
Mediante le strategie nazionali il Consiglio federale anticipa il cambiamento sociale, tecnologico<br />
ed economico nonché le nuove sfide. Le strategie sono attuate attraverso piani d’azione<br />
e di misure e comprendono importanti aspetti in materia di ricerca. Alcune strategie orientano<br />
i loro obiettivi all’interno del sistema alimentare lungo la catena di valore, come ad esempio<br />
il Piano d'azione per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari,<br />
la strategia Selezione vegetale nonché la strategia Catena alimentare. Un altro gruppo di strategie<br />
va dal sistema alimentare ad altri settori del contesto nazionale. Un esempio è la Strategia<br />
contro le resistenze agli antibiotici. Un terzo gruppo di strategie si concentra su sfide globali e<br />
intersettoriali e agisce in modo significativo sull’evoluzione del sistema alimentare. In merito<br />
va citata, in particolare, la strategia Sviluppo sostenibile.<br />
La varietà di temi riguardanti l’agricoltura e la filiera alimentare si rispecchia nel numero e<br />
nell’orientamento degli attori della ricerca svizzeri, laddove le diverse istituzioni possono integrarsi<br />
in maniera opportuna grazie ai loro diversi orientamenti nei settori della ricerca di base,<br />
ricerca di base orientata alla pratica e ricerca applicata. Da un’analisi delle attività di ricerca<br />
emerge altresì un enorme potenziale di sinergie. Per sfruttarle, il panorama svizzero della ricerca<br />
offre numerose forme di interconnessione che, a seconda dell’orientamento, favoriscono<br />
lo scambio scientifico tra gli attori della ricerca o promuovono la collaborazione inter e transdisciplinare.<br />
Inoltre vari strumenti delle istituzioni svizzere di promozione sostengono la collaborazione.<br />
Mediante i Programmi nazionali di ricerca e i Poli di ricerca nazionali si promuove<br />
la ricerca coordinata, mentre la Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) funge da<br />
anello di congiunzione tra la scienza e l’economia privata.<br />
L’innovazione si afferma sempre più come tema chiave per l’ulteriore sviluppo di un'agricoltura<br />
e una filiera alimentare competitive, efficienti nell’utilizzo delle risorse e sostenibili. Particolarmente<br />
importante è un processo di innovazione che coinvolga tutti gli attori della ricerca,<br />
della formazione, della consulenza nonché della pratica agricola fino ai consumatori. Se gli<br />
utilizzatori vengono coinvolti già nella fase di definizione dei progetti di sviluppo e di ricerca,<br />
gli sviluppi possono orientarsi meglio alle loro esigenze e tener maggiormente conto dello specifico<br />
contesto sociale, economico ed ecologico di un’innovazione. Per un utilizzo più efficiente<br />
delle risorse finanziarie e delle potenziali sinergie, gli attuali strumenti di promozione<br />
dell’UFAG in futuro dovranno essere connessi in modo più saldo.<br />
286<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 198 / 222<br />
POLITICA > RICERCA, CONSULENZA, FORMAZIONE PROFESSIONALE<br />
In quanto centro di competenze della Confederazione nel settore della politica agricola, spetta<br />
all’UFAG il fondamentale compito di formulare tempestivamente le sue esigenze di ricerca in<br />
riferimento all’evoluzione della politica agricola e alla valutazione delle misure di politica agricola<br />
e di individuare gli strumenti adeguati per condurre queste ricerche. A tal fine, l’Ufficio<br />
può stipulare contratti di prestazione periodici con i partner della ricerca agronomica e conferire<br />
mandati e contributi specifici di ricerca, tra i quali rivestono una notevole valenza gli<br />
accordi di prestazione annuali con Agroscope e il mandato di prestazione quadriennale con il<br />
FiBL. Per i mandati e i contributi di ricerca i costi di finanziamento dell’UFAG per il periodo<br />
2017-2020 ammontano a 48 milioni di franchi di cui circa 29 milioni vanno al FiBL. I costi di<br />
finanziamento per la ricerca pubblica di Agroscope nello stesso periodo si aggirano intorno ai<br />
434 milioni di franchi.<br />
Agroscope è il centro di competenze della Confederazione per la ricerca agronomica e tra i suoi<br />
obiettivi di ricerca ci sono un sistema agroalimentare sostenibile e resiliente, un’alimentazione<br />
sana con derrate alimentari di qualità e un ambiente incontaminato a beneficio della società,<br />
della politica e della pratica. I compiti di Agroscope comprendono la ricerca per l’ulteriore<br />
sviluppo delle politiche settoriali dell’agricoltura e della filiera alimentare e per la pratica, la<br />
ricerca e lo sviluppo di prodotti e metodi per gli attori dell’agricoltura e della filiera alimentare<br />
nonché lo scambio di conoscenze e il trasferimento di tecnologie. Inoltre Agroscope, nel<br />
quadro delle disposizioni di legge, svolge compiti esecutivi e sostiene l’UFAG fornendo guide<br />
per l’esecuzione.<br />
Il FiBL è una fondazione di pubblica utilità il cui obiettivo è migliorare i metodi dell'agricoltura<br />
biologica dal profilo scientifico e fornire consulenza agli agricoltori. I suoi compiti comprendono<br />
la ricerca per gli agricoltori svizzeri attivi nel settore biologico, per l’industria a monte e a<br />
valle, nonché per un utilizzo del suolo sostenibile; la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi; la<br />
ricerca e la consulenza per i Paesi emergenti e in via di sviluppo; la consulenza e la formazione,<br />
nonché le prestazioni per l’esecuzione dell’ordinanza svizzera sull’agricoltura biologica.<br />
La strategia di politica agricola mira all’obiettivo superiore di un settore agroalimentare sostenibile<br />
nell’orizzonte temporale 2025. La strategia è concretizzata secondo valori di riferimento<br />
che forniscono delle prospettive per l’agricoltura e la filiera alimentare svizzere. Tali<br />
valori di riferimento sono definiti mediante la politica per l’andamento positivo dello smercio<br />
sui mercati attuali e futuri, per la preservazione del paesaggio rurale, la produzione di derrate<br />
alimentari e le prestazioni ambientali rispettose delle risorse nonché per lo sviluppo imprenditoriale<br />
delle aziende nell’agricoltura e nella filiera alimentare. Connettendo i tre obiettivi<br />
politici che forniscono prospettive si ottengono forme di produzione, prodotti e prestazioni<br />
sostenibili che sono competitivi, presentano un’elevata qualità e la cui realizzazione e origine<br />
sono trasparenti per tutti. L’agricoltura e la filiera alimentare sono al contempo fruitrici e custodi<br />
delle risorse di produzione.<br />
Agroscope attua questa strategia focalizzandosi sui tre campi d’attività: i) miglioramento della<br />
competitività, ii) impiego più sostenibile delle risorse, iii) ampliamento delle opportunità e<br />
riduzione dei rischi, dei quali si occupa mediante 17 campi di ricerca strategici (CRS). I CRS<br />
sono concretizzati nel programma di lavoro 2018-2021.<br />
Juliana Zweifel, Markus Lötscher, UFAG, Settore Ricerca, consulenza e valutazione, markus.loetscher@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
287
Il mio Rapporto agricolo 199 / 222<br />
POLITICA > RICERCA, CONSULENZA, FORMAZIONE PROFESSIONALE<br />
Agricoltura biologica e agricoltura sostenibile<br />
Negli ultimi anni gli obiettivi dell’agricoltura biologica e di quella sostenibile si sono avvicinati,<br />
con il risultato che l’agricoltura svizzera oggi presta maggiore attenzione all’ambiente e al<br />
benessere degli animali. Nel quadro della Politica agricola 2014-2017 sono promosse e incentivate<br />
in modo mirato forme di produzione in sintonia con la natura, rispettose dell’ambiente e<br />
degli animali, come quella biologica o la PI. Ad esempio, si utilizzano in modo più efficiente le<br />
risorse naturali e i mezzi ausiliari mediante innovazioni tecniche, organizzative e strutturali,<br />
si promuovono gli organismi utili o si applicano misure per la lavorazione rispettosa del suolo<br />
e per la conservazione della fertilità del suolo. Questa evoluzione fa sì che l’agricoltura non<br />
biologica adotti sempre più pratiche che rientrano negli standard dell’agricoltura biologica.<br />
Contemporaneamente, anche per quest’ultima si aprono nuove opportunità che le consentono,<br />
ad esempio, di potenziare ulteriormente le sue competenze di base nel settore del benessere<br />
degli animali o delle prestazioni ecologiche mediante un maggiore utilizzo delle tecnologie<br />
d’informazione e di comunicazione.<br />
Questa evoluzione va sostenuta ulteriormente. A tal fine sono indispensabili la ricerca e lo sviluppo<br />
inter e transdisciplinari che ampliano le conoscenze e le rendono fruibili sotto forma<br />
di applicazioni pratiche per tutta la filiera agroalimentare. Per il successo è imprescindibile la<br />
collaborazione nazionale e internazionale tra le istituzioni di ricerca da un lato e tra la ricerca,<br />
la consulenza, le aziende private e la pratica dall’altro. Pertanto, dal 2016 l’UFAG, con la nuova<br />
categoria di contributi «Ricerca per l’agricoltura biologica e un’agricoltura sostenibile», impiega<br />
una parte dei fondi destinati ai contributi per la ricerca a favore di progetti i cui risultati<br />
sono utilizzabili in primo luogo nell’agricoltura biologica, ma anche in quella non biologica. La<br />
promozione dei progetti avviene mediante gara pubblica. Da un lato possono essere promossi<br />
progetti di partenariato i cui consorzi coinvolgono ricercatori di almeno due diversi centri di<br />
ricerca. I consorzi includono preferibilmente anche le categorie, l’industria/le PMI e la pratica.<br />
Dall’altro lato i progetti di ricerca possono essere promossi nel quadro di programmi di ricerca<br />
connessi sul piano internazionale, nello specifico nell’ambito di iniziative ERA-NET.<br />
La nuova categoria di contributi promuove le sinergie tra gli approcci di ricerca dell’agricoltura<br />
biologica e dell’agricoltura sostenibile e intensifica la collaborazione degli attori della ricerca,<br />
potenziando sia la competitività della ricerca agricola svizzera sia il ruolo della Svizzera come<br />
precursore nella produzione di derrate alimentari rispettosa dell’ambiente e degli animali.<br />
Progetti di ricerca<br />
Christoph Bracher, Markus Lötscher, UFAG, Settore Ricerca, consulenza e valutazione,<br />
markus.loetscher@blw.admin.ch<br />
288<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 200 / 222<br />
POLITICA > RICERCA, CONSULENZA, FORMAZIONE PROFESSIONALE<br />
Consulenza agricola<br />
Come parte del Sistema della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura SCIA, la consulenza<br />
in ambito agricolo e in economia domestica rurale in Svizzera è organizzata su due livelli. La<br />
consulenza diretta alle famiglie contadine è fornita sul posto, in primo luogo dai servizi cantonali<br />
di consulenza. In alcuni settori specifici quali apicoltura, avicoltura o economia alpestre,<br />
sono operativi i servizi di consulenza di organizzazioni agricole.<br />
AGRIDEA sostiene il personale addetto alla consulenza nei Cantoni e nelle organizzazioni. Come<br />
associazione, AGRIDEA offre innanzitutto servizi per i propri membri, ovvero i Cantoni e circa<br />
40 organizzazioni agricole. Inoltre offre corsi di formazione per il personale addetto alla consulenza<br />
o coordina piattaforme e forum per lo scambio di conoscenze ed esperienze.<br />
Di questo sistema globale della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura fanno parte anche<br />
altri attori che partecipano più o meno attivamente alla consulenza e allo scambio di informazioni:<br />
Agroscope, scuole universitarie professionali, FiBL, associazioni, media ed economia<br />
privata.<br />
Mezzi finanziari 2015<br />
Oltre che ad AGRIDEA, la Confederazione accorda aiuti finanziari anche ad alcuni dei servizi di<br />
consulenza nei settori specifici citati in precedenza. Essa sostiene altresì accertamenti per la<br />
fase iniziale delle iniziative collettive di progetto. Dal 2014, inoltre, l'UFAG può promuovere<br />
progetti di consulenza messi a concorso direttamente o che gli vengono inoltrati sotto forma<br />
di domande di contribuzione di terzi. I fondi utilizzati a tal scopo provengono da riduzioni effettuate<br />
presso altri beneficiari di aiuti finanziari, soprattutto presso AGRIDEA.<br />
Uscite della Confederazione nel settore della consulenza - 2015<br />
Destinatario<br />
Mio. fr.<br />
Centrale di consulenza (AGRIDEA) 8,7<br />
Servizi di consulenza speciali delle organizzazioni agricole<br />
1,4<br />
Iniziative collettive di progetto 0,7<br />
Gara pubblica per progetti di consulenza: bandi pubblici 0,1<br />
Gara pubblica per progetti di consulenza: richieste di<br />
contributi<br />
1,0<br />
Totale 11,9<br />
Fonte: Conto dello Stato<br />
Assegnazione previa gara pubblica nel settore della consulenza<br />
Mediante l'assegnazione previa gara pubblica, l'UFAG vuole promuovere la concorrenza e garantire<br />
la comparabilità dei costi nel settore della consulenza. I nuovi attori hanno la possibilità<br />
di diventare attivi e di dare prova della loro efficacia ed efficienza. Anche attori già noti possono<br />
richiedere sussidi se propongono tematiche differenti o procedure metodologiche finora inesplorate.<br />
Negli ultimi due anni entrambi i gruppi hanno sfruttato appieno questa possibilità.<br />
In tale contesto sono a disposizione dell’UFAG due strumenti. Il primo consente all'UFAG di<br />
mettere a concorso tematiche che ritiene importanti, tra le quali spiccano la competitività e<br />
l'efficienza delle risorse dell'agricoltura. Le gare pubbliche sono sottoposte alle norme in materia<br />
di acquisti pubblici. Nel 2015 si sono svolti due grandi progetti: la revisione della guida<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
289
Il mio Rapporto agricolo 201 / 222<br />
POLITICA > RICERCA, CONSULENZA, FORMAZIONE PROFESSIONALE<br />
sulle stime e la prima fase del progetto Valore aggiunto mediante cooperazioni interaziendali,<br />
la quale comprende l’elaborazione della cosiddetta «cassetta degli attrezzi» per i tre principali<br />
tipi di cooperazione: gestione delle superfici, investimenti in macchinari ed edifici nonché<br />
forme di collaborazione.<br />
Come secondo tipo di strumento sono disponibili le richieste di contributo per i progetti di<br />
consulenza. Quattro volte all’anno gli attori interessati hanno la possibilità di inoltrare i progetti<br />
all’UFAG per il cofinanziamento. Questi vengono esaminati e valutati internamente e, a<br />
seconda dell'ambito, anche esternamente. Infine, il Consiglio di direzione dell'UFAG decide se<br />
e in che misura sostenerli. Per i progetti approvati, l’UFAG conclude contratti di aiuto finanziario<br />
con i rispettivi promotori. Nel 2015 sono state inoltrate 12 nuove richieste di contributo di<br />
cui ne sono state approvate 7. Nel 2014 ne erano state presentate due volte tante. In futuro si<br />
vedrà su che media ci si stabilizzerà. Nelle richieste occorre segnalare in modo chiaro il carattere<br />
del progetto: si deve indicare una durata prestabilita (nessun finanziamento perenne) e<br />
affrontare, modificare e trasmettere temi nuovi, quindi con effetto innovativo (nessun finanziamento<br />
di normali prestazioni di consulenza diretta). I progetti sono respinti, tra le altre motivazioni,<br />
o perché non sono impostati correttamente come progetti o non sono valutati come<br />
prioritari o superano i limiti dei fondi finanziari disponibili.<br />
Nel 2015 erano in corso complessivamente 25 progetti, promossi con 1.1 milioni di franchi.<br />
Su tutta la durata dei progetti, calcolando l’anno precedente e quelli successivi, il volume di<br />
promozione ammonta a 3 milioni di franchi. I progetti hanno una durata compresa tra alcuni<br />
mesi e un massimo di cinque anni.<br />
La concessione di un aiuto finanziario a un progetto dipende, da un lato, dalla qualità delle<br />
informazioni fornite e, dall'altro, dalla sua compatibilità con l’orientamento strategico della<br />
politica agricola. È possibile inoltrare progetti riguardanti uno dei seguenti quattro compiti<br />
principali della consulenza:<br />
• ottimizzazione del sistema di consulenza (scambio consulenza pratica), consulenza<br />
come sottosistema autoregolatore nell'ambito dello SCIA;<br />
• introduzione di nuove conoscenze nella pratica (scienza pratica), anello di congiunzione<br />
tra ricerca e pratica;<br />
• divulgazione di esperienze (pratica pratica), consulenza come catalizzatore dello<br />
scambio nella pratica;<br />
• trasmissione di condizioni quadro e provvedimenti (amministrazione/società pratica),<br />
consulenza per informare la pratica sulle misure politiche e sulle condizioni quadro socioeconomiche.<br />
I progetti sono seguiti e valutati periodicamente da esperti dell'UFAG. I pagamenti vengono<br />
effettuati solo se le attività del progetto vengono svolte come da programma e se le valutazioni<br />
intermedie e finali sono positive. Una valutazione dei progetti finora conclusi mostra che le attività<br />
sono state realizzate come da contratto e i prodotti auspicati sono stati forniti. È tuttavia<br />
difficile valutare quale effetto hanno avuto o avranno nella pratica.<br />
290<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 202 / 222<br />
POLITICA > RICERCA, CONSULENZA, FORMAZIONE PROFESSIONALE<br />
Fondi assicurati e versati nel 2015 per progetti di consulenza (bandi pubblici e richieste<br />
di contributi)<br />
Compito della consulenza Progetti in corso Importo assicurato per<br />
l’intera durata del progetto<br />
Importo versato nel 2015<br />
Numero in 1 000 fr. in 1 000 fr.<br />
Ottimizzazione del sistema<br />
di consulenza (consulenza<br />
pratica)<br />
Introduzione di nuove conoscenze<br />
nella pratica (scienza<br />
pratica)<br />
Divulgazione di esperienze<br />
(pratica pratica)<br />
Trasmissione di condizioni<br />
quadro e provvedimenti<br />
(amministrazione/società<br />
pratica)<br />
5 221 96<br />
8 1 223 419<br />
7 928 292<br />
5 640 311<br />
Totale 25 3 012 1 118<br />
Fonte: UFAG<br />
Orientamento strategico<br />
dell'UFAG<br />
Produzione, prodotti e prestazioni<br />
sostenibili<br />
Produzione e prodotti competitivi<br />
Utilizzo e preservazione<br />
delle risorse di produzione<br />
Progetti autorizzati<br />
Importo assicurato per<br />
l’intera durata del progetto<br />
Importo versato nel 2015<br />
Numero in 1 000 fr. in 1 000 fr.<br />
9 1 316 484<br />
11 1 135 367<br />
5 561 267<br />
Totale 25 3 012 1 118<br />
Fonte: UFAG<br />
Anton Stöckli, Markus Lötscher, UFAG, Settore Ricerca, consulenza e valutazione, anton.stoeckli@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
291
Il mio Rapporto agricolo 203 / 222<br />
POLITICA > RICERCA, CONSULENZA, FORMAZIONE PROFESSIONALE<br />
Formazione professionale<br />
La formazione professionale è un compito in comune<br />
La formazione professionale è un compito in comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni<br />
del mondo del lavoro (OML). Insieme i tre partner s'impegnano per una formazione professionale<br />
di alto livello qualitativo, mirando a offrire sufficienti aziende di tirocinio e cicli di<br />
formazione. L'obiettivo è raggiungere un’elevata competitività sul mercato di coloro che hanno<br />
concluso una formazione professionale. La vicinanza al mondo della pratica, inoltre, garantisce<br />
la trasmissione di contenuti formativi rilevanti e al passo coi tempi.<br />
La Confederazione disciplina la formazione professionale per oltre 230 professioni. Con le direttive<br />
relative all’elaborazione delle ordinanze in materia di formazione, dei piani di formazione<br />
e delle procedure di qualificazione, essa è responsabile della gestione strategica e dello<br />
sviluppo di questo settore. Inoltre, tramite la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e<br />
l'innovazione (SEFRI), emana i suddetti testi normativi della formazione professionale di base.<br />
Per la formazione professionale superiore, la Confederazione fissa le prescrizioni per la redazione<br />
di regolamenti d'esame e programmi quadro d'insegnamento.<br />
Gli uffici cantonali della formazione professionale sono gli organi esecutivi a livello di Cantone;<br />
offrono la formazione scolastica e si fanno quindi carico della maggior parte del finanziamento<br />
della formazione professionale di base. Rientrano tra le loro competenze i controlli dei rapporti<br />
di formazione e l’esecuzione di procedure di qualificazione.<br />
Le organizzazioni professionali, ossia le organizzazioni del mondo del lavoro (OML), difendono<br />
gli interessi degli operatori, in qualità di terzo attore del partenariato. Si occupano dei contenuti<br />
degli esami e della formazione e definiscono i profili professionali. Grazie ai piani di formazione<br />
e alle procedure di qualificazione, assicurano una formazione professionale al passo<br />
coi tempi e corrispondente alle esigenze del rispettivo settore. Le OML, inoltre, sono responsabili<br />
dei centri di apprendimento (corsi interaziendali, CI) e delle campagne pubblicitarie sulla<br />
formazione professionale.<br />
Il partenariato nella formazione professionale agricola è effettivo ed efficace. AgriAliForm<br />
è un’OML che riunisce dieci organizzazioni professionali del settore. Essa svolge compiti<br />
nell'ambito della formazione professionale sia di base (livello secondario II) sia superiore.<br />
Le professioni del campo professionale agricoltura<br />
Il campo professionale agricoltura comprende sei professioni con formazione professionale<br />
di base triennale e attestato federale di capacità (AFC) e una con formazione professionale<br />
di base biennale e certificato federale di formazione pratica (CFP). Le formazioni sono molto<br />
ampie e adatte a giovani con interessi vari. Per acquisire nuove capacità o assumere la guida di<br />
un’azienda, una parte di coloro che hanno concluso la formazione di base segue una formazione<br />
continua nel settore terziario B, come ad esempio agricoltore/trice con attestato professionale<br />
federale, maestro/a orticoltore/trice (esame professionale superiore) o tecnico vitivinicolo<br />
dipl. SSS. Tutte le professioni di questo campo professionale offrono una serie di interessanti<br />
carriere nell’ambito agricolo come per esempio la vendita, il marketing, la pianificazione, la<br />
trasformazione, la guida e la gestione dell’azienda.<br />
L’evoluzione del numero dei diplomi dipende da diversi fattori: evoluzione demografica, attrattiva<br />
della professione (alternanza, interesse, prospettive, condizioni quadro), considerazione,<br />
immagine e modelli. Negli ultimi anni il numero dei diplomi nel campo professionale agricoltura<br />
è di nuovo aumentato leggermente. Questo è un dato positivo. Un numero sufficiente di<br />
diplomati di tutti i livelli è una condizione necessaria per garantire una regolare successione<br />
nell’azienda con manodopera qualificata e quindi un’agricoltura professionale e imprendito-<br />
292<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 204 / 222<br />
POLITICA > RICERCA, CONSULENZA, FORMAZIONE PROFESSIONALE<br />
riale. Le proiezioni e i dati empirici mostrano che, per la successione dell’azienda da un lato e<br />
le esigenze nei settori a monte e a valle dall’altro, devono essere formate circa 200 leve in più<br />
all’anno rispetto a quanto avviene oggi.<br />
L’obiettivo di formare professionisti qualificati con le giuste competenze non può, però, essere<br />
raggiunto attraverso questa mera riflessione quantitativa. Occorre considerare almeno<br />
nella stessa misura la qualità della formazione e la competitività sul mercato per il futuro. È<br />
necessario continuare a mantenere alta l'attrattiva poiché, a causa del calo demografico, sarà<br />
sempre più difficile accaparrarsi nuove leve alla fine della scuola dell'obbligo.<br />
Controlli quinquennali<br />
Le ordinanze in materia di formazione professionale di base stabiliscono che deve essere creata<br />
una commissione, costituita da partner, per lo sviluppo professionale e la qualità (commissione<br />
SP&Q) nella rispettiva professione. Uno dei compiti principali di tale commissione SP&Q<br />
è controllare, almeno ogni cinque anni, i contenuti formativi, gli obiettivi e i requisiti della<br />
formazione professionale di base in quanto ad aggiornamento, adeguatezza al livello, qualità<br />
e collocabilità sul mercato.<br />
In ambito agricolo cinque anni fa è stata attuata una profonda riforma della formazione di<br />
base. In un sondaggio online condotto su vasta scala (circa 1400 attori, apprendisti, formatori,<br />
scuole, ecc.) e durante workshop di approfondimento è stato chiesto ai gruppi d’interesse di<br />
indicare punti forti e punti deboli, nonché possibilità di miglioramento della formazione agricola<br />
di base. Le informazioni, conclusioni e raccomandazioni ricavate sono state raccolte in un<br />
rapporto conclusivo.<br />
In detto rapporto sono riportati gli evidenti punti forti del sistema attuale, ma anche alcuni<br />
punti deboli e il potenziale di miglioramento. In linea di massima gli interpellati sono soddisfatti<br />
del sistema esistente. Tra i punti forti sono stati annoverati il profilo professionale, la<br />
struttura del piano di formazione, i luoghi di formazione azienda, i corsi interaziendali (CI)<br />
e le scuole professionali, nonché la possibilità di cambiare azienda di tirocinio e le lezioni<br />
pratiche. È stato invece individuato potenziale di miglioramento nei seguenti quattro campi<br />
d'intervento: contenuto del piano di formazione, materiale didattico, struttura e durata della<br />
procedura di qualificazione e distribuzione delle lezioni sugli anni di tirocinio.<br />
Revisione parziale della formazione professionale di base nel campo<br />
professionale agricoltura<br />
Le professioni del campo professionale agricoltura vanno costantemente adeguate agli sviluppi<br />
economici, tecnologici, ecologici e didattici. Almeno ogni cinque anni vanno verificati i contenuti<br />
formativi, gli obiettivi e i requisiti della formazione professionale di base in quanto ad<br />
aggiornamento, adeguatezza al livello, qualità e collocabilità sul mercato. Sulla base di questa<br />
ampia verifica, l’OML AgriAliForm ha deciso di mantenere i punti di forza indiscussi come il cambiamento<br />
del posto di tirocinio, i corsi interaziendali e il riferimento alla pratica, ma allo stesso<br />
tempo di analizzare in modo dettagliato e rivedere i punti deboli e le sovrapposizioni in quattro<br />
campi d’intervento. Gli adeguamenti sono perseguiti nei contenuti dei piani di formazione, nel<br />
materiale didattico, nella procedura di qualificazione e nei corsi interaziendali per la pratica<br />
agricola. Per le professioni delle colture speciali, inoltre, si passa da un modello scolastico progressivo<br />
a uno lineare, il che vuol dire che il numero delle lezioni è ripartito sui tre anni di formazione<br />
in modo equilibrato. Per tutti gli adeguamenti sono state debitamente considerate le<br />
opinioni e le osservazioni dei partner coinvolti. Le commissioni responsabili si sono espresse<br />
a favore di un ulteriore sviluppo organico delle professioni agricole e contro grandi “cantieri”.<br />
I controlli quinquennali offrono però la possibilità e l'occasione di avviare tempestivamente e<br />
con sufficiente anticipo una discussione tra partner sulle fasi successive.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
293
Il mio Rapporto agricolo 205 / 222<br />
POLITICA > RICERCA, CONSULENZA, FORMAZIONE PROFESSIONALE<br />
Nuovo regolamento sul fondo per la formazione professionale<br />
Il Consiglio federale ha conferito carattere obbligatorio generale al nuovo regolamento<br />
dell’OML AgriAliForm sul fondo per la formazione professionale, con integrazioni concernenti<br />
le professioni equestri. Esso è entrato in vigore il 1° febbraio 2016. Il fondo mira a promuovere<br />
la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione<br />
professionale continua delle professioni rappresentate dall’OML AgriAliForm.<br />
Formazione professionale superiore<br />
L’OML AgriAliForm è preposta agli esami di professione e di maestria. Con l’entrata in vigore<br />
dei regolamenti d’esame per gli esami di professione e gli esami professionali superiori è stata<br />
posta la base per l’attuazione del nuovo concetto degli esami federali per l’intero campo professionale<br />
agricoltura in cui rientra il potenziamento delle competenze nell’economia aziendale<br />
e nel mercato, la ridefinizione e l’aggiornamento delle descrizioni dei moduli e l’introduzione<br />
di un esame finale al livello dell’esame di professione nell’azienda del candidato. L’attuazione<br />
del nuovo esame di professione si è svolta nel 2015 senza difficoltà. Lo stesso è avvenuto<br />
nel 2016 per l’esame professionale superiore. Il nuovo concetto sembra dare risultati positivi.<br />
Il più recente accesso alla formazione professionale superiore riguarda le contadine: grazie<br />
all’introduzione dei nuovi regolamenti d’esame anch’esse, con i loro cicli di formazione, rientrano<br />
sotto l’OML AgriAliForm. In tal modo si possono fruttare ulteriori sinergie.<br />
Attrattiva delle professioni del campo professionale agricoltura<br />
Le attività per la promozione di una formazione e di un perfezionamento professionale moderni<br />
e attrattivi devono essere svolte a tutti i livelli in modo coerente. Alla qualità della formazione<br />
occorre attribuire una grande valenza. Vanno potenziate le misure in corso per la pubblicità<br />
a favore delle professioni e quindi la promozione delle nuove leve. Un’esigenza fondamentale<br />
dell’associazione professionale è far in modo che quanti più giovani possibile conseguano un<br />
titolo a livello di AFC o CFP. È il miglior modo per garantire che siano acquisite competenze di<br />
base per poter in seguito aver successo nelle numerose carriere dell’agricoltura o in uno dei<br />
settori economici a monte e a valle. Tutti coloro che portano a termine una formazione di base<br />
agricola sono preziosi ambasciatori dell’agricoltura e della filiera alimentare.<br />
Martin Schmutz, Unione svizzera dei contadini, Agriprof<br />
Contatto: Anton Stöckli, UFAG, Settore Ricerca, consulenza e valutazione, anton.stoeckli@blw.admin.ch<br />
294<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 206 / 222<br />
POLITICA > GESTIONE DEI DATI<br />
Gestione dei dati lungo la filiera alimentare<br />
Da oltre cinque anni il portale Agate e la rispettiva infrastruttura informatica supportano la<br />
gestione dei dati lungo la filiera alimentare per garantire maggiore sicurezza e tracciabilità<br />
degli alimenti. I servizi coinvolti hanno sfruttato questo lasso di tempo per definire e concretizzare<br />
lo sviluppo futuro dell'intero sistema e delle sue applicazioni.<br />
Il sistema del portale Agate<br />
I gestori di aziende agricole, i detentori di animali, oltre che i proprietari di animali della specie<br />
equina hanno l’obbligo di notificare diversi dati alle autorità. L'Ufficio federale dell'agricoltura<br />
(UFAG) ha creato il portale Agate allo scopo di semplificare la notifica elettronica dei dati da<br />
parte di questi gruppi di utenti (user). Effettuando un unico login (Single-Sign-On), gli utenti<br />
possono accedere a tutte le applicazioni connesse, per le quali hanno i diritti. È come se l'utente<br />
inserisse tutti i dati sul portale Agate. Dietro questa porta d’ingresso, però, vi sono numerose<br />
applicazioni indipendenti e dotate di diverse funzionalità.<br />
Tra queste rientrano, ad esempio, la Banca dati sul traffico di animali, HODUFLU, per la dichiarazione<br />
di cessioni e ritiri di sostanze nutritive come liquame, letame, compost a livello<br />
aziendale, le applicazioni cantonali per l'amministrazione dei pagamenti diretti e altri dati necessari<br />
a fini statistici o per la lotta contro le epizoozie.<br />
Queste applicazioni vengono altresì utilizzate da collaboratori dei servizi cantonali e federali<br />
o da terzi cui sono stati concessi i diritti di accesso per lo svolgimento di determinati compiti.<br />
Anche per questi utenti vale la procedura Single-Sign-On. Tuttavia, oltre a quelle summenzionate,<br />
essi hanno a disposizione applicazioni che possono essere utilizzate soltanto all'interno<br />
dell'Amministrazione. Tra queste rientrano sistemi come quello d'informazione sulla politica<br />
agricola (AGIS) dell'UFAG o lo strumento di gestione delle pratiche per il settore veterinario<br />
dell'Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria. L'utilizzo dei dati oltre i limiti delle<br />
applicazioni e del portale Agate è stato descritto in maniera esaustiva nel Rapporto agricolo<br />
2015 (Dati agricoli, Agate).<br />
Il portale Agate è un elemento del sistema e dell'infrastruttura informatica ad esso connessa, il<br />
cui scopo è fornire supporto per l'esecuzione della legislazione agricola e la sicurezza alimentare.<br />
Ottimizzazione del sistema<br />
La strategia sull'amministrazione dei dati agricoli e sulla sicurezza della filiera alimentare<br />
(ASA-LMK-S) è stata elaborata per l'orizzonte temporale 2016-2020 sulla base di documenti<br />
già disponibili, di workshop con i gruppi di utenti e delle esperienze maturate in cinque anni<br />
di attività sul piano operativo e tecnico.<br />
I risultati delle analisi evidenziano che nell'ottica della strategia ASA-LMK-S 2016-2020 è opportuno<br />
ottimizzare il sistema utilizzato finora. A questa conclusione si è giunti esaminando le<br />
prestazioni del sistema attuale (portale Agate), le valutazioni e le esigenze dei diversi gruppi<br />
di utenti nonché le interazioni tra le applicazioni. Per interazioni si intende la connessione tra<br />
applicazioni federali o parafederali e sistemi cantonali.<br />
Per la strategia ASA-LMK-S 2016-2020 sono state formulate le seguenti linee guida.<br />
• Il sistema ASA-LMK-S (portale Agate incl.) è, per la Confederazione, i Cantoni e l'economia<br />
privata, un sistema d'informazione nazionale (sistema congiunto), che comprende gli ambiti<br />
agricoltura, veterinaria e sicurezza alimentare (principio delle 3 a: agricoltura, animali,<br />
alimenti).<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
295
Il mio Rapporto agricolo 207 / 222<br />
POLITICA > GESTIONE DEI DATI<br />
Permette in primo luogo di eseguire in maniera efficiente le rispettive legislazioni.<br />
• Il portale genera, per gli utenti, un valore aggiunto dal profilo dell'informazione impostata<br />
in maniera specifica sull'utente, dell'utilizzo sicuro dei propri dati e della trasmissione semplice<br />
e controllata dei dati.<br />
• Il portale e i sistemi collegati sono utilizzabili in maniera semplice e in caso di problemi è<br />
a disposizione un'organizzazione di supporto ben funzionante.<br />
• L'infrastruttura e il portale devono essere stabili ed efficienti.<br />
Da queste linee guida sono scaturiti i seguenti sei campi d'intervento.<br />
• Campo d'intervento 1 - un sistema per tutta la filiera alimentare:<br />
Il sistema ASA-LMK-S è impostato anche in futuro per l'intera filiera alimentare. È inoltre possibile<br />
utilizzare applicazioni già esistenti anche al di fuori della filiera alimentare. I controlli in<br />
materia di protezione degli animali per «animali da compagnia», ad esempio, possono essere<br />
gestiti con quelli per «animali da reddito» nel medesimo sistema nel quadro di ASA-LMK- S.<br />
In ASA-LMK-S vengono amministrati soltanto i dati necessari per l'esecuzione della legislazione<br />
federale. Non vengono amministrati dati privati.<br />
• Campo d'intervento 2 - piccoli passi per un miglioramento costante:<br />
Il collegamento a nuove applicazioni avviene progressivamente e dipende dalla risorse finanziarie<br />
e umane disponibili presso i servizi interessati.<br />
L'intero sistema è aperto a nuovi aspetti e ottimizza quelli esistenti.<br />
• Campo d'intervento 3 - dalla registrazione decentrata dei dati al concetto di dati<br />
master:<br />
La registrazione decentrata dei dati, per esempio nei sistemi cantonali, viene mantenuta. Deve<br />
tuttavia adempiere determinati presupposti, affinché la qualità e l'attualità dei dati rispondano<br />
alle esigenze. A tal fine è indispensabile elaborare e attuare rigorosamente un concetto di dati<br />
master che disciplini chi è responsabile della prima registrazione e della successiva gestione<br />
dei singoli dati (p.es. indirizzi, recapiti telefonici, indirizzi e-mail) e secondo quali modalità.<br />
Occorre inoltre definire le interfacce necessarie per una gestione ottimale dei dati, onde evitare<br />
registrazioni inutili.<br />
• Campo d'intervento 4 - Agate come piattaforma per la comunicazione e l'informazione :<br />
Il portale Agate, oltre alla funzione prioritaria dell'autenticazione degli utenti per le applicazioni<br />
nel quadro di ASA-LMK-S, viene utilizzato sempre più come piattaforma per la comunicazione<br />
e l'informazione, onde aumentare ulteriormente i vantaggi per gli utenti.<br />
• Campo d'intervento 5 - registrazione unica, utilizzo ripetuto:<br />
I dati dell'ambito di diritto pubblico (p.es. AGIS) sono già ampiamente utilizzati da diversi servizi<br />
federali. Il principio «Registrazione unica, utilizzo ripetuto» è ormai assodato sul piano<br />
federale.<br />
A livello di applicazioni, invece, mancano le possibilità per un utilizzo semplice dei dati a<br />
scopo privato o per una trasmissione mirata dei dati a terzi con il consenso del gestore.<br />
La situazione viene sensibilmente migliorata attraverso lo sviluppo delle rispettive funzionalità<br />
e la creazione di interfacce standard dei dati.<br />
• Campo d'intervento 6 - sostegno ottimale all'utente del portale:<br />
Il potenziale e l'impiego di moderne tecnologie (apparecchi mobili, cloudcomputing) vengono<br />
valutati dal profilo tecnico e operativo e, laddove opportuno, esse vengono applicate.<br />
296<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 208 / 222<br />
POLITICA > GESTIONE DEI DATI<br />
Onde contenere i costi, la priorità viene data a prodotti standard.<br />
Un'organizzazione di supporto adeguata fornisce assistenza ottimale a utenti e servizi amministrativi<br />
in caso di problemi.<br />
I campi d'intervento mostrano in quali ambiti sono necessari ulteriori lavori concettuali e fissano<br />
al contempo le linee guida per decisioni o strumenti sul piano operativo.<br />
La strategia ASA-LMK-S 2016–2020 contempla altresì il periodo dopo il 2020. Dai lavori concettuali<br />
nell'orizzonte temporale 2016-2020 possono scaturire anche adeguamenti sul piano<br />
legale che, a causa dell’iter prescritto, potranno tuttavia essere attuati soltanto a partire dal<br />
2022. Si parte dal presupposto che la gestione dei dati lungo la filiera alimentare nel periodo<br />
dopo il 2020 potrebbe nuovamente subire profondi cambiamenti. È probabile che prima di tale<br />
scadenza gli attuali sistemi o parte di essi saranno sostituiti da sistemi di nuova generazione.<br />
È tuttavia opportuno concentrarsi sui processi operativi e sulle esigenze delle diverse cerchie<br />
coinvolte anziché sulla tecnologia (IT follows strategy).<br />
Manfred Tschumi, UFAG, Settore Sistemi d'informazione sull'agricoltura, manfred.tschumi@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
297
Il mio Rapporto agricolo 209 / 222<br />
POLITICA > GESTIONE DEI DATI<br />
HODUFLU<br />
Sintesi e contesto legale<br />
L'UFAG gestisce il sistema d'informazione HODUFLU (acronimo in tedesco di flussi di concimi)<br />
per la registrazione dei trasferimenti di sostanze nutritive nell'agricoltura. L'applicazione web<br />
HODUFLU è stata sviluppata come strumento esecutivo per il settore della protezione delle<br />
acque dagli inquinanti di origine agricola e per amministrare i trasferimenti di concimi aziendali<br />
e ottenuti dal riciclaggio, concentrandosi, in particolare, sui trasferimenti delle sostanze<br />
nutritive azoto e fosforo.<br />
Gli utenti di HODUFLU sono aziende agricole nonché impianti di biogas e di compostaggio agricoli,<br />
artigianali e industriali. Questi devono registrare in HODUFLU tutti i trasferimenti di concimi<br />
aziendali e ottenuti dal riciclaggio da e verso l'agricoltura nonché tra le singole aziende.<br />
In alcuni casi vengono effettuati trasferimenti anche oltrefrontiera, in particolare in Germania,<br />
nel Liechtenstein e in Austria.<br />
Nel sistema i trasferimenti di concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio sono registrati come<br />
bollettini di consegna con indicazione di quantità, tenore in sostanze nutritive, fornitore e<br />
acquirente. I bollettini di consegna HODUFLU vengono utilizzati per il calcolo del bilancio delle<br />
sostanze nutritive - Suisse Bilanz - a condizione che siano stati confermati dall'acquirente.<br />
HODUFLU – Dettagli e limite del sistema<br />
I gestori registrano personalmente i prodotti e i bollettini di consegna. Chi cede concimi aziendali<br />
o ottenuti dal riciclaggio è responsabile della corretta registrazione del bollettino di<br />
consegna e della sua attribuzione a un acquirente. Nel momento in cui riceve fisicamente la fornitura,<br />
l'acquirente è tenuto a confermare il bollettino di consegna nel sistema web HODUFLU.<br />
298<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 210 / 222<br />
POLITICA > GESTIONE DEI DATI<br />
Il grafico definisce il limite del sistema HODUFLU e mostra, sulla base di un esempio, un trasferimento<br />
di concimi aziendali dall'azienda A all'azienda B. La registrazione del bollettino di<br />
consegna è compito del gestore dell'azienda A. La conferma del bollettino di consegna viene<br />
eseguita dall'acquirente dell'azienda B. Se una fornitura è destinata a un impianto di fermentazione<br />
o di compostaggio, per il ritrasferimento a un'azienda agricola sono nuovamente necessarie<br />
la registrazione del bollettino di consegna da parte dell'impianto di compostaggio o di<br />
fermentazione e la conferma del bollettino di consegna da parte dell'acquirente (azienda B).<br />
Coloro che cedono concimi aziendali sono generalmente gestori agricoli con un'elevata densità<br />
di animali e di conseguenza un volume notevole di concimi aziendali rispetto alla superficie<br />
concimabile. Il tenore in sostanze nutritive del concime aziendale è calcolato dall'azienda<br />
fornitrice o indicato utilizzando un tenore standard; per le forniture provenienti da impianti di<br />
biogas il tenore in sostanze nutritive è generalmente stabilito mediante analisi di laboratorio.<br />
Di norma i concimi aziendali vengono forniti ad aziende agricole con un comprovato fabbisogno<br />
di sostanze nutritive o a impianti di biogas e di compostaggio. Dopo la fermentazione o il compostaggio,<br />
i prodotti vengono generalmente «restituiti» all'agricoltura.<br />
Nel grafico seguente è illustrato il limite del sistema HODUFLU. La freccia all'altezza dei cosubstrati<br />
(cfr. riquadro) indica che questi finiscono negli impianti di biogas, ma non vengono<br />
registrati in HODUFLU sotto forma di bollettini di consegna. Tuttavia, gli impianti agricoli di<br />
biogas dichiarano annualmente le quantità in entrata in un modulo di bilancio. Anche gli apporti<br />
di alimenti per animali non vengono registrati in HODUFLU, nonostante siano all'origine<br />
di un aumento dei concimi aziendali nella produzione animale. In HODUFLU vengono registrate<br />
soltanto le quantità di concimi aziendali effettivamente trasferite. I cicli di sostanze nutritive<br />
all'interno dell'azienda non sono oggetto di registrazione.<br />
Gli apporti di sostanze nutritive riconducibili all'importazione di carne, al riciclaggio del fosforo<br />
o ai concimi minerali non sono contemplati da HODUFLU, ma incidono sulla situazione<br />
svizzera in fatto di sostanze nutritive.<br />
Co-substrati frequenti:<br />
scarti vegetali, come erba tagliata o rami, provenienti generalmente dal giardinaggio<br />
resti alimentari provenienti dalle economie domestiche o dalla ristorazione<br />
scarti della macellazione o alimenti scaduti<br />
sottoprodotti della trasformazione delle derrate alimentari (p.es. glicerina)<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
299
Il mio Rapporto agricolo 211 / 222<br />
POLITICA > GESTIONE DEI DATI<br />
I concimi minerali, le importazioni di alimenti per animali o il fosforo ottenuto dal riciclaggio non sono contemplati<br />
da HODUFLU. L'apporto di co-substrati agli impianti di biogas non è registrato sotto forma di bollettini di consegna;<br />
negli impianti agricoli di biogas l'apporto di co-substrati è oggetto di un bilancio annuale.<br />
Prodotti e determinazione del tenore<br />
I prodotti trasferiti in HODUFLU provengono, di base, da due fonti diverse. I concimi aziendali<br />
provenienti dalla detenzione agricola di animali, sotto forma di concime e liquame, sono<br />
sempre considerati concimi aziendali. I prodotti ottenuti dagli impianti di biogas sono dichiarati<br />
come concimi aziendali o ottenuti dal riciclaggio a seconda della percentuale di co-substrati.<br />
Le quattro principali categorie di prodotti trasferiti in HODUFLU sono:<br />
• i concimi aziendali provenienti dalla detenzione di animali<br />
• i concimi aziendali provenienti da impianti agricoli di biogas<br />
• i concimi ottenuti dal riciclaggio provenienti da impianti artigianali/industriali di biogas<br />
(digestato solido, digestato liquido, concentrato di sostanze nutritive)<br />
• il compost, concime ottenuto dal riciclaggio, proveniente da impianti di compostaggio<br />
Dichiarazione di concimi aziendali o ottenuti dal riciclaggio dopo la trasformazione in un<br />
impianto di biogas<br />
Impianto agricolo di fermentazione<br />
(zona agricola)<br />
Materiale di partenza<br />
≥ 80 % di concimi aziendali<br />
50–80 % di concimi aziendali<br />
Materiale finale<br />
Concimi aziendali<br />
Concimi ottenuti dal riciclaggio<br />
Impianto artigianale/industriale di<br />
fermentazione<br />
< 50 % di di concimi aziendali Concimi ottenuti dal riciclaggio<br />
300<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 212 / 222<br />
POLITICA > GESTIONE DEI DATI<br />
Valutazione dei dati HODUFLU – Cifre salienti<br />
Attualmente HODUFLU conta circa 20 000 utenti, corrispondenti al numero di account HO-<br />
DUFLU attivi. Di questi, 8000 sono fornitori e 12 000 acquirenti; alcune aziende sono al contempo<br />
fornitrici e acquirenti.<br />
Nella tabella seguente sono riportate tutte le forniture registrate in HODUFLU nel 2015. Dei<br />
46 000 bollettini di consegna registrati, 35 5000 riguardavano forniture di concimi aziendali<br />
provenienti dalla detenzione di animali e 10 484 forniture di concimi aziendali e ottenuti dal<br />
riciclaggio provenienti da impianti di biogas e di compostaggio. In totale sono stati trasferiti<br />
circa 3,7 milioni di metri cubi di materiale, per una quantità di sostanze nutritive pari a circa<br />
17 000 tonnellate di azoto (Ntot = azoto totale) e 8500 tonnellate di fosforo (P 2 O 5 ). Il flusso di<br />
sostanze nutritive più consistente riguarda i concimi aziendali provenienti dalla detenzione di<br />
animali, con circa 11 000 tonnellate di Ntot e 5700 tonnellate di P 2 O 5 . Dagli impianti di biogas<br />
e di compostaggio (sia agricoli sia artigianali/industriali) sono state trasferite complessivamente<br />
6400 tonnellate di Ntot e 2800 tonnellate di P 2 O 5 .<br />
Forniture registrate in HODUFLU nel 2015<br />
Bollettini di<br />
consegna (numero)<br />
Quantità<br />
(m 3 )<br />
Ntot (t) P 2 O 5 (t)<br />
Concimi aziendali<br />
Concimi ottenuti<br />
dal riciclaggio<br />
da impianti di<br />
biogas agricoli<br />
dalla detenzione<br />
di animali<br />
Totale intermedio<br />
da impianti di<br />
biogas art./ind.<br />
2424 343 337 1187 519<br />
35 473 2 445 806 10 931 5669<br />
37 897 2 789 143 12 118 6189<br />
5591 647 791 3259 1278<br />
Compost 2471 260 999 2020 1026<br />
Totale intermedio 8062 908 790 5279 2305<br />
TOTALE 45 959 3 697 933 17 397 8494<br />
Fonte: UFAG<br />
Sul territorio svizzero la produzione di concimi aziendali ammonta a 23 milioni di tonnellate, di<br />
cui il 90 per cento viene impiegato direttamente nell'azienda produttrice e il 10 per cento viene<br />
trasferito nel quadro di HODUFLU. Di questo 10 per cento, quattro quinti sono trasferiti direttamente<br />
in altre aziende agricole che li distribuiscono sui propri campi, mentre un quinto è destinato<br />
ad impianti di biogas e di compostaggio. L'agricoltura fornisce pertanto 2630 tonnellate<br />
di Ntot e 1491 tonnellate di P 2 O 5 ad impianti di biogas che, dal canto loro, ne restituiscono<br />
quasi il doppio al primario, ovvero 5123 tonnellate di Ntot e 2262 tonnellate di P 2 O 5 . Questo<br />
aumento di sostanze nutritive è riconducibile principalmente all'apporto di co-substrati.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
301
Il mio Rapporto agricolo 213 / 222<br />
POLITICA > GESTIONE DEI DATI<br />
Quote dei flussi di concimi aziendali tra l'agricoltura e gli impianti di biogas e di compostaggio<br />
Bollettini<br />
di consegna<br />
(numero)<br />
Quantità<br />
(m 3 )<br />
Ntot (t)<br />
P 2 O 5 (t)<br />
Agricoltura<br />
come fornitore<br />
Agricoltura<br />
come fornitore<br />
Agricoltura<br />
come acquirente<br />
Fonte: UFAG<br />
# Agricoltura<br />
come acquirente<br />
# Impianto di<br />
biogas/compostaggio<br />
come acquirente<br />
# Impianto di<br />
biogas/compostaggio<br />
come fornitore<br />
29 535 1 957 363 8301 4177<br />
5940 488 688 2630 1491<br />
9396 979 330 5123 2262<br />
Trasferimenti a livello cantonale<br />
Dei 26 Cantoni che formano la Svizzera, 8 hanno fornito oltre 50 000 m 3 di concimi aziendali<br />
e ottenuti dal riciclaggio. Nei Cantoni AG, BE, FR, LU, SG, TG, VD e ZG è stato registrato oltre il<br />
78 per cento dei trasferimenti complessivi. Nel grafico seguente sono riportati gli 8 Cantoni in<br />
questione; le frecce indicano i principali trasferimenti.<br />
Nella tabella seguente sono riportati in dettaglio le quantità in metri cubi trasferite da questi 8<br />
Cantoni. I campi contrassegnati in rosso rappresentano i trasferimenti all'interno del Cantone.<br />
Quelli in verde indicano i trasferimenti intercantonali, riprodotti sulla carta della Svizzera mediante<br />
frecce. Da un confronto tra i campi di colore rosso e verde emerge chiaramente che le<br />
quantità più consistenti vengono trasferite all'interno dei Cantoni.<br />
302<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 214 / 222<br />
POLITICA > GESTIONE DEI DATI<br />
Nel 2015 il trasferimento intercantonale più importante ha interessato i Cantoni Lucerna (fornitore)<br />
e Berna (acquirente), con una quantità di 63 393 m 3 , ovvero 422 tonnellate di Ntot e<br />
232 tonnellate di P 2 O 5 . Il secondo trasferimento intercantonale più consistente ha interessato<br />
i Cantoni Lucerna (fornitore) e Argovia (acquirente), con una quantità di 83 943 m 3 , ovvero<br />
390 tonnellate di Ntot e 186 tonnellate di 2 PO 5 . Il terzo ha coinvolto i Cantoni San Gallo (fornitore)<br />
e Turgovia (acquirente) e il quarto i Cantoni San Gallo (fornitore) e Zurigo (acquirente).<br />
I dati completi sono visualizzati nelle seguenti tabelle con celle a tendina.<br />
» A104<br />
» A105<br />
Quantità di azoto trasferita<br />
Quantità di fosforo trasferita<br />
Conclusioni<br />
Queste prime valutazioni dei dati HODUFLU forniscono indicazioni interessanti. Non è tuttavia<br />
ancora possibile trarre conclusioni definitive. La base di dati disponibile può essere utilizzata<br />
a sostegno dell'esecuzione a livello cantonale e consente di rispondere a domande su come<br />
affrontare le sfide future.<br />
HODUFLU illustra unicamente le quantità di concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio trasferite.<br />
Attualmente il 10 per cento circa della produzione di concimi aziendali è trasferito tra le<br />
aziende. È interessante constatare che attraverso gli impianti di biogas, o più precisamente attraverso<br />
i co-substrati, viene restituita all'agricoltura una notevole quantità di sostanze nutritive.<br />
HODUFLU contribuisce a sgravare le regioni con un volume elevato di sostanze nutritive e a<br />
garantire una migliore distribuzione in zone carenti. La valorizzazione dei concimi aziendali<br />
e ottenuti dal riciclaggio e una migliore distribuzione delle sostanze nutritive rimangono gli<br />
obiettivi principali. Grazie alla registrazione centralizzata, HODUFLU fornisce una base di dati<br />
attendibile e contribuisce ad accrescere la trasparenza in merito ai trasferimenti di sostanze<br />
nutritive.<br />
Mathias Kuhn, UFAG, Settore Pagamenti diretti Programmi, mathias.kuhn@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
303
Il mio Rapporto agricolo 2 / 5<br />
POLITICA > PROGRAMMI REGIONALI E SETTORIALI<br />
Contributi per la protezione delle acque<br />
Dal 1999, mediante l'articolo 62a della legge sulla protezione delle acque, nell'ambito del programma<br />
sulla protezione delle acque la Confederazione può promuovere i provvedimenti presi<br />
dal settore agricolo per prevenire il convogliamento e il dilavamento di sostanze nelle acque<br />
superficiali e sotterranee. I progetti possono essere sostenuti finanziariamente e attuati se i<br />
divieti e i precetti, la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) e i programmi facoltativi<br />
nel quadro dei pagamenti diretti (agricoltura biologica, produzione estensiva, biodiversità)<br />
non sono sufficienti a ridurre l'inquinamento delle acque. Finora la maggior parte dei<br />
programmi lanciati era finalizzata alla riduzione del carico di nitrati nell'acqua potabile (attualmente<br />
31 progetti). Un progetto ha l'obiettivo di ridurre il carico di fosforo nei laghi di Baldegg,<br />
Sempach e Hallwil. Sono stati lanciati anche due progetti relativi ai prodotti fitosanitari.<br />
» A106<br />
In virtù dell’ordinanza sulla protezione delle acque, i Cantoni sono tenuti a designare un settore<br />
d’alimentazione per le captazioni di acque superficiali e sotterranee nonché a ordinare provvedimenti<br />
di risanamento qualora la qualità dell’acqua fosse insufficiente. Questi provvedimenti<br />
possono comportare limitazioni significative rispetto allo stato della tecnica per quanto<br />
concerne l’utilizzazione del suolo nonché perdite finanziarie insopportabili per le aziende. Per<br />
compensarle la Confederazione appronta mezzi finanziari nell'ambito del programma sulla protezione<br />
delle acque. Nel 2015 a favore del programma messo a punto per l'agricoltura sono<br />
stati stanziati circa 3 milioni di franchi.<br />
Il grado di raggiungimento degli obiettivi dei singoli progetti è eterogeneo e dipende dal contesto<br />
agricolo nonché dalle caratteristiche naturali e territoriali. I progetti sono stati in gran<br />
parte realizzati in conformità di quanto prescritto.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura: Programma sulla protezione delle acque<br />
Caroline Amsler, UFAG, Settore Sistemi agroambientali e sostanze nutritive, caroline.amsler@blw.admin.ch<br />
Ivo Strahm, UFAG, Settore Sistemi agroambientali e sostanze nutritive, ivo.strahm@blw.admin.ch<br />
304<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 4 / 5<br />
POLITICA > PROGRAMMI REGIONALI E SETTORIALI<br />
Contributi per i programmi sulle risorse<br />
In virtù degli articoli 77a e 77b LAgr, dal 2008 la Confederazione versa contributi intesi a<br />
migliorare l'impiego delle risorse naturali in ambito agricolo. Il programma sulle risorse ha<br />
l'obiettivo di accrescere l'efficienza dell'impiego delle risorse necessarie per la produzione<br />
agricola, di ottimizzare l'impiego di sostanze ausiliarie e di promuovere la biodiversità in ambito<br />
agricolo. A tale scopo vengono sostenuti provvedimenti che contribuiscono a un rapido<br />
adeguamento alle novità organizzative, tecniche e strutturali nella pratica agricola. Se questi<br />
provvedimenti sono fattibili e hanno un'applicazione pratica, in un secondo tempo possono<br />
eventualmente essere promossi anche al di fuori di una regione o di una filiera.<br />
I progetti sulle risorse perseguono sempre due obiettivi.<br />
1. Obiettivo d’efficacia: migliorare in maniera durevole la sostenibilità nell'impiego delle risorse<br />
naturali rilevanti per l'agricoltura nel comprensorio di ciascun progetto sulle risorse.<br />
L'efficacia del progetto viene verificata con un monitoraggio specifico.<br />
2. Obiettivo di apprendimento: acquisire nuove conoscenze al di là della durata e del comprensorio<br />
del progetto. Per raggiungere tale obiettivo di apprendimento, è necessaria un’assistenza<br />
di tipo scientifico durante l’esecuzione del progetto.<br />
Il miglioramento dal profilo ecologico deve essere ottenuto aumentando l'efficienza<br />
nell'impiego delle risorse. La produzione agricola non deve essere ridotta.<br />
Il sostegno della Confederazione è inteso come aiuto iniziale ed è limitato a sei anni. L'UFAG<br />
partecipa ai costi nella misura dell'80 per cento al massimo. Il finanziamento dei costi residui<br />
del progetto deve essere garantito da un ente responsabile. Le misure devono continuare a<br />
espletare i loro effetti anche dopo la conclusione del progetto.<br />
Ogni progetto sulle risorse prevede un approccio integrale con una determinata combinazione<br />
di misure, che comprende il sostegno di innovazioni strutturali, tecniche e organizzative<br />
nell'agricoltura, alle quali si aggiungono la formazione, la consulenza, l'informazione, il controllo<br />
dell'attuazione, il monitoraggio dell'efficacia e l'assistenza scientifica.<br />
Al centro del programma sulle risorse vi è la pratica agricola, ma è possibile sostenere anche<br />
innovazioni lungo l’intera filiera alimentare, come progetti che promuovono la produzione e<br />
l’impiego di concimi fosforici ottenuti da riciclaggio o progetti che contribuiscono globalmente<br />
alla sicurezza del sistema di produzione agricolo.<br />
Progetti sulle risorse in corso<br />
» A107<br />
Dal 2008 sono stati lanciati complessivamente 24 progetti sui temi ammoniaca, suolo, biodiversità,<br />
energia, aria e acqua. A fine 2015 ne sono stati portati a termine 12; nel 2016 sono<br />
stati lanciati 2 nuovi progetti sulle risorse incentrati sul tema del clima e 1 sugli antibiotici.<br />
Nella tabella seguente sono riportati i progetti in corso nell'anno oggetto del rapporto.<br />
Nel 2015 la Confederazione ha versato complessivamente 22,9 milioni di franchi a favore di<br />
progetti sulle risorse, ovvero il 14 per cento circa in meno rispetto al 2014.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
305
Il mio Rapporto agricolo 5 / 5<br />
POLITICA > PROGRAMMI REGIONALI E SETTORIALI<br />
Progetti sulle risorse il cui inizio è previsto nel 2017/2018<br />
Nuovi progetti<br />
Nome del progetto<br />
Progetto sui prodotti fitosanitari - Basilea Campagna<br />
Progetto sui prodotti fitosanitari - Berna<br />
Progetti sulle api e sulle api selvatiche - Argovia<br />
Progetto sugli impollinatori - Vaud, Giura e Berna<br />
Progetto sulla biodiversità e sulla campicoltura Stazione<br />
ornitologica<br />
Progetto sull'irrigazione - Vaud<br />
Progetto "BiodivSol" - Vaud<br />
Progetto di miglioramento del suolo Grosses Moos<br />
Progetto sulla gestione dell'humus - Soletta<br />
Eliminazione dello Staphylococcus Aureus - Ticino<br />
Progetto sulle risorse del servizio sanitario per i vitelli<br />
Progetto sulla frutticoltura - Vaud, Vallese e Ginevra<br />
Progetto sulla frutticoltura - Turgovia<br />
Precision Farming<br />
Obiettivo del progetto<br />
Riduzione del rischio di immissioni di prodotti fitosanitari<br />
e di substrato del suolo nelle acque superficiali<br />
Riduzione del rischio di immissioni di prodotti fitosanitari<br />
e di substrato del suolo nelle acque superficiali<br />
Promozione di api e api selvatiche<br />
Promozione di api e api selvatiche<br />
Promozione della biodiversità in campicoltura<br />
Irrigazione sostenibile<br />
Gestione sostenibile del suolo<br />
Miglioramento del suolo<br />
Aumento della fertilità del suolo<br />
Riduzione dell'utilizzo di antibiotici<br />
Riduzione dell'utilizzo di antibiotici<br />
Miglioramento della sostenibilità in frutticoltura<br />
Miglioramento della sostenibilità in frutticoltura<br />
Implementazione dell'agricoltura di precisione<br />
Fonte: UFAG<br />
Nell'ambito del programma sulle risorse, dal 2008 è stata lanciata una serie di progetti. Soprattutto<br />
per quanto riguarda il tema «ammoniaca» sono stati avviati progetti su quasi tutto<br />
il territorio nazionale. Con la nuova impostazione del programma sulle risorse e la pubblicazione<br />
di nuove spiegazioni, nel 2014, è aumentata considerevolmente l'eterogeneità dei temi<br />
nel programma sulle risorse. L'assistenza scientifica nel quadro dei progetti sulle risorse contribuirà<br />
ad acquisire conoscenze approfondite sull'idoneità delle innovazioni per l'agricoltura<br />
svizzera al di là dei confini regionali e della durata dei progetti.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura: Programma sulle risorse<br />
Caroline Amsler, UFAG, Settore Sistemi agroambientali e sostanze nutritive, caroline.amsler@blw.admin.ch<br />
Ivo Strahm, UFAG, Settore Sistemi agroambientali e sostanze nutritive, ivo.strahm@blw.admin.ch<br />
306<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
307
Il mio Rapporto agricolo 2 / 42<br />
INTERNAZIONALE > INTRODUZIONE<br />
Introduzione<br />
La Svizzera, con la sua economia piccola, ma molto efficiente, orientata all'esportazione, ha<br />
bisogno di essere ben collegata con i mercati internazionali. Gli sviluppi internazionali, in un<br />
contesto globale contraddistinto dall'impegno verso una maggiore liberalizzazione, rivestono<br />
un'importanza enorme per l'economia elvetica. A questo livello non si deve accettare alcun<br />
risvolto negativo che possa pregiudicare la competitività sul piano economico. Ciò vale anche<br />
per le imprese della filiera agroalimentare. Il potenziale di esportazione esistente nel primario<br />
deve poter essere sfruttato nel miglior modo possibile. Questo aspetto sta diventando sempre<br />
più importante a causa della crescente globalizzazione. Anche nel 2016 la Svizzera ha pertanto<br />
ampliato la sua rete globale di accordi di libero scambio con Paesi terzi. Accanto a un accordo<br />
di libero scambio con le Filippine ne ha concluso uno con la Georgia. Oltre all'Associazione europea<br />
di libero scambio (AELS) e all'Accordo di libero scambio con l'UE, questa rete comprende<br />
30 accordi con 41 partner. Tutti, ad eccezione di quelli con Cina, Giappone e le Isole Färöer,<br />
sono stati conclusi nel quadro dell'AELS.<br />
Nel dicembre 2015, a Nairobi, si è riunita per la decima volta la Conferenza dei ministri, il massimo<br />
organo decisionale dell'OMC. Al di là dell'approvazione dell'estensione dell'accordo sulla<br />
liberalizzazione del commercio di prodotti della tecnologia dell’informazione, il Pacchetto di<br />
Nairobi riveste una particolare importanza soprattutto per il settore agricolo. Particolarmente<br />
rilevante per la Svizzera è stata la decisione di abolire completamente tutti i sussidi alle esportazioni.<br />
Il nostro Paese versa contributi di questo genere per le materie prime latte e cereali nei<br />
prodotti agricoli trasformati nel quadro della cosiddetta legge sul cioccolato. Per smantellare<br />
questi sussidi la decisione di Nairobi concede, alla Svizzera segnatamente, un termine transitorio<br />
di cinque anni entro il quale i contributi all'esportazione dovranno essere completamente<br />
eliminati. L'abolizione dei sussidi alle esportazioni avverrà in un'unica tappa alla fine del periodo<br />
di transizione.<br />
Tra i Paesi membri dell'OMC regna un forte disaccordo sul futuro del ciclo di Doha, avviato nel<br />
2001 e non ancora concluso. L'interrogativo principale è se vada portato avanti a prescindere<br />
oppure se ciò non sia realistico e di conseguenza sia meglio dedicarsi a nuovi temi. La situazione<br />
sui mercati internazionali non è più paragonabile a quella del 2001 quando il ciclo di Doha è<br />
stato avviato. Il mandato originario non sembra più adeguato alla situazione attuale. In particolare<br />
gli Stati emergenti come Cina, India e Brasile, che stanno consolidando la loro posizione<br />
nel commercio agricolo globale, si oppongono a una nuova valutazione della situazione.<br />
La cooperazione con l'UE nella filiera agroalimentare è disciplinata mediante accordi bilaterali,<br />
costantemente adeguati a livello operativo in funzione dei cambiamenti delle condizioni<br />
quadro. Considerati i problemi di ordine superiore irrisolti tra la Svizzera e l'UE, spesso simili<br />
adeguamenti, necessari per la convivenza quotidiana, incontrano enormi difficoltà.<br />
Sul piano internazionale la Svizzera si impegna a più livelli a favore<br />
di una filiera agroalimentare efficace e sostenibile<br />
A settembre 2015 l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato la cosiddetta Agenda 2030 per<br />
uno sviluppo sostenibile, che va a sostituire gli obiettivi di sviluppo del Millennio, scaduti a<br />
fine 2015. Uno dei 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals<br />
- SDG) dell'Agenda 2030 riguarda esplicitamente il settore agricoltura sostenibile, sicurezza<br />
alimentare e qualità delle derrate alimentari. Nel dicembre 2015 il Consiglio federale ha deciso<br />
di appurare, nel quadro di una fase transitoria nel periodo 2016-2017, gli strumenti e gli organi<br />
fondamentali per la Svizzera in vista dell'attuazione dell'Agenda 2030 e di sviluppare un<br />
apposito sistema nazionale di monitoraggio e reporting.<br />
In occasione della Conferenza dei ministri dell'OCSE, nell'aprile 2016, i 400 partecipanti da 48<br />
Paesi, tra cui 35 ministri, hanno discusso all'insegna del motto "politiche migliori per un sis-<br />
308<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 3 / 42<br />
INTERNAZIONALE > INTRODUZIONE<br />
tema alimentare globale resiliente, sostenibile e produttivo". Gli obiettivi della conferenza del<br />
2016 erano lo scambio di informazioni e la discussione sui sistemi agroalimentari globali sostenibili<br />
di domani nonché sulle politiche innovative e lungimiranti necessarie e attuabili a tal<br />
fine. Da un lato si è fatto riferimento ai recenti accordi e negoziati nel quadro dell'Agenda 2030<br />
per uno sviluppo sostenibile (SDG incl.), della Conferenza sul clima dell'ONU del 2015 (COP21)<br />
e della Conferenza dei ministri dell’OMC di Nairobi. Dall'altro sono stati menzionati anche la<br />
sicurezza alimentare della popolazione mondiale in crescita, la rarefazione e la fragilità delle<br />
risorse, la protezione del clima, lo sviluppo economico e la resilienza del primario. La Svizzera<br />
si è impegnata affinché l’OCSE assuma un ruolo attivo, nel quadro delle sue competenze, al fine<br />
di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030.<br />
La Svizzera è stata scelta, assieme a Sudafrica, Hivos e WWF International, per codirigere il Programma<br />
per sistemi alimentari sostenibili, che si colloca nel quadro decennale di programmi<br />
per un modello di consumo e di produzione sostenibile e che conta sulla collaborazione degli<br />
attori lungo l'intera catena del valore del settore privato, della ricerca, delle organizzazioni internazionali,<br />
delle ONG e delle organizzazioni governative. La collaborazione mirata consente<br />
di sfruttare le sinergie e di impiegare le risorse in maniera puntuale per accelerare la transizione<br />
verso sistemi alimentari sostenibili. Il Programma per sistemi alimentari sostenibili contribuisce<br />
direttamente alla realizzazione degli obiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile.<br />
Martijn Sonnevelt, UFAG, Unità di direzione Affari internazionali, martijn.sonnevelt@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
309
Il mio Rapporto agricolo 4 / 42<br />
INTERNAZIONALE > DIMENSIONE COMMERCIALE<br />
FAO<br />
Nel 2015, l'impegno dell'UFAG in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per<br />
l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) si è concretizzato in particolare in due eventi importanti:<br />
la 39sima sessione della Conferenza della FAO che si è tenuta dal 6 al 13 giugno 2015 e il dibattito<br />
di alto livello sulla sicurezza alimentare e i cambiamenti climatici nel quadro dell'Expo<br />
2015 a Milano.<br />
39sima sessione della Conferenza FAO, 6-13 giugno 2015<br />
Preceduta da un forum ministeriale sull'agricoltura e l'alimentazione organizzato a Milano<br />
nel quadro dell'esposizione universale 2015, la Conferenza, organo supremo della FAO, ha<br />
esaminato, nel quadro della sua 39 sima sessione, la situazione mondiale dell'alimentazione e<br />
dell'agricoltura. Il tema del dibattito generale è stato "Spezzare il circolo vizioso della povertà<br />
rurale e della fame potenziando la resilienza nelle aree rurali: protezione sociale e sviluppo<br />
sostenibile dell'agricoltura". In relazione a questo punto dell'ordine del giorno la Conferenza<br />
ha preso atto dell'importanza del suolo per l'agricoltura sostenibile e ha espresso la propria<br />
soddisfazione nei confronti dell'Anno internazionale dei suoli. Inoltre, ha sottolineato che i<br />
cambiamenti climatici minacciano sempre più la sicurezza alimentare e l'alimentazione a livello<br />
mondiale. Dal canto suo, la Svizzera ha sottolineato il suo impegno a favore del nuovo quadro<br />
globale in materia di sviluppo sostenibile nel contesto dell'agenda post-2015 (nel frattempo<br />
denominata Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile). Ha altresì chiesto alla FAO di contribuire<br />
all'attuazione rapida e coerente dei "Principi per investimenti responsabili nell’agricoltura e<br />
nei sistemi alimentari" e di potenziare la sua collaborazione con le altre agenzie ONU a Roma.<br />
Infine ha menzionato la sua volontà di collaborare con la FAO a favore di iniziative globali e innovatrici,<br />
quali il Programma mondiale per un allevamento sostenibile, il Programma mondiale<br />
per sistemi alimentari sostenibili nel quadro del programma decennale concernente le modalità<br />
di consumo e di produzione sostenibili (10YFP) nonché l'Alleanza globale per un'agricoltura<br />
intelligente per il clima.<br />
La Conferenza ha altresì affrontato importanti temi per il futuro della FAO quali:<br />
• il Piano a medio termine 2014-2017 (PM 14-17) e il Programma di lavoro e preventivo<br />
2016-2017 (PLP 16-17), per i quali è stata sottolineata l'importanza delle attività relative<br />
alla resistenza agli antibiotici. Pur approvando l'attuazione del PMT 14-17 e del PLP 16-17,<br />
la Svizzera ha chiesto una migliore ripartizione geografica nell'impegno del personale in<br />
merito alla parità uomo-donna.<br />
• la nomina alla carica di Direttore generale di José Graziano da Silva (Brasile) per il periodo<br />
compreso tra il 1° agosto 2015 e il 31 giugno 2019 e<br />
• la nomina del nuovo Presidente indipendente del Consiglio Wilfred Joseph Ngirwa (Tanzania).<br />
Dibattito di alto livello "Food Security and Climate Change: Shaping<br />
Innovation for Agriculture’s Future", 25 giugno 2015, Expo 2015, Milano<br />
Organizzato in collaborazione con la FAO nel quadro della Giornata internazionale sulla sicurezza<br />
alimentare in occasione dell'Expo Milano 2015, il dibattito è stato aperto dal Consigliere<br />
federale Schneider-Ammann e ha visto la partecipazione di Michael Mack (Syngenta), Hans<br />
Herren (Biovision), Dyborne Chybonga (Associazione nazionale delle piccole aziende agricole<br />
del Malawi), Anne Powell (Centre for Agriculture and Biosciences International - CABI) e Ren<br />
Wang (FAO).<br />
310<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 5 / 42<br />
INTERNAZIONALE > DIMENSIONE COMMERCIALE<br />
Davanti a una platea di circa 100 persone, i partecipanti hanno posto l'accento sulla maggiore<br />
sfida, ovvero i cambiamenti climatici, in vista di raggiungere la sicurezza alimentare per tutti<br />
e si sono confrontati sulle migliori soluzioni applicabili sul campo. In particolare hanno sottolineato<br />
l'importanza di rendere il sistema alimentare globale più resiliente e sostenibile per<br />
far fronte a maggiore stress. L'innovazione, definita come l'applicazione di migliori soluzioni<br />
capaci di rispondere a bisogni esistenti o nuovi, svolge un ruolo chiave per affrontare queste<br />
sfide. I partecipanti hanno inoltre ribadito che l'innovazione necessaria nell'agricoltura non<br />
deve riguardare unicamente gli aspetti tecnici e scientifici ma deve anche essere:<br />
• imprenditoriale: sviluppo della produzione e del consumo locali, agricoltura urbana, nuovi<br />
circuiti della catena alimentare;<br />
• sociale: sviluppo di sistemi di protezione sociale per combattere la povertà rurale e favorire<br />
l'investimento degli agricoltori nel proprio settore;<br />
• organizzativa: sviluppo del quadro istituzionale ed esplorazione di nuove possibilità di collaborazione<br />
tra gli attori della filiera alimentare (approccio e partenariato multipartitici).<br />
Inoltre i partecipanti hanno indicato la necessità di combinare differenti approcci che a prima<br />
vista potrebbero sembrare contraddittori e di uscire dagli schemi di pensiero prestabiliti. Infine,<br />
per essere davvero efficiente, l'innovazione deve giungere sul campo ed essere ampiamente<br />
diffusa.<br />
Michaël Würzner, UFAG, Settore Agricoltura sostenibile internazionale, michael.wuerzner@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
311
Il mio Rapporto agricolo 6 / 42<br />
INTERNAZIONALE > DIMENSIONE COMMERCIALE<br />
OCSE<br />
Il presente articolo fornisce una breve panoramica sulle attività dell'UFAG nei gruppi di lavoro<br />
rilevanti per l'agricoltura dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).<br />
Conferenza dei ministri 2016<br />
Perché una Conferenza dei ministri dell'OCSE?<br />
Dal 7 all'8 aprile 2016 oltre 400 partecipanti provenienti da 48 Paesi (di cui 35 ministri o viceministri)<br />
si sono incontrati a Parigi per la Conferenza dei ministri dell 'OCSE. Le discussioni si<br />
sono svolte all’insegna del motto «Politiche migliori per un sistema alimentare globale resiliente,<br />
sostenibile e produttivo».<br />
Gli obiettivi della conferenza del 2016 erano lo scambio di informazioni e la discussione sui<br />
sistemi agroalimentari globali sostenibili di domani nonché sulle politiche innovative e lungimiranti<br />
necessarie e attuabili a tal fine. La base per tali discussioni sono stati gli sviluppi e le<br />
sfide dei diversi sistemi agroalimentari.<br />
Da un lato si è fatto riferimento agli accordi siglati recentemente e ai negoziati nel quadro<br />
dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile (SDG incl.), della Conferenza sul clima dell'ONU<br />
del 2015 (COP21) e della Conferenza dei ministri di Nairobi. Dall'altro sono stati menzionati<br />
la sicurezza alimentare per una popolazione mondiale in crescita, la rarefazione e la fragilità<br />
delle risorse, la protezione del clima, lo sviluppo economico e la resilienza del primario. La<br />
discussione è ruotata attorno al principio secondo cui l'agricoltura va considerata come parte<br />
della soluzione. L'ultima Conferenza dei ministri si è svolta nel 2010.<br />
Ruolo della Svizzera<br />
Le discussioni in occasione della Conferenza dei ministri si sono svolte secondo un nuovo formato,<br />
nessuna lettura di discorsi preparati a tavolino, bensì dibattiti nell'ambito dei seguenti<br />
due blocchi tematici:<br />
1) blocco tematico 1: un nuovo paradigma politico per l'agricoltura e l'alimentazione<br />
2) blocco tematico 2: da obiettivi comuni a misure concrete.<br />
Entrambi i blocchi tematici sono stati discussi in cinque workshop paralleli. Tale procedura ha<br />
consentito a tutti i partecipanti di contribuire alla discussione in modo positivo. La Svizzera<br />
ha diretto egregiamente uno di questi workshop e ha presentato in seduta plenaria tre assi di<br />
possibili cambiamenti politici.<br />
A Parigi la Svizzera si è anche impegnata affinché l’OCSE assuma un ruolo attivo, nel quadro<br />
delle sue competenze, al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). Ha fatto<br />
appello, in particolare, a una riduzione della domanda di risorse attraverso la diminuzione degli<br />
sprechi e delle perdite alimentari (food waste). L’obiettivo è ridurre la dipendenza dalle risorse<br />
non rinnovabili e ottimizzare il potenziale naturale di produzione optando per una produzione<br />
adatta alle condizioni locali e che faccia un uso efficiente delle risorse. Vanno, inoltre, preservate<br />
la qualità e la quantità di terreni utilizzabili a scopo agricolo.<br />
A margine della Conferenza dei ministri, la Svizzera ha colto l'occasione per tenere incontri<br />
bilaterali.<br />
312<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 7 / 42<br />
INTERNAZIONALE > DIMENSIONE COMMERCIALE<br />
Conclusione e ripercussioni della Conferenza dei ministri<br />
Dalle discussioni è emerso un largo consenso sulle sfide elencate nonché sul fatto che<br />
l'agricoltura deve continuare a focalizzare l'attenzione sulla produzione di derrate alimentari<br />
ma ridurre l'impronta ecologica. Occorre pertanto adeguare le condizioni quadro. Inoltre, tutti<br />
erano d'accordo sul fatto che solo sistemi alimentari sostenibili possono essere efficaci a lungo<br />
termine. Ciò vuol dire che occorre considerare i tre livelli della sostenibilità (sociale, ecologica<br />
ed economica).<br />
Per quanto riguarda le riforme politiche necessarie si continua ad attribuire grande importanza<br />
agli indirizzi precedenti: maggiore considerazione degli aspetti sociali nonché della politica<br />
ambientale e climatica, riforme di mercato e del commercio, integrazione di piccoli contadini<br />
e zone rurali. Inoltre i ministri si sono accordati sulle seguenti nuove priorità e idee politiche:<br />
• coerenza delle politiche e misure nazionali, ovvero considerazione globale dei sistemi agroalimentari;<br />
• misure politiche trasparenti, mirate, adeguate, flessibili, consistenti ed equilibrate considerati<br />
gli esigui fondi pubblici;<br />
• promozione della solidità economica (resilienza) delle aziende agricole, affinché possano<br />
affrontare meglio eventi sempre più frequenti e imprevedibili (fenomeni atmosferici, epizoozie<br />
e oscillazioni dei prezzi di mercato);<br />
• necessità di emanare norme supplementari per nuove tecnologie (in particolare nel settore<br />
dello scambio di dati o banche dati).<br />
I ministri hanno confermato l'importante ruolo dell'OCSE per analisi fondate, coerenti e basate<br />
sui fatti in materia di riforme di politica agricola nonché per il potenziamento della collaborazione<br />
internazionale. Hanno incaricato l'OCSE di continuare a potenziare tale ruolo alla luce<br />
della necessità di riforme individuata.<br />
Al termine della Conferenza dei ministri i partecipanti hanno approvato la dichiarazione<br />
«Better Policies to Achieve a Productive, Sustainable and Resilient Global Food System». Questa<br />
dichiarazione costituisce il quadro dei futuri programmi biennali di lavoro e di preventivo del<br />
Comitato agricolo dell'OCSE.<br />
a) Pagina Internet Conferenza dei ministri<br />
b) Video dell'OCSE «The Future of Agriculture»<br />
c) Dichiarazione finale e riassunto del Co-Presidente<br />
d) Informazioni di base<br />
e) Rapporti, grafici interattivi e ulteriori informazioni dell'OCSE<br />
Catene del valore responsabili nell'agricoltura<br />
Alla luce di una popolazione in crescita con reddito in aumento e penuria di risorse naturali,<br />
il settore agroalimentare mondiale necessita di ulteriori investimenti. Il livello dei prezzi relativamente<br />
elevato attuale e atteso a medio termine rende il settore interessante anche per<br />
investitori non agricoli (fondi, enti previdenziali, ecc.). A seconda di dove si trovano gli investitori<br />
lungo la catena del valore, sono confrontati con diversi rischi.<br />
L'obiettivo di questo progetto comune dell'OCSE e della FAO è offrire agli investitori una guida<br />
per un'amministrazione responsabile attraverso norme concordate a livello internazionale.<br />
Essa si rivolge alle aziende attive lungo la catena del valore internazionale per i prodotti agricoli.<br />
La guida mira a sostenere le aziende nella percezione dei loro meccanismi di diligenza<br />
nonché nella valutazione di effetti negativi correlati alle loro attività.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
313
Il mio Rapporto agricolo 8 / 42<br />
INTERNAZIONALE > DIMENSIONE COMMERCIALE<br />
Analogamente alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, contiene raccomandazioni<br />
per una politica aziendale che considera gli standard internazionali rilevanti per<br />
una catena del valore agricola responsabile, come ad esempio i Principi per l'Investimento Responsabile<br />
(CSA-RAI). Inoltre comprende un piano per lo sviluppo di un processo basato sul<br />
rischio per la valutazione dei meccanismi di diligenza, in relazione ai maggiori rischi e per il<br />
coinvolgimento della popolazione indigena.<br />
Sulla base di un vasto catalogo di temi viene descritto lo spirito imprenditoriale responsabile<br />
(Corporate Social Responsibility). La guida OCSE-FAO si applica ovunque le multinazionali esercitano<br />
la loro attività commerciale. È un importante strumento per la creazione di uno sviluppo<br />
sostenibile.<br />
A marzo 2016 è stato pubblicato l 'OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply<br />
Chains. L'UFAG ha partecipato attivamente al gruppo consultivo per questo progetto.<br />
OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains – Leitfaden, Broschüre, Tools<br />
und Lessons Learnt<br />
Quale ruolo svolgono le condizioni quadro politiche nella promozione<br />
di un'agricoltura produttiva, innovativa e sostenibile?<br />
L'evoluzione del settore agroalimentare non dipende soltanto dalle misure di politica agricola,<br />
ma anche da una serie di altre politiche settoriali. Importanti fattori per una crescita sostenibile<br />
della produttività nell'agricoltura sono le innovazioni, il cambiamento strutturale nonché<br />
l'accesso alle risorse naturali. Per l'analisi sistematica di diversi (forvianti) incentivi politici<br />
l’OCSE ha sviluppato un quadro concettuale. Sulla base di una serie di indicatori e quesiti<br />
possono essere individuati (forvianti) incentivi desiderati e indesiderati nelle varie politiche<br />
settoriali e valutate le loro ripercussioni sui fattori della crescita sostenibile nell'agricoltura.<br />
Nel quadro di studi in corso, al momento questo quadro concettuale è utilizzato per gli USA e<br />
la Turchia. Gli studi di casi su Canada, Australia, Paesi Bassi e Brasile hanno potuto già essere<br />
conclusi e pubblicati.<br />
Studio sulla Svizzera<br />
Su mandato dell'UFAG, Christian Flury, Theresa Tribaldos (entrambi Flury&Giuliani GmbH, Zurigo)<br />
e Michael Weber (webermanagement, Wilen (SZ)) hanno trasposto tale quadro concettuale,<br />
modificato, alla Svizzera. Si sono occupati dell’influsso che hanno le condizioni quadro<br />
politiche sulla produttività e la sostenibilità della filiera alimentare e dell'agricoltura svizzere.<br />
Gli autori hanno definito dieci tesi e le hanno discusse nel quadro di un workshop con un gruppo<br />
di esperti della filiera agroalimentare. Le tesi si riferiscono alle strutture e al cambiamento<br />
strutturale, alle condizioni di produzione naturali, all'immagine dell'agricoltura predominante<br />
tra la popolazione, alle regolamentazioni amministrative nonché allo spirito imprenditoriale.<br />
Secondo lo studio, effettuato sotto forma di prospetto, i settori della politica agricola rilevanti<br />
dal profilo delle strutture (p.es. aiuti nella fase iniziale attraverso miglioramenti strutturali,<br />
promozione degli investimenti) nonché il sostegno del reddito mediante pagamenti diretti<br />
hanno un grande effetto leva. Hanno un effetto leva medio i provvedimenti nell’ambito dei<br />
miglioramenti strutturali in senso stretto, le condizioni quadro in materia di politica territoriale,<br />
la formazione, la consulenza e la ricerca applicata nonché le regolamentazioni amministrative.<br />
Uno scarso effetto leva potrebbe derivare delle condizioni quadro economiche nonché<br />
dalle misure politiche volte a garantire la stabilità politica ed economica.<br />
314<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 9 / 42<br />
INTERNAZIONALE > DIMENSIONE COMMERCIALE<br />
Lo studio è stato concluso a luglio e fornisce spunti di riflessione sull'influenza delle condizioni<br />
quadro politiche e sulle loro ripercussioni sull'ulteriore sviluppo dell'agricoltura e della filiera<br />
alimentare svizzere.<br />
a) Quadro concettuale<br />
b) Studi di casi:Canada, Australia, Olanda & Brasile<br />
c) Studio Svizzera<br />
Monitoraggio e valutazione della politica agricola - 2016<br />
Ogni anno l'OCSE pubblica il suo rapporto «Agricultural Policy Monitoring and Evaluation» nel<br />
quale sono valutate le politiche agricole di 50 Paesi membri dell'OCSE e non. I Paesi analizzati<br />
perseguono per la maggior parte obiettivi simili, ad esempio:<br />
• consentire un accesso affidabile a derrate alimentari sicure, sane e nutrienti;<br />
• mettere i produttori nella posizione di migliorare il loro standard di vita attraverso la loro<br />
attività commerciale in un sistema commerciale globale, aperto e trasparente;<br />
• contribuire alla garanzia di buone condizioni di vita per tutta la la popolazione rurale, in<br />
particolare mediante l'approntamento di una serie di servizi ecosistemici;<br />
• migliorare la resistenza delle economie domestiche agricole nei confronti dei rischi.<br />
Tuttavia i Paesi danno importanza diversa a questi obiettivi e perseguono varie soluzioni, il che<br />
si riflette in politiche differenti.<br />
Insieme, i Paesi analizzati nel periodo 2013-2015 hanno sostenuto i produttori agricoli con<br />
in media 469 miliardi di euro l'anno e hanno impiegato altri 69 miliardi di euro per servizi di<br />
carattere generale a sostegno del settore (p.es. ricerca, consulenza, infrastrutture). Negli ultimi<br />
30 anni in media il livello delle misure di sostegno nei Paesi OCSE è diminuito di circa il 50<br />
per cento e oggi si attesta al 17 per cento delle entrate lorde dell'agricoltura. Contemporaneamente<br />
il livello medio di sostegno nelle economie emergenti è salito da un livello molto basso<br />
o addirittura negativo quasi al livello medio dei Paesi dell'OCSE. Secondo il rapporto, Islanda,<br />
Giappone, Corea, Norvegia e Svizzera accordano il più elevato livello di sostegno.<br />
Nel rapporto l'OCSE è giunto alla conclusione che in molti Paesi è necessario reimpostare<br />
l'attuale politica agroalimentare. Raccomanda (anche in riferimento alla dichiarazione della<br />
Conferenza dei ministri di quest'anno) quanto segue.<br />
• Gli ambiti tematici della politica agricola dovrebbero concentrarsi sulle nuove opportunità<br />
e sfide, ovvero potenziare la crescita della produzione, l'impiego sostenibile delle risorse<br />
naturali e la resistenza delle economie domestiche agricole. Sono necessari in particolare<br />
investimenti sul piano umano (formazione, competenze e, in alcuni casi, servizi sanitari),<br />
nelle infrastrutture strategiche fisiche e nei sistemi d'innovazione agricola che reagiscono<br />
alle esigenze dei produttori e dei consumatori.<br />
• I Paesi dovrebbero chiarire e migliorare le loro misure politiche nel settore della gestione<br />
del rischio. Le linee di confine tra i normali rischi commerciali (rischi che possono essere<br />
gestiti con strumenti che tengono conto del mercato) e rischi derivanti da catastrofi naturali<br />
devono essere trasparenti e definite sul piano operativo.<br />
• Il sostegno dei prezzi di mercato dovrebbe essere progressivamente eliminato. Non è mirato<br />
e non raggiunge il gruppo target concepito; comporta notevoli costi per l'industria<br />
alimentare e i consumatori, il che si ripercuote in modo particolarmente dannoso sui Paesi<br />
del gruppo di reddito più basso.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
315
Il mio Rapporto agricolo 10 / 42<br />
INTERNAZIONALE > DIMENSIONE COMMERCIALE<br />
Le raccomandazioni per la Svizzera si rifanno a quelle del 2015 pubblicate nell’OECD Review<br />
of Agricultural Policies: Switzerland:<br />
• migliore differenziazione tra le politiche concernenti il fallimento del mercato e il sostegno<br />
del reddito;<br />
• pagamenti diretti più mirati per rispondere alle esigenze della società;<br />
• ulteriore riduzione degli ostacoli commerciali;<br />
• riduzione del livello generale dei pagamenti diretti o destinazione di una parte di essi al<br />
trasferimento delle conoscenze per potenziare la produttività del settore.<br />
La struttura del rapporto di quest'anno è stata rivista. La versione cartacea comprende da<br />
ora, oltre al riassunto, anche una sintesi generale degli sviluppi in materia di politica agricola<br />
nonché uno spaccato del Paese («Country-Snapshots»). Il capitolo esaustivo sul Paese e<br />
l'allegato statistico sono disponibili solo in versione elettronica.<br />
a) Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2016 -Rapporto, Highlights und Empfehlungen<br />
& Länderkapitel Schweiz<br />
b) Ulteriori informazioni: Grafici interattivi e Banca dati PSE<br />
c)OECD Review of Agricultural Policies: Switzerland 2015<br />
OCSE-FAO#Agricultural Outlook 2016-2025<br />
Ogni anno OCSE e FAO pubblicano un rapporto congiunto, l’Outlook, che fornisce previsioni su<br />
10 anni per i principali mercati agricoli; quest'anno è giunto alla sua 21esima edizione (OECD-<br />
FAO Agricultural Outlook). Il rapporto riguarda il periodo 2016-2025. Oltre alle principali materie<br />
prime agricole (cereali, mais, semi oleosi, soia, zucchero, carne, latte), sono considerati<br />
anche pesce, cotone e biocarburanti.<br />
Secondo il rapporto, è finita l'era dei prezzi elevati per tutti i sottosettori considerati. Nel 2015<br />
il calo dei prezzi di cereali, prodotti carnei e ittici conferma tale realtà. I motivi principale del<br />
calo sono (a) una consistente crescita dell'offerta, (b) un rallentamento della domanda e (c)<br />
un ulteriore accumulo delle scorte esistenti.<br />
Secondo le attuali proiezioni, entro il 2025 si calcola una domanda in progressiva, lenta<br />
crescita. I motivi principali sono (i) una crescita demografica in calo a livello mondiale e (ii)<br />
una crescita del reddito più debole nei Paesi emergenti e in via di sviluppo correlata a una quota<br />
di reddito sempre più esigua da destinare agli alimenti di base. La domanda di prodotti carnei,<br />
ittici e latticini dovrebbe crescere in misura relativamente massiccia con ulteriori ripercussioni<br />
sulla domanda di cereali da foraggio. Per la domanda di materie prime agricole per biocarburanti<br />
invece si prevede una stagnazione a causa dei bassi prezzi dell'energia e le politiche conservative<br />
in materia in alcuni Paesi.<br />
Un crescente consumo nei Paesi in via di sviluppo, secondo le proiezioni, dovrebbe tradursi in<br />
un calo del numero delle persone sottonutrite, che passerebbe da 790 milioni a 650 milioni. La<br />
sottonutrizione nell'Africa sub-sahariana tuttavia resta elevata.<br />
Molti Paesi anche in futuro saranno confrontati con complesse situazioni di sottonutrizione,<br />
iperalimentazione e alimentazione carente. Secondo le proiezioni, il consumo di zucchero, olio<br />
e grassi nei Paesi sviluppati e in via di sviluppo aumenterà più rapidamente rispetto al consumo<br />
di alimenti di base e proteine, a causa del crescente consumo di prodotti lavorati.<br />
È nella natura delle cose che le proiezioni siano incerte. È il caso anche del rapporto annuale<br />
di OCSE e FAO. Le incertezze riguardano le affermazioni sull'evoluzione del prezzo del petrolio,<br />
sulle rese fisiche, sulla crescita economica, ma anche sugli sviluppi politici e sulle ripercussioni<br />
316<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 11 / 42<br />
INTERNAZIONALE > DIMENSIONE COMMERCIALE<br />
dei cambiamenti climatici. Il consorzio OCSE-FAO pertanto collabora con la Commissione UE a<br />
un'analisi stocastica per poter stimare meglio tale insicurezza nelle proiezioni.<br />
Ogni anno diversi media (Reuters, AFP, Financial Times, ecc.) danno ampio risalto ai risultati e<br />
alle considerazioni principali del rapporto Outlook.<br />
a) Rapporto, riassunto, banca dati, grafici interattivi, ecc.<br />
b) Rapporto (pdf)<br />
Altri studi pubblicati di recente<br />
1) Alternative Payment Approaches for Biodiversity Conservation in Agriculture<br />
2) Farm Management Practices to Foster Green Growth Inglese<br />
3) Mitigating Droughts and Floods in Agriculture - Policy Lessons and Approaches Inglese<br />
4) Drying Wells, Rising Stakes - Towards Sustainable Agricultural Groundwater Use Inglese<br />
5) Cost-Effectiveness of Greenhouse Gas Mitigation Measures for Agriculture - A Literature Review<br />
Inglese<br />
Michael Hartmann, UFAG, Settore Agricoltura sostenibile internazionale, michael.hartmann@blw.admin.ch,<br />
Jérôme Frei, UFAG, Settore Sistemi agroambientali ed elementi nutritivi<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
317
Il mio Rapporto agricolo 12 / 42<br />
INTERNAZIONALE > DIMENSIONE COMMERCIALE<br />
OMC<br />
Attuazione delle decisioni di Nairobi<br />
Nel dicembre 2015, a Nairobi, si è riunita per la decima volta la Conferenza dei ministri, il massimo<br />
organo decisionale dell'OMC. Al di là dell'approvazione dell'estensione dell'accordo multilaterale<br />
sulla liberalizzazione del commercio di prodotti della tecnologia dell’informazione,<br />
il Pacchetto di Nairobi riveste una particolare importanza soprattutto per il settore agricolo.<br />
I ministri si sono accordati su mandati negoziali per la costituzione statale di scorte volte a<br />
garantire la sicurezza alimentare da parte dei Paesi in via di sviluppo (SSM). Non per nulla il<br />
Direttore generale dell’OMC Roberto Azevêdo ha definito le decisioni di Nairobi come la maggiore<br />
conquista per l’agricoltura nella storia dell’organizzazione. Particolarmente rilevante per<br />
la Svizzera è stata la decisione di abolire in via definitiva tutte le sovvenzioni all’esportazione.<br />
Il nostro Paese versa contributi di questo genere per le materie prime latte e cereali nei prodotti<br />
agricoli trasformati nel quadro della cosiddetta legge sul cioccolato.<br />
Per smantellare queste sovvenzioni la decisione di Nairobi prevede, segnatamente per la Svizzera,<br />
un termine transitorio di cinque anni entro il quale i contributi all'esportazione dovranno<br />
essere completamente eliminati. L'abolizione dei sussidi alle esportazioni avverrà in un'unica<br />
tappa alla fine del periodo di transizione.<br />
Lavori nel regolare Comitato agricolo dell'OMC<br />
In seguito alla decima Conferenza dei ministri, il Committee on Agriculture dell'OMC si è occupato<br />
soprattutto dell'attuazione dei mandati conferiti a Nairobi. Nel primo semestre 2016 è<br />
stata data priorità soprattutto alle consultazioni all'interno dei diversi gruppi nazionali e con il<br />
Comitato della Presidenza. Poco prima della pausa estiva si è sviluppata una certa dinamica tra i<br />
membri in relazione al sostegno interno. Dopo l'abolizione delle sovvenzioni all'esportazione,<br />
il sostegno all'interno del Paese è tra le principali misure restanti con potenziale distorsivo del<br />
mercato. Un documento sottoscritto da vari Stati contenente quattro proposte concrete per il<br />
futuro dei sostegni all'interno del Paese ha posto le basi per l'ulteriore sviluppo delle discussioni<br />
a Ginevra.<br />
A ciò si contrappongono i negoziati nel settore della costituzione di scorte statali con<br />
l'obiettivo della sicurezza alimentare e dello Special Safeguard Mechanism (SSM). Il divario tra<br />
fautori e oppositori è profondo e i Paesi membri sono prevalentemente rimasti arroccati sulle<br />
loro posizioni. Anche se questo ha reso difficile il dibattito, ha regnato in generale il consenso<br />
sul fatto che la tematica fosse di notevole importanza e dovesse essere presentata una soluzione<br />
entro la prossima Conferenza dei ministri 2017.<br />
Un’ulteriore importante decisione della Conferenza dei ministri di Nairobi è stata l'ammissione<br />
della Liberia e dell'Afghanistan rispettivamente come 163° e 164° Paese membro. La Svizzera<br />
ha sostenuto l'ammissione di entrambi gli Stati.<br />
Futuro del ciclo di Doha<br />
Tra i Paesi membri regna un forte disaccordo sul futuro del ciclo di Doha, avviato nel 2001 e non<br />
ancora concluso. L'interrogativo principale è se vada portato avanti nonostante tutto oppure<br />
se non sia realistico e di conseguenza più opportuno dedicarsi a nuovi temi. Quest'ultima posizione<br />
viene sostenuta in particolare dagli Stati Uniti e dall'UE che già a Nairobi parlavano<br />
della «Morte del ciclo di Doha». Per quanto riguarda l'agricoltura va notato che il problema<br />
principale consiste nell'evoluzione delle circostanze. La situazione sui mercati internazionali<br />
non è più paragonabile a quella del 2001 quando il ciclo di Doha è stato avviato. Il mandato<br />
originario non è più adeguato alla situazione attuale. In particolare gli Stati emergenti, come<br />
India e Brasile che stanno consolidando la loro posizione nel commercio agricolo globale, si<br />
318<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 13 / 42<br />
INTERNAZIONALE > DIMENSIONE COMMERCIALE<br />
oppongono a una nuova valutazione della situazione. La Svizzera non detiene una posizione<br />
rigida e in linea di principio sarebbe disposta a portare a termine determinati temi anche al di<br />
fuori dei negoziati di Doha.<br />
Tematiche d'attualità nel contesto agricolo<br />
A cadenza regolare, in ogni Paese membro dell’OMC vengono svolte verifiche delle politiche<br />
commerciali (Trade Policy Review, TPR), durante le quali la Segreteria dell'OMC analizza<br />
l’evoluzione dei principi di politica commerciale in loco e in seguito pubblica un rapporto<br />
all'attenzione degli altri Stati membri. Questi hanno la possibilità di porre domande allo Stato<br />
oggetto dell'analisi in merito alla sua politica. L'intera procedura si conclude in occasione della<br />
Conferenza TPR a Ginevra dove tra i membri e lo Stato oggetto dell'analisi può avvenire uno<br />
scambio intenso. Tale meccanismo è molto utilizzato anche dalla Svizzera come è avvenuto ad<br />
esempio nell'anno della verifica della politica commerciale della Cina. Con 1800 domande rivolte<br />
alla Cina, è stato conseguito un nuovo record. Per la Svizzera sono stati particolarmente<br />
interessanti i chiarimenti della Cina in materia di contingenti doganali non riempiti (riso, frumento,<br />
mais).<br />
Alla fine dell'anno l'OMC ha sottoposto gli Stati Uniti a una TPR. Anche la Svizzera nel secondo<br />
semestre ha iniziato la preparazione per la TPR che dovrebbe essere conclusa probabilmente<br />
a maggio 2017.<br />
Tim Kränzlein, UFAG, Settore Politica commerciale internazionale, tim.kraenzlein@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
319
Il mio Rapporto agricolo 14 / 42<br />
INTERNAZIONALE > DIMENSIONE COMMERCIALE<br />
CIC/CAA<br />
Consiglio Internazionale dei Cereali<br />
L'attività principale del Consiglio Internazionale dei Cereali (International Grains Council, IGC)<br />
è fornire il resoconto della situazione dei mercati di cereali, mais, riso e semi oleosi a livello<br />
mondiale. Esso informa, in pubblicazioni quotidiane, settimanali e mensili, sull’evoluzione<br />
dei prezzi, sulle quantità prodotte e quelle smerciate e sulle attività principali dei Paesi<br />
d’esportazione e d’importazione (modifiche dei dazi all’importazione e all’esportazione,<br />
appalti, ecc.). Le informazioni che esso fornisce contribuiscono in maniera fondamentale a<br />
creare maggiore trasparenza sul mercato e a rafforzare la sicurezza alimentare a livello mondiale.<br />
Il CIC non interviene direttamente sull'andamento del mercato o nell'impostazione delle<br />
politiche cerealicole dei Paesi membri. Il CIC svolge i suoi compiti relativi alla trasparenza del<br />
mercato anche coadiuvando la Segreteria del Sistema di informazione sul mercato agricolo<br />
(AMIS). Le informazioni sul mercato del Consiglio Internazionale dei Cereali sono accessibili<br />
anche al pubblico e possono essere consultate al link<br />
http://www.igc.int/en/Default.aspx.<br />
Convenzione sull’assistenza alimentare<br />
Nella Convenzione sull’assistenza alimentare (Food Assistance Convention, FAC/CAA) le parti<br />
si impegnano a versare un importo prestabilito (commitment) a favore degli aiuti alimentari.<br />
La Svizzera si è impegnata a versare 34 milioni di franchi l'anno fino a nuovo avviso. Tale importo<br />
corrisponde al credito quadro di cui al Messaggio concernente la cooperazione internazionale<br />
2013-2016. Allo scadere di ogni anno, le parti devono fare rapporto sulle loro attività<br />
e dimostrare se e come hanno adempiuto i propri obblighi. Per l’adempimento degli obblighi,<br />
oltre alle forniture di derrate alimentari, possono essere considerate anche altre attività. Tra<br />
queste vi sono la fornitura di sostanze nutritive per l’integrazione di derrate alimentari, trasferimenti<br />
di denaro o i cosiddetti programmi voucher. Le parti riconoscono i principi fondamentali<br />
(Guiding principles) che devono essere rispettati nei programmi di assistenza alimentare.<br />
Al momento le Parti della Convenzione sono 13 Paesi e l'UE. Maggiori informazioni sulla Convenzione<br />
sull'assistenza alimentare al link: http://www.foodassistanceconvention.org<br />
Tim Kränzlein, UFAG, Settore Politica commerciale internazionale, tim.kraenzlein@blw.admin.ch<br />
320<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 15 / 42<br />
INTERNAZIONALE > DIMENSIONE COMMERCIALE<br />
UE<br />
Politica agricola comune dell'UE<br />
Novità 2016 della PAC<br />
Dopo un primo semestre contrassegnato da alcune difficoltà sui mercati agricoli, il 18 luglio<br />
2016 la Commissione europea ha presentato un nuovo piano di sostegno alla categoria di 500<br />
milioni di euro. Un importo di 150 milioni di euro, elemento centrale di questo piano è stato<br />
riservato agli incentivi per la riduzione volontaria della produzione di latte. Parallelamente,<br />
un fondo di 350 milioni di euro consentirà agli Stati membri di potenziare il loro dispositivo<br />
a favore delle aziende dedite alla produzione di latte o adottare misure per gli altri settori<br />
dell'allevamento.<br />
La semplificazione della PAC è rimasta un obiettivo principale dell'UE in materia di agricoltura.<br />
Ha rappresentato una delle priorità delle presidenze olandese (gennaio-giugno) e slovacca<br />
(luglio-dicembre) del Consiglio dell'UE. Tuttavia la Commissione ha apportato alcune modifiche<br />
alle norme di attuazione dei programmi di sviluppo rurale. Ha altresì presentato al Consiglio<br />
dei Ministri i risultati del suo riesame delle disposizioni relative al Greening della PAC al<br />
termine del primo anno di attuazione. Tali risultati devono servire come base per l'elaborazione<br />
di nuove misure che potrebbero entrare in vigore nel 2017.<br />
Nel settore dell'organizzazione comune del mercato, il sistema di regolazione dei quantitativi<br />
nel settore viticolo, che si basa sui diritti di impianto dei vigneti, è scaduto alla fine del<br />
2015. È stato sostituito da un sistema di autorizzazione d'impianto che limita all'1 per cento<br />
la crescita annuale della superficie viticola per Stato membro nel periodo 2016-2030. Il regime<br />
delle quote di zucchero, invece, terminerà il 30 settembre 2017.<br />
La Politica agricola comune dell'UE<br />
La Politica agricola comune dell'Unione europea (PAC) si fonda su due pilastri. Il primo, contenente<br />
la maggior parte dei fondi, comprende i pagamenti diretti e i provvedimenti rilevanti<br />
per il mercato, il secondo è destinato allo sviluppo rurale.<br />
Dall'attuazione della PAC 2014-2020 i pagamenti concessi nel quadro del primo pilastro sono<br />
quasi del tutto disaccoppiati. Tuttavia, gli Stati membri hanno tuttora la possibilità, su base<br />
volontaria, di vincolare fino al 13 per cento del bilancio degli aiuti diretti ai quantitativi prodotti<br />
o all'effettivo di bestiame.<br />
Per migliorare le prestazioni ambientali dell'agricoltura europea, gli Stati membri devono destinare<br />
il 30 per cento degli aiuti del primo pilastro a pagamenti ecologici. La Commissione<br />
ha fissato tre condizioni per il versamento di questi pagamenti Greening: la salvaguardia dei<br />
pascoli permanenti su scala regionale, la presenza di superfici d'interesse ecologico sul 5 per<br />
cento della superficie agricola (7 % dal 2018) e l’avvicendamento variato delle colture.<br />
La convergenza degli aiuti mira ad assicurare una ripartizione più equa dei pagamenti diretti. A<br />
partire dal 2019 nessuno Stato membro riceverà meno del 75 per cento della media europea e<br />
all’interno dei singoli Stati ogni contadino dovrà percepire, per ettaro, almeno il 60 per cento<br />
della media regionale o nazionale del rispettivo Stato. Gli Stati membri avranno la possibilità<br />
di adottare misure volte a limitare al 30 per cento le perdite dei singoli agricoltori.<br />
La PAC attuale fornisce un sostegno particolare ai giovani agricoltori (fino a 40 anni) i quali<br />
fruiscono di un incentivo speciale: nei primi cinque anni ricevono, oltre ai pagamenti diretti generali,<br />
un sostegno aggiuntivo obbligatorio del 25 per cento. Anche le regioni sfavorite, segna-<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
321
Il mio Rapporto agricolo 16 / 42<br />
INTERNAZIONALE > DIMENSIONE COMMERCIALE<br />
tamente quelle di montagna, beneficiano di un sostegno più consistente. Gli Stati membri<br />
hanno la facoltà di assegnare loro, nel quadro del preventivo nazionale, un importo massimo<br />
del 5 per cento.<br />
Soltanto gli agricoltori attivi possono beneficiare degli aiuti previsti. Le aziende che non esercitano<br />
l’agricoltura a titolo professionale saranno pertanto escluse dai pagamenti diretti. Tra<br />
queste vi sono, segnatamente, i terreni da golf, le ferrovie, gli aerodromi e i campi sportivi.<br />
I quattro regolamenti di base della PAC attuale sono stati varati il 16 dicembre 2013 dal Parlamento<br />
europeo e dal Consiglio dei Ministri dell'UE. Tali regolamenti coprono rispettivamente<br />
lo sviluppo rurale, i pagamenti diretti, le misure di mercato e le questioni orizzontali quali il<br />
finanziamento e il controllo. La Commissione ha in seguito emesso gli atti delegati ed esecutivi<br />
necessari e ogni Stato membro ha precisato le disposizioni applicate per l'attuazione a livello<br />
nazionale.<br />
Maggiori informazioni, in particolare sugli aiuti del secondo pilastro, sono disponibili al sito<br />
Internet della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione<br />
europea.<br />
Accordo agricolo Svizzera – UE<br />
L'accordo del 21 giugno 1999 tra Svizzera e UE sul commercio di prodotti agricoli (accordo<br />
agricolo) mira a migliorare l'accesso reciproco al mercato mediante l'abolizione di ostacoli<br />
tariffali (contingenti d'importazione e abolizione dei dazi doganali) e non tariffali (prescrizioni<br />
sui prodotti o disposizioni in materia di omologazione) in alcuni settori di produzione. Firmato<br />
nel quadro degli Accordi bilaterali I, l'accordo agricolo è entrato in vigore il 1 ° giugno 2002.<br />
I membri del Comitato misto incaricato della gestione dell'accordo agricolo tra la Svizzera e<br />
l'UE si sono riuniti il 19 novembre 2015 per la quindicesima volta, sotto la presidenza della<br />
Svizzera. Le parti presenti si sono dichiarate soddisfatte dell'applicazione dell'accordo e hanno<br />
deciso di proseguire lo sviluppo mirato dei diversi allegati.<br />
In occasione di questa riunione del Comitato, è stato possibile estendere il campo<br />
d'applicazione dell'allegato 9 (prodotti biologici), sospeso da tempo. L'equivalenza tra la<br />
legislazione dell'UE e quella della Svizzera nel settore del vino di produzione biologica è<br />
stata espressamente sancita nell'accordo. Nel corso degli ultimi anni, inoltre, è stato possibile<br />
proseguire l'armonizzazione delle disposizioni delle due parti contraenti nel settore<br />
della protezione dall'introduzione di organismi nocivi mediante vegetali. Il Comitato misto<br />
dell'agricoltura ha fissato il risultato di questi sforzi in una decisione che modifica l'allegato<br />
4 (protezione fitosanitaria). Entrata in vigore il 1° gennaio 2016, tale decisione ha in particolare<br />
sancito il principio del controllo al primo punto d'ingresso. Inoltre assicura una migliore<br />
protezione della produzione agricola e orticola.<br />
I prossimi aggiornamenti dell'accordo mirano, in particolare, ad estendere il campo<br />
d'applicazione dell'allegato 10 (frutta e verdura fresche) agli agrumi. Nel 2016 sono previsti<br />
sviluppi e aggiornamenti nei settori delle sementi e del reciproco riconoscimento delle denominazioni<br />
di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) per i prodotti<br />
agricoli e le derrate alimentari.<br />
Protocollo n. 2<br />
Il Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972 disciplina il traffico di prodotti agricoli<br />
trasformati tra la Svizzera e l'UE. Tale protocollo è stato rivisto nel quadro degli Accordi<br />
bilaterali II ed è entrato in vigore nel 2005. Con il 75 per cento delle importazioni e il 58 per<br />
322<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 17 / 42<br />
INTERNAZIONALE > DIMENSIONE COMMERCIALE<br />
cento delle esportazioni, nel 2015 l’UE si riconferma il principale partner commerciale della<br />
Svizzera anche per i prodotti agricoli trasformati.<br />
Il Protocollo n. 2 consente alla Svizzera di compensare gli svantaggi di prezzo delle materie<br />
prime agricole nel commercio di prodotti agricoli trasformati con l’UE per l’industria alimentare<br />
mediante la concessione di contributi d’esportazione per prodotti agricoli trasformati<br />
e la riscossione di dazi all’importazione su tali prodotti. Sulla base delle decisioni adottate<br />
nell’ambito della decima Conferenza dei ministri dell'OMC tenutasi a Nairobi in materia di contributi<br />
all'esportazione, i contributi all’esportazione saranno ancora accordati per un periodo<br />
transitorio fino al 2020 (cfr. anche testo «Sviluppi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale<br />
del commercio (OMC)»).<br />
Le misure di compensazione dei prezzi all’importazione e all’esportazione non devono superare<br />
le differenze di prezzo delle materie prime agricole esistenti tra Svizzera e UE. Il Protocollo<br />
n. 2 contempla i prezzi di riferimento e le differenze di prezzo determinanti per le misure di<br />
compensazione, esaminati una volta all'anno e, se necessario, adeguati d’intesa con l'UE. I<br />
prezzi di riferimento sono stati rivisti l’ultima volta il 1° aprile 2015. Nell'anno oggetto del<br />
rapporto non sono stati intrapresi adeguamenti.<br />
Pierre-François Righetti, UFAG, Settore Politica commerciale internazionale, pierre-francois.righetti@blw.admin.ch<br />
Tim Kränzlein, UFAG, Settore Politica commerciale internazionale<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
323
Il mio Rapporto agricolo 18 / 42<br />
INTERNAZIONALE > SOSTENIBILITA<br />
2030 Agenda per lo sviluppo sostenibile<br />
All'Assemblea generale dell'ONU è stato elaborato un nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo<br />
sostenibile per il periodo 2016-2030, adottato a settembre 2015, in sostituzione degli<br />
obiettivi di sviluppo del Millennio, scaduti a fine 2015. Contrariamente agli obiettivi di sviluppo<br />
del Millennio, la cosiddetta Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030) ha validità<br />
universale ed è, pertanto, significativa anche per lo sviluppo sul piano nazionale elvetico.<br />
Uno dei 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG)<br />
dell'Agenda 2030, il SDG 2, riguarda esplicitamente il settore agricoltura sostenibile, sicurezza<br />
alimentare e qualità delle derrate alimentari. È composto dai 5 obiettivi specifici seguenti.<br />
Obiettivo 2. Eliminare il problema della fame, garantire la sicurezza<br />
alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere l'agricoltura sostenibile<br />
2.1 Entro il 2030, eliminare il problema della fame e fare in modo che tutti, in particolare anche<br />
i poveri e le persone in situazioni vulnerabili, compresi i bambini, abbiano accesso durante<br />
tutto l'anno ad alimenti sicuri, nutrienti e sufficienti.<br />
2.2 Entro il 2030, porre fine a tutte le forme di malnutrizione, realizzando entro il 2025 gli obiettivi<br />
concordati a livello internazionale relativi ai ritardi nello sviluppo e ai problemi di crescita<br />
tra i bambini di età inferiore ai 5 anni, e rispondere ai bisogni nutritivi degli adolescenti, delle<br />
donne incinte o che allattano e degli anziani.<br />
2.3 Entro il 2030 raddoppiare la produttività agricola e i ricavi dei piccoli produttori alimentari,<br />
in particolare delle donne, delle popolazioni autoctone, delle aziende familiari, degli allevatori<br />
e dei pescatori, garantendo un accesso equo e sicuro alle terre, alle altre risorse e ai fattori di<br />
produzione, al sapere, ai servizi finanziari, ai mercati e alle opportunità di creare valore aggiunto<br />
e d’occupazione al di fuori dell'agricoltura.<br />
2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e attuare pratiche agricole<br />
resilienti che consentano di accrescere la produttività e la produzione, contribuendo alla<br />
preservazione degli ecosistemi, potenziando le capacità di adattamento ai cambiamenti climatici,<br />
ai fenomeni meteorologici estremi, alla siccità, alle inondazioni e ad altre catastrofi e<br />
migliorare progressivamente la qualità dei terreni e dei suoli.<br />
2.5 Entro il 2020, preservare la diversità genetica delle sementi, delle colture e degli animali da<br />
allevamento o da compagnia e delle specie selvatiche della stessa famiglia, mediante banche<br />
delle sementi e delle piante opportunamente gestite e diversificate a livello nazionale, regionale<br />
e internazionale, e favorendo l'accesso ai benefici correlati all’uso delle risorse genetiche<br />
e del sapere tradizionale associato e la condivisione equa e sostenibile di questi benefici, come<br />
convenuto a livello internazionale.<br />
Fonte: ONU<br />
Vi è, inoltre, una serie di altri obiettivi specifici in settori come consumo e produzione sostenibili,<br />
biodiversità, acqua, eccetera direttamente correlati alla filiera agroalimentare.<br />
La validità universale dell'Agenda 2030 significa che tutti gli Stati, oltre a impegnarsi sul piano<br />
internazionale, si adoperano attivamente a realizzarla su quello nazionale (p.es. mediante la<br />
collaborazione allo sviluppo). In Svizzera questi obiettivi vengono tenuti in considerazione<br />
nell’evoluzione della politica agricola.<br />
324<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 19 / 42<br />
INTERNAZIONALE > SOSTENIBILITA<br />
Nel dicembre 2015, il Consiglio federale ha decisodi appurare, nel quadro di una fase transitoria<br />
nel periodo 2016-2017, gli strumenti e gli organi fondamentali per la Svizzera in vista<br />
dell'attuazione dell'Agenda 2030 e di sviluppare un apposito sistema nazionale di monitoraggio<br />
e reporting. A questo scopo è stato istituito il «Gruppo di lavoro Agenda 2030 nazionale»<br />
(AA2030) che lavora sotto la codirezione di DSC e ARE. In esso è rappresentato anche<br />
l’UFAG, assieme ad altri Uffici federali centrali quali UST, UFAM e UFSP nonché alla Direzione<br />
politica del DFAE.<br />
Concretamente l’AA2030 traspone i SDG nel contesto elvetico per poi procedere, sulla scorta<br />
di un baseline report e di una gap analysis, alla rilevazione dello stato di realizzazione attuale<br />
(baseline) e delle eventuali lacune nel raggiungimento degli obiettivi nazionali. Su questa base<br />
viene redatto un rapporto sulla necessità di intervento prioritario per il raggiungimento dei<br />
SDG. Successivamente l’AA2030 presenta al Consiglio federale un documento di discussione in<br />
cui sono illustrati i processi e le strutture interne all’Amministrazione che in futuro saranno necessari<br />
per attuare l’Agenda 2030 e la necessità di intervento prioritario per il raggiungimento<br />
dei SDG. L’AA2030 è responsabile anche della redazione di un rapporto nazionale sullo stato<br />
di attuazione dei SDG in Svizzera all’attenzione dell’ONU, per l’High Level Political Forum on<br />
Sustainable Development (HLPF) 2018.<br />
In vista dell’attuazione dei SDG a livello nazionale, è necessario che durante la fase transitoria<br />
essi siano trasferiti sotto la responsabilità degli Uffici federali competenti per gli ambiti politici<br />
settoriali. Nel caso degli obiettivi specifici nel settore agricoltura sostenibile, sicurezza<br />
alimentare e qualità delle derrate alimentari ciò significa integrarli nella Politica agricola 22+.<br />
Patrick Mink, UFAG, Settore Agricoltura sostenibile internazionale, patrick.mink@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
325
Il mio Rapporto agricolo 20 / 42<br />
INTERNAZIONALE > SOSTENIBILITA<br />
10YFP Programma per sistemi alimentari sostenibili<br />
Nel 2012 in seno all’ONU è stato varato un quadro decennale globale per programmi di promozione<br />
di modelli di produzione e di consumo sostenibili (ingl. 10-Year Framework of Programmes<br />
on Sustainable Consumption and Production, 10YFP), con la convinzione che la<br />
produzione e il consumo non sostenibili siano la causa principale del costante peggioramento<br />
delle condizioni in cui versa l’ambiente a livello mondiale.<br />
Il Programma per sistemi alimentari sostenibili è stato sviluppato a partire dal 2011 in un processo<br />
comune di FAO e UNEP che la Svizzera ha seguito e sostenuto attivamente fin dall’inizio.<br />
Sulla base di questi lavori preliminari, nell’ottobre 2015 è finalmente avvenuto il lancio di un<br />
programma multi-stakeholder globale per sistemi alimentari sostenibili nel quadro del 10YFP<br />
(ingl. 10YFP Sustainable Food Sytsems Programme).<br />
Cos’è un sistema alimentare sostenibile?<br />
Il Programma per sistemi alimentari sostenibili si basa dalle seguenti definizioni dell’High Level<br />
Panel of Experts on Food Security and Nutrition (HLPE) del Comitato della sicurezza alimentare<br />
mondiale (CSA).<br />
«A food system gathers all the elements (environment, people, inputs, processes, infrastructures,<br />
institutions, etc.) and activities that relate to the production, processing, distribution,<br />
preparation and consumption of food and the outputs of these activities, including socio-economic<br />
and environmental outcomes».<br />
«A sustainable food system (SFS) is a food system that delivers food security and nutrition for<br />
all in such a way that the economic, social and environmental bases to generate food security<br />
and nutrition for future generations are not compromised».<br />
Il programma è inteso a sostenere il passaggio a modelli di consumo e di produzione sostenibili<br />
lungo l’intera catena di valore. Segue un approccio sistemico che mira a coinvolgere gli attori<br />
lungo l’intera filiera alimentare. È esplicitamente orientato verso i Paesi industrializzati e quelli<br />
in via di sviluppo tenendo conto, in fase di realizzazione, delle esigenze specifiche sul piano<br />
nazionale e regionale.<br />
Il Programma per sistemi alimentari sostenibili punta su attività nei settori sensibilizzazione<br />
dell’opinione pubblica, sviluppo delle competenze (capacity building), divulgazione del sapere<br />
e delle informazioni, rafforzamento dei partenariati. I principali temi del programma riguardano<br />
la promozione di un’alimentazione sostenibile e rispettosa delle risorse, la riduzione dello<br />
spreco alimentare (food waste) e il potenziamento della resilienza in agricoltura.<br />
In occasione del lancio ufficiale del programma 10YFP Sustainable Food Systems Programme, a<br />
ottobre 2015, la Svizzera è stata scelta per codirigere il programma assieme a Sudafrica, Hivos<br />
e WWF International («Multi-stakeholder Advisory Committee», MAC). Il MAC è composto da<br />
23 Paesi e istituzioni di diversi gruppi di stakeholder, come Brasile, Francia, USA, FAO, UNEP,<br />
Nestlé e Biovision. È stato inoltre già possibile ottenere l’appoggio di oltre 70 organizzazioni<br />
a livello mondiale quali partner nell’attuazione, di cui alcune dalla Svizzera (Agroscope, ETH<br />
World Food System Center, FiBL, foodwaste.ch, Foodways Consulting, SSAFA, Helvetas Intercooperation,<br />
Origin for Sustainability, Schweizerische Gesellschaft für Ernährung, Università<br />
di Berna – Centre for Development and Environment, ZHAW).<br />
326<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 21 / 42<br />
INTERNAZIONALE > SOSTENIBILITA<br />
Lancio ufficiale di 10YFP Sustainable Food Systems Programme<br />
Il lancio ufficiale del programma 10YFP Sustainable Food Systems Programme è avvenuto a<br />
ottobre 2015 nel padiglione svizzero dell’Expo di Milano. In concomitanza di quest’evento il<br />
comitato direttivo si è riunito per la prima volta allo scopo di fissare le priorità in termini di<br />
contenuti che il programma dovrà seguire nei prossimi anni.<br />
In quell’occasione, però, la codirezione del programma SFS e i membri del comitato direttivo<br />
non si sono occupati soltanto dei temi essenziali del programma. Nei vari padiglioni espositivi<br />
hanno potuto interrogarsi in un contesto più ampio su come garantire a tutti un’alimentazione<br />
sicura, sana e al contempo rispettosa delle risorse, un aspetto che resterà fondamentale anche<br />
nella realizzazione del programma per sistemi alimentari sostenibili.<br />
Il programma conta sulla collaborazione degli attori lungo l'intera catena di valore del settore<br />
privato, della ricerca, delle organizzazioni internazionali, delle ONG e delle organizzazioni governative.<br />
La collaborazione mirata consente di sfruttare le sinergie e di impiegare le risorse<br />
in maniera puntuale per accelerare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili. I partner<br />
di progetto possono presentare i loro progetti già esistenti e svilupparne e realizzarne altri in<br />
maniera congiunta.<br />
Il programma SFS contribuisce direttamente all’attuazione degli obiettivi dell’ONU per lo sviluppo<br />
sostenibile (SDG), tra cui spiccano in particolare il SDG 2 per lottare contro la fame e<br />
per promuovere l’agricoltura sostenibile e il SDG 12 per promuovere modelli di consumo e di<br />
produzione sostenibili, ma anche una serie di altri SDG correlati alla filiera agroalimentare.<br />
Patrick Mink, UFAG, Settore Agricoltura sostenibile internazionale, patrick.mink@blw.admin.ch<br />
Dominique Wolf, UFAG, Settore Agricoltura sostenibile internazionale<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
327
Il mio Rapporto agricolo 22 / 42<br />
INTERNAZIONALE > SOSTENIBILITA<br />
Agrobiodiversità / Risorse genetiche<br />
La varietà di flora e fauna consente all’uomo di avere un accesso ampio ai cicli delle sostanze<br />
nutritive della biosfera. L’addomesticamento e la selezione hanno fatto sì che, con il trascorrere<br />
del tempo, nascessero diverse varietà di piante coltivabili, razze animali e agrosistemi<br />
specializzati. Ciò ha favorito l’adeguamento alle differenti condizioni ambientali locali spesso<br />
difficili, garantendo l’alimentazione e la sopravvivenza dell’uomo.<br />
Anche in futuro l’agrobiodiversità conserverà una valenza fondamentale in un contesto agricolo<br />
in trasformazione, poiché la preservazione e la disponibilità di una grande varietà di esseri<br />
viventi utilizzabili offrono molteplici opzioni e garanzie. Attraverso la selezione, ad esempio,<br />
ci si può preparare meglio e con lungimiranza alle sfide poste dal cambiamento climatico, dalla<br />
rarefazione delle risorse e dall’evoluzione delle abitudini dell’uomo legate ai consumi.<br />
Se queste risorse genetiche vengono utilizzate di meno, si rischia di perderle per sempre. Per<br />
questo diversi programmi nazionali e internazionali si sono concentrati sul riconoscimento,<br />
sulla protezione, sulla conservazione e sulla promozione dell’utilizzo di un’ampia varietà genetica.<br />
Traguardi fondamentali segnati a questo riguardo sono la Convenzione sulla diversità biologica<br />
(Convention on Biological Diversity), il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche e il<br />
Piano d’azione globale per le risorse zoogenetiche.<br />
Biodiversità significa diversità degli organismi viventi e degli ecosistemi cui essi appartengono.<br />
La diversità si manifesta a vari livelli: all’interno di una specie (genetica ed epigenetica),<br />
tra specie (specie diverse) e all’interno e tra ecosistemi.<br />
Per agrobiodiversità s’intende la varietà e la diversità di fauna, flora e microrganismi che<br />
possono essere utilizzati direttamente o indirettamente dall’uomo per l’alimentazione e<br />
l’agricoltura. Contempla le piante coltivabili e silvestri, comprese le varietà spontanee, gli animali<br />
utili, gli animali selvatici utili, i pesci e gli altri organismi acquatici nonché i microrganismi<br />
utilizzabili per la tecnologia alimentare.<br />
Comprende anche la varietà di organismi viventi che sostengono la produzione quali microrganismi<br />
del suolo e organismi utili quali impollinatori, nonché la varietà degli agrosistemi nel<br />
loro complesso.<br />
Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione<br />
e l’agricoltura<br />
Il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (TI-<br />
RFGAA) è entrato in vigore il 29 giugno 2004. A oggi è stato firmato da 140 Stati. La Svizzera lo<br />
ha ratificato il 22 novembre 2004. Il trattato è in linea con la Convenzione sulla diversità biologica.<br />
I suoi obiettivi sono la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per<br />
l’alimentazione e l’agricoltura e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro<br />
utilizzazione. Costituisce uno strumento fondamentale per garantire la varietà delle risorse<br />
fitogenetiche necessaria agli agricoltori e ai selezionatori per far fronte alle sfide globali in<br />
materia di sicurezza alimentare e cambiamento climatico. Il trattato contempla un sistema multilaterale<br />
per facilitare l’accesso alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura<br />
(RFGAA) e ripartire i benefici derivanti dal loro impiego. Le transazioni tra fornitori e utilizzatori<br />
di risorse sono effettuate nel quadro dell’Accordo tipo di trasferimento di materiale (ATM).<br />
Ogni anno vengono conclusi migliaia di ATM, prevalentemente da parte di centri del gruppo<br />
328<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 23 / 42<br />
INTERNAZIONALE > SOSTENIBILITA<br />
consultivo per la ricerca agricola internazionale. In Svizzera, dal 2007 la banca genetica nazionale<br />
ha rilasciato 141 ATM riguardanti più di 1821 accessioni.<br />
La 6a sessione dell’Organo Direttivo si è svolta dal 5 al 9 ottobre 2015 presso la sede principale<br />
della FAO a Roma, Italia. I negoziati hanno riguardato in particolare il processo di riforma del<br />
Sistema multilaterale del Trattato. Le parti contraenti hanno preso atto dei risultati delle prime<br />
quattro riunioni del gruppo di lavoro che ha discusso di tale revisione. L’Organo Direttivo ha<br />
deciso di proseguire il processo. Ha incaricato il gruppo di lavoro di presentare una proposta<br />
concreta per un nuovo ATM entro la prossima sessione nell’autunno 2017.<br />
Sono stati necessari lunghi negoziati per definire le modalità del mandato assegnato al gruppo<br />
di lavoro. La Svizzera è riuscita a far sì che la revisione dell’ATM continuasse sulla base di una<br />
proposta avanzata da cerchie interessate elvetiche, relativa a un cosiddetto modello di sottoscrizione.<br />
È stata scelta anche nel gruppo delle cinque rappresentanti della regione europea<br />
che prenderanno parte al gruppo di lavoro. Nell’arco delle prossime due riunioni il gruppo di<br />
lavoro dovrà mettere a punto una proposta concreta per l’ATM entro maggio 2017.<br />
Tra gli altri successi dell'incontro si può annoverare il lancio di un programma specifico per<br />
l’elaborazione di una strategia di finanziamento per l’Accordo internazionale. L’obiettivo è<br />
esaminare lo scopo del fondo multilaterale per la ripartizione equa dei benefici monetari (il<br />
cosiddetto benefit sharing fund), affinché acquisisca una maggiore attrattiva per gli utilizzatori<br />
delle risorse genetiche. La Svizzera si è impegnata su questo fronte sin dalla 5a sessione<br />
dell’Organo Direttivo nel 2014.<br />
L’agricoltura nella Convenzione internazionale sulla diversità biologica<br />
La collaborazione tra gli attori internazionali nel settore biodiversità e agricoltura sembra consolidarsi.<br />
La 13a Conferenza degli Stati firmatari della Convenzione sulla diversità biologica<br />
(CBD), svoltasi a Cancun nel dicembre 2016, mira a promuovere l'integrazione sistematica nella<br />
CBD di agricoltura, turismo, itticoltura e silvicoltura.<br />
Il nesso scientifico è già ben delineato. Si tratta ora di procedere in maniera mirata<br />
all'attuazione. Questa integrazione ha una valenza globale ed è particolarmente importante<br />
per i Paesi emergenti e in via di sviluppo. I necessari sforzi di intensivazione in agricoltura per<br />
poter sfamare in futuro oltre 9 miliardi di persone devono essere fatti in maniera per quanto<br />
possibile sostenibile, in modo da ridurre al minimo anche gli effetti negativi sulla biodiversità.<br />
Si sono tenute già diverse conferenze preparatorie su questo cosiddetto «mainstreaming». Nel<br />
novembre 2015 l'UFAG è stato invitato a una conferenza internazionale a Città del Messico dove<br />
ha presentato le misure e le esperienze sul piano nazionale nel settore biodiversità e agricoltura.<br />
Dal 1993, ogni tre anni, il Governo norvegese organizza, inoltre, la «Trondheim Conference on<br />
Biodiversity», che ospita i focal points della CBD ed esperti dei settori affini. Quest'anno è stata<br />
la volta degli esperti del settore agricolo. Personalità di spicco forniscono input alle discussioni<br />
che vengono poi riassunte in un co-chairs text. La conferenza di quest’anno, cui è stato invitato<br />
l'UFAG, verteva sul tema «Food Systems for a Sustainable Future – Interlinkages between<br />
biodiversity and agriculture». La tematica riguardava anche la valenza della biodiversità e dei<br />
servizi ecosistemici per l'alimentazione e l'agricoltura, gli ambiti politici e le istituzioni per la<br />
promozione di metodi di produzione sostenibili e la pianificazione a fronte del cambiamento<br />
climatico. Sono stati discussi, inoltre, l'attuazione dei SDG dell'Agenda 2030 e i lavori della<br />
CBD. Il documento finale dei presidenti della Trondheim Conference servirà da spunto per il<br />
segmento ministeriale della XIII Conferenza degli Stati firmatari cui parteciperanno i ministri<br />
dell'agricoltura, della silvicoltura e del turismo.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
329
Il mio Rapporto agricolo 24 / 42<br />
INTERNAZIONALE > SOSTENIBILITA<br />
Alwin Kopse, UFAG, Settore Agricoltura sostenibile internazionale, alwin.kopse@blw.admin.ch<br />
Janice Johnson, UFAG, Settore Agricoltura sostenibile internazionale<br />
330<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 25 / 42<br />
INTERNAZIONALE > SOSTENIBILITA<br />
Sicurezza alimentare e resilienza<br />
La sfida che l'agricoltura dovrà cogliere nei prossimi anni consiste nel conservare la sicurezza<br />
alimentare. Secondo la definizione della FAO, la sicurezza alimentare esiste quando tutte le<br />
persone in ogni momento, hanno accesso fisico ed economico ad una quantità di cibo sufficiente,<br />
sicuro e nutriente per soddisfare le loro esigenze dietetiche e preferenze alimentari per<br />
una vita attiva e sana.<br />
La garanzia della sicurezza alimentare dipende in maniera determinante dalla struttura degli<br />
agrosistemi e dei sistemi agro-alimentari che sono soggetti a profonde trasformazioni come<br />
i cambiamenti climatici, la perdita di terreni fertili e di biodiversità. In questo contesto, una<br />
condizione essenziale per un'agricoltura sostenibile è la capacità degli agrosistemi di ritornare<br />
al loro stato iniziale, dopo essere stati sottoposti a una perturbazione che ha modificato quello<br />
stato. Questa capacità di far fronte a perturbazioni e a superarle conservando il proprio stato<br />
iniziale è detta resilienza.<br />
La Svizzera e la comunità internazionale lavorano a programmi e iniziative allo scopo di impostare<br />
il sistema agroalimentare a livello sia locale sia globale verso la sicurezza alimentare e<br />
di potenziarne la resilienza a fronte dei cambiamenti. L'obiettivo è garantire a lungo termine<br />
l'alimentazione umana in un contesto in evoluzione.<br />
Piano d’azione globale per la produzione animale sostenibile<br />
L'UFAG continua a lavorare con la FAO e altri partner al piano d'azione globale per la produzione<br />
animale sostenibile (Global Agenda for Sustainable Livestock, GASL). Affinché il settore<br />
dell’allevamento possa rispondere a una crescente domanda a livello mondiale di prodotti animali<br />
e affrontare i nuovi bisogni della popolazione, sono necessari investimenti e sforzi maggiori<br />
nella ricerca agricola, unitamente a una governance solida. Allo stesso tempo il settore<br />
deve contribuire alla lotta contro la povertà, al miglioramento della sicurezza alimentare e alla<br />
preservazione dell’ambiente e della salute umana.<br />
LA GASL mira alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile duraturo in questo settore, anche<br />
attraverso un utilizzo efficiente delle risorse naturali. L'iniziativa affronta i temi della sicurezza<br />
alimentare globale e della sanità pubblica, della crescita equa, delle risorse naturali e del cambiamento<br />
climatico.<br />
Nel 2015 la struttura della governance della GASL è stata modificata onde meglio rappresentare<br />
i differenti settori della società. Istituzioni pubbliche, economia privata, ricerca, ONG e<br />
finanziatori sono rappresentati in seno a sette gruppi d’interesse e anche nel comitato direttivo,<br />
riunitosi per la prima volta a settembre 2015 a Ginevra per elaborare il Piano d’azione<br />
2016-2018. Entrato in vigore all’inizio del 2016, il piano punta essenzialmente ad agevolare<br />
il dialogo, ad acquisire conoscenze scientifiche e a consolidare l’applicazione della migliore<br />
pratica nella produzione animale.<br />
Nel giugno 2016, a Panama si è tenuto il sesto incontro multi-stakeholder della GASL. I partecipanti<br />
hanno discusso della necessità di riconoscere in modo coerente il ruolo e il significato<br />
del settore della produzione animale nello sviluppo sostenibile. Al centro delle discussioni è<br />
stata l’Agenda 2030 delle Nazione Unite sullo sviluppo sostenibile con i suoi 17 obiettivi di<br />
sostenibilità (Sustainable Development Goals, SDG) che la GASL si impegna profondamente a<br />
sostenere (cfr. Panama Declaration). Nel quadro dell’incontro il comitato direttivo ha anche<br />
nominato uno Svizzero alla presidenza della GASL.<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
331
Il mio Rapporto agricolo 26 / 42<br />
INTERNAZIONALE > SOSTENIBILITA<br />
Promozione di uno sviluppo sostenibile delle regioni montane: Mountain<br />
Partnership<br />
La «Mountain Partnership» (MP) è un’alleanza volontaria di Stati, organizzazioni e ONG che<br />
si impegnano per la protezione sostenibile delle regioni montane e per il miglioramento delle<br />
condizioni di vita della popolazione di montagna. Attualmente conta 272 membri tra organizzazioni<br />
intergovernative, società civili, settore privato nonché 57 Governi. La segreteria della<br />
MP è stata fondata nel 2002 e avviata da Svizzera, Italia, FAO e UNEP.<br />
La segreteria sede presso la FAO di Roma e il suo compito principale è assistere i vari membri<br />
nell’attuare l’iniziativa collettiva e promuoverne la cooperazione.<br />
Nel 2015 l’UFAG si è sostituito alla DSC nel sostenere la segretera diventando il focal point per<br />
la Svizzera. L’UFAG le fornisce assistenza e dà modo all’organizzazione, impegnata da oltre un<br />
decennio nella promozione dello sviluppo sostenibile delle regioni montane, di presentare le<br />
proprie attività. Il suo ultimo studio sulla sicurezza alimentare delle popolazioni di montagna<br />
è stato presentato nella primavera 2016 al Museo Alpino di Berna. La segreteria ha potuto approfittare<br />
di numerosi eventi come utile piattaforma per pubblicizzare il proprio operato, ad<br />
esempio alla Conferenza sul clima a Parigi (COP21), a Bonn durante i successivi negoziati nel<br />
maggio 2016 e all’ONU a New York.<br />
Un’alleanza per un’agricoltura intelligente dal punto di vista del clima:<br />
Global Alliance for Climate Smart Agriculture<br />
La «Global Alliance for Climate Smart Agriculture» (GACSA) è stata lanciata ufficialmente dal<br />
segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon durante il vertice sul clima nel settembre<br />
2014. Il suo obiettivo è aumentare la produttività agricola e la capacità di far fronte al cambiamento<br />
climatico riducendo al contempo le emissioni di gas serra.<br />
La GACSA è una piattaforma che coordina le conoscenze e le esperienze dei partner e mette in<br />
contatto organizzazioni con l’obiettivo di promuovere gli scambi e la cooperazione tra di esse.<br />
Le attività dell’alleanza si concentrano su tre aspetti:<br />
i) promuovere sapere, ricerca e sviluppo per un’agricoltura intelligente dal punto di vista del<br />
clima,<br />
ii) aumentare l’efficienza degli investimenti privati e pubblici, e<br />
iii) creare condizioni quadro favorevoli integrando l’agricoltura intelligente dal punto di vista<br />
del clima nelle politiche, nelle strategie e nella pianificazione a livello locale, regionale e nazionale.<br />
L’UFAG ha sostenuto la GACSA nel suo primo anno d’attività perché si occupa di misure di mitigazione<br />
e adeguamento puntando a rafforzare la comunità internazionale delle conoscenze per<br />
agricoltura e cambiamento climatico. L’Alleanza attualmente conta 117 membri tra governi,<br />
settore privato, organizzazioni contadine, società civili, istituti di ricerca e organizzazioni intergovernative.<br />
La segreteria della GACSA ha sede presso la FAO di Roma.<br />
Jeanine Volken, UFAG, Settore Agricoltura sostenibile internazionale, jeanine.volken@blw.admin.ch<br />
332<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 27 / 42<br />
INTERNAZIONALE > SOSTENIBILITA<br />
Investimenti responsabili nell’agricoltura e nei sistemi alimentari<br />
Coorganizzato, il 28 aprile 2016, dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e<br />
l’Agricoltura (FAO), dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e dalla Direzione delle Istituzioni<br />
dell’agricoltura e delle foreste dello Stato di Friburgo (DIAF), questo congresso era finalizzato<br />
alla ricerca di soluzioni adeguate per agevolare l’attuazione dei Principi per l’investimento<br />
responsabile nell’agricoltura e nei sistemi alimentari (RAI).<br />
Presso l’Istituto agricolo di Grangeneuve (Friburgo) al congresso hanno preso parte circa 150<br />
partecipanti provenienti da diversi settori quali bancario, commercio di materie prime, agricoltura,<br />
società civile (ONG) e multinazionali, per trovare le soluzioni migliori per attuare a<br />
livello nazionale i principi su base volontaria RAI che hanno l’obiettivo di fornire agli attori<br />
le condizioni quadro necessarie per investire responsabilmente e di apportare benefici a tutti<br />
gli operatori della filiera agroalimentare. Per sfamare oltre 9 miliardi di persone entro il 2050,<br />
esercitando un impatto concreto sul terreno e generando benefici per tutti, occorre in effetti<br />
aumentare sia la quantità sia la qualità di questi investimenti o, in altre parole, tenere in considerazione<br />
gli aspetti socio-ambientali.<br />
La presenza a Grangeneuve di Paul Bulcke, CEO di Nestlé, è stata un segnale forte per dimostrare<br />
ai vari attori presenti l’importanza di investire responsabilmente nell’agricoltura e nei sistemi<br />
alimentari per accrescere le prospettive occupazionali nelle regioni rurali e rendere il settore<br />
attrattivo per i giovani. Nel suo intervento ha sottolineato in particolare l’importanza di uno<br />
sforzo coordinato e di una collaborazione stretta tra gli attori coinvolti, segnatamente attraverso<br />
partenariati. Ha inoltre ribadito l’importanza fondamentale di avere una visione a lungo<br />
termine se si vuole investire nel primario e nei sistemi alimentari.<br />
Cinque rappresentanti del mondo della finanza (Gaëlle Bonnieux, ResponsAbility), del primario<br />
(Fritz Glauser, World Farmers Organization), della società civile (Andreas Schriber, Biovision)<br />
e del commercio di materie prime (Ramon M. Esteve, ECOM Agroindustrial Corp Ltd.) nonché di<br />
organizzazioni internazionali (Amira Gornass, Presidente del Comitato della sicurezza alimentare<br />
mondiale) hanno preso parte a una tavola rotonda che ha permesso di identificare i principali<br />
benefici dell’applicazione dei principi RAI, ma anche le difficoltà e le sfide legate alla loro<br />
effettiva attuazione su larga scala.<br />
Nel pomeriggio si sono svolti dei workshop in cui i partecipanti hanno sviluppato i temi toccati<br />
in mattinata. In particolare, è stata messa in rilievo l’importanza della fiducia e della<br />
trasparenza lungo la catena di valore. È stata altresì sottolineata la necessità di sviluppare<br />
meccanismi di controllo e partenariati a lungo termine per sensibilizzare tutti gli attori<br />
sull’importanza di abbracciare i principi RAI. È stato ribadito il ruolo dei consumatori e quanto<br />
sia fondamentale sviluppare incentivi adeguati per investire e fare acquisti in maniera responsabile.<br />
L’attuazione dei principi RAI può rivelarsi delicata per via del gran numero di parti<br />
implicate e dell’assenza di meccanismi vincolanti. In tal ambito, sviluppando linee guida e strumenti<br />
di autocontrollo adeguati a ogni settore si potrebbe aumentare la loro comprensione<br />
e l’applicazione nei vari settori. Infine, i partecipanti hanno sottolineato quanto sia importante<br />
pubblicizzare e divulgare i principi RAI, segnatamente individuando gli attori chiave che<br />
possono fare da volano.<br />
Michaël Würzner, UFAG, Settore Agricoltura sostenibile internazionale, michael.wuerzner@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
333
Il mio Rapporto agricolo 28 / 42<br />
INTERNAZIONALE > ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO<br />
Accordo di libero scambio<br />
Considerato l'aumento, a livello mondiale, degli sforzi di liberalizzazione regionali, per la Svizzera<br />
è fondamentale concludere accordi di libero scambio al fine di evitare, quanto più possibile,<br />
una discriminazione delle aziende elvetiche sui mercati esteri.<br />
Per tale motivo, anche nel 2015 la Svizzera si è impegnata per ampliare la sua rete mondiale<br />
di accordi di libero scambio con Paesi terzi. Al momento, in via suppletiva alla Convenzione<br />
relativa all’Associazione europea di libero scambio (AELS) e all’accordo di libero scambio con<br />
l’UE il nostro Paese dispone di oltre 28 accordi di libero scambio siglati con 38 partner. Fatta<br />
eccezione per quelli con Cina, Giappone e Isole Färöer, tutti gli accordi di libero scambio sono<br />
stati conclusi nel quadro dell’AELS.<br />
Le disposizioni sul traffico delle merci contenute nell’accordo contemplano anche norme sui<br />
prodotti agricoli. A causa delle diverse politiche agricole e sensibilità dei singoli Stati AELS,<br />
gli accordi agricoli sono negoziati in maniera bilaterale. Tutte le concessioni doganali fatte<br />
dalla Svizzera a un partner di libero scambio sono conciliabili con la politica agricola elvetica.<br />
Nel caso dei prodotti agricoli di base si tratta per lo più di concessioni per prodotti non sensibili<br />
(p.es. frutta tropicale), riduzioni di dazio nel quadro degli esistenti contingenti doganali<br />
dell'OMC o concessioni al di fuori della stagione. Dal canto suo, durante i negoziati per simili<br />
accordi la Svizzera cerca di ottenere maggiori concessioni possibili per i prodotti agricoli di<br />
base ad elevato potenziale d'esportazione come formaggio e altri latticini, carne secca e vino<br />
nonché per prodotti agricoli trasformati come bevande, cioccolata, dolciumi e caffè.<br />
Sviluppi attuali degli accordi di libero scambio nel quadro dell’AELS<br />
Negoziati conclusi<br />
Il 1° gennaio 2015 è entrato in vigore l’accordo di libero scambio tra gli Stati AELS e la Bosnia ed<br />
Erzegovina grazie al quale la Svizzera riceve, oltre a un accesso al mercato esente da dazi per la<br />
maggior parte dei prodotti industriali, anche un accesso preferenziale in Bosnia ed Erzegovina<br />
per alcuni prodotti agricoli trasformati e non trasformati ai quali è interessata. Il nostro Paese,<br />
dal canto suo, accorda un accesso preferenziale per prodotti agricoli provenienti dalla Bosnia<br />
ed Erzegovina come peperoni, salsa ajvar, funghi, olive, pesche e pesche noci.<br />
In occasione della Conferenza ministeriale dell'AELS tenutasi a Schaan (Liechtenstein) il 22 giugno<br />
2015, è stato firmato il protocollo per estendere al Guatemala l'Accordo di libero scambio<br />
tra gli Stati AELS e gli Stati dell'America centrale. In tal modo, il Guatemala aderisce all'accordo<br />
di libero scambio tra gli Stati AELS e Costa Rica e Panama, entrato in vigore già il 29 agosto<br />
2014. Nel quadro di detto accordo la Svizzera riceve dal Guatemala accesso preferenziale per<br />
alcuni importanti prodotti agricoli di base (come un contingente esente da dazio per il formaggio<br />
e riduzioni dei dazi su succhi e carne secca). Per i prodotti agricoli trasformati la Svizzera<br />
riceve concessioni simili a quelle che il Guatemala accorda all'UE. Il protocollo di adesione deve<br />
ora essere ratificato da tutte le parti.<br />
Negoziati in corso<br />
Attualmente sono in corso negoziati tra gli Stati dell'AELS e il Vietnam e la Malesia. Nel 2015<br />
sono state avviate trattative anche con le Filippine e la Georgia. I negoziati con India, Indonesia,<br />
Thailandia, Algeria e Unione doganale Russia-Bielorussia-Kazakistan, invece, per diversi<br />
motivi sono sospesi fino a nuovo avviso.<br />
334<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 29 / 42<br />
INTERNAZIONALE > ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO<br />
Con alcuni partner sono in atto oppure in fase di preparazione o valutazione, negoziati suppletivi<br />
per sviluppare gli accordi. Tra questi vi sono Turchia, Israele, Cile, Canada e Messico.<br />
Colloqui esplorativi<br />
Gli Stati AELS vagliano la fattibilità di intavolare negoziati di libero scambio con gli Stati Mercosur<br />
(Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay). Inoltre, durante la loro Conferenza ministeriale<br />
di fine giugno 2015, hanno firmato una dichiarazione di cooperazione con l'Ecuador, allo<br />
scopo di avviare negoziati per un accordo di libero scambio nel corso del 2016.<br />
Contatti sono stati presi anche con Stati africani della regione subsahariana nonché con altri<br />
Stati asiatici.<br />
Sviluppi attuali degli accordi bilaterali di libero scambio<br />
Attualmente sono in vigore tre accordi bilaterali di libero scambio, segnatamente con Giappone,<br />
Isole Färöer e Cina, che contribuiscono ad ampliare la rete commerciale mondiale del<br />
nostro Paese e sostengono soprattutto i settori d'esportazione, mediante l’apertura dei rispettivi<br />
mercati. La pietra miliare della politica economica estera elvetica è l'Accordo globale tra<br />
Svizzera e Cina, vigente dal 1° luglio 2014, che a solo un anno dalla sua entrata in vigore ha<br />
comportato un notevole aumento delle importazioni ed esportazioni da e verso la Cina.<br />
Anche l’accordo bilaterale tra Svizzera e Giappone, in vigore dal 2009, ha determinato un incremento<br />
delle esportazioni di prodotti agricoli elvetici verso il Paese asiatico: nel 2014 esse<br />
hanno raggiunto un valore di oltre 278 milioni di franchi (155 mio. fr. in più rispetto al 2008). I<br />
principali prodotti svizzeri destinati al mercato giapponese sono tabacco, bevande, caffè, prodotti<br />
a base di cacao, nonché preparazioni alimentari diverse. Le importazioni agricole provenienti<br />
dal Giappone non hanno subito variazioni di rilievo anche dopo l’entrata in vigore<br />
dell’accordo di libero scambio: nel 2014 la Svizzera ha importato prodotti agricoli per un valore<br />
di quasi 16 milioni di franchi (nel 2008 le importazioni, con un valore di quasi 17 mio. fr., erano<br />
state persino più elevate). I principali prodotti d’importazione provenienti dal Giappone sono<br />
grassi e oli di pesce, salsa di soia, alghe, tè e preparazioni alimentari diverse.<br />
Pierre-François Righetti, UFAG, Settore Politica commerciale internazionale, pierre-francois.righetti@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
335
Il mio Rapporto agricolo 30 / 42<br />
INTERNAZIONALE > STATISTICHE E MODELLIZZAZIONE<br />
Sviluppi dei mercati agricoli<br />
Il presente capitolo fornisce una panoramica sugli sviluppi a breve, medio e lungo termine dei<br />
mercati agricoli. Diverse fonti offrono informazioni sugli sviluppi del mercato delle principali<br />
materie prime agricole. Questi si differenziano principalmente per le colture e i prodotti esaminati,<br />
l'orizzonte temporale dell'analisi (breve, medio o lungo termine) nonché i limiti geografici<br />
del sistema (valutazione nazionale vs. valutazione globale). In seguito alle crisi alimentari<br />
degli anni 2008, 2011 e 2012 diverse istituzioni hanno intensificato i loro sforzi in vista di<br />
migliorare la trasparenza sui mercati alimentari. A titolo esemplificativo si cita l'Agricultural<br />
Market Information System (AMIS) istituito nel 2011 su proposta dei ministri dell'agricoltura<br />
del G20 e che si concentra su una valutazione a breve e medio termine.<br />
Valutazione a breve termine<br />
Il clima mutevole ha influenzato i mercati per quanto riguarda le colture considerate nell'AMIS<br />
(frumento, mais, riso e soia) già nel primo semestre. Nel mesi successivi i fattori meteorologici<br />
hanno avuto probabilmente un influsso decisivo sulle rese di mais, soia e riso nell'emisfero<br />
boreale. La decisione della Gran Bretagna di uscire dall'UE ha contribuito a creare un'ulteriore<br />
incertezza sui mercati anche se le prime ripercussioni sui mercati finanziari si stavano già delineando.<br />
Il Foreign Agricultural Service dell'United States Departement of Agriculture (USDA) pubblica<br />
su base mensile dati concernenti il mercato e il commercio cerealicolo. Per la produzione di frumento<br />
di quest'anno a livello mondiale prevede un quantitativo record che per il quarto anno<br />
consecutivo supera la domanda. Tale tendenza determina un'eccessiva offerta sul mercato e<br />
una pressione sui prezzi. Gli esportatori più importanti sono Argentina, Australia, Canada, UE,<br />
Kazakistan, Russia, Ucraina e Stati Uniti d'America. In tale contesto caratterizzato da prezzi<br />
bassi si deve presupporre un aumento della domanda d'importazione. Di questa domanda in<br />
aumento, soprattutto dai mercati in crescita nel Medio Oriente e nell'Africa e settentrionale,<br />
beneficiano in primo luogo gli esportatori con un’elevata competitività dal profilo dei prezzi<br />
come, ad esempio, l'UE o i Paesi nella regione del Mar Nero che presentano vantaggi connessi<br />
ai costi di trasporto e logistica rispetto ai loro concorrenti.<br />
Valutazione a medio e lungo termine<br />
Secondo l'Agraroutlook OCSE_FAO 2016-2025, nel 2015 i prezzi di tutte le più importanti piante<br />
utili, animali da reddito e prodotti ittici sono diminuiti. Questo segnala che è probabilmente<br />
finita un'era di prezzi elevati per tutti i comparti. Mentre i prezzi record della carne<br />
registrati nel 2014 sono diminuiti, nel 2013 e 2014 è proseguita la tendenza negativa per i<br />
prezzi dei latticini; per quanto riguarda i cereali, invece, dopo gli alti livelli del 2012, il calo<br />
dei prezzi è proseguito. I principali fattori correlati ai prezzi bassi sono, da un lato, la robusta<br />
crescita dell'offerta in atto da anni e dall’altro la tendenza negativa che sarà ulteriormente<br />
potenziata mediante una moderata crescita della domanda a causa della debole congiuntura a<br />
livello generale, dei bassi prezzi del petrolio e di un ulteriore aumento delle peraltro già considerevoli<br />
scorte.<br />
336<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 31 / 42<br />
INTERNAZIONALE > STATISTICHE E MODELLIZZAZIONE<br />
Ogni anno l'Agraroutlook OCSE-FAO affronta un tema particolare. L'edizione 2016 è consacrata<br />
all'Africa sub-sahariana, una regione con più di 950 milioni di abitanti e circa il 13 per cento<br />
della popolazione mondiale. Nonostante la continua trasformazione dell'economia della regione,<br />
l'agricoltura resta un settore fondamentale. Le differenze regionali nella struttura e<br />
nello stato di sviluppo dell'agricoltura rispecchiano grandi differenze agroecologiche, economiche,<br />
politiche e culturali nell'intero continente.<br />
Lo sviluppo del settore agricolo è influenzato da diversi fattori. Di notevole rilievo sono, in<br />
particolare, i cambiamenti climatici, il connesso accesso alle risorse idriche, la rapida crescita<br />
demografica, l’affacciarsi di un ceto medio e la progressiva urbanizzazione, la diversificazione<br />
dell'economia rurale e il conseguente cambiamento strutturale nonché una crescente<br />
domanda (sia all'interno del Paese sia all'estero) di terreni campicoli. Mentre finora la maggior<br />
parte dell'incremento di produzione è stata riconducibile a un ampliamento della superficie<br />
agricola, in futuro tale crescita sarà dovuta sempre più a una migliore produttività.<br />
La sottoalimentazione è una sfida costante. Il progresso in materia di sicurezza alimentare presenta<br />
caratteristiche molto diverse nei vari Stati.<br />
Prospettive per l'UE<br />
La Commissione UE pubblica annualmente un Agraroutlook UE. Il rapporto parte dal presupposto<br />
che in un contesto con bassi prezzi dell'energia e delle materie prime i prezzi dei cereali<br />
UE in media si attestano tra 150 e 190 euro la tonnellata. La domanda mondiale di carne costantemente<br />
in crescita, a causa anche dell'incremento, sul piano mondiale, del potere di acquisto<br />
e di prezzi abbordabili dei foraggi, favorisce la produzione animale. Quindi, nonostante<br />
le difficoltà attuali sul mercato lattiero, è probabile che il settore lattiero UE a medio termine<br />
amplierà la sua offerta.<br />
Prospettive per la Svizzera<br />
Swiss AgrarOutlook (SAO), pubblicato per la prima volta nel 2015, fornisce una panoramica a<br />
medio termine sull'evoluzione dei prezzi alla produzione e dei quantitativi dei principali mercati<br />
di produzione svizzeri (cereali panificabili e da foraggio, colza, patate, barbabietola da<br />
zucchero, latte e formaggio, carne di manzo, suino e pollame) ed effettua proiezioni su una<br />
serie di indicatori economici e strutturali del settore agricolo svizzero. SAO non fa previsioni<br />
ma descrive i possibili sviluppi del settore agricolo svizzero purché le condizioni quadro economiche<br />
e in materia di politica agricola e le ipotesi alla base del SAO si verifichino come sono<br />
state considerate nel modello. Le proiezioni si riferiscono ai dati e alle informazioni presenti a<br />
gennaio 2015 sullo sviluppo economico nell'UE e sui mercati mondiali, sulle previsioni macroeconomiche<br />
per la Svizzera nonché sulla politica agricola vigente.<br />
I mercati agricoli svizzeri in generale si distinguono per un'elevata protezione doganale. Tuttavia<br />
gli sviluppi nell'UE, a seconda del mercato del prodotto e del sistema doganale, rivestono<br />
un ruolo fondamentale per l'evoluzione indigena dei prezzi. Secondo la Commissione UE, i mercati<br />
di prodotti vegetali sono caratterizzati da una stabile domanda mondiale il che determina<br />
a sua volta prezzi stabili al livello attuale. Soltanto sul mercato dello zucchero, contrariamente<br />
alla tendenza attuale, persistono prezzi bassi a causa dell'abrogazione delle quote zucchero<br />
UE a partire dal 2017.<br />
I risultati del SAO mostrano soltanto pochi spostamenti nella gestione della superficie agricola<br />
utile in Svizzera, riconducibili all'elevata protezione esterna, in particolare sui mercati<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
337
Il mio Rapporto agricolo 32 / 42<br />
INTERNAZIONALE > STATISTICHE E MODELLIZZAZIONE<br />
cerealicoli, ai tuttora elevati contributi per i pagamenti diretti riferiti alla superficie e a costi<br />
in diminuzione per i consumi intermedi. I cambiamenti strutturali nell'agricoltura, secondo le<br />
simulazioni, continueranno con lo stesso ritmo cosicché la superficie agricola utile sarà gestita<br />
da sempre meno aziende. Grazie all’incremento della superficie media per azienda, le aziende<br />
possono beneficiare di un effetto di scala con conseguente diminuzione degli ammortamenti<br />
dell'intero settore.<br />
Complessivamente il SAO 2014-2024, alle attuali condizioni quadro, delinea un'immagine<br />
stabile dell'agricoltura svizzera. Questo grazie all'elevata protezione doganale e a un effetto<br />
stabilizzante del sistema dei pagamenti diretti che garantisce continuità. In questo orizzonte<br />
temporale tuttavia si attendono cambiamenti che modificano le condizioni quadro.<br />
Martijn Sonnevelt, UFAG, Unità di direzione Affari internazionali, martijn.sonnevelt@blw.admin.ch<br />
338<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 33 / 42<br />
INTERNAZIONALE > STATISTICHE E MODELLIZZAZIONE<br />
Statistiche agricole di alcuni partner commerciali<br />
Nella presente sezione commentiamo i recenti sviluppi di alcuni aspetti del commercio agricolo<br />
estero della Svizzera e dei rapporti di prezzo tra la Svizzera e l'estero.<br />
Partner commerciali internazionali<br />
A complemento delle statistiche sul commercio estero per prodotto pubblicate nella sezione<br />
«Mercato» e per tutta l'agricoltura svizzera nella sezione «Mercato / Evoluzione dei mercati /<br />
Commercio estero», di seguito sono presentate analisi puntuali del commercio estero agricolo<br />
svizzero.<br />
Esportazioni svizzere nel quadro della legge sul cioccolato<br />
Le esportazioni di prodotti agricoli trasformati disciplinate dalla legge sul cioccolato, quali biscotti<br />
e cioccolato, comprendono prodotti agricoli di base di origine svizzera. Nel 2015 questi<br />
ultimi sono stati principalmente composti da 74 000 tonnellate di latte condensato, 12 000<br />
tonnellate di latte in polvere, 2400 tonnellate di burro e 36 000 tonnellate di farina di frumento.<br />
Il volume totale di queste esportazioni di prodotti agricoli di base svizzeri compresi nei<br />
prodotti agricoli trasformati è più che raddoppiato (più 2.16 volte) tra il 2002 e il 2015.<br />
Traffico di perfezionamento<br />
Il traffico di perfezionamento è un elemento importante del commercio estero agricolo svizzero.<br />
Il traffico di perfezionamento attivo comprende la lavorazione, la trasformazione o la<br />
riparazione di merci estere importate in Svizzera per poi essere riesportate sotto forma di prodotti<br />
perfezionati. Nel 2015 la Svizzera ha importato prodotti agricoli nel quadro del traffico<br />
di perfezionamento attivo per un valore di 185 milioni di franchi, ovvero il 2 per cento delle<br />
sue importazioni agricole totali (11,3 mia. fr.), corrispondenti a un aumento del 32 per cento<br />
rispetto al 2002. I principali prodotti interessati sono siero di latte, carne bovina disossata in<br />
particolare per la fabbricazione di carne secca dei Grigioni, grassi e oli vegetali e lattosio. Nel<br />
2015 la Svizzera ha riesportato prodotti agricoli nell’ambito del traffico di perfezionamento<br />
attivo per un valore pari a 2788 milioni di franchi, ovvero il 30 per cento delle esportazioni<br />
agricole totali (9,3 mia. fr.), valore triplicato rispetto al 2002. I principali prodotti interessati<br />
sono limonate, sigarette, preparazioni per l’alimentazione dei bambini, cioccolata, alimenti<br />
per cani e gatti, alimenti per neonati, paste alimentari, miscele di grassi o oli non lattieri e carne<br />
secca. In termini di materie prime presenti in tali esportazioni di prodotti agricoli trasformati<br />
figurano, ad esempio, l'equivalente di 80 000 tonnellate di zucchero cristallizzato, 27 000 tonnellate<br />
di altri zuccheri, 32 000 tonnellate di oli e grassi vegetali e 9000 tonnellate di semola<br />
di grano duro. Il traffico di perfezionamento passivo comprende la lavorazione, trasformazione<br />
o riparazione di beni indigeni all’estero per poi essere reimportati sotto forma di prodotti<br />
perfezionati. Per la Svizzera, la sua portata è inferiore a quella del traffico di perfezionamento<br />
attivo. Nel 2015 sono stati esportati prodotti nel quadro del traffico di perfezionamento passivo<br />
per un valore di 38 milioni di franchi, ovvero lo 0,4 per cento delle esportazioni agricole<br />
totali del Paese e il 104 per cento in più rispetto al 2002. I principali prodotti interessati sono<br />
farina di frumento, panna e siero di latte. Nel 2015 sono stati reimportati prodotti nel quadro<br />
del traffico di perfezionamento passivo per un valore di 65 milioni di franchi, ovvero lo 0,6<br />
per cento delle importazioni agricole totali del Paese, segnando un incremento quasi del triplo<br />
(2.6) rispetto al 2002. I principali prodotti interessati sono il pane, la panna e le patatine.<br />
Misure d'importazione della Russia<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
339
Il mio Rapporto agricolo 34 / 42<br />
INTERNAZIONALE > STATISTICHE E MODELLIZZAZIONE<br />
Le misure all'importazione decretate dalla Russia il 6 agosto 2014 per le importazioni agricole<br />
provenienti dall'UE non hanno avuto l'effetto di aumentare le esportazioni di tutti i prodotti<br />
agricoli svizzeri verso la Russia. Al contrario, tali esportazioni tra il 2013 e il 2015 si sono ridotte<br />
del 21 per cento. Le esportazioni agricole svizzere verso la Russia nel 2013 si attestavano a 231<br />
milioni di franchi, ovvero il 2,4 per cento delle esportazioni agricole svizzere totali (9604 mio.<br />
fr.) e nel 2015 a 181 milioni di franchi, ovvero l'1,9 per cento (9349 mio. fr.). Nonostante un<br />
lieve aumento tra il 2013 e il 2015, le esportazioni svizzere di formaggio verso la Russia restano<br />
trascurabili (1 %) anche nel 2015, se si confrontano con quelle dell'UE-28 verso la Russia,<br />
antecedenti alle misure da essa disposte (1181 mio. fr. nel 2013). Tra il 2013 e il 2015, invece, si<br />
è registrata una flessione di 19 milioni di franchi (da 81 a 62 mio. fr.) dell'esportazione svizzera<br />
verso la Russia per quanto riguarda preparazioni alimentari per l'infanzia.<br />
Esportazioni di una selezione di prodotti agricoli svizzeri e dell'UE<br />
nel mondo e verso la Russia tra il 2012 e il 2015 (mio. fr.)<br />
Brexit<br />
Alla domanda «Il Regno Unito deve rimanere membro o lasciare l'Unione europea?» posta il 23<br />
giugno 2016 al popolo della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, il 51,9 per cento dei votanti<br />
ha risposto "Lasciare l'Unione europea". Questa decisione comporterà una rinegoziazione del<br />
diritto internazionale che disciplina le relazioni commerciali agricole tra la Svizzera e il Regno<br />
Unito. Il commercio agricolo bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito è classificato in ordine<br />
decrescente di valori nella tabella sottostante. Si osserva che le autorità del Regno Unito registrano<br />
valori all’importazione (134 mio. fr.) quattro volte inferiori a quelli (562 mio. fr.) dichiarati<br />
per l'esportazione alle autorità doganali svizzere. Le ragioni di tale differenza vanno<br />
ancora chiarite. Ad esempio potrebbe darsi che il Regno Unito non applichi davvero il principio<br />
del Paese di provenienza dell'importazione; che menziona il Paese di spedizione invece del<br />
Paese di provenienza mentre quest'ultimo è sconosciuto; che la merce svizzera sia rispedita<br />
verso altri Paesi; o che le esportazioni svizzere verso il Regno Unito non siano tutte di origine<br />
svizzera. Ciò ci mostra che occorre un lavoro di armonizzazione delle statistiche. Partendo da<br />
questo presupposto, i prodotti agricoli interessati dall'esportazione sono principalmente prodotti<br />
trasformati, vino, anche riesportato, e formaggio. Per quanto riguarda l'importazione si<br />
tratta principalmente di whisky, gin, caffè e tabacco.<br />
Commercio estero agricolo nel 2015 tra la Svizzera e il Regno Unito<br />
(migliaia di fr.)<br />
340<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 35 / 42<br />
INTERNAZIONALE > STATISTICHE E MODELLIZZAZIONE<br />
Fonti: Amministrazione federale delle dogane AFD e Centro del commercio internazionale (CCI)<br />
Importazioni e dazi doganali<br />
Nel 2015 la metà del valore totale delle importazioni agricole svizzere ha avuto luogo<br />
nell’ambito della franchigia doganale. L’aliquota di dazio lorda media ponderata per il valore<br />
delle importazioni per tutti i prodotti agricoli importati ammonta al 6 per cento del valore delle<br />
importazioni. Secondo la pubblicazione «Profili tariffari nel mondo 2015» dell'OMC, la media<br />
aritmetica semplice dei dazi applicati in Svizzera a livello della nazione più favorita si attesta al<br />
36 per cento nel 2014. Quest'ultimo dato è sei volte superiore al precedente poiché da un lato<br />
non tiene conto delle importazioni realizzate a dazi preferenziali, delle agevolazioni doganali<br />
connesse all'uso specifico, nel traffico di perfezionamento secondo il regime sospensivo e non<br />
è ponderato per il valore delle importazioni. D'altro canto l'OMC determina la media in due fasi.<br />
Calcola prima la media delle linee tariffali nazionali per ogni sottovoce a sei cifre del Sistema<br />
armonizzato (HS), poi considera la media delle medie di tutte le sottovoci.<br />
Valore delle importazioni e importi dei dazi doganali lordi per tutti i prodotti agricoli nel<br />
2015<br />
Tipi di dazio Importazioni Dazi doganali lordi<br />
mio. fr. mio. fr. %<br />
(a) (b) (c) (d) = (c) / (b)<br />
Dazio normale 4411 532 12 %<br />
Dazio ridotto 1381 131 10 %<br />
Franchigia 5484 - 0 %<br />
Totale 11 276 663 6 %<br />
Fonte: Amministrazione federale delle dogane<br />
Schede dei Paesi<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
341
Il mio Rapporto agricolo 36 / 42<br />
INTERNAZIONALE > STATISTICHE E MODELLIZZAZIONE<br />
Al seguente link il lettore interessato può consultare le statistiche riguardanti una selezione di<br />
50 partner commerciali, compresi quelli con i quali la Svizzera ha intavolato negoziati in vista<br />
della conclusione di accordi di libero scambio. Tali statistiche contemplano indicatori economici<br />
generali, prezzi pagati ai produttori agricoli, dati sul commercio estero agricolo, l’elenco<br />
dei principali partner commerciali e i dazi doganali.<br />
Jean Girardin, UFAG, Settore Politica commerciale internazionale, jean.girardin@blw.admin.ch<br />
342<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 37 / 42<br />
INTERNAZIONALE > STATISTICHE E MODELLIZZAZIONE<br />
Confronto internazionale<br />
Introduzione<br />
In questa parte sono presentati i prezzi alla produzione e al consumo in Svizzera e nei tre Paesi<br />
limitrofi (Germania, Francia e Austria) di diversi prodotti animali e vegetali. Questi sono influenzati<br />
da vari fattori lungo la catena del valore, tra i quali citiamo i seguenti: la struttura delle<br />
aziende, il costo dei fattori di produzione, le prescrizioni legali, le strutture di trasformazione<br />
e di distribuzione nonché il comportamento dei consumatori. Tali fattori non sono identici per<br />
la Svizzera e i Paesi limitrofi. D'altra parte il confronto si scontra con la difficoltà di trovare<br />
prodotti identici e confrontabili per i quali sono disponibili dati. Pertanto occorre tener conto<br />
di questo aspetto nell'interpretazione delle cifre. I prodotti considerati sono quelli che meglio<br />
si prestano a tale confronto tra i prezzi.<br />
Prezzi alla produzione più elevati di quelli dei Paesi limitrofi<br />
» A108<br />
I prodotti svizzeri e quelli dei tre Paesi limitrofi si differenziano dal profilo della qualità, del<br />
label, del condizionamento e dei servizi. Laddove è stato impossibile trovare un prodotto comparabile,<br />
non vi è alcuna indicazione. Sono stati osservati i seguenti prodotti: latte crudo,<br />
carne, uova, cereali e semi oleosi, patate, frutta e verdura.<br />
Prezzi alla produzione in Svizzera e nei Paesi limitrofi – 2015<br />
In Svizzera, a causa dei fattori summenzionati e della protezione doganale, i prezzi alla produzione<br />
sono superiori a quelli dell’UE. Nei tre Paesi limitrofi dell'UE sono relativamente omogenei<br />
per il latte, la carne e le patate, mentre presentano differenze talvolta notevoli nel caso<br />
della frutta e verdura. In tali Paesi il prezzo del latte equivale a un po' meno della metà di quello<br />
svizzero. Per quanto riguarda la carne, il prezzo oscilla tra il 40 e il 55 per cento dei prezzi svizzeri.<br />
Il livello di prezzo di cereali e semi oleosi in Germania varia tra il 36 e il 50 per cento di<br />
quello svizzero. Frutta e verdura nei Paesi limitrofi presentano prezzi inferiori a quelli osservati<br />
in Svizzera. Lo scarto può essere molto diverso a seconda del Paese ed è compreso tra il 24 e<br />
l'84 per cento.<br />
Prezzi al consumo più elevati di quelli dei Paesi limitrofi<br />
A livello di consumo è ancora più difficile che a livello di produzione individuare prodotti adatti<br />
al confronto, anche a causa della maggiore varietà di prodotti. I prezzi dei prodotti possono<br />
variare soprattutto a seconda delle strutture di smercio e del comportamento dei consumatori,<br />
molto diverso tra un Paese e l'altro. Sono stati osservati i seguenti prodotti: latte e latticini,<br />
carne, uova, cereali e semi oleosi, patate, frutta e verdura.<br />
» A109<br />
Prezzi al consumo in Svizzera e nei Paesi limitrofi – 2015<br />
Come i prezzi alla produzione, anche quelli al consumo sono più elevati in Svizzera rispetto ai<br />
Paesi limitrofi. I consumatori tedeschi beneficiano tendenzialmente dei prezzi minori. Latte<br />
e latticini nei Paesi limitrofi hanno prezzi tra il 25 e l'83 per cento più bassi rispetto a quelli<br />
elvetici, per la carne e le uova tra il 26 e il 75 per cento, mentre per frutta, verdura e patate tra<br />
il 42 e l’88 per cento. Le differenze tra la Svizzera e i tre Paesi limitrofi sono particolarmente<br />
evidenti per quanto riguarda i prezzi della carne. Nei tre Paesi limitrofi i consumatori pagano<br />
per molti tagli di carne meno della metà rispetto alla Svizzera. I prezzi della carne nei tre Paesi<br />
limitrofi sono compresi tra il 26 e il 52 per cento di quelli della Svizzera (ad eccezione del pollo<br />
intero che si attesta al 75 per cento del prezzo svizzero). Per i latticini, il burro registra lo scarto<br />
di prezzo maggiore tra la Svizzera e i Paesi limitrofi.<br />
Michel Yawo Afangbedji, UFAG, Settore Osservazione del mercato,<br />
michel-yawo.afangbedji@blw.admin.ch<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
343
Il mio Rapporto agricolo 40 / 42<br />
INTERNAZIONALE > STATISTICHE E MODELLIZZAZIONE<br />
Analisi quantitative<br />
L’UFAG utilizza modelli economici di simulazione ex-ante al fine di studiare e quantificare<br />
l’impatto degli accordi commerciali internazionali sull’agricoltura svizzera. Tali modelli permettono<br />
di analizzare un ampio ventaglio di accordi bilaterali e multilaterali, nonché l’impatto<br />
dei cambiamenti delle politiche agricole e commerciali dei Paesi terzi. In questo campo, l’UFAG<br />
lavora in stretta collaborazione con il «Campo strategico Competitività e valutazione dei sistemi»<br />
di Agroscope.<br />
L’utilizzo di tali strumenti quantitativi, comprovati e riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale,<br />
consente non solo di produrre risultati di qualità elevata, ma anche di rafforzare<br />
la solidità della posizione negoziale della Svizzera nelle trattative. Ciò è reso possibile, da<br />
una parte, grazie alla partecipazione costante nel dibattito, in ambito accademico e nei network<br />
di ricerca internazionali, per l’utilizzo delle metodologie più avanzate, e dall’altra grazie<br />
all’impegno costante degli esperti di mercato dell’UFAG per la validazione di dati, ipotesi e risultati.<br />
Bisogna tuttavia ricordare che i modelli economici di simulazione offrono pur sempre una<br />
rappresentazione semplificata della realtà. Per poter interpretare correttamente i risultati, è<br />
quindi assolutamente necessario comprendere bene i metodi utilizzati e le loro limitazioni.<br />
Attualmente, due modelli sono utilizzati all’UFAG: il Tariff Reduction Impact Model for Agriculture<br />
(TRIMAG) e il modello di mercato del Common Agricultural Policy Regionalized Impact<br />
model (CAPRI).<br />
Il modello TRIMAG<br />
TRIMAG è stato sviluppato ed è utilizzato unicamente presso l’UFAG. Questo modello offre una<br />
rappresentazione estremamente dettagliata della struttura delle importazioni svizzere per i<br />
prodotti agricoli ed alimentari. La sua banca dati include quindi prezzi, volumi e politiche commerciali<br />
della Svizzera (tariffe doganali, contingenti all’importazione, prezzi soglia per alcuni<br />
cereali foraggeri), nonché i corrispondenti prezzi internazionali.<br />
TRIMAG viene utilizzato come supporto decisionale per i negoziati commerciali internazionali,<br />
al fine di identificare la migliore strategia per l’accesso al mercato. Le varie opzioni alternative<br />
di riduzioni tariffarie vengono analizzate e valutate in base all’impatto atteso sui prezzi agricoli<br />
svizzeri.<br />
Inoltre, TRIMAG può essere utilizzato come strumento per aggregare le oltre 2000 linee di tariffe<br />
doganali per i prodotti agricoli (ad esempio, «Viandes désossées de bovins (à l'excl. de<br />
celles de veaux), fraîches ou réfrigérées, hors contingent» oppure «Tomates cerises [cherry],<br />
à l'état frais ou réfrigéré, du 1er mai au 20 octobre, hors contingent») per circa 50 prodotti<br />
agricoli (come «carne bovina» o «pomodoro»). La metodologia sviluppata ed utilizzata per<br />
l’aggregazione delle tariffe tiene conto degli effetti di sostituzione al consumo tra le varie linee<br />
tariffarie, in base alle variazioni relative dei prezzi interni. Questo permette di sintetizzare una<br />
grande quantità di informazioni relative alla complessa politica di protezione doganale della<br />
Svizzera, al fine di poterla utilizzare in modelli che rappresentano il funzionamento dei mercati<br />
mondiali, come nel caso di CAPRI.<br />
Il modello CAPRI<br />
CAPRI è un modello globale di equilibrio parziale comparativo statico 1 per l’agricoltura sviluppato<br />
da una rete internazionale di istituti di ricerca, coordinati dall’Institut für Lebensmittelund<br />
Ressourcenökonomik dell’Università di Bonn (www.capri-model.org). Da oltre 15 anni,<br />
CAPRI viene utilizzato da ministeri, agenzie ed istituti di ricerca dell’UE e di altri Paesi per ana-<br />
344<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
Il mio Rapporto agricolo 41 / 42<br />
INTERNAZIONALE > STATISTICHE E MODELLIZZAZIONE<br />
lizzare l’impatto delle politiche agricole (compresi gli aspetti ambientali) e commerciali. La<br />
Svizzera è inclusa esplicitamente nel modello (prima era infatti nel gruppo di Paesi «Rest of<br />
Europe») dal 2011.<br />
CAPRI include un modello spaziale dei mercati mondiali, nel quale sono rappresentate, per<br />
circa 80 Paesi e 50 prodotti agricoli, le funzioni di produzione, consumo (distinguendo tra<br />
consumo umano, foraggero e destinato alla trasformazione), importazioni ed esportazioni,<br />
nonché tutte le principali misure di politica interna e commerciale. Il cosiddetto approccio «Armington»,<br />
utilizzato in CAPRI, consente di differenziare i prodotti secondo il Paese d’origine,<br />
e dunque di rappresentare tutti i flussi di commercio bilaterale. Per la Svizzera, particolare attenzione<br />
è posta a un’adeguata rappresentazione delle politiche commerciali grazie all’utilizzo<br />
delle tariffe aggregate calcolate grazie al modello TRIMAG.<br />
Con CAPRI è possibile analizzare, per un dato momento nel futuro e rispetto ad uno scenario di<br />
riferimento, l’impatto atteso sui prezzi all’equilibrio, la produzione, il consumo ed il commercio<br />
di un cambiamento della politica nazionale o commerciale. In seguito a queste variazioni, è<br />
possibile dedurre gli effetti sul benessere economico dei vari attori a parità di condizioni sul<br />
resto dell’economia. Lo scenario di riferimento è definito come la situazione futura più probabile<br />
assumendo che non vi siano cambiamenti rispetto alle politiche esistenti o già decise, e<br />
si basa su proiezioni internazionali fornite da istituzioni internazionali quali l’OCSE, la FAO e<br />
l’UE. A partire dal 2014, la Swiss Agricultural Outlook fornisce delle proiezioni a medio termine<br />
sull’evoluzione delle quantità e dei prezzi per i principali prodotti agricoli svizzeri. Queste proiezioni<br />
sono utilizzate e puntualmente aggiornate nel modello CAPRI.<br />
CAPRI è normalmente utilizzato per simulazioni ex-ante e con una prospettiva a medio-termine<br />
(tipicamente, 10-15 anni), il che ben si adatta sia al carattere comparativo statico del modello,<br />
che al periodo tipico di implementazione delle politiche agricole.<br />
L’uso combinato di TRIMAG e CAPRI permette dunque di abbinare un’elevata precisione nel riprodurre<br />
e testare l’impatto dettagliato dei vari possibili scenari di politica commerciale internazionale<br />
(TRIMAG), come richiesto nella realtà dai negoziati, con la possibilità di analizzarne<br />
l’impatto a livello aggregato sui mercati agricoli mondiali (CAPRI).<br />
Infine, i risultati di CAPRI vengono ulteriormente utilizzati per dedurre considerazioni più precise<br />
sulla reazione a livello di singola azienda agricola. Questo è possibile grazie all’interazione<br />
con il modello SWISSland (StrukturWandel InformationsSystem Schweiz, Sistema informatico<br />
sui cambiamenti strutturali in Svizzera), sviluppato ed utilizzato da Agroscope. Si tratta di un<br />
modello dell’offerta ricorsivo dinamico, multi agente, che riproduce il comportamento strategico<br />
delle singole aziende agricole (crescita dell’azienda, esercizio di un’attività accessoria,<br />
abbandono della produzione) e quindi del settore nel suo complesso, permettendo di valutare<br />
il rendimento e la struttura del settore agricolo svizzero in scenari alternativi di politica agricola.<br />
SWISSland si basa sulle 3300 aziende di riferimento del sistema di Analisi centralizzata<br />
dei dati contabili del campo strategico «Competitività e valutazione dei sistemi» di Agroscope.<br />
In breve, l’interazione fra i due modelli CAPRI e SWISSland si svolge come segue: 1) l’impatto<br />
dei vari scenari di politica commerciale viene simulato in CAPRI; 2) i cambiamenti dei prezzi<br />
all’equilibrio sul mercato interno sono poi trasmessi a SWISSland, che simula la risposta produttiva<br />
nel tempo all’interno del settore agricolo svizzero. La coerenza tra CAPRI e SWISSland<br />
è assicurata grazie all’armonizzazione delle ipotesi di base e delle banche dati.<br />
Valutazione delle politiche ex-post<br />
Oltre agli esercizi di simulazione sopra descritti per le analisi ex-ante, l’UFAG è responsabile,<br />
nel quadro delle attività ordinarie di valutazione delle politiche, di eseguire regolarmente analisi<br />
di valutazione ex-post. Questo consente di verificare se l’applicazione di determinate politiche<br />
commerciali è stata efficace ed efficiente nel rispondere agli obiettivi previsti. Nel 2015,<br />
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG<br />
345
Il mio Rapporto agricolo 42 / 42<br />
INTERNAZIONALE > STATISTICHE E MODELLIZZAZIONE<br />
questa attività ha riguardato la misura di politica commerciale più rilevante per la Svizzera,<br />
ovvero i contingenti all’importazione.<br />
Bibliografia<br />
CAPRI model documentation 2014. Wolfgang Britz, Heinz Peter Witzke, 2014.<br />
Analyse de l’impact sur le marché laitier du supplément pour le lait transformé en fromage. Recherche Agronomique<br />
Suisse 5 (5): 212–215. Giulia Listorti, Axel Tonini, 2014.<br />
How to Implement WTO Scenarios in Simulation Models: Linking the TRIMAG Tariff Aggregation Tool to Capri. 135th<br />
EAAE Seminar, Belgrade, Serbia, 28-30 August. Giulia Listorti, Axel Tonini, Markus Kempen, Marcel Adenäuer, 2013.<br />
Evaluating existing policy flexibilities in WTO agricultural negotiations: different criteria for the selection of sensitive<br />
products. 122nd EAAE Seminar, Ancona, Italy, 17-18 February. Giulia Listorti, Markus Kempen, Jean Girardin, Tim<br />
Kränzlein, 2011.<br />
Do price uncertainties affect the use of policy flexibilities? The selection of sensitive products in WTO agricultural<br />
negotiations. EAAE 2011 Congress, Zurich, Switzerland. August 30 to September 2. Giulia Listorti, Markus Kempen,<br />
Jean Girardin, Tim Kränzlein, 2011.<br />
Reciproca apertura settoriale del mercato con l'UE per tutti i prodotti lattieri, rapporto del Consiglio federale, 14<br />
maggio 2014.<br />
1 CAPRI è un modello d’equilibrio parziale perché valuta esclusivamente l’impatto di un cambiamento economico o<br />
politico sul settore agricolo, supponendo che il resto dell’economia resti invariato (condizione «ceteris paribus»).<br />
Per i Paesi sviluppati, i cambiamenti del settore agricolo hanno effetti limitati sul resto dell’economia. CAPRI è<br />
quindi adatto alle analisi d’impatto ex-ante sul settore agricolo svizzero.<br />
Giulia Listorti, UFAG, Settore Politica Commerciale Internazionale, giulia.listorti@blw.admin.ch<br />
346<br />
Ufficio federale dell’agricoltura dell'agricoltura UFAG
347
348<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Caratteristiche e indicatori per la misurazione della vitalità di uno spazio rurale<br />
Settore parziale/<br />
Dimensioni<br />
Vitalità sociale<br />
Vitalità economica<br />
Vitalità ecologica<br />
Attributo Indicatore Dati statistici [anno(i)]<br />
Popolazione vitale<br />
Società civile viva e<br />
coesistenza intatta<br />
Salute e situazione sociale<br />
Competitività<br />
Ecosistema intatto e<br />
resiliente<br />
Sviluppo demografico Variazione della popolazione residente in %<br />
positivo<br />
[Ø 2009 – 2014]<br />
Coefficiente di gioventù Quota < 20enni in % [2013]<br />
Partecipazione attiva al Quota di votanti/elettori rispetto agli aventi<br />
voto/alle elezioni<br />
diritti al voto/all'elezione in % [2011]<br />
Scarsa disoccupazione<br />
Quota di disoccupati registrati rispetto al totale<br />
di tutte le persone attive in % [2013]<br />
Pochi beneficiari di aiuti Quota di beneficiari di aiuti sociali rispetto<br />
sociali<br />
all'intera popolazione in % [2013]<br />
Evoluzione dei posti di lavoro Sviluppo del numero di equivalenti a tempo<br />
(senza ente pubblico) pieno nell'economia privata in % [2008 –<br />
Spirito imprenditoriale<br />
Creazione di nuovi posti di lavoro in nuove<br />
aziende ogni 1000 lavoratori [2008 – 2012]<br />
Potenziale in base alla Quota di SPB (ex superficie di compensazione<br />
superficie<br />
ecologica) rispetto alla SAU in % [2013]<br />
Potenziale in base alla Quota di superficie campicola gestita in modo<br />
superficie<br />
ecologico<br />
Quota di superficie degli inventari dei biotipi<br />
Potenziale in base alla rispetto alla superficie complessiva in %<br />
superficie<br />
[2007/2008/2010/2013, differente a seconda<br />
del tipo di inventario dei biotipi]<br />
Quota di superficie di oggetti IFP nonché zone<br />
Potenziale in base alla<br />
palustri rispetto alla superficie complessiva in<br />
superficie<br />
% [2001]<br />
Potenziale in base alla Quota di superficie di parchi rispetto alla<br />
superficie<br />
superficie complessiva in % [2015]<br />
Sigillatura<br />
Quota della superficie d'insediamento rispetto<br />
alla superficie complessiva in % [2004/2009]<br />
Fonte: Ecoplan<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A1
Caratteristiche e indicatori per la misurazione dell'attrattiva di uno spazio rurale<br />
Settore parziale/<br />
Prospettiva<br />
Luogo di residenza<br />
Piazza economica<br />
Spazio ricreativo e<br />
per il tempo libero<br />
Fonte: Ecoplan<br />
Attributo Indicatore Dati statistici [anno]<br />
Servizio pubblico e assetto di<br />
base<br />
Possibilità di lavoro e<br />
formazione<br />
Varietà naturale e del<br />
paesaggio rurale<br />
Situazione del reddito<br />
e carico fiscale<br />
Manodopera qualificata<br />
Infrastrutture economiche e<br />
relative alle risorse<br />
Raggiungibilità dal profilo<br />
tecnico dei trasporti<br />
Infrastrutture e offerte<br />
turistiche<br />
Offerta di servizi per la<br />
popolazione<br />
Numero di aziende nei servizi per la<br />
popolazione ogni 1000 abitanti [2012]<br />
Lavoratori del proprio Comune e di quelli<br />
Potenziale raggiungibilità di<br />
limitrofi ponderato con la matrice di<br />
posti di lavoro<br />
raggiungibilità del PFZ [2010]<br />
Percezione della bellezza Portata dell'apprezzamento globale di un<br />
del paesaggio<br />
paesaggio (scala di valutazione = 0 – 5) [2011]<br />
Livello di reddito delle<br />
persone fisiche<br />
Reddito netto pro capite delle persone fisiche<br />
[2011]<br />
Carico fiscale delle persone Carico fiscale delle persone non coniugate con<br />
fisiche<br />
reddito lordo di 80‘000 CHF [2014]<br />
Potenziale di manodopera<br />
Popolazione residente proveniente dal proprio<br />
Comune e da quelli limitrofi<br />
Zone edificabili non edificate Quota delle zone edificabili non edificate<br />
Raggiungibilità con mezzi Tempo di viaggio verso gli agglomerati o<br />
pubblici o traffico<br />
singole città con mezzi pubblici o traffico<br />
motorizzato privato motorizzato privato<br />
Lavoratori nel turismo<br />
Quota dei lavoratori nel turismo sul totale degli<br />
occupati in % [2012]<br />
Lavoratori nel settore tempo Quota dei lavoratori nel settore tempo libero<br />
libero<br />
sul totale degli occupati in % [2012]<br />
A2<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Evoluzione delle aziende agricole<br />
Classi di dimensioni<br />
Aziende<br />
2000 2014 2015<br />
ha Numero Numero Numero<br />
0-1 3 609 2 261 2 247<br />
1-3 4 762 3 354 3 335<br />
3-5 5 393 2 793 2 717<br />
5-10 13 149 7 688 7 431<br />
10-15 13 812 8 642 8 339<br />
15-20 11 172 8 089 7 870<br />
20-25 7 244 6 381 6 294<br />
25-30 4 430 4 740 4 713<br />
30-40 4 168 5 278 5 322<br />
40-50 1 591 2 373 2 412<br />
50-70 921 1 731 1 794<br />
70-100 209 542 572<br />
> 100 77 174 186<br />
Totale 70 537 54 046 53 232<br />
Fonte: UST<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A3
Evoluzione del numero di lavoratori nell’agricoltura<br />
Categoria<br />
Lavoratori a tempo pieno Lavoratori a tempo parziale Totale<br />
2000 2014 2015 2000 2014 2015 2000 2014 2015<br />
Capiazienda Uomini 49 339 34 939 34 302 25 385 16 306 16 081 74 724 51 245 50 383<br />
Donne 524 1 115 1 083 1 822 1 686 1 766 2 346 2 801 2 849<br />
Altri membri della fam. Uomini 8 749 8 663 8 403 18 212 18 326 18 042 26 961 26 989 26 445<br />
Donne 14 281 7 830 7 536 47 665 37 193 36 381 61 946 45 023 43 917<br />
Manodopera familiare Totale 72 893 52 547 51 324 93 084 73 511 72 270 165 977 126 058 123 594<br />
Man. extrafam., svizzeri Uomini 10 836 7 970 7 782 5 125 3 818 3 640 15 961 11 788 11 422<br />
Donne 2 592 1 679 1 663 4 194 3 611 3 414 6 786 5 290 5 077<br />
Man. extrafam., stranieri Uomini 8 061 7 314 6 943 3 454 3 437 3 499 11 515 10 751 10 442<br />
Donne 1 613 2 064 1 939 1 941 2 811 2 710 3 554 4 875 4 649<br />
Manodopera extrafam. Totale 23 102 19 027 18 327 14 714 13 677 13 263 37 816 32 704 31 590<br />
Lavoratori Totale 95 995 71 574 69 651 107 798 87 188 85 533 203 793 158 762 155 184<br />
Fonte: UST<br />
A4<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Evoluzione della superficie agricola utile<br />
Classi di dimensioni<br />
Superficie agricola utile<br />
2000 2014 2015<br />
ha ha ha ha<br />
0-1 1 336 764 734<br />
1-3 8 861 6 118 6 084<br />
3-5 21 348 11 169 10 842<br />
5-10 99 056 58 048 56 040<br />
10-15 171 817 107 887 104 118<br />
15-20 193 856 140 829 137 157<br />
20-25 161 311 142 614 140 738<br />
25-30 121 005 129 926 129 105<br />
30-40 142 266 180 979 182 582<br />
40-50 70 501 105 329 107 077<br />
50-70 52 672 99 623 103 503<br />
70-100 17 021 43 627 46 032<br />
> 100 11 444 24 269 25 466<br />
Totale 1 072 492 1 051 183 1 049 478<br />
Fonte: UST<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A5
Evoluzione delle unità di bestiame grosso<br />
Classi di dimensioni<br />
Unità di bestiame grosso<br />
2000 2014 2015<br />
ha Numero Numero Numero<br />
0-1 61 016 52 414 55 000<br />
1-3 14 753 11 712 11 374<br />
3-5 27 714 14 480 13 925<br />
5-10 127 361 71 788 71 026<br />
10-15 230 628 143 384 140 350<br />
15-20 247 517 188 134 184 628<br />
20-25 191 057 183 141 182 271<br />
25-30 130 901 159 549 161 139<br />
30-40 142 628 208 966 215 048<br />
40-50 61 914 112 112 114 880<br />
50-70 42 707 100 384 105 724<br />
70-100 13 290 41 067 42 433<br />
> 100 8 025 20 742 22 607<br />
Totale 1 299 512 1 307 872 1 320 406<br />
Fonte: UST<br />
A6<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A7
A8<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Risultati d’esercizio in base ai redditi del lavoro: tutte le regioni 2015<br />
Caratteristica Unità 2015 I quartile<br />
0 – 25%<br />
II quartile<br />
25 – 50%<br />
III quartile<br />
50 – 75%<br />
IV quartile<br />
75 – 100%<br />
∆ in %<br />
2014/2015<br />
Numero di aziende (campione situazione reddituale) 2 198 533 465 576 624<br />
Aziende rappresentate 36 743 9 188 9 190 9 182 9 183<br />
Struttura aziendale<br />
Affitto industriale % 6.6 6.1 5.6 5.8 8.9 n.a.<br />
Manodopera ULA 1.9 1.7 1.8 2.0 2.1 0.4<br />
di cui manodopera familiare ULAF 1.4 1.4 1.5 1.4 1.3 -1.5<br />
Superficie agricola utile (SAU) ha 24.9 19.0 22.7 27.0 31.0 1.1<br />
di cui superficie coltiva aperta ha 6.3 3.62 4.18 6.34 11.12 0.9<br />
di cui superficie inerbita ha 17.7 14.72 17.87 19.8 18.37 1.2<br />
di cui colture perenni ha 0.5 0.31 0.22 0.46 1.03 -1.8<br />
Effettivo medio di animali totale (presente) UBG 32.8 24.3 30.3 33.5 42.9 0.3<br />
di cui della specie bovina UBG 25.1 19.4 24.9 26.7 29.4 0.2<br />
di cui piccoli ruminanti UBG 0.9 1.1 0.9 0.8 0.6 5.1<br />
di cui suini UBG 4.5 2.9 3.5 4.0 7.7 -1.1<br />
di cui pollame UBG 1.7 0.3 0.7 1.3 4.5 2.6<br />
Densità di animali UBG / ha SAU 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4 -0.8<br />
Bilancio di chiusura dell'azienda<br />
Attivi fr. 958 207 817 921 845 957 972 746 1 196 379 1.0<br />
Attivo circolante fr. 217 114 149 824 181 887 233 451 303 363 2.7<br />
Immobilizzazioni fr. 741 093 668 097 664 070 739 295 893 015 4.9<br />
Passivi fr. 958 207 817 921 845 957 972 746 1 196 379 1.0<br />
Capitale di terzi fr. 469 607 441 001 427 940 457 468 552 067 2.0<br />
Capitale proprio fr. 488 600 376 920 418 017 515 278 644 311 0.1<br />
di cui variazione del capitale proprio fr. 16 860 8 058 12 171 17 901 29 319 20.1<br />
Grado di liquidità 2 (quick ratio) % 506 414 513 522 540 11.5<br />
Grado d'indebitamento % 49 54 51 47 46 1.0<br />
Grado di copertura dell'impianto 2 (capitale di terzi a lungo % 115 111 113 117 119 -3.1<br />
Conto economico<br />
+ Ricavi d'esercizio agricolo fr. 294 028 183 336 227 530 299 606 465 762 - 3<br />
di cui ricavo produzione vegetale fr. 49 509 21 902 20 266 50 949 104 958 -6<br />
di cui ricavo detenzione di animali fr. 144 663 87 703 121 262 146 714 223 027 -5.8<br />
di cui ricavo da prodotti trasformati fr. 11 867 5 747 6 982 10 782 23 968 -4.2<br />
di cui altri ricavi (p.es. locazione di macchine) fr. 15 572 9 754 10 764 12 922 28 853 18<br />
di cui pagamenti diretti fr. 69 537 55 628 65 433 75 285 81 816 0.1<br />
- Spese per materiale, merci e servizi fr. 106 819 67 268 82 156 103 700 174 197 - 3<br />
di cui spese produzione vegetale fr. 17 974 9 237 9 640 18 628 34 402 -3.5<br />
di cui spese per detenzione e acquisti di animali fr. 71 568 47 560 59 683 68 552 110 499 -3.7<br />
= Contributo di copertura dell’azienda (risultato lordo 1) fr. 187 209 116 068 145 373 195 906 291 566 - 3<br />
- Spese per il personale fr. 33 264 18 188 19 216 34 413 61 261 0<br />
- Altre spese azied. (escl. ammortam. e ricavi finanz.) fr. 53 862 43 287 46 057 55 323 70 794 - 1<br />
di cui canoni d'affitto e onere dell’affittuario) fr. 11 131 6 948 8 976 11 087 17 517 1.9<br />
= EBITDA (risultato d'esercizio meno tassi d'int., tasse e ammortam.) fr. 100 083 54 594 80 100 106 170 159 511 - 5<br />
Utili e perdite (risultato d'impresa CoFi) fr. 59 206 20 848 45 693 65 759 104 560 2<br />
Rettificazioni di valore e ammortamenti totali fr. 37 550 29 646 31 248 37 288 52 030 - 9<br />
Interessi su debiti totali fr. 6 076 5 778 5 736 5 909 6 883 - 6<br />
Calcolo armonizzato del reddito agricolo e profitto del lavoro<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, CoFi fr. 57 565 18 015 45 075 63 490 103 715 - 1<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, al di fuori della CoFi fr. 627 143 353 954 1 057 - 94<br />
+ spese per il personale 1° e 2° pilastro: correzione per LE fr. 3 210 1 092 2 308 3 551 5 891<br />
= Reddito agricolo fr. 61 402 19 251 47 736 67 995 110 663 - 6<br />
Profitto del lavoro della manodopera familiare fr. 61 402 19 251 47 736 67 995 110 663 - 1<br />
Profitto del lavoro per manodopera familiare fr./ULA 44 570 13 874 32 344 48 575 88 723 1<br />
Utile calcolatorio/perdita calcolatoria fr. - 35 380 - 76 849 - 54 943 - 30 654 20 969 - 2<br />
Redditività del capitale proprio % - 7 - 20 - 13 - 6 3 8<br />
Famiglia ed economia domestica (escl. comunità aziendale (CA))<br />
Reddito dell’economia domestica/reddito totale fr. 88 342 60 908 72 235 89 157 132 315 -3<br />
Reddito agricolo (escl. CA) fr. 58 468 18 803 46 480 64 880 105 213 -5.8<br />
Reddito extraagricolo fr. 29 874 42 105 25 756 24 277 27 102 3.4<br />
Fonte: Agroscope ISS, Analisi centralizzata<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A9
Risultati d’esercizio in base ai redditi del lavoro: regione di pianura* 2014/15<br />
Media di<br />
Caratteristica Unità tutte le I quartile II quartile III quartile IV quartile ∆ in %<br />
aziende 0 – 25% 25 – 50% 50 – 75% 75 – 100% 2014/2015<br />
Numero di aziende (campione situazione reddituale) 975 241 240 245 249<br />
Aziende rappresentate 15 542 3 901 3 876 3 898 3 868<br />
Struttura aziendale<br />
Affitto industriale % 7.0 3.9 6.9 8.6 8.6 n.a.<br />
Manodopera ULA 2.2 2.1 2.2 2.3 2.3 1.4<br />
di cui manodopera familiare ULAF 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 -2.2<br />
Superficie agricola utile (SAU) ha 27.1 22.9 25.8 28.3 31.3 1.1<br />
di cui superficie coltiva aperta ha 12.3 9.64 10.59 13 15.885 2.097<br />
di cui superficie inerbita ha 13.5 12.171 14.23 14.03 13.392 0.42<br />
di cui colture perenni ha 1.1 0.836 0.74 1.02 1.643 -1.821<br />
Effettivo medio di animali totale (presente) UBG 35.8 29.7 33.2 36.9 43.6 -0.1<br />
di cui della specie bovina UBG 25.9 23.307 25.6 29.7 25.2 -0.2<br />
di cui piccoli ruminanti UBG 0.5 0.504 0.5 0.7 0.2 9.3<br />
di cui suini UBG 6.0 4.566 5.3 4.5 9.7 -1.4<br />
di cui pollame UBG 2.7 0.675 1.1 1.4 7.7 2.1<br />
Densità di animali UBG / ha SAU 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 -1.2<br />
Bilancio di chiusura dell'azienda<br />
Attivi fr. 1 138 466 1 004 375 1 094 395 1 119 514 1 336 967 0.9<br />
Attivo circolante fr. 264 525 195 805 221 866 302 557 338 254 2.0<br />
Immobilizzazioni fr. 873 942 808 570 872 529 816 957 998 713 4.2<br />
Passivi fr. 1 138 466 1 004 375 1 094 395 1 119 514 1 336 967 0.9<br />
Capitale di terzi fr. 550 679 575 769 532 576 489 227 605 443 2.6<br />
Capitale proprio fr. 587 787 428 606 561 819 630 287 731 524 -0.7<br />
di cui variazione del capitale proprio fr. 17 450 3 503 11 102 22 168 33 121 -28.6<br />
Grado di liquidità 2 (quick ratio) % 484 304 531 550 557 7.2<br />
Grado d'indebitamento % 48 57 49 44 45 1.8<br />
Grado di copertura dell'impianto 2 (capitale di terzi a lungo % 117 112 114 120 121 -2.7<br />
Conto economico<br />
+ Ricavi d'esercizio agricolo fr. 392 412 259 687 327 160 427 659 556 141 - 4<br />
di cui ricavo produzione vegetale fr. 102 278 55 887 73 420 109 341 170 869 -7.56<br />
di cui ricavo detenzione di animali fr. 181 192 123 289 159 407 200 041 242 427 -6.502<br />
di cui ricavo da prodotti trasformati fr. 22 236 12 909 14 515 29 168 32 395 -4.935<br />
di cui altri ricavi (p.es. locazione di macchine) fr. 20 301 13 093 15 857 19 160 33 173 25.803<br />
di cui pagamenti diretti fr. 63 475 52 207 60 535 66 483 74 754 -1.055<br />
- Spese per materiale, merci e servizi fr. 153 148 105 630 129 331 168 860 209 106 - 3<br />
di cui spese produzione vegetale fr. 35 045 22 955 27 061 38 259 52 002 -3.021<br />
di cui spese per detenzione e acquisti di animali fr. 91 383 62 674 79 976 97 860 125 241 -4.049<br />
= Contributo di copertura dell’azienda (risultato lordo 1) fr. 239 263 154 057 197 829 258 798 347 035 - 5<br />
- Spese per il personale fr. 52 392 32 718 37 477 57 251 82 283 - 1<br />
- Altre spese azied. (escl. ammortam. e ricavi finanz.) fr. 66 849 56 942 61 143 70 101 79 282 - 2<br />
di cui canoni d'affitto e onere dell’affittuario) fr. 15 556 11 336 12 553 18 407 19 950 1.42<br />
= EBITDA (risultato d'esercizio meno tassi d'int., tasse e ammortam.) fr. 120 022 64 396 99 208 131 446 185 470 - 8<br />
Utili e perdite (risultato d'impresa CoFi) fr. 71 049 24 219 54 950 83 491 121 876 - 1<br />
Rettificazioni di valore e ammortamenti totali fr. 43 623 30 829 38 571 46 403 58 789 - 11<br />
Interessi su debiti totali fr. 7 184 7 592 7 074 6 304 7 769 - 5<br />
Calcolo armonizzato del reddito agricolo e profitto del lavoro<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, CoFi fr. 69 851 22 904 54 007 81 867 120 969 - 3<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, al di fuori della CoFi fr. 890 480 671 1 259 1 149 - 87<br />
+ spese per il personale 1° e 2° pilastro: correzione per LE fr. 4 023 1 610 2 937 4 601 6 962<br />
= Reddito agricolo fr. 74 764 24 995 57 615 87 727 129 080 - 7<br />
Profitto del lavoro della manodopera familiare fr. 74 764 24 995 57 615 87 727 129 080 - 1<br />
Profitto del lavoro per manodopera familiare fr./ULA 54 680 17 688 40 293 62 305 106 035 1<br />
Utile calcolatorio/perdita calcolatoria fr. - 26 432 - 79 592 - 48 213 - 16 483 38 984 - 5<br />
Redditività del capitale proprio % - 4 - 19 - 9 - 3 5 12<br />
Famiglia ed economia domestica (escl. comunità aziendale (CA))<br />
Reddito dell’economia domestica/reddito totale fr. 100 892 64 834 82 616 107 244 149 902 -3<br />
Reddito agricolo (escl. CA) fr. 70 562 24 125 55 877 81 929 121 768 -6.3<br />
Reddito extraagricolo fr. 30 331 40 709 26 739 25 316 28 134 3.5<br />
Fonte: Agroscope ISS, Analisi centralizzata<br />
A10<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Risultati d’esercizio in base ai redditi del lavoro: regione collinare* 2015<br />
Media di<br />
Caratteristica Unità tutte le I quartile II quartile III quartile IV quartile ∆ in %<br />
aziende 0 – 25% 25 – 50% 50 – 75% 75 – 100% 2014/2015<br />
Numero di aziende (campione situazione reddituale) 657 164 151 154 188<br />
Aziende rappresentate 10 031 2 541 2 491 2 496 2 503<br />
Struttura aziendale<br />
Affitto industriale % 6.2 7.0 6.0 5.7 6.2 n.a.<br />
Manodopera ULA 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8 -2.5<br />
di cui manodopera familiare ULAF 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 -3.4<br />
Superficie agricola utile (SAU) ha 23.0 18.1 20.7 23.2 30.1 1.8<br />
di cui superficie coltiva aperta ha 3.9 2.78 3.16 4.14 5.47 -0.4<br />
di cui superficie inerbita ha 18.6 14.92 17.15 18.55 23.94 2.3<br />
di cui colture perenni ha 0.1 0.13 0.11 0.09 0.19 -2.7<br />
Effettivo medio di animali totale (presente) UBG 35.6 28.3 31.5 36.6 46.2 0.9<br />
di cui della specie bovina UBG 26.9 21 24.6 27.9 34.1 0.8<br />
di cui piccoli ruminanti UBG 1.0 1.4 1.2 0.7 0.7 6.5<br />
di cui suini UBG 5.8 4.8 4.0 6.4 7.9 0.0<br />
di cui pollame UBG 1.5 0.7 1.2 1.1 3.2 6.6<br />
Densità di animali UBG / ha SAU 1.6 1.6 1.5 1.6 1.5 -0.9<br />
Bilancio di chiusura dell'azienda<br />
Attivi fr. 900 217 848 748 798 509 898 139 1 055 735 2.7<br />
Attivo circolante fr. 205 276 159 622 179 359 217 715 264 999 3.4<br />
Immobilizzazioni fr. 694 941 689 126 619 150 680 424 790 735 5.9<br />
Passivi fr. 900 217 848 748 798 509 898 139 1 055 735 2.7<br />
Capitale di terzi fr. 462 888 472 261 391 901 466 704 520 199 3.6<br />
Capitale proprio fr. 437 329 376 487 406 608 431 435 535 536 1.8<br />
di cui variazione del capitale proprio fr. 17 044 8 356 13 723 24 371 21 859 58.5<br />
Grado di liquidità 2 (quick ratio) % 553 669 443 511 631 19.4<br />
Grado d'indebitamento % 51 56 49 52 49 0.9<br />
Grado di copertura dell'impianto 2 (capitale di terzi a lungo termine) % 115 112 113 116 117 -2.2<br />
Conto economico<br />
+ Ricavi d'esercizio agricolo fr. 251 769 186 221 215 367 253 303 352 997 - 2<br />
di cui ricavo produzione vegetale fr. 16 334 13 253 10 801 14 347 26 949 2.1<br />
di cui ricavo detenzione di animali fr. 151 717 108 454 126 358 156 574 216 022 -4.4<br />
di cui ricavo da prodotti trasformati fr. 4 819 1 865 7 882 3 084 6 501 -5.2<br />
di cui altri ricavi (p.es. locazione di macchine) fr. 11 011 7 741 9 980 9 771 16 593 27.9<br />
di cui pagamenti diretti fr. 65 179 52 414 57 774 66 960 83 727 -0.6<br />
- Spese per materiale, merci e servizi fr. 92 532 75 587 80 598 92 037 122 103 - 1<br />
di cui spese produzione vegetale fr. 8 841 6 618 7 179 8 616 12 973 1.4<br />
di cui spese per detenzione e acquisti di animali fr. 72 439 60 661 60 599 73 195 95 420 -1<br />
= Contributo di copertura dell’azienda (risultato lordo 1) fr. 159 237 110 634 134 769 161 266 230 894 - 3<br />
- Spese per il personale fr. 21 621 14 862 15 712 22 529 33 454 2<br />
- Altre spese azied. (escl. ammortam. e ricavi finanz.) fr. 47 890 42 304 43 614 44 607 61 089 - 1<br />
di cui canoni d'affitto e onere dell’affittuario) fr. 9 200 6 626 8 173 8 313 13 721 -0.2<br />
= EBITDA (risultato d'esercizio meno tassi d'int., tasse e ammortam.) fr. 89 726 53 468 75 443 94 130 136 351 - 4<br />
Utili e perdite (risultato d'impresa CoFi) fr. 52 647 18 169 42 145 60 568 90 196 3<br />
Rettificazioni di valore e ammortamenti totali fr. 35 006 31 421 30 858 33 014 44 760 - 12<br />
Interessi su debiti totali fr. 5 899 6 269 5 009 5 633 6 675 - 5<br />
Calcolo armonizzato del reddito agricolo e profitto del lavoro<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, CoFi fr. 50 233 14 460 41 264 56 659 89 060 0<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, al di fuori della CoFi fr. 631 208 210 725 1 385 - 96<br />
+ spese per il personale 1° e 2° pilastro: correzione per LE fr. 2 782 883 2 141 3 142 4 988<br />
= Reddito agricolo fr. 53 645 15 552 43 614 60 526 95 432 - 9<br />
Profitto del lavoro della manodopera familiare fr. 53 645 15 552 43 614 60 526 95 432 - 4<br />
Profitto del lavoro per manodopera familiare fr./ULA 39 675 11 944 30 215 43 665 74 669 0<br />
Utile calcolatorio/perdita calcolatoria fr. - 39 697 - 74 337 - 56 035 - 35 165 7 201 - 5<br />
Redditività del capitale proprio % - 9 - 20 - 14 - 8 1 1<br />
Famiglia ed economia domestica (escl. comunità aziendale (CA))<br />
Reddito dell’economia domestica/reddito totale fr. 84 672 65 102 72 936 86 898 115 113 -1<br />
Reddito agricolo (escl. CA) fr. 51 627 15 071 42 856 59 483 91 281 -8.2<br />
Reddito extraagricolo fr. 33 045 50 031 30 080 27 415 23 832 13.0<br />
Fonte: Agroscope ISS, Analisi centralizzata<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A11
Risultati d’esercizio in base ai redditi del lavoro: regione di montagna* 2015<br />
Media di<br />
Caratteristica Unità tutte le I quartile II quartile III quartile IV quartile ∆ in %<br />
aziende 0 – 25% 25 – 50% 50 – 75% 75 – 100% 2014/2015<br />
Numero di aziende (campione situazione reddituale) 566 137 114 134 181<br />
Aziende rappresentate 11 170 2 816 2 787 2 777 2 791<br />
Struttura aziendale<br />
Affitto industriale % 6.5 8.2 2.4 6.7 8.6 n.a.<br />
Manodopera ULA 1.7 1.6 1.8 1.7 1.7 1.7<br />
di cui manodopera familiare ULAF 1.4 1.4 1.5 1.5 1.2 0.8<br />
Superficie agricola utile (SAU) ha 23.6 17.3 20.6 23.9 32.8 0.4<br />
di cui superficie coltiva aperta ha 0.2 0.07 0.1 0.24 0.41 -2.4<br />
di cui superficie inerbita ha 22.7 16.79 19.92 22.92 31.35 0.5<br />
di cui colture perenni ha 0.1 0.01 0 0.01 0.25 5.5<br />
Effettivo medio di animali totale (presente) UBG 25.9 19.0 23.4 27.3 34.1 0.4<br />
di cui della specie bovina UBG 22.4 17 20.7 24.1 27.9 0.2<br />
di cui piccoli ruminanti UBG 1.2 1.1 0.9 1.3 1.6 1.4<br />
di cui suini UBG 1.4 0.5 1.3 1.3 2.4 0.4<br />
di cui pollame UBG 0.5 0.1 0.2 0.2 1.4 8.5<br />
Densità di animali UBG / ha SAU 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 0.0<br />
Bilancio di chiusura dell'azienda<br />
Attivi fr. 759 470 670 677 636 469 804 491 927 085 -0.1<br />
Attivo circolante fr. 161 777 112 114 136 044 176 446 222 984 4.2<br />
Immobilizzazioni fr. 597 693 558 563 500 425 628 045 704 101 5.7<br />
Passivi fr. 759 470 670 677 636 469 804 491 927 085 -0.1<br />
Capitale di terzi fr. 362 838 324 908 325 123 373 092 428 564 -0.9<br />
Capitale proprio fr. 396 632 345 769 311 346 431 399 498 521 0.6<br />
di cui variazione del capitale proprio fr. 15 875 13 591 8 674 16 310 24 936 149.5<br />
Grado di liquidità 2 (quick ratio) % 514 597 451 615 464 11.8<br />
Grado d'indebitamento % 48 48 51 46 46 -0.8<br />
Grado di copertura dell'impianto 2 (capitale di terzi a lungo % 113 110 112 114 115 -5.0<br />
Conto economico<br />
+ Ricavi d'esercizio agricolo fr. 195 087 132 054 161 063 197 821 289 936 - 1<br />
di cui ricavo produzione vegetale fr. 5 876 4 393 3 132 3 098 12 878 8.4<br />
di cui ricavo detenzione di animali fr. 87 502 56 672 71 937 96 242 125 454 -5.2<br />
di cui ricavo da prodotti trasformati fr. 3 770 2 948 2 247 2 621 7 264 2.9<br />
di cui altri ricavi (p.es. locazione di macchine) fr. 13 087 5 260 8 245 10 676 28 219 -4<br />
di cui pagamenti diretti fr. 81 886 59 821 72 332 81 776 113 800 1.4<br />
- Spese per materiale, merci e servizi fr. 55 188 39 040 42 180 56 541 83 122 - 5<br />
di cui spese produzione vegetale fr. 2 422 1 749 1 534 1 983 4 423 -11.9<br />
di cui spese per detenzione e acquisti di animali fr. 43 214 31 639 36 306 45 923 59 095 -6.2<br />
= Contributo di copertura dell’azienda (risultato lordo 1) fr. 139 900 93 015 118 882 141 280 206 814 0<br />
- Spese per il personale fr. 17 106 9 506 12 624 14 387 31 956 2<br />
- Altre spese azied. (escl. ammortam. e ricavi finanz.) fr. 41 154 32 351 39 016 40 442 52 881 1<br />
di cui canoni d'affitto e onere dell’affittuario) fr. 6 708 4 305 5 667 6 588 10 289 7.3<br />
= EBITDA (risultato d'esercizio meno tassi d'int., tasse e ammortam.) fr. 81 639 51 159 67 243 86 451 121 977 0<br />
Utili e perdite (risultato d'impresa CoFi) fr. 48 618 19 902 41 662 53 778 79 400 7<br />
Rettificazioni di valore e ammortamenti totali fr. 31 385 28 658 25 413 32 267 39 222 - 2<br />
Interessi su debiti totali fr. 4 694 4 364 4 728 4 191 5 495 - 7<br />
Calcolo armonizzato del reddito agricolo e profitto del lavoro<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, CoFi fr. 47 055 16 974 40 054 52 869 78 610 5<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, al di fuori della CoFi fr. 257 80 0 491 460 - 100<br />
+ spese per il personale 1° e 2° pilastro: correzione per LE fr. 2 462 896 1 888 2 651 4 429<br />
= Reddito agricolo fr. 49 775 17 950 41 942 56 011 83 499 - 1<br />
Profitto del lavoro della manodopera familiare fr. 49 775 17 950 41 942 56 011 83 499 5<br />
Profitto del lavoro per manodopera familiare fr./ULA 35 177 12 850 27 258 37 797 67 170 4<br />
Utile calcolatorio/perdita calcolatoria fr. - 43 953 - 74 578 - 59 982 - 42 149 1 156 3<br />
Redditività del capitale proprio % - 11 - 22 - 19 - 10 0 9<br />
Famiglia ed economia domestica (escl. comunità aziendale (CA))<br />
Reddito dell’economia domestica/reddito totale fr. 74 377 53 927 66 432 75 707 102 058 -3<br />
Reddito agricolo (escl. CA) fr. 47 980 17 626 40 307 53 863 80 963 -2.4<br />
Reddito extraagricolo fr. 26 397 36 301 26 125 21 844 21 094 -5.3<br />
Fonte: Agroscope ISS, Analisi centralizzata<br />
A12<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Risultati d’esercizio in base ai redditi del lavoro: campicoltura 2015<br />
Caratteristica Unità 2015 I quartile<br />
0 – 25%<br />
IV quartile<br />
75–100%<br />
∆ in %<br />
2014/2015<br />
Numero di aziende (campione situazione reddituale) 102 26 26<br />
Aziende rappresentate 1 781 460 423<br />
Struttura aziendale<br />
Affitto industriale % 4.4 5.8 0.0 n.a.<br />
Manodopera ULA 1.4 1.5 1.3 -2.7<br />
di cui manodopera familiare ULAF 1.1 1.1 1.0 -2.6<br />
Superficie agricola utile (SAU) ha 34.0 27.6 39.3 0.6<br />
di cui superficie coltiva aperta ha 27.6 21.899 33.451 0.123<br />
di cui superficie inerbita ha 5.9 5.272 5.138 2.67<br />
di cui colture perenni ha 0.3 0.254 0.444 1.746<br />
Effettivo medio di animali totale (presente) UBG 9.6 7.6 9.9 -3.2<br />
di cui della specie bovina UBG 6.9 4.324 7.6 -5.5<br />
di cui piccoli ruminanti UBG 0.5 0.166 0.0 104.1<br />
di cui suini UBG 0.6 2.419 0.0 -100.0<br />
di cui pollame UBG 1.3 0.509 2.1 -0.9<br />
Densità di animali UBG / ha SAU 0.3 0.3 0.3 -3.7<br />
Bilancio di chiusura dell'azienda<br />
Attivi fr. 938 739 962 752 963 777 0.9<br />
Attivo circolante fr. 206 753 140 347 252 630 0.1<br />
Immobilizzazioni fr. 731 987 822 405 711 146 6.3<br />
Passivi fr. 938 739 962 752 963 777 0.9<br />
Capitale di terzi fr. 332 389 472 931 281 585 6.4<br />
Capitale proprio fr. 606 350 489 821 682 191 -2.2<br />
di cui variazione del capitale proprio fr. 14 654 - 8 168 19 341 -23.9<br />
Grado di liquidità 2 (quick ratio) % 735 274 1 144 28.2<br />
Grado d'indebitamento % 35 49 29 5.5<br />
Grado di copertura dell'impianto 2 (capitale di terzi a lungo termine) % 122 111 128 -3.8<br />
Conto economico<br />
+ Ricavi d'esercizio agricolo fr. 272 138 208 215 343 468 - 6<br />
di cui ricavo produzione vegetale fr. 110 009 81 747 132 866 -14.111<br />
di cui ricavo detenzione di animali fr. 59 613 34 297 79 962 1.19<br />
di cui ricavo da prodotti trasformati fr. 1 248 3 554 242 -83.976<br />
di cui altri ricavi (p.es. locazione di macchine) fr. 24 397 22 722 44 650 12.305<br />
di cui pagamenti diretti fr. 74 667 62 036 84 880 -0.085<br />
- Spese per materiale, merci e servizi fr. 92 865 71 929 108 399 - 5<br />
di cui spese produzione vegetale fr. 41 494 36 485 46 184 -13.092<br />
di cui spese per detenzione e acquisti di animali fr. 34 292 24 375 41 545 -0.685<br />
= Contributo di copertura dell’azienda (risultato lordo 1) fr. 179 273 136 286 235 069 - 6<br />
- Spese per il personale fr. 22 625 16 168 32 111 - 2<br />
- Altre spese azied. (escl. ammortam. e ricavi finanz.) fr. 60 766 65 327 67 414 1<br />
di cui canoni d'affitto e onere dell’affittuario) fr. 15 344 11 372 19 474 5.258<br />
= EBITDA (risultato d'esercizio meno tassi d'int., tasse e ammortam.) fr. 95 882 54 792 135 544 - 10<br />
Utili e perdite (risultato d'impresa CoFi) fr. 62 786 20 337 98 921 - 6<br />
Rettificazioni di valore e ammortamenti totali fr. 29 142 25 196 41 583 - 2<br />
Interessi su debiti totali fr. 4 431 6 726 3 852 - 4<br />
Calcolo armonizzato del reddito agricolo e profitto del lavoro<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, CoFi fr. 61 796 18 375 98 380 - 9<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, al di fuori della CoFi fr. 1 789 251 5 331 - 72<br />
+ spese per il personale 1° e 2° pilastro: correzione per LE fr. 3 663 1 800 5 534<br />
= Reddito agricolo fr. 67 248 20 426 109 245 - 12<br />
Profitto del lavoro della manodopera familiare fr. 67 248 20 426 109 245 - 8<br />
Profitto del lavoro per manodopera familiare fr./ULA 58 942 17 951 112 215 - 5<br />
Utile calcolatorio/perdita calcolatoria fr. - 17 086 - 63 618 37 210 55<br />
Redditività del capitale proprio % - 3 - 13 5 407<br />
Famiglia ed economia domestica (escl. comunità aziendale (CA))<br />
Reddito dell’economia domestica/reddito totale fr. 102 884 64 965 142 090 -8<br />
Reddito agricolo (escl. CA) fr. 64 880 19 278 109 245 -12.1<br />
Reddito extraagricolo fr. 38 004 45 687 32 845 2.0<br />
Fonte: Agroscope ISS, Analisi centralizzata<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A13
Risultati d’esercizio in base ai redditi del lavoro: colture speciali 2015<br />
Caratteristica Unità 2015 I quartile<br />
0 – 25%<br />
IV quartile<br />
75–100%<br />
∆ in %<br />
2014/2015<br />
Numero di aziende (campione situazione reddituale) 241 71 56<br />
Aziende rappresentate 3 066 774 764<br />
Struttura aziendale<br />
Affitto industriale % 11.0 7.4 13.5 n.a.<br />
Manodopera ULA 3.4 2.5 3.8 13.5<br />
di cui manodopera familiare ULAF 1.4 1.4 1.2 -1.0<br />
Superficie agricola utile (SAU) ha 17.0 13.4 22.3 0.4<br />
di cui superficie coltiva aperta ha 9.0 7.16 11.985 1.379<br />
di cui superficie inerbita ha 3.2 2.667 3.609 -2.313<br />
di cui colture perenni ha 4.6 3.4 6.318 0.266<br />
Effettivo medio di animali totale (presente) UBG 2.3 1.3 2.0 -3.4<br />
di cui della specie bovina UBG 1.6 0.779 1.4 -4.6<br />
di cui piccoli ruminanti UBG 0.2 0.188 0.1 -16.5<br />
di cui suini UBG 0.0 0.018 0.0 -32.3<br />
di cui pollame UBG 0.1 0.141 0.2 2.7<br />
Densità di animali UBG / ha SAU 0.1 0.1 0.1 -3.8<br />
Bilancio di chiusura dell'azienda<br />
Attivi fr. 998 547 803 701 1 184 196 -2.3<br />
Attivo circolante fr. 252 805 177 568 333 437 4.9<br />
Immobilizzazioni fr. 745 742 626 133 850 759 1.4<br />
Passivi fr. 998 547 803 701 1 184 196 -2.3<br />
Capitale di terzi fr. 484 312 454 245 543 867 -2.6<br />
Capitale proprio fr. 514 235 349 456 640 329 -1.9<br />
di cui variazione del capitale proprio fr. 14 214 - 7 238 21 765 -14.8<br />
Grado di liquidità 2 (quick ratio) % 423 272 471 15.5<br />
Grado d'indebitamento % 49 57 46 -0.4<br />
Grado di copertura dell'impianto 2 (capitale di terzi a lungo termine) % 127 120 131 -3.4<br />
Conto economico<br />
+ Ricavi d'esercizio agricolo fr. 490 950 245 902 745 559 1<br />
di cui ricavo produzione vegetale fr. 307 364 126 277 520 247 -1.04<br />
di cui ricavo detenzione di animali fr. 9 680 6 313 6 222 7.315<br />
di cui ricavo da prodotti trasformati fr. 102 224 57 788 116 687 -3.043<br />
di cui altri ricavi (p.es. locazione di macchine) fr. 32 807 24 571 50 792 47.581<br />
di cui pagamenti diretti fr. 37 170 28 756 50 043 3.753<br />
- Spese per materiale, merci e servizi fr. 145 190 69 819 202 006 4<br />
di cui spese produzione vegetale fr. 80 379 35 098 132 956 1.1<br />
di cui spese per detenzione e acquisti di animali fr. 5 200 3 098 2 884 22.213<br />
= Contributo di copertura dell’azienda (risultato lordo 1) fr. 345 760 176 083 543 554 0<br />
- Spese per il personale fr. 132 253 63 487 208 097 2<br />
- Altre spese azied. (escl. ammortam. e ricavi finanz.) fr. 82 178 60 150 111 118 0<br />
di cui canoni d'affitto e onere dell’affittuario) fr. 18 901 11 824 28 051 8.568<br />
= EBITDA (risultato d'esercizio meno tassi d'int., tasse e ammortam.) fr. 131 329 52 445 224 339 - 1<br />
Utili e perdite (risultato d'impresa CoFi) fr. 82 426 20 841 148 546 9<br />
Rettificazioni di valore e ammortamenti totali fr. 44 349 28 768 67 261 - 15<br />
Interessi su debiti totali fr. 7 026 7 460 7 732 - 4<br />
Calcolo armonizzato del reddito agricolo e profitto del lavoro<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, CoFi fr. 82 108 20 686 148 168 9<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, al di fuori della CoFi fr. 987 - 63 497 - 98<br />
+ spese per il personale 1° e 2° pilastro: correzione per LE fr. 5 291 1 831 9 382<br />
= Reddito agricolo fr. 88 386 22 455 158 046 0<br />
Profitto del lavoro della manodopera familiare fr. 88 386 22 455 158 046 5<br />
Profitto del lavoro per manodopera familiare fr./ULA 63 724 16 516 130 338 6<br />
Utile calcolatorio/perdita calcolatoria fr. - 13 679 - 77 314 68 788 - 24<br />
Redditività del capitale proprio % - 3 - 22 11 - 7<br />
Famiglia ed economia domestica (escl. comunità aziendale (CA))<br />
Reddito dell’economia domestica/reddito totale fr. 107 940 61 728 170 299 1<br />
Reddito agricolo (escl. CA) fr. 79 021 22 980 136 124 0.1<br />
Reddito extraagricolo fr. 28 919 38 748 34 175 4.3<br />
Fonte: Agroscope ISS, Analisi centralizzata<br />
A14<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Risultati d’esercizio in base ai redditi del lavoro: vacche da latte 2015<br />
Caratteristica Unità 2015 I quartile<br />
0 – 25%<br />
IV quartile<br />
75 – 100%<br />
∆ in %<br />
2014/2015<br />
Numero di aziende (campione situazione reddituale) 433 106 130<br />
Aziende rappresentate 11 739 2 964 2 924<br />
Struttura aziendale<br />
Affitto industriale % 6.3 5.6 8.3 n.a.<br />
Manodopera ULA 1.7 1.7 1.7 -0.5<br />
di cui manodopera familiare ULAF 1.4 1.5 1.3 -0.9<br />
Superficie agricola utile (SAU) ha 22.9 17.7 31.0 1.2<br />
di cui superficie coltiva aperta ha 1.1 0.522 1.809 0.829<br />
di cui superficie inerbita ha 21.1 16.772 28.274 1.213<br />
di cui colture perenni ha 0.0 0.047 0.05 8.333<br />
Effettivo medio di animali totale (presente) UBG 29.6 23.0 37.9 0.2<br />
di cui della specie bovina UBG 28.2 21.831 36.3 0.2<br />
di cui piccoli ruminanti UBG 0.4 0.417 0.4 4.6<br />
di cui suini UBG 0.7 0.363 0.8 -1.2<br />
di cui pollame UBG 0.1 0.04 0.2 5.4<br />
Densità di animali UBG / ha SAU 1.3 1.3 1.2 -1.0<br />
Bilancio di chiusura dell'azienda<br />
Attivi fr. 832 625 739 092 998 401 4.2<br />
Attivo circolante fr. 183 776 129 953 257 060 4.2<br />
Immobilizzazioni fr. 648 849 609 140 741 342 9.2<br />
Passivi fr. 832 625 739 092 998 401 4.2<br />
Capitale di terzi fr. 397 573 377 673 438 761 8.0<br />
Capitale proprio fr. 435 052 361 419 559 640 1.1<br />
di cui variazione del capitale proprio fr. 14 108 5 795 20 482 41.2<br />
Grado di liquidità 2 (quick ratio) % 600 460 659 -1.7<br />
Grado d'indebitamento % 48 51 44 3.6<br />
Grado di copertura dell'impianto 2 (capitale di terzi a lungo termine) % 114 109 118 -3.9<br />
Conto economico<br />
+ Ricavi d'esercizio agricolo fr. 206 729 144 618 284 383 - 3<br />
di cui ricavo produzione vegetale fr. 6 423 4 051 9 893 8.249<br />
di cui ricavo detenzione di animali fr. 119 361 76 942 167 996 -6.311<br />
di cui ricavo da prodotti trasformati fr. 1 503 2 447 1 160 -25.852<br />
di cui altri ricavi (p.es. locazione di macchine) fr. 8 406 3 208 13 994 7.334<br />
di cui pagamenti diretti fr. 68 223 55 707 89 173 -0.139<br />
- Spese per materiale, merci e servizi fr. 60 119 45 556 72 193 - 5<br />
di cui spese produzione vegetale fr. 4 478 2 780 6 624 -1.234<br />
di cui spese per detenzione e acquisti di animali fr. 48 877 37 542 58 725 -3.713<br />
= Contributo di copertura dell’azienda (risultato lordo 1) fr. 146 610 99 062 212 189 - 3<br />
- Spese per il personale fr. 17 902 13 692 27 047 3<br />
- Altre spese azied. (escl. ammortam. e ricavi finanz.) fr. 44 054 36 824 55 619 - 1<br />
di cui canoni d'affitto e onere dell’affittuario) fr. 9 119 5 759 14 449 -2.696<br />
= EBITDA (risultato d'esercizio meno tassi d'int., tasse e ammortam.) fr. 84 654 48 546 129 524 - 5<br />
Utili e perdite (risultato d'impresa CoFi) fr. 51 577 23 027 88 556 - 2<br />
Rettificazioni di valore e ammortamenti totali fr. 31 266 24 474 41 270 - 8<br />
Interessi su debiti totali fr. 4 804 4 773 5 060 - 4<br />
Calcolo armonizzato del reddito agricolo e profitto del lavoro<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, CoFi fr. 50 109 19 694 86 855 - 4<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, al di fuori della CoFi fr. 133 10 0 - 99<br />
+ spese per il personale 1° e 2° pilastro: correzione per LE fr. 2 636 926 4 771<br />
= Reddito agricolo fr. 52 878 20 630 91 627 - 8<br />
Profitto del lavoro della manodopera familiare fr. 52 878 20 630 91 627 - 2<br />
Profitto del lavoro per manodopera familiare fr./ULA 37 600 14 228 69 968 - 2<br />
Utile calcolatorio/perdita calcolatoria fr. - 43 599 - 77 916 749 3<br />
Redditività del capitale proprio % - 10 - 22 0 10<br />
Famiglia ed economia domestica (escl. comunità aziendale (CA))<br />
Reddito dell’economia domestica/reddito totale fr. 79 406 58 882 114 175 -2<br />
Reddito agricolo (escl. CA) fr. 51 038 19 492 87 935 -8.1<br />
Reddito extraagricolo fr. 28 368 39 390 26 240 11.3<br />
Fonte: Agroscope ISS, Analisi centralizzata<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A15
Risultati d’esercizio in base ai redditi del lavoro: vacche madri 2015<br />
Caratteristica Unità 2015 I quartile<br />
0 – 25%<br />
IV quartile<br />
75 – 100%<br />
∆ in %<br />
2014/2015<br />
Numero di aziende (campione situazione reddituale) 132 24 43<br />
Aziende rappresentate 1 771 443 422<br />
Struttura aziendale<br />
Affitto industriale % 10.4 8.9 16.1 n.a.<br />
Manodopera ULA 1.8 1.5 1.5 -2.3<br />
di cui manodopera familiare ULAF 1.3 1.4 1.2 1.1<br />
Superficie agricola utile (SAU) ha 28.8 21.8 36.9 2.7<br />
di cui superficie coltiva aperta ha 1.8 0.946 2.839 -6.986<br />
di cui superficie inerbita ha 26.4 20.278 32.944 3.219<br />
di cui colture perenni ha 0.1 0.05 0.167 -3.398<br />
Effettivo medio di animali totale (presente) UBG 33.5 27.6 40.6 -1.0<br />
di cui della specie bovina UBG 31.9 26.836 38.4 -1.1<br />
di cui piccoli ruminanti UBG 0.6 0.239 1.0 10.0<br />
di cui suini UBG 0.3 0.273 0.1 0.3<br />
di cui pollame UBG 0.1 0.062 0.1 45.7<br />
Densità di animali UBG / ha SAU 1.2 1.3 1.1 -3.6<br />
Bilancio di chiusura dell'azienda<br />
Attivi fr. 898 987 1 036 877 843 794 5.4<br />
Attivo circolante fr. 192 877 186 643 210 763 3.3<br />
Immobilizzazioni fr. 706 110 850 235 633 031 7.1<br />
Passivi fr. 898 987 1 036 877 843 794 5.4<br />
Capitale di terzi fr. 467 122 593 225 420 791 3.8<br />
Capitale proprio fr. 431 865 443 652 423 003 6.8<br />
di cui variazione del capitale proprio fr. 27 325 50 459 27 376 310.7<br />
Grado di liquidità 2 (quick ratio) % 476 579 483 45.0<br />
Grado d'indebitamento % 52 57 50 -1.5<br />
Grado di copertura dell'impianto 2 (capitale di terzi a lungo termine) % 112 111 113 -0.1<br />
Conto economico<br />
+ Ricavi d'esercizio agricolo fr. 201 023 154 706 249 042 3<br />
di cui ricavo produzione vegetale fr. 12 003 9 259 17 334 1.606<br />
di cui ricavo detenzione di animali fr. 71 101 56 664 77 122 4.516<br />
di cui ricavo da prodotti trasformati fr. 5 394 2 601 5 947 -0.023<br />
di cui altri ricavi (p.es. locazione di macchine) fr. 13 481 10 597 19 291 10.006<br />
di cui pagamenti diretti fr. 96 709 73 002 126 281 0.688<br />
- Spese per materiale, merci e servizi fr. 49 265 44 329 51 872 - 3<br />
di cui spese produzione vegetale fr. 6 995 4 166 8 061 10.656<br />
di cui spese per detenzione e acquisti di animali fr. 29 270 29 666 25 855 -1.077<br />
= Contributo di copertura dell’azienda (risultato lordo 1) fr. 151 758 110 377 197 169 5<br />
- Spese per il personale fr. 16 542 8 266 22 619 0<br />
- Altre spese azied. (escl. ammortam. e ricavi finanz.) fr. 45 381 36 275 52 333 5<br />
di cui canoni d'affitto e onere dell’affittuario) fr. 8 162 3 997 12 207 15.137<br />
= EBITDA (risultato d'esercizio meno tassi d'int., tasse e ammortam.) fr. 89 835 65 836 122 217 6<br />
Utili e perdite (risultato d'impresa CoFi) fr. 47 546 16 704 78 094 10<br />
Rettificazioni di valore e ammortamenti totali fr. 38 769 36 612 46 078 15<br />
Interessi su debiti totali fr. 6 089 6 906 5 305 - 6<br />
Calcolo armonizzato del reddito agricolo e profitto del lavoro<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, CoFi fr. 45 045 14 221 75 917 5<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, al di fuori della CoFi fr. 1 990 0 924 - 100<br />
+ spese per il personale 1° e 2° pilastro: correzione per LE fr. 2 414 1 447 3 678<br />
= Reddito agricolo fr. 49 448 15 668 80 519 - 1<br />
Profitto del lavoro della manodopera familiare fr. 49 448 15 668 80 519 6<br />
Profitto del lavoro per manodopera familiare fr./ULA 36 794 11 387 69 279 5<br />
Utile calcolatorio/perdita calcolatoria fr. -42 401 -77 714 7 - 1<br />
Redditività del capitale proprio % - 10 - 18 0 0<br />
Famiglia ed economia domestica (escl. comunità aziendale (CA))<br />
Reddito dell’economia domestica/reddito totale fr. 81 842 67 859 99 744 -2<br />
Reddito agricolo (escl. CA) fr. 48 906 15 668 80 126 -1.4<br />
Reddito extraagricolo fr. 32 936 52 190 19 618 -2.4<br />
Fonte: Agroscope ISS, Analisi centralizzata<br />
A16<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Risultati d’esercizio in base ai redditi del lavoro: bovini misti 2015<br />
Caratteristica Unità 2015 I quartile<br />
0 – 25%<br />
IV quartile<br />
75 – 100%<br />
∆ in %<br />
2014/2015<br />
Numero di aziende (campione situazione reddituale) 230 56 67<br />
Aziende rappresentate 4 047 1 022 1 003<br />
Struttura aziendale<br />
Affitto industriale % 7.6 12.0 7.5 n.a.<br />
Manodopera ULA 1.7 1.5 1.7 -1.4<br />
di cui manodopera familiare ULAF 1.4 1.3 1.3 -1.1<br />
Superficie agricola utile (SAU) ha 25.3 17.4 36.9 0.8<br />
di cui superficie coltiva aperta ha 0.8 0.424 1.423 -13.782<br />
di cui superficie inerbita ha 23.9 16.415 34.8 1.231<br />
di cui colture perenni ha 0.0 0.038 0.007 3.723<br />
Effettivo medio di animali totale (presente) UBG 26.7 18.9 37.1 2.6<br />
di cui della specie bovina UBG 25.7 18.18 35.6 2.7<br />
di cui piccoli ruminanti UBG 0.4 0.317 0.3 -5.7<br />
di cui suini UBG 0.2 0.223 0.4 -4.1<br />
di cui pollame UBG 0.1 0.032 0.1 -4.6<br />
Densità di animali UBG / ha SAU 1.1 1.1 1.0 1.7<br />
Bilancio di chiusura dell'azienda<br />
Attivi fr. 784 413 737 811 1 030 707 -6.9<br />
Attivo circolante fr. 162 714 119 047 220 208 9.6<br />
Immobilizzazioni fr. 621 699 618 764 810 499 -3.8<br />
Passivi fr. 784 413 737 811 1 030 707 -6.9<br />
Capitale di terzi fr. 396 967 370 135 547 024 -10.3<br />
Capitale proprio fr. 387 447 367 677 483 683 -4.0<br />
di cui variazione del capitale proprio fr. 18 095 20 763 23 581 203.0<br />
Grado di liquidità 2 (quick ratio) % 381 511 249 21.2<br />
Grado d'indebitamento % 51 50 53 -3.6<br />
Grado di copertura dell'impianto 2 (capitale di terzi a lungo termine) % 111 109 110 -4.0<br />
Conto economico<br />
+ Ricavi d'esercizio agricolo fr. 206 222 130 522 328 481 0<br />
di cui ricavo produzione vegetale fr. 4 520 3 129 5 822 1.486<br />
di cui ricavo detenzione di animali fr. 90 454 59 507 142 360 -2.136<br />
di cui ricavo da prodotti trasformati fr. 3 768 1 476 4 325 15.256<br />
di cui altri ricavi (p.es. locazione di macchine) fr. 19 587 5 966 50 587 -2.644<br />
di cui pagamenti diretti fr. 84 698 57 937 121 364 2.795<br />
- Spese per materiale, merci e servizi fr. 63 100 39 988 110 829 - 5<br />
di cui spese produzione vegetale fr. 3 565 2 021 5 770 -9.95<br />
di cui spese per detenzione e acquisti di animali fr. 43 803 32 568 64 632 -5.232<br />
= Contributo di copertura dell’azienda (risultato lordo 1) fr. 143 122 90 534 217 651 3<br />
- Spese per il personale fr. 16 182 9 863 28 481 - 2<br />
- Altre spese azied. (escl. ammortam. e ricavi finanz.) fr. 44 274 34 544 57 409 - 2<br />
di cui canoni d'affitto e onere dell’affittuario) fr. 7 190 5 054 8 668 7.836<br />
= EBITDA (risultato d'esercizio meno tassi d'int., tasse e ammortam.) fr. 82 666 46 127 131 762 6<br />
Utili e perdite (risultato d'impresa CoFi) fr. 48 016 15 871 82 648 9<br />
Rettificazioni di valore e ammortamenti totali fr. 33 277 31 091 45 031 1<br />
Interessi su debiti totali fr. 5 433 5 003 7 218 - 11<br />
Calcolo armonizzato del reddito agricolo e profitto del lavoro<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, CoFi fr. 47 067 13 043 82 753 8<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, al di fuori della CoFi fr. 55 216 0 - 100<br />
+ spese per il personale 1° e 2° pilastro: correzione per LE fr. 2 424 739 4 729<br />
= Reddito agricolo fr. 49 545 13 998 87 482 4<br />
Profitto del lavoro della manodopera familiare fr. 49 545 13 998 87 482 10<br />
Profitto del lavoro per manodopera familiare fr./ULA 35 643 11 120 67 793 11<br />
Utile calcolatorio/perdita calcolatoria fr. - 43 648 -70 285 792 - 8<br />
Redditività del capitale proprio % - 11 - 19 0 2<br />
Famiglia ed economia domestica (escl. comunità aziendale (CA))<br />
Reddito dell’economia domestica/reddito totale fr. 74 492 54 962 104 630 -1<br />
Reddito agricolo (escl. CA) fr. 47 257 13 973 84 124 3.6<br />
Reddito extraagricolo fr. 27 235 40 989 20 506 -7.5<br />
Fonte: Agroscope ISS, Analisi centralizzata<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A17
Risultati d’esercizio in base ai redditi del lavoro: 2015 equini/ovini/caprini<br />
Caratteristica Unità 2015 I quartile<br />
0 – 25%<br />
IV quartile<br />
75 – 100%<br />
∆ in %<br />
2014/2015<br />
Numero di aziende (campione situazione reddituale) 78 18 21<br />
Aziende rappresentate 895 228 221<br />
Struttura aziendale<br />
Affitto industriale % 4.6 13.6 4.7 n.a.<br />
Manodopera ULA 1.8 1.8 1.8 -5.6<br />
di cui manodopera familiare ULAF 1.4 1.5 1.2 -2.3<br />
Superficie agricola utile (SAU) ha 20.6 15.0 25.3 1.0<br />
di cui superficie coltiva aperta ha 0.7 0.4 0.428 -4.632<br />
di cui superficie inerbita ha 19.4 14.361 24.368 1.274<br />
di cui colture perenni ha 0.1 0.036 0.248 -22.587<br />
Effettivo medio di animali totale (presente) UBG 26.9 21.3 34.2 1.9<br />
di cui della specie bovina UBG 3.2 1.758 3.4 -4.2<br />
di cui piccoli ruminanti UBG 17.5 15.549 20.8 5.6<br />
di cui suini UBG 0.1 0.063 0.2 -17.7<br />
di cui pollame UBG 0.0 0.094 0.0 -56.7<br />
Densità di animali UBG / ha SAU 1.3 1.4 1.3 0.9<br />
Bilancio di chiusura dell'azienda<br />
Attivi fr. 732 089 701 940 790 834 -0.8<br />
Attivo circolante fr. 123 269 97 400 182 059 -13.8<br />
Immobilizzazioni fr. 608 820 604 539 608 775 11.2<br />
Passivi fr. 732 089 701 940 790 834 -0.8<br />
Capitale di terzi fr. 394 456 333 756 394 305 -2.2<br />
Capitale proprio fr. 337 633 368 184 396 529 0.4<br />
di cui variazione del capitale proprio fr. 13 731 18 447 22 081 -13.6<br />
Grado di liquidità 2 (quick ratio) % 468 798 539 -16.5<br />
Grado d'indebitamento % 54 48 50 -1.4<br />
Grado di copertura dell'impianto 2 (capitale di terzi a lungo termine) % 111 110 117 -10.1<br />
Conto economico<br />
+ Ricavi d'esercizio agricolo fr. 195 038 161 105 267 707 - 1<br />
di cui ricavo produzione vegetale fr. 7 849 18 046 4 957 -8.9<br />
di cui ricavo detenzione di animali fr. 96 552 85 239 128 309 -0.845<br />
di cui ricavo da prodotti trasformati fr. 8 211 116 28 037 -7.362<br />
di cui altri ricavi (p.es. locazione di macchine) fr. 12 674 10 096 17 858 32.613<br />
di cui pagamenti diretti fr. 66 783 45 609 83 758 -1.407<br />
- Spese per materiale, merci e servizi fr. 50 844 53 881 64 834 - 1<br />
di cui spese produzione vegetale fr. 3 411 5 386 3 015 -7.511<br />
di cui spese per detenzione e acquisti di animali fr. 33 796 33 993 39 744 0.86<br />
= Contributo di copertura dell’azienda (risultato lordo 1) fr. 144 194 107 224 202 873 - 2<br />
- Spese per il personale fr. 26 256 21 298 39 909 - 13<br />
- Altre spese azied. (escl. ammortam. e ricavi finanz.) fr. 40 897 37 723 49 475 - 1<br />
di cui canoni d'affitto e onere dell’affittuario) fr. 6 829 6 608 10 837 11.557<br />
= EBITDA (risultato d'esercizio meno tassi d'int., tasse e ammortam.) fr. 77 041 48 204 113 488 1<br />
Utili e perdite (risultato d'impresa CoFi) fr. 46 478 16 902 82 995 23<br />
Rettificazioni di valore e ammortamenti totali fr. 34 948 24 802 48 605 0<br />
Interessi su debiti totali fr. 4 103 3 641 4 338 - 5<br />
Calcolo armonizzato del reddito agricolo e profitto del lavoro<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, CoFi fr. 44 460 9 853 83 044 18<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, al di fuori della CoFi fr. 168 0 0 - 100<br />
+ spese per il personale 1° e 2° pilastro: correzione per LE fr. 2 491 970 4 372<br />
= Reddito agricolo fr. 47 119 10 823 87 416 6<br />
Profitto del lavoro della manodopera familiare fr. 47 119 10 823 87 416 13<br />
Profitto del lavoro per manodopera familiare fr./ULA 34 709 7 454 75 258 16<br />
Utile calcolatorio/perdita calcolatoria fr. - 46 218 - 89 151 6 997 - 15<br />
Redditività del capitale proprio % - 14 - 24 2 - 10<br />
Famiglia ed economia domestica (escl. comunità aziendale (CA))<br />
Reddito dell’economia domestica/reddito totale fr. 73 077 45 000 105 539 7<br />
Reddito agricolo (escl. CA) fr. 48 206 10 299 94 301 6.5<br />
Reddito extraagricolo fr. 24 871 34 702 11 238 7.6<br />
Fonte: Agroscope ISS, Analisi centralizzata<br />
A18<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Risultati d’esercizio in base ai redditi del lavoro: 2015 trasformazione<br />
Caratteristica Unità 2015 I quartile<br />
0 – 25%<br />
IV quartile<br />
75 – 100%<br />
∆ in %<br />
2014/2015<br />
Numero di aziende (campione situazione reddituale) 159 42 35<br />
Aziende rappresentate 1 179 299 294<br />
Struttura aziendale<br />
Affitto industriale % 2.9 2.5 0.0 n.a.<br />
Manodopera ULA 1.8 1.7 1.9 -0.4<br />
di cui manodopera familiare ULAF 1.4 1.4 1.1 0.0<br />
Superficie agricola utile (SAU) ha 17.2 14.2 20.0 1.0<br />
di cui superficie coltiva aperta ha 1.2 1.197 1.482 -7.048<br />
di cui superficie inerbita ha 15.7 12.767 18.269 1.689<br />
di cui colture perenni ha 0.0 0.042 0.062 12.622<br />
Effettivo medio di animali totale (presente) UBG 69.5 40.5 101.4 -1.6<br />
di cui della specie bovina UBG 20.2 13.981 24.4 -1.1<br />
di cui piccoli ruminanti UBG 0.5 0.093 0.2 10.1<br />
di cui suini UBG 36.9 17.714 56.5 -2.1<br />
di cui pollame UBG 11.7 8.47 20.3 1.0<br />
Densità di animali UBG / ha SAU 4.0 2.9 5.1 -2.6<br />
Bilancio di chiusura dell'azienda<br />
Attivi fr. 1 121 319 768 301 1 465 127 1.1<br />
Attivo circolante fr. 268 837 152 800 329 214 9.8<br />
Immobilizzazioni fr. 852 482 615 501 1 135 914 3.7<br />
Passivi fr. 1 121 319 768 301 1 465 127 1.1<br />
Capitale di terzi fr. 618 028 458 302 866 747 0.5<br />
Capitale proprio fr. 503 291 310 000 598 380 1.9<br />
di cui variazione del capitale proprio fr. 20 993 7 596 30 125 346.6<br />
Grado di liquidità 2 (quick ratio) % 471 417 404 17.3<br />
Grado d'indebitamento % 55 60 59 -0.7<br />
Grado di copertura dell'impianto 2 (capitale di terzi a lungo termine) % 115 112 113 -2.1<br />
Conto economico<br />
+ Ricavi d'esercizio agricolo fr. 473 832 293 603 733 567 - 6<br />
di cui ricavo produzione vegetale fr. 10 368 9 738 13 438 -7.228<br />
di cui ricavo detenzione di animali fr. 389 084 224 667 625 402 -7.645<br />
di cui ricavo da prodotti trasformati fr. 4 971 47 19 390 14.401<br />
di cui altri ricavi (p.es. locazione di macchine) fr. 10 864 11 859 8 367 27.488<br />
di cui pagamenti diretti fr. 56 235 45 327 63 635 -2.231<br />
- Spese per materiale, merci e servizi fr. 262 469 166 997 403 080 - 5<br />
di cui spese produzione vegetale fr. 5 327 3 963 5 620 -3.999<br />
di cui spese per detenzione e acquisti di animali fr. 243 441 156 387 372 403 -4.699<br />
= Contributo di copertura dell’azienda (risultato lordo 1) fr. 211 363 126 605 330 486 - 7<br />
- Spese per il personale fr. 33 044 16 009 60 326 0<br />
- Altre spese azied. (escl. ammortam. e ricavi finanz.) fr. 53 358 42 622 64 576 - 2<br />
di cui canoni d'affitto e onere dell’affittuario) fr. 11 212 7 885 12 679 -4.519<br />
= EBITDA (risultato d'esercizio meno tassi d'int., tasse e ammortam.) fr. 124 961 67 973 205 585 - 11<br />
Utili e perdite (risultato d'impresa CoFi) fr. 74 267 26 243 132 707 - 5<br />
Rettificazioni di valore e ammortamenti totali fr. 46 550 32 339 62 375 - 19<br />
Interessi su debiti totali fr. 8 681 6 844 11 571 - 6<br />
Calcolo armonizzato del reddito agricolo e profitto del lavoro<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, CoFi fr. 72 797 24 851 131 517 - 8<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, al di fuori della CoFi fr. 2 572 1 760 2 197 - 61<br />
+ spese per il personale 1° e 2° pilastro: correzione per LE fr. 4 101 1 625 7 243<br />
= Reddito agricolo fr. 79 471 28 236 140 958 - 10<br />
Profitto del lavoro della manodopera familiare fr. 79 471 28 236 140 958 - 6<br />
Profitto del lavoro per manodopera familiare fr./ULA 58 655 20 199 122 956 - 6<br />
Utile calcolatorio/perdita calcolatoria fr. - 15 366 -68 484 60 000 34<br />
Redditività del capitale proprio % - 3 - 22 10 92<br />
Famiglia ed economia domestica (escl. comunità aziendale (CA))<br />
Reddito dell’economia domestica/reddito totale fr. 105 871 75 244 157 879 -6<br />
Reddito agricolo (escl. CA) fr. 77 518 25 699 140 095 -7.5<br />
Reddito extraagricolo fr. 28 353 49 545 17 784 -3.7<br />
Fonte: Agroscope ISS, Analisi centralizzata<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A19
Risultati d’esercizio in base ai redditi del lavoro: 2015 combinate vacche da latte/campicoltura<br />
Caratteristica Unità 2015 I quartile<br />
0 – 25%<br />
IV quartile<br />
75 – 100%<br />
∆ in %<br />
2014/2015<br />
Numero di aziende (campione situazione reddituale) 125 31 30<br />
Aziende rappresentate 2 249 565 551<br />
Struttura aziendale<br />
Affitto industriale % 7.1 1.9 7.1 n.a.<br />
Manodopera ULA 2.1 1.9 2.3 -3.2<br />
di cui manodopera familiare ULAF 1.4 1.4 1.4 -2.9<br />
Superficie agricola utile (SAU) ha 32.0 23.7 37.7 -0.1<br />
di cui superficie coltiva aperta ha 16.3 12.231 20.204 0.772<br />
di cui superficie inerbita ha 15.4 11.239 17.138 -0.745<br />
di cui colture perenni ha 0.1 0.125 0.176 -26.958<br />
Effettivo medio di animali totale (presente) UBG 38.0 28.3 49.0 1.1<br />
di cui della specie bovina UBG 37.2 27.618 48.6 1.0<br />
di cui piccoli ruminanti UBG 0.1 0.083 0.0 -10.9<br />
di cui suini UBG 0.3 0.455 0.0 -3.4<br />
di cui pollame UBG 0.1 0.088 0.1 7.5<br />
Densità di animali UBG / ha SAU 1.2 1.2 1.3 1.2<br />
Bilancio di chiusura dell'azienda<br />
Attivi fr. 1 050 125 842 416 1 198 513 2.1<br />
Attivo circolante fr. 281 008 190 959 307 734 7.3<br />
Immobilizzazioni fr. 769 117 651 458 890 779 4.5<br />
Passivi fr. 1 050 125 842 416 1 198 513 2.1<br />
Capitale di terzi fr. 516 526 502 292 637 359 2.5<br />
Capitale proprio fr. 533 599 340 125 561 154 1.7<br />
di cui variazione del capitale proprio fr. 27 002 - 778 43 404 34.4<br />
Grado di liquidità 2 (quick ratio) % 638 400 489 17.3<br />
Grado d'indebitamento % 49 60 53 0.4<br />
Grado di copertura dell'impianto 2 (capitale di terzi a lungo termine) % 120 114 117 -1.9<br />
Conto economico<br />
+ Ricavi d'esercizio agricolo fr. 323 510 235 000 422 215 - 5<br />
di cui ricavo produzione vegetale fr. 61 418 42 362 91 656 -14.081<br />
di cui ricavo detenzione di animali fr. 168 928 131 516 212 146 -5.678<br />
di cui ricavo da prodotti trasformati fr. 3 940 2 105 25 104.35<br />
di cui altri ricavi (p.es. locazione di macchine) fr. 15 531 7 928 29 511 42.492<br />
di cui pagamenti diretti fr. 71 114 49 673 84 677 -1.479<br />
- Spese per materiale, merci e servizi fr. 114 177 98 477 135 393 - 3<br />
di cui spese produzione vegetale fr. 29 042 20 830 38 447 -9.9<br />
di cui spese per detenzione e acquisti di animali fr. 65 691 59 412 76 724 2.045<br />
= Contributo di copertura dell’azienda (risultato lordo 1) fr. 209 333 136 523 286 821 - 6<br />
- Spese per il personale fr. 35 032 20 126 50 140 - 2<br />
- Altre spese azied. (escl. ammortam. e ricavi finanz.) fr. 68 361 49 224 82 981 2<br />
di cui canoni d'affitto e onere dell’affittuario) fr. 15 638 8 697 19 677 8.47<br />
= EBITDA (risultato d'esercizio meno tassi d'int., tasse e ammortam.) fr. 105 940 67 174 153 700 - 11<br />
Utili e perdite (risultato d'impresa CoFi) fr. 66 680 28 959 107 889 - 1<br />
Rettificazioni di valore e ammortamenti totali fr. 38 391 28 320 48 871 - 11<br />
Interessi su debiti totali fr. 6 666 7 009 8 105 - 1<br />
Calcolo armonizzato del reddito agricolo e profitto del lavoro<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, CoFi fr. 64 856 27 697 106 628 - 4<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, al di fuori della CoFi fr. 691 220 2 011 - 95<br />
+ spese per il personale 1° e 2° pilastro: correzione per LE fr. 3 685 1 617 5 816<br />
= Reddito agricolo fr. 69 232 29 534 114 456 - 12<br />
Profitto del lavoro della manodopera familiare fr. 69 232 29 534 114 456 - 7<br />
Profitto del lavoro per manodopera familiare fr./ULA 48 626 20 402 83 285 - 5<br />
Utile calcolatorio/perdita calcolatoria fr. -35 358 -76 856 13 235 4<br />
Redditività del capitale proprio % - 7 - 23 2 13<br />
Famiglia ed economia domestica (escl. comunità aziendale (CA))<br />
Reddito dell’economia domestica/reddito totale fr. 90 372 57 476 127 364 -10<br />
Reddito agricolo (escl. CA) fr. 65 496 30 922 109 189 -13.7<br />
Reddito extraagricolo fr. 24 875 26 554 18 176 -0.3<br />
Fonte: Agroscope ISS, Analisi centralizzata<br />
A20<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Risultati d’esercizio in base ai redditi del lavoro: 2015 aziende combinate vacche da latte<br />
Caratteristica Unità 2015 I quartile<br />
0 – 25%<br />
IV quartile<br />
75 – 100%<br />
∆ in %<br />
2014/2015<br />
Numero di aziende (campione situazione reddituale) 76 20 18<br />
Aziende rappresentate 822 219 195<br />
Struttura aziendale<br />
Affitto industriale % 6.3 0.0 8.1 n.a.<br />
Manodopera ULA 1.8 1.5 2.1 5.1<br />
di cui manodopera familiare ULAF 1.3 1.1 1.2 -1.7<br />
Superficie agricola utile (SAU) ha 31.0 24.8 35.4 0.5<br />
di cui superficie coltiva aperta ha 13.6 10.551 15.462 4.252<br />
di cui superficie inerbita ha 16.5 13.504 18.806 -2.307<br />
di cui colture perenni ha 0.6 0.453 0.718 0.013<br />
Effettivo medio di animali totale (presente) UBG 35.6 26.8 36.4 -1.2<br />
di cui della specie bovina UBG 34.7 25.485 35.4 -1.2<br />
di cui piccoli ruminanti UBG 0.1 0.127 0.1 78.7<br />
di cui suini UBG 0.5 0.741 0.6 1.8<br />
di cui pollame UBG 0.1 0.083 0.0 2.2<br />
Densità di animali UBG / ha SAU 1.1 1.1 1.0 -1.7<br />
Bilancio di chiusura dell'azienda<br />
Attivi fr. 1 045 592 984 486 949 354 1.4<br />
Attivo circolante fr. 235 970 177 421 246 295 2.3<br />
Immobilizzazioni fr. 809 622 807 065 703 059 2.3<br />
Passivi fr. 1 045 592 984 486 949 354 1.4<br />
Capitale di terzi fr. 526 081 587 154 457 754 3.2<br />
Capitale proprio fr. 519 512 397 332 491 599 -0.4<br />
di cui variazione del capitale proprio fr. 25 503 21 896 26 612 29.5<br />
Grado di liquidità 2 (quick ratio) % 392 330 633 -15.6<br />
Grado d'indebitamento % 50 60 48 1.8<br />
Grado di copertura dell'impianto 2 (capitale di terzi a lungo termine) % 113 111 118 -1.8<br />
Conto economico<br />
+ Ricavi d'esercizio agricolo fr. 290 017 209 874 324 313 6<br />
di cui ricavo produzione vegetale fr. 63 972 41 895 94 340 -5.999<br />
di cui ricavo detenzione di animali fr. 93 531 68 724 81 169 17.577<br />
di cui ricavo da prodotti trasformati fr. 22 990 14 703 10 602 0.228<br />
di cui altri ricavi (p.es. locazione di macchine) fr. 19 756 16 949 32 703 37.576<br />
di cui pagamenti diretti fr. 85 811 65 484 102 183 -2.212<br />
- Spese per materiale, merci e servizi fr. 105 184 78 927 94 713 10<br />
di cui spese produzione vegetale fr. 25 474 16 802 33 453 3.602<br />
di cui spese per detenzione e acquisti di animali fr. 51 157 36 234 35 060 18.222<br />
= Contributo di copertura dell’azienda (risultato lordo 1) fr. 184 833 130 947 229 599 3<br />
- Spese per il personale fr. 30 014 21 035 49 583 4<br />
- Altre spese azied. (escl. ammortam. e ricavi finanz.) fr. 59 612 44 588 58 001 3<br />
di cui canoni d'affitto e onere dell’affittuario) fr. 12 913 7 821 12 471 10.618<br />
= EBITDA (risultato d'esercizio meno tassi d'int., tasse e ammortam.) fr. 95 207 65 323 122 016 3<br />
Utili e perdite (risultato d'impresa CoFi) fr. 56 705 16 787 86 418 14<br />
Rettificazioni di valore e ammortamenti totali fr. 38 323 47 575 35 418 2<br />
Interessi su debiti totali fr. 7 613 8 867 6 205 - 10<br />
Calcolo armonizzato del reddito agricolo e profitto del lavoro<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, CoFi fr. 53 679 10 715 85 750 10<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, al di fuori della CoFi fr. 0 0 0 - 100<br />
+ spese per il personale 1° e 2° pilastro: correzione per LE fr. 2 797 1 077 4 388<br />
= Reddito agricolo fr. 56 476 11 792 90 138 9<br />
Profitto del lavoro della manodopera familiare fr. 56 476 11 792 90 138 19<br />
Profitto del lavoro per manodopera familiare fr./ULA 43 805 10 269 78 290 21<br />
Utile calcolatorio/perdita calcolatoria fr. -37 982 -71 529 5 149 - 23<br />
Redditività del capitale proprio % - 7 - 18 1 - 15<br />
Famiglia ed economia domestica (escl. comunità aziendale (CA))<br />
Reddito dell’economia domestica/reddito totale fr. 97 821 79 352 129 278 6<br />
Reddito agricolo (escl. CA) fr. 53 368 11 792 90 138 9.5<br />
Reddito extraagricolo fr. 44 453 67 560 39 140 1.3<br />
Fonte: Agroscope ISS, Analisi centralizzata<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A21
Risultati d’esercizio in base ai redditi del lavoro: aziende combinate, trasformazione 2015<br />
Caratteristica Unità 2015 I quartile<br />
0 – 25%<br />
IV quartile<br />
75 – 100%<br />
∆ in %<br />
2014/2015<br />
Numero di aziende (campione situazione reddituale) 367 93 90<br />
Aziende rappresentate 4 372 1 099 1 084<br />
Struttura aziendale<br />
Affitto industriale % 4.8 2.5 5.3 n.a.<br />
Manodopera ULA 1.9 1.8 2.1 -0.5<br />
di cui manodopera familiare ULAF 1.4 1.4 1.3 -0.4<br />
Superficie agricola utile (SAU) ha 24.3 20.8 30.8 0.5<br />
di cui superficie coltiva aperta ha 8.0 6.301 13.437 0.9<br />
di cui superficie inerbita ha 15.9 14.187 16.595 0.299<br />
di cui colture perenni ha 0.1 0.054 0.27 5.363<br />
Effettivo medio di animali totale (presente) UBG 61.7 50.1 88.0 0.3<br />
di cui della specie bovina UBG 26.7 22.225 31.0 0.7<br />
di cui piccoli ruminanti UBG 0.5 0.54 0.5 -4.9<br />
di cui suini UBG 24.3 24.463 30.3 -0.7<br />
di cui pollame UBG 9.9 2.452 25.8 2.4<br />
Densità di animali UBG / ha SAU 2.5 2.4 2.9 -0.1<br />
Bilancio di chiusura dell'azienda<br />
Attivi fr. 1 234 449 1 171 546 1 651 298 -0.3<br />
Attivo circolante fr. 261 162 213 668 358 348 -0.2<br />
Immobilizzazioni fr. 973 288 957 878 1 292 950 2.0<br />
Passivi fr. 1 234 449 1 171 546 1 651 298 -0.3<br />
Capitale di terzi fr. 627 097 713 749 743 818 -1.3<br />
Capitale proprio fr. 607 352 457 797 907 480 0.7<br />
di cui variazione del capitale proprio fr. 15 364 - 25 44 446 -13.8<br />
Grado di liquidità 2 (quick ratio) % 402 349 399 16.9<br />
Grado d'indebitamento % 51 61 45 -1.0<br />
Grado di copertura dell'impianto 2 (capitale di terzi a lungo termine) % 113 110 114 -1.5<br />
Conto economico<br />
+ Ricavi d'esercizio agricolo fr. 437 293 317 205 655 356 - 7<br />
di cui ricavo produzione vegetale fr. 35 391 23 887 60 622 -8.54<br />
di cui ricavo detenzione di animali fr. 312 854 222 472 483 595 -9.227<br />
di cui ricavo da prodotti trasformati fr. 2 427 1 091 3 698 13.799<br />
di cui altri ricavi (p.es. locazione di macchine) fr. 15 159 13 712 18 714 35.85<br />
di cui pagamenti diretti fr. 68 857 54 552 85 292 -1.68<br />
- Spese per materiale, merci e servizi fr. 213 063 167 399 315 428 - 5<br />
di cui spese produzione vegetale fr. 16 278 10 989 26 805 -1.861<br />
di cui spese per detenzione e acquisti di animali fr. 181 629 140 948 271 320 -6.388<br />
= Contributo di copertura dell’azienda (risultato lordo 1) fr. 224 229 149 806 339 927 - 8<br />
- Spese per il personale fr. 35 567 21 522 60 419 - 2<br />
- Altre spese azied. (escl. ammortam. e ricavi finanz.) fr. 59 405 52 843 73 263 - 1<br />
di cui canoni d'affitto e onere dell’affittuario) fr. 12 104 8 209 18 850 3.298<br />
= EBITDA (risultato d'esercizio meno tassi d'int., tasse e ammortam.) fr. 129 257 75 441 206 245 - 13<br />
Utili e perdite (risultato d'impresa CoFi) fr. 69 321 23 674 121 062 - 1<br />
Rettificazioni di valore e ammortamenti totali fr. 50 360 42 839 69 914 - 18<br />
Interessi su debiti totali fr. 8 503 10 362 9 764 - 11<br />
Calcolo armonizzato del reddito agricolo e profitto del lavoro<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, CoFi fr. 67 088 19 838 119 764 - 5<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, al di fuori della CoFi fr. 732 770 1 136 - 87<br />
+ spese per il personale 1° e 2° pilastro: correzione per LE fr. 4 105 1 587 7 491<br />
= Reddito agricolo fr. 71 926 22 195 128 390 - 10<br />
Profitto del lavoro della manodopera familiare fr. 71 926 22 195 128 390 - 5<br />
Profitto del lavoro per manodopera familiare fr./ULA 51 700 15 811 99 514 - 4<br />
Utile calcolatorio/perdita calcolatoria fr. - 26 871 - 76 484 33 950 12<br />
Redditività del capitale proprio % - 4 - 17 4 37<br />
Famiglia ed economia domestica (escl. comunità aziendale (CA))<br />
Reddito dell’economia domestica/reddito totale fr. 98 159 66 941 148 984 -6<br />
Reddito agricolo (escl. CA) fr. 69 079 21 556 124 065 -8.5<br />
Reddito extraagricolo fr. 29 080 45 385 24 919 -1.0<br />
Fonte: Agroscope ISS, Analisi centralizzata<br />
A22<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Risultati d’esercizio in base ai redditi del lavoro: aziende combinate, altre 2015<br />
Caratteristica Unità 2015 I quartile<br />
0 – 25%<br />
IV quartile<br />
75 – 100%<br />
∆ in %<br />
2014/2015<br />
Numero di aziende (campione situazione reddituale) 255 73 58<br />
Aziende rappresentate 4 822 1 210 1 198<br />
Struttura aziendale<br />
Affitto industriale % 5.8 8.8 10.0 n.a.<br />
Manodopera ULA 1.9 1.8 1.9 -2.3<br />
di cui manodopera familiare ULAF 1.4 1.4 1.2 -4.7<br />
Superficie agricola utile (SAU) ha 28.7 22.1 36.8 1.0<br />
di cui superficie coltiva aperta ha 10.5 7.217 15.109 0.834<br />
di cui superficie inerbita ha 17.5 14.267 20.686 1.218<br />
di cui colture perenni ha 0.4 0.419 0.663 -7.523<br />
Effettivo medio di animali totale (presente) UBG 36.3 25.8 50.8 -1.1<br />
di cui della specie bovina UBG 33.0 21.749 47.6 -1.5<br />
di cui piccoli ruminanti UBG 0.9 2.036 0.2 8.6<br />
di cui suini UBG 1.0 0.742 1.2 -7.0<br />
di cui pollame UBG 0.2 0.114 0.1 2.5<br />
Densità di animali UBG / ha SAU 1.3 1.2 1.4 -2.0<br />
Bilancio di chiusura dell'azienda<br />
Attivi fr. 1 106 941 839 877 1 374 173 0.2<br />
Attivo circolante fr. 265 784 159 705 411 785 -2.5<br />
Immobilizzazioni fr. 841 156 680 172 962 388 3.8<br />
Passivi fr. 1 106 941 839 877 1 374 173 0.2<br />
Capitale di terzi fr. 551 536 417 257 693 254 2.4<br />
Capitale proprio fr. 555 404 422 620 680 919 -2.0<br />
di cui variazione del capitale proprio fr. 15 899 - 1 377 32 188 -28.2<br />
Grado di liquidità 2 (quick ratio) % 592 372 621 5.6<br />
Grado d'indebitamento % 50 50 50 2.2<br />
Grado di copertura dell'impianto 2 (capitale di terzi a lungo termine) % 116 111 120 -2.8<br />
Conto economico<br />
+ Ricavi d'esercizio agricolo fr. 328 733 199 131 520 898 - 4<br />
di cui ricavo produzione vegetale fr. 41 716 27 541 66 201 -9.449<br />
di cui ricavo detenzione di animali fr. 190 086 89 775 332 138 -5.616<br />
di cui ricavo da prodotti trasformati fr. 5 470 10 309 709 68.995<br />
di cui altri ricavi (p.es. locazione di macchine) fr. 17 566 11 657 32 589 2.23<br />
di cui pagamenti diretti fr. 69 589 56 128 84 813 -1.137<br />
- Spese per materiale, merci e servizi fr. 131 949 78 641 224 673 - 2<br />
di cui spese produzione vegetale fr. 19 479 13 715 28 234 -2.913<br />
di cui spese per detenzione e acquisti di animali fr. 93 027 47 929 170 214 -3.085<br />
= Contributo di copertura dell’azienda (risultato lordo 1) fr. 196 784 120 490 296 226 - 5<br />
- Spese per il personale fr. 31 128 19 098 46 835 2<br />
- Altre spese azied. (escl. ammortam. e ricavi finanz.) fr. 58 106 47 690 73 609 - 6<br />
di cui canoni d'affitto e onere dell’affittuario) fr. 11 422 8 243 17 605 -6.664<br />
= EBITDA (risultato d'esercizio meno tassi d'int., tasse e ammortam.) fr. 107 549 53 702 175 781 - 6<br />
Utili e perdite (risultato d'impresa CoFi) fr. 61 816 20 992 106 484 2<br />
Rettificazioni di valore e ammortamenti totali fr. 40 917 25 972 62 299 - 11<br />
Interessi su debiti totali fr. 6 707 4 534 7 915 - 3<br />
Calcolo armonizzato del reddito agricolo e profitto del lavoro<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, CoFi fr. 59 295 20 291 105 613 0<br />
+ risultato proveniente dall'agricoltura, al di fuori della CoFi fr. 741 0 0 - 95<br />
+ spese per il personale 1° e 2° pilastro: correzione per LE fr. 3 020 971 5 194<br />
= Reddito agricolo fr. 63 056 21 262 110 807 - 7<br />
Profitto del lavoro della manodopera familiare fr. 63 056 21 262 110 807 - 1<br />
Profitto del lavoro per manodopera familiare fr./ULA 45 634 14 780 91 878 3<br />
Utile calcolatorio/perdita calcolatoria fr. - 36 570 - 81 368 22 324 - 10<br />
Redditività del capitale proprio % - 7 - 19 3 1<br />
Famiglia ed economia domestica (escl. comunità aziendale (CA))<br />
Reddito dell’economia domestica/reddito totale fr. 93 611 66 324 142 841 -2<br />
Reddito agricolo (escl. CA) fr. 59 899 20 810 105 208 -6.4<br />
Reddito extraagricolo fr. 33 712 45 514 37 633 6.0<br />
Fonte: Agroscope ISS, Analisi centralizzata<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A23
Detentori ed effettivi di animali<br />
2000/02 2013 2014 2015 2000/02–<br />
2013/15<br />
Capi Capi Capi Capi %<br />
Detentori di animali da reddito<br />
Detentori di animali 58 602 46 621 45 711 44 789 -22.0<br />
Detentori di bovini 49 598 38 546 37 742 36 738 -24.0<br />
Detentori di equini 10 564 8 671 8 528 8 483 -19.0<br />
Detentori di suini 14 656 7 277 7 045 6 865 -51.8<br />
Detentori di ovini 12 158 8 903 8 700 8 414 -28.7<br />
Detentori di caprini 1) 6 977 6 466 6 333 6 313 -8.7<br />
Detentori di pollame da reddito 19 943 11 982 11 953 12 065 -39.8<br />
Effettivi<br />
Bovini 1 597 684 1 557 474 1 562 801 1 554 319 -2.5<br />
di cui vacche 716 784 703 489 705 371 701 172 -1.9<br />
Cavalli 50 566 57 243 57 200 55 479 12.0<br />
Suini 1 534 217 1 484 732 1 498 321 1 495 737 -2.7<br />
Ovini 423 413 409 493 402 772 347 025 -8.7<br />
Caprini 63 828 87 935 87 817 74 269 30.6<br />
Pollame da reddito 6 934 609 10 003 437 10 644 412 10 752 686 50.9<br />
di cui galline ovaiole e da 2 124 632 2 588 580 2 665 143 2 821 943 26.7<br />
1) Incl. rispettivamente detentori di capre nane e capre nane<br />
Fonte: UST, bovini: dati dal 2009 provenienti dalla banca dati sul traffico di animali<br />
A24<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
ab16_markt_anhang_tabellen_3_12_tab4_nutztierhaltung_i.xlsx<br />
Tab4 29.11.16
Grado di autoapprovvigionamento<br />
Prodotto 2000/02 2007 r 2008 r 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2000/02-<br />
2012/14<br />
% % % % % % % % % %<br />
Percentuale quantitativa:<br />
Totale cereali 1 56 53 54 49 52 50 46 51<br />
Cereali da foraggio 2 68 60 62 56 55 52 47 57<br />
Percentuale in energia secondo il bilancio alimentare 3 :<br />
Totale cereali (compr. riso) 52 58 55 56 55 57 59 53<br />
Cereali panificabili 4 75 85 81 80 83 79 82 76<br />
Patate commestibili 90 89 92 88 95 89 76 98<br />
Zucchero 73 71 83 70 94 81 64 93<br />
Grassi e oli vegetali 21 20 21 20 21 21 21 26<br />
Frutta a granella e a nocciolo 5 97 72 81 68 111 70 69 84<br />
Verdura 48 51 50 47 54 50 48 52<br />
Latte di consumo 96 96 95 95 95 95 96 96<br />
Burro 88 109 114 113 111 114 101 109<br />
Formaggio 120 119 117 116 116 119 117 117<br />
Totale latte e latticini 112 122 120 118 117 117 112 115<br />
Carne di vitello 96 97 98 97 98 98 98 98<br />
Carne bovina 86 82 88 88 88 90 85 86<br />
Carne suina 93 89 93 94 94 96 93 95<br />
Carne ovina 47 47 48 48 47 45 44 43<br />
Pollame 47 46 47 48 49 49 51 52<br />
Carne, pesci e crostacei 6 79 75 79 79 79 80 77 79<br />
Uova e conserve di uova 45 45 46 47 49 49 50 52<br />
Derrate alimentari di origine vegetale 42 43 45 42 47 45 41 46<br />
Derrate alimentari di origine animale lorde 97 102 102 101 100 101 97 100<br />
Derrate alimentari di origine animale nette 7 79 81 82 78 78 78 72 76<br />
Totale derrate alimentari lorde 8 62 59 61 62 59 63 62 58 63 -1.6<br />
Totale derrate alimentari nette 7 56 53 55 56 52 56 55 50 55 -5.1<br />
1 Bilancio cerealicolo: cereali panificabili e da foraggio, compreso il grano duro, senza riso<br />
2 Bilancio foraggero: compresi prodotti della molitura e cereali panificabili germogliati, esclusi i panelli oleosi<br />
3 In energia assimilabile secondo il bilancio alimentare<br />
4 Frumento tenero, spelta, farro, piccola spelta e segale; senza amido di frumento<br />
5 Mele, pere, ciliegie, prugne, susine, albicocche e pesche<br />
6 Compresa la carne equina, caprina, di coniglio e la selvaggina, nonché pesci, crostacei e molluschi<br />
7 Esclusi i prodotti di origine animale ottenuti a partire da alimenti per animali importati<br />
8 In energia assimilabile, comprese le bevande alcoliche, in base al bilancio alimentare<br />
r Nuovi valori in base al metodo «Bilancio alimentare 08»<br />
Fonte: Agristat<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A25
Prezzi alla produzione (Bio escl.)<br />
Prodotto Unità 2000/02 2013 2014 2015 2000/02–<br />
2013/15<br />
%<br />
Latte<br />
Totale Svizzera ct. / kg 79.19 66.30 68.23 61.87 -17.3<br />
Latte trasformato in formaggio ct. / kg 79.13 70.13 72.32 67.46 -11.6<br />
Bestiame da macello 1, 2<br />
Vacche T3 QM fr. / kg PM 5.25 6.82 7.37 7.74 39.2<br />
Giovani vacche T3 QM fr. / kg PM 6.11 7.19 7.73 8.18 26.0<br />
Torelli T3 QM fr. / kg PM 7.65 8.51 8.41 9.04 13.1<br />
Buoi T3 QM fr. / kg PM 7.62 8.51 8.41 9.04 13.6<br />
Manzi T3 QM fr. / kg PM 7.40 8.57 8.39 9.05 17.2<br />
Vitelli T3 QM fr. / kg PM 12.38 13.95 13.74 13.86 11.9<br />
Suini QM fr. / kg PM 4.40 4.47 4.15 3.45 -8.6<br />
Agnelli fino a 40 kg, T3 QM fr. / kg PM 12.34 11.20 11.65 11.71 -6.6<br />
Uova 3<br />
Uova da allevamento al suolo ct. / pz. 22.76 22.37 22.59 22.11 -1.8<br />
Uova da allevamento all’aperto estensivo ct. / pz. 25.46 23.80 24.08 23.21 -6.9<br />
Cereali 3, 4<br />
Frumento (panif.) Top fr. / 100 kg 60.23 51.00 50.50 49.64 -16.4<br />
Frumento (panif.) Classe I fr. / 100 kg 57.38 49.40 49.00 48.11 -14.9<br />
Frumento (foraggio) fr. / 100 kg 45.18 37.20 36.50 36.04 -19.0<br />
Segale (panif.) Classe A fr. / 100 kg 44.24 40.40 40.40 39.62 -9.3<br />
Orzo (foraggio) 67/69 fr. / 100 kg 42.68 34.90 34.50 34.05 -19.2<br />
Avena (foraggio) 57/58 fr. / 100 kg 39.45 31.60 30.00 29.30 -23.2<br />
Mais da granella fr. / 100 kg 45.70 38.20 37.20 37.56 -17.6<br />
Sarchiate 3, 5<br />
Patate resistenti alla cottura fr. / 100 kg 45.10 51.71 43.61 50.73 7.9<br />
Patate farinose fr. / 100 kg 42.32 46.62 40.67 45.64 4.7<br />
Patate destinate alla trasformazione fr. / 100 kg 41.30 44.18 38.42 43.01 1.4<br />
Patate novelle6 fr. / 100 kg 79.37 106.62 72.94 80.84 9.4<br />
Barbabietole da zucchero fr. / 100 kg 12.21 7.99 7.47 7.05 -38.6<br />
Semi oleosi 3, 4<br />
Colza (varietà convenzionali) fr. / 100 kg 83.19 88.70 80.30 74.96 -2.3<br />
Girasole, high oleic fr. / 100 kg 84.61 98.70 91.90 86.37 9.1<br />
Frutta 7<br />
Mele: Goden Delicious, classe I 9,10, 11 fr. / kg 1.00 1.12 1.02 1.06 6.3<br />
Mele: Maigold, Braeburn dal 2010, classe I 9, 10, 11 fr. / kg 1.13 1.03 1.02 1.01 -8.4<br />
Pere: Conférence, classe I 9,10, 11 fr. / kg 1.08 1.36 1.15 1.35 20.8<br />
Albicocche, tutte le classi 10, 11 fr. / kg 2.69 3.02 2.52 2.55 1.4<br />
Ciliegie da tavola, tutte le classi 10, 11, 13 fr. / kg 3.86 6.21 6.18 6.02 59.7<br />
Prugne de tavola, 33 mm, Fellenberg<br />
fr. / kg 2.21 2.41 2.20 2.30 5.1<br />
compr. 10, 11, 14<br />
Fragole 15 fr. / kg 5.61 6.50 6.36 6.41 14.5<br />
Verdure 8<br />
Carote (scorte) fr. / kg 1.09 1.13 1.23 1.26 10.7<br />
Cipolle (scorte) fr. / kg 1.00 0.67 0.77 0.66 -30.0<br />
Sedano rapa (scorte) fr. / kg 1.75 2.10 2.59 2.59 38.7<br />
Pomodori tondi fr. / kg 2.09 2.18 2.22 2.39 8.3<br />
Lattuga cappuccio fr. / pz. 0.92 1.12 0.97 1.06 14.1<br />
Cavolfiore fr. / kg 2.04 2.52 2.58 2.70 27.5<br />
Cetrioli fr. / pz. 0.98 1.22 1.11 1.06 15.3<br />
1 Prezzi franco macello, escl. i suini da carne franco fattoria<br />
2 2000/02: prezzo convenzionale<br />
3<br />
2000/02: per mancanza d’informazioni si utilizza la media 2002/04<br />
4 Prezzo alla produzione lordo<br />
5 Prezzi indicativi (media aritmetica delle principali varietà), merce sfusa, escl. costi di trasporto e di cernita, contributo alla categoria e IVA<br />
6 Prezzo indicativo provvisorio; solo mag.-ago. secondo la campagna di commercializzazione di swisspatat<br />
7 Prezzi alla produzione indicativi<br />
8 Prezzi indicativi franco grande distributore Suisse Garantie / (PI); escl. costi d'imballaggio, prodotto lavato, Ifco, escl. IVA, incl. TTPCP<br />
9<br />
Prezzi indicativi alla produzione definitivi<br />
10<br />
Media degli anni 2000/03<br />
11<br />
Variazione 2000/03-2012/15<br />
12<br />
Agroscope: passaggio a un nuovo sistema di calcolo nel 2003<br />
13 Incl. costi di imballaggio; 2012-2015 tutte le classi, base 5 kg sfusi; 2000/03 classe 1 (21mm), base vaschetta/sacchetto da 1 kg<br />
14 Incl. costi di imballaggio; 2012-2015 prugne da tavola 33mm incl. Fellenberg, base 6 kg sfusi; 2000/03 soltanto Fellenberg, base vaschetta da 1kg<br />
15 Incl. costi di imballaggio; base 10 vaschette da 500 g, aperte<br />
Fonti:<br />
Latte, uova, cereali e semi oleosi: UFAG<br />
Bestiame da macello: Proviande<br />
Sarchiate: Swisspatat (patate), Agroscope-ISS (barbabietole da zucchero)<br />
Frutta: Associazione svizzera frutta e Interprofession des fruits et légumes du Valais<br />
Verdura: Centrale svizzera dell’ orticoltura e delle colture speciali<br />
A26<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Prezzi alla produzione Bio<br />
Prodotto Unità 2002/04 2013 2014 2015 2002/04–<br />
2013/15<br />
%<br />
Latte<br />
Latte biologico ct. / pz. 89.28 77.49 78.57 77.51 -12.8<br />
Bestiame da macello 1, 2<br />
Torelli da banco T3 fr. / kg PM 8.76 8.98 8.73 9.44 3.3<br />
Bio Weidebeef T3 fr. / kg PM - 10.88 10.89 11.14 -<br />
Bio Natura Beef T3 fr. / kg PM - 11.26 11.15 11.65 -<br />
Vitelli da banco T3 fr. / kg PM 13.20 15.50 14.85 15.18 15.0<br />
Suini da macello fr. / kg PM 6.88 7.21 7.30 7.40 6.2<br />
Agnelli T3 fr. / kg PM 13.10 13.22 13.63 14.54 5.3<br />
Uova<br />
Uova da allevamento biologico ct. / pz. 39.58 41.57 42.38 42.16 6.2<br />
Cereali 2<br />
Frumento per la molitura fr. / 100 kg - 107.40 106.30 105.33 -<br />
Spelta, classe A, pane, spelta vestita fr. / 100 kg - 114.70 115.10 112.27 -<br />
Frumento (foraggio) 3 fr. / 100 kg - 83.60 84.60 84.95 -<br />
Orzo (foraggio) 3 fr. / 100 kg - 80.80 81.80 81.01 -<br />
Mais da granella 3 fr. / 100 kg - 83.70 84.50 85.66 -<br />
Sarchiate 4<br />
Patate resistenti alla cottura fr. / 100 kg 85.12 104.39 89.76 93.66 12.7<br />
Patate farinose fr. / 100 kg 71.95 104.39 88.78 92.68 32.4<br />
Patate destinate alla trasformazione fr. / 100 kg 72.20 79.02 74.15 78.86 7.1<br />
Patate novelle 5 fr. / 100 kg 108.57 202.63 149.39 148.51 53.7<br />
Semi oleosi 2<br />
Girasole fr. / 100 kg - 162.30 157.70 150.29 -<br />
Verdure 6<br />
Carote (scorte) fr. / kg 1.93 2.23 2.23 2.32 17.1<br />
Cipolle (scorte) fr. / kg 2.98 3.10 3.27 3.17 6.7<br />
Sedano rapa (scorte) fr. / kg 3.43 4.20 4.48 4.63 29.3<br />
Pomodori tondi fr. / kg 3.26 4.02 3.79 4.20 22.8<br />
Lattuga cappuccio fr. / pz. 1.40 1.75 1.51 1.55 14.5<br />
Cavolfiore fr. / kg 3.51 3.81 3.83 4.66 16.8<br />
Cetrioli fr. / pz. 1.45 1.76 1.67 1.70 17.9<br />
1 Prezzi franco macello, escl. i suini da carne franco fattoria<br />
2 Prezzo alla produzione lordo, Gemma Bio<br />
3 Prezzo alla produzione lordo, Gemma Bio / conversione<br />
4 Prezzi indicativi (media aritmetica delle principali varietà), merce sfusa, escl. costi di trasporto e di cernita, contributo alla categoria e IVA<br />
5 Prezzo indicativo provvisorio; solo mag.-ago. secondo la campagna di commercializzazione di swisspatat<br />
6 Prezzi indicativi franco grande distributore; escl. costi d'imballaggio, prodotto lavato, Ifco, escl. IVA, incl. TTPCP<br />
Fonti:<br />
Latte, uova: UFAG<br />
Bestiame da macello: Bio Suisse, Mutterkuh Schweiz, MGB<br />
Cereali e semi oleosi: Bio Suisse<br />
Sarchiate: Swisspatat (patate)<br />
Verdure: Centrale svizzera dell’ orticoltura e delle colture speciali<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A27<br />
AB16_Markt_Anhang_Tabellen_3_12_Tab_Ppreise_Bio_i.xlsx<br />
Bio 18.10.16
Prezzi nella fornitura e acquisto all’ingrosso, Bio escl.<br />
Prodotto Unità 2013 2014 2015 2014 Quota di mercato<br />
2015 sul segmento<br />
totale<br />
(2015)<br />
% %<br />
Latte 1 2, 3, 4, 5<br />
e latticini<br />
Latte intero, pastorizzato, confezionato fr. / l - 1.45 1.44 -0.90 1.9<br />
Latte intero UHT standardizzato 35 g fr. / l - 1.25 1.23 -1.80 73.9<br />
Latte drink, pastorizzato, confezionato fr. / l - 1.49 1.44 -3.10 0.6<br />
Latte scremato UHT fr. / l - 1.16 1.17 1.30 1.6<br />
Emmentaler surchoix fr. / kg - 17.76 17.00 -4.30 0.1<br />
Gruyère surchoix fr. / kg - 19.99 23.34 16.80 0.0<br />
Tilsiter surchoix fr. / kg - 13.74 13.95 1.50 0.7<br />
Camembert 60% (grasso s.s.) fr. / kg - 19.04 18.93 -0.60 0.4<br />
Formaggio a pasta molle, a crosta fiorita fr. / kg - 18.56 17.90 -3.60 0.7<br />
Mozzarella fr. / kg - 8.45 8.28 -2.00 25.0<br />
Burro speziale fr. / kg - 13.35 12.81 -4.00 35.6<br />
Il Burro (burro da cucina) fr. / kg - 12.91 12.75 -1.20 37.6<br />
Panna intera, confezionata fr. / l - 6.11 5.88 -3.80 55.5<br />
Panna per caffè, confezinata fr. / l - 4.02 3.94 -2.10 32.1<br />
Yogurt, aromatizzato o alla frutta fr. / kg - 3.68 3.65 -0.80 43.4<br />
Carne di manzo 6<br />
Entrecôte fr. / kg - 33.75 35.37 4.80 3.2<br />
Fettine, noce fr. / kg - 26.39 26.44 0.20 1.5<br />
Arrosto, spalla fr. / kg - 16.88 16.49 -2.30 1.4<br />
Carne macinata fr. / kg - 9.75 11.77 20.70 1.9<br />
Carne di vitello 6<br />
Costolette fr. / kg - 39.43 36.34 -7.80 0.3<br />
Fettine, noce fr. / kg - 24.99 24.89 -0.40 1.0<br />
Spezzatino fr. / kg - 19.25 19.23 -0.10 1.0<br />
Carne suina 6<br />
Costolette fr. / kg - 11.77 11.38 -3.30 2.7<br />
Fettine, noce fr. / kg - 17.77 14.69 -17.30 1.6<br />
Arrosto, spalla fr. / kg - 11.27 10.35 -8.20 0.8<br />
Spezzatino, spalla fr. / kg - 10.50 9.22 -12.20 0.9<br />
Carne d’agnello, indigena, fresca 6<br />
Cosciotto senza osso femorale fr. / kg - 19.76 20.78 5.20 0.2<br />
Costolette fr. / kg - 45.84 42.74 -6.80 0.0<br />
Polli 6<br />
Indigeni, freschi fr. / kg - 7.14 7.22 1.10 1.3<br />
Petto fr. / kg - 18.98 18.93 -0.30 5.7<br />
Coscia fr. / kg - 8.30 8.79 5.90 3.3<br />
Uova 7<br />
Uova da allevamento al suolo, crude ct. / pz. 40.56 40.70 41.26 1.4 15.2<br />
Uova da allevamento al suolo, sode ct. / pz. 51.2 51.22 49.55 -3.3 6.3<br />
Uva da allevamento all’aperto estensivo, crude ct. / pz. 43.68 43.24 43.67 1.0 21.7<br />
Uova da allevamento all’aperto estensivo, sode ct. / pz. 64.76 64.34 63.50 -1.3 1.0<br />
Uova da allevamento al suolo, crude, importate ct. / pz. 31.49 30.67 28.95 -5.6 39.5<br />
Uova da allevamento al suolo, sode, importate ct. / pz. 42.69 42.27 41.37 -2.1 14.7<br />
Patate 8<br />
Patate resistenti alla cottura fr. / kg 1.29 1.25 1.27 1.6 27.9<br />
Patate farinose fr. / kg 1.26 1.06 1.19 12.3 3.0<br />
Raclette fr. / kg 1.29 1.15 1.23 7.0 7.5<br />
Patate resistenti alle alte temperature fr. / kg 1.1 1.26 1.23 -2.4 14.6<br />
Patate novelle fr. / kg 2.27 1.69 1.74 3.0 3.2<br />
Verdure (per conumo fresco; indigene ed estere) 9<br />
Carote (scorte) fr. / kg 1.42 1.66 1.62 -2.7 25.2<br />
Cipolle (scorte) fr. / kg 1.78 2.36 2.45 3.5 2.2<br />
Pomodori tondi fr. / kg 1.7 2.69 2.80 3.9 25.6<br />
Lattuga cappuccio 10 fr. / kg - 4.78 4.96 3.6 2.0<br />
Cavolfiore fr. / kg 2.72 2.56 2.59 1.2 3.1<br />
Cetrioli 11 fr. / kg 2.4 2.88 2.92 1.3 7.0<br />
1<br />
Quota di mercato rispetto all’offerta di latte di consumo nella fornitura e acquisto all’ingrosso<br />
2<br />
Quota di mercato rispetto all’offerta di formaggio nella fornitura e acquisto all’ingrosso<br />
3<br />
Quota di mercato rispetto all’offerta di burro nella fornitura e acquisto all’ingrosso<br />
4<br />
Quota di mercato rispetto all’offerta di panna di consumo nella fornitura e acquisto all’ingrosso<br />
5<br />
Quota di mercato rispetto all’offerta di yogurt nella fornitura e acquisto all’ingrosso<br />
6<br />
Quota di mercato rispetto all’offerta di carne fresca nel commercio all’ingrosso<br />
7<br />
Quota di mercato rispetto all’offerta di uova in guscio nel commercio all’ingrosso<br />
8<br />
Quota di mercato rispetto all’offerta di patate da tavola crude nella fornitura e acquisto all’ingrosso<br />
9<br />
Quota di mercato rispetto all’offerta di verdura fresca nel commercio all’ingrosso<br />
10 Coefficiente di conversione: 1 pz. = 0.3 kg<br />
11 Coefficiente di conversione: 1 pz.. = 0.5 kg<br />
Fonti:<br />
Grossopanel AG, Stans<br />
A28<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Prezzi nella fornitura e acquisto all’ingrosso Bio<br />
Prodotto Unità 2013 2014 2015 2014 Quota di mercato<br />
2015 sul segmento<br />
totale<br />
(2015)<br />
% %<br />
Carne di manzo 1<br />
Entrecôte, tagliato fr. / kg - 48.50 47.20 -2.7 >0,1<br />
Carne macinata fr. / kg - 17.35 19.20 10.8 >0,1<br />
Carne di vitello 1<br />
Costolette, tagliate fr. / kg - 42.72 42.00 -1.7 >0,1<br />
Fettine, noce fr. / kg - 23.82 21.40 -10.0 >0,1<br />
Spezzatino fr. / kg - 28.16 25.80 -8.2 >0,1<br />
Carne suina 1<br />
Arrosto, spalla fr. / kg - 19.60 - - -<br />
Uova 2<br />
Uova da allevamento al suolo, crude ct. / pz. 63.46 59.93 62.62 4.5 1.2<br />
Patate 3<br />
Patate resistenti alla cottura fr. / kg 2.16 2.26 2.36 4.6 >0,1<br />
Patate novelle fr. / kg 2.76 2.72 2.62 -3.5 >0,1<br />
Verdure (per conumo fresco; indigene ed estere) 4<br />
Carote (scorte) fr. / kg 3.24 3.01 2.77 -8.0 >0,1<br />
Cipolle (scorte) fr. / kg 3.96 4.20 4.06 -3.3 >0,1<br />
Pomodori tondi fr. / kg 2.56 6.02 5.85 -2.8 >0,1<br />
Lattuga cappuccio 5 fr. / kg - 9.46 9.74 3.0 >0,1<br />
Cavolfiore fr. / kg 5.36 6.34 6.53 3.0 >0,1<br />
Cetrioli 6 fr. / kg 4.27 6.77 6.14 -9.3 >0,1<br />
1<br />
Quota di mercato rispetto all’offerta di carne fresca nel commercio all’ingrosso<br />
2<br />
Quota di mercato rispetto all’offerta di uova in guscio nel commercio all’ingrosso<br />
3<br />
Quota di mercato rispetto all’offerta di patate da tavola crude nella fornitura e acquisto all’ingrosso<br />
4<br />
Quota di mercato rispetto all’offerta di verdura fresca nel commercio all’ingrosso<br />
5 Coefficiente di conversione: 1 pz. = 0.3 kg<br />
6 Coefficiente di conversione 1 pz. = 0.5 kg<br />
Fonti:<br />
Grossopanel AG, Stans<br />
AB16_Markt_Anhang_Tabellen_3_12_Tab_LAGHpreise_Bio_i.xlsx<br />
Bio 18.10.16<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A29
Prezzi al consumo, Bio escl.<br />
Prodotto Unità 2000/02 2013 2014 2015 2000/02–<br />
2013/15<br />
%<br />
Latte e latticini<br />
Latte intero, pastorizzato, confezionato fr. / l 1.55 1.45 1.49 1.46 -5.6<br />
Latte intero UHT standardizzato 35 g 1 fr. / l 1.55 1.26 1.32 1.29 -16.8<br />
Latte drink, pastorizzato, confezionato fr. / l 1.55 1.42 1.46 1.44 -7.0<br />
Latte scremato UHT fr. / l 1.44 1.49 1.53 1.48 4.4<br />
Emmentaler surchoix fr. / kg 20.37 16.72 18.61 19.09 -10.9<br />
Gruyère surchoix fr. / kg 20.47 19.06 19.44 19.39 -5.7<br />
Tilsiter surchoix fr. / kg 17.66 15.14 16.58 16.81 -8.4<br />
Camembert 60% (grasso s.s.) fr. / 125 g 2.68 2.33 2.38 2.33 -12.6<br />
Formaggio a pasta molle, a crosta fiorita fr. / 150 g 3.50 3.37 3.42 3.40 -2.9<br />
Mozzarella fr. / 150 g 2.35 1.47 1.52 1.49 -36.4<br />
Burro speziale fr. / 200 g 3.10 2.98 3.04 2.99 -2.9<br />
Il Burro (burro da cucina) fr. / 250 g 3.01 3.05 3.15 3.03 2.2<br />
Panna intera, confezionata fr. / 1/2 l 4.89 3.27 3.34 3.22 -32.9<br />
Panna per caffè, confezinata fr. / 1/2 l 2.52 1.82 1.84 1.79 -27.8<br />
Yogurt, aromatizzato o alla frutta fr. / 180 g 0.69 0.57 0.56 0.56 -18.2<br />
Carne di manzo<br />
Entrecôte, tagliato fr. / kg 49.80 65.51 67.18 69.14 35.1<br />
Fettine, noce fr. / kg 38.77 46.66 45.48 45.68 18.5<br />
Arrosto, spalla fr. / kg 26.68 31.86 31.73 32.00 19.4<br />
Carne macinata fr. / kg 15.47 16.56 18.10 17.99 13.4<br />
Carne di vitello<br />
Costolette, tagliate fr. / kg 40.89 50.49 51.44 54.48 27.5<br />
Fettine, noce fr. / kg 34.44 36.66 39.02 40.26 12.2<br />
Spezzatino fr. / kg 28.68 34.83 37.33 37.73 27.7<br />
Carne suina<br />
Costolette, tagliate fr. / kg 20.31 20.94 19.82 19.23 -1.6<br />
Fettine, noce fr. / kg 26.06 26.60 26.25 23.81 -1.9<br />
Arrosto, spalla fr. / kg 19.09 18.22 18.62 17.48 -5.1<br />
Spezzatino, spalla fr. / kg 18.02 17.91 18.42 16.98 -1.4<br />
Carne d’agnello, indigena, fresca<br />
Cosciotto senza osso femorale fr. / kg 27.85 34.12 36.01 34.52 25.3<br />
Costolette, tagliate fr. / kg 34.21 35.33 36.16 35.87 4.6<br />
Prodotti carnei<br />
Prosciutto cotto a fette fr. / kg 28.62 30.53 31.18 29.83 6.6<br />
Cervelat fr. / 100 g 1.16 0.98 1.07 1.02 -11.6<br />
Wienerli fr. / 100 g 1.56 1.43 1.50 1.43 -7.1<br />
Bratwurst di vitello fr. / 100 g 1.76 1.68 1.73 1.78 -1.5<br />
Salame indigeno I, affettato fr. / 100 g 3.82 4.85 4.92 4.90 27.9<br />
Polli<br />
Indigeni, freschi fr. / kg 8.99 9.05 8.81 8.92 -0.7<br />
Petto fr. / kg - 31.94 29.80 29.01 -<br />
Coscia - 12.99 11.15 11.36 -<br />
Uova 1<br />
Uova da allevamento al suolo, crude ct. / pz. 47.76 45.05 45.13 44.30 -6.1<br />
Uova da allevamento al suolo, sode ct. / pz. 57.01 60.23 59.87 59.44 5.0<br />
Uova da allevamento all’aperto estensivo, crude ct. / pz. 61.99 61.77 63.24 62.63 0.9<br />
Uova da allevamento all’aperto estensivo, sode ct. / pz. 75.40 82.65 83.74 81.38 9.5<br />
Uova da allevamento al suolo, crude, importate ct. / pz. 31.00 30.15 28.89 27.45 -7.0<br />
Uova da allevamento al suolo, sode, importate ct. / pz. 39.97 33.87 32.00 32.77 -17.7<br />
Farina e pane 2<br />
Farina bigia fr. / kg - 1.92 1.87 1.93 -<br />
Farina semibianca fr. / kg - 1.95 1.98 2.02 -<br />
Farina bianca fr. / kg - 1.76 1.76 1.81 -<br />
Farina del segmento di prezzo basso fr. / kg - 0.90 0.89 0.90 -<br />
Pane bigio fr. / kg - 2.24 2.26 2.32 -<br />
Pane semibianco fr. / kg - 2.33 2.35 2.40 -<br />
Patate 3<br />
Patate resistenti alla cottura fr. / kg 1.96 1.67 1.54 1.56 -18.7<br />
Patate farinose fr. / kg 1.79 1.67 1.66 1.64 -7.1<br />
Raclette fr. / kg 1.79 1.82 1.60 1.64 -5.5<br />
Patate resistenti alle alte temperature fr. / kg 1.71 1.62 1.56 1.62 -6.7<br />
Patate novelle fr. / kg 1.82 2.29 1.75 1.96 9.9<br />
Zucchero cristallizzato fr. / kg 1.43 1.19 1.18 1.04 -20.7<br />
Frutta 4<br />
Mele: Goden Delicious, classe I 5 fr. / kg 3.57 3.34 3.43 3.25 -8.1<br />
Pere: Conférence, classe I 5 fr. / kg 3.53 3.90 3.73 3.61 4.2<br />
Albicocche, classe I 5 fr. / kg 5.50 7.02 7.29 6.55 26.7<br />
Ciliegie, classe I 5 fr. / kg 9.27 11.08 10.56 11.06 22.1<br />
Prugne; classe I 5 fr. / kg 3.96 4.55 4.29 4.25 13.5<br />
Fragole fr. / kg 10.03 12.61 12.74 12.06 24.3<br />
Verdure 4<br />
Carote (scorte) fr. / kg 2.00 2.39 2.49 2.30 19.7<br />
Cipolle (scorte) fr. / kg 2.20 2.40 2.42 2.28 7.5<br />
Sedano rapa (scorte) fr. / kg 3.59 4.65 4.94 4.59 31.6<br />
Pomodori tondi fr. / kg 3.48 3.76 3.79 3.72 8.0<br />
Lattuga cappuccio fr. / pz. 1.72 1.84 1.72 1.52 -1.5<br />
Cavolfiore fr. / kg 3.95 4.15 3.89 3.82 0.1<br />
Cetrioli fr. / pz. 1.60 1.52 1.42 1.22 -13.4<br />
1<br />
2000/02: per mancanza d’informazioni si utilizza la media 2002/04<br />
2 500 grammi di peso e 4 chilogrammi di peso per la farina nel segmento di prezzo basso sono convertiti in 1 chilogrammo<br />
3<br />
2000/02: per mancanza d’informazioni si utilizzano i dati del 2005<br />
4 Consumo fresco; provenienza svizzera ed estera<br />
5 Media degli anni 2000/ 03; Variazione 2000/ 03-2012/ 15<br />
Fonti:<br />
Latte, uova, carne (paniere con carne label e convenzionale)<br />
Farina e pane, patate, frutta e verdura: UFAG<br />
Zucchero cristallizzato: UST<br />
A30<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Prezzi al consumo Bio<br />
Prodotto Unità 2002/04 2013 2014 2015 2002/04–<br />
2013/15<br />
%<br />
Latte e latticini<br />
Latte intero, pastorizzato, confezionato 1 l - 1.76 1.78 1.78 -<br />
Latte intero UHT standardizzato 1 l - 1.79 1.81 1.80 -<br />
Latte drink, pastorizzato, confezionato 1 l - 1.73 1.78 1.78 -<br />
Emmentaler 1 kg - 18.93 19.34 19.77 -<br />
Gruyère 1 kg - 20.51 21.73 21.63 -<br />
Tilsiter 1 kg - 19.66 19.73 19.80 -<br />
Mozzarella 150 g - 2.22 2.13 2.10 -<br />
Burro speziale 200 g - 3.73 3.78 3.79 -<br />
Panna intera, confezionata 2 dl - 2.61 2.63 2.63 -<br />
Yogurt, aromatizzato o alla frutta 180 g - 0.75 0.74 0.75 -<br />
Carne di manzo 1<br />
Entrecôte, tagliato fr. / kg - 75.36 78.74 82.38 -<br />
Fettine, noce fr. / kg - 53.62 54.66 54.90 -<br />
Carne di vitello 1<br />
Fettine, lombata fr. / kg - 83.72 84.21 86.29 -<br />
Fettine, noce fr. / kg - 81.12 83.43 83.64 -<br />
Carne suina<br />
Fettine, lonza fr. / kg - 44.15 45.47 43.87 -<br />
Costolette, tagliate fr. / kg - 25.44 26.05 26.61 -<br />
Fettine, noce fr. / kg - 39.03 39.11 38.88 -<br />
Prodotti carnei 1<br />
Wienerli fr. / 100 g - 1.71 1.80 1.95 -<br />
Bratwurst di vitello fr. / 100 g - 5.23 5.31 5.30 -<br />
Salame indigeno I, affettato fr. / 100 g - 2.27 2.29 2.26 -<br />
Polli 1<br />
Indigeni, freschi fr. / kg - 18.69 18.74 18.81 -<br />
Petto fr. / kg - 56.56 52.99 53.47 -<br />
Uova<br />
Uova da allevamento al suolo, crude ct. /pz. 80.49 81.13 82.12 81.08 1.2<br />
Uova da allevamento al suolo, sode ct. /pz. 92.69 94.23 93.69 95.93 2.1<br />
Patate 2<br />
Patate resistenti alla cottura fr. / kg 2.70 2.93 2.88 2.90 7.6<br />
Patate farinose fr. / kg 2.84 3.05 3.03 2.93 5.5<br />
Raclette fr. / kg 3.03 3.08 3.01 2.89 -1.4<br />
Patate resistenti alle alte temperature fr. / kg 2.69 3.01 3.02 2.79 9.4<br />
Patate novelle fr. / kg 2.96 4.51 3.19 - 30.2<br />
Frutta 3<br />
Mele: Goden Delicious, classe I 5 fr. / kg 5.57 5.99 6.24 5.99 7.9<br />
Pere: Conférence, classe I 5 fr. / kg 5.64 5.98 6.15 6.14 7.0<br />
Albicocche, classe I 5 fr. / kg 8.48 10.45 10.15 10.60 21.5<br />
Ciliegie, classe I 5 fr. / kg 12.40 14.95 13.93 14.56 14.2<br />
Prugne; classe I 5 fr. / kg 6.36 8.66 9.28 9.90 41.8<br />
Fragole fr. / kg 16.00 14.36 15.02 12.55 -12.6<br />
Verdure 3<br />
Carote (scorte) fr. / kg 3.39 3.67 3.87 3.98 13.3<br />
Cipolle (scorte) fr. / kg 5.28 5.68 5.80 5.86 9.5<br />
Sedano rapa (scorte) fr. / kg 6.16 7.99 8.21 8.38 33.0<br />
Pomodori tondi fr. / kg 6.28 5.60 6.25 6.59 -2.1<br />
Lattuga cappuccio fr. / pz. 2.65 3.04 2.92 2.71 9.1<br />
Cavolfiore fr. / kg 6.48 6.64 6.30 6.65 0.8<br />
Cetrioli fr. / pz. 2.88 2.60 2.59 2.39 -12.3<br />
1 2011: set.-dic.<br />
2 Nessun dato per gli anni 2002/04, bensì per il 2005<br />
3 Consumo fresco; provenienza svizzera ed estera<br />
4 Nel 2015 nel campione non figuravano le patate novelle da tavola bio<br />
5 Media degli anni 2002/05; Variazione 2002/05 - 2012/15<br />
Fonti:<br />
Latte, uova, carne (paniere con carne label e convenzionale), patate, verdure: UFAG<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
AB16_Markt_Anhang_Tabellen_3_12_Tab_Kpreise_Bio_i.xlsx<br />
Bio 18.10.16<br />
A31
Paniere delle merci non bio 1<br />
Prodotti Unità Ponderazione 2014 2015<br />
Variazione anno<br />
precedente 2<br />
%<br />
Latte Fr. 27.45 27.03 -1.5<br />
Latte intero Fr. / litro 8.6 l 1.40 1.38 -2.0<br />
Gruyère Fr. / kg 200 g 17.90 17.87 -0.2<br />
Mozzarella Fr. / kg 210 g 10.15 9.90 -2.5<br />
Emmentaler Fr. / kg 150 g 16.99 17.28 +1.7<br />
Burro speciale Fr. / kg 110 g 15.22 14.97 -1.6<br />
Panna intera Fr. / litro 4.5 dl 6.69 6.44 -3.7<br />
Yogurt alla frutta, frutti di bosco Fr. / kg 500 g 3.14 3.13 -0.3<br />
Yogurt naturale Fr. / kg 350 g 2.44 2.38 -2.4<br />
Carne Fr. 47.52 47.21 -0.7<br />
Entrecôte di manzo Fr. / kg 120 g 67.18 69.14 +2.9<br />
Scaloppine di manzo Fr. / kg 100 g 45.48 45.68 +0.5<br />
Bistecche di vitello (lombata) Fr. / kg 60 g 72.41 76.58 +5.8<br />
Scaloppine di vitello (coscia) Fr. / kg 40 g 68.12 70.45 +3.4<br />
Bistecche di maiale (lonza) Fr. / kg 170 g 36.30 34.52 -4.9<br />
Cotolette di maiale Fr. / kg 210 g 19.82 19.23 -3.0<br />
Scaloppine di maiale (coscia) Fr. / kg 180 g 26.25 23.81 -9.3<br />
Salame CH Fr. / 100g 80 g 4.92 4.90 -0.3<br />
Wienerli Fr. / 100g 310 g 1.50 1.43 -4.5<br />
Bratwurst di vitello Fr. / 100g 470 g 1.73 1.78 +3.2<br />
Pollo intero Fr. / kg 720 g 8.81 8.92 +1.2<br />
Petto di pollo Fr. / kg 160 g 29.80 29.01 -2.6<br />
Uova da allevamento all'aperto, fresche Fr. 17.26 17.16 -0.6<br />
Confezione da 6 Fr. / uovo 18 Stk. 0.64 0.63 -1.5<br />
Confezione da 10 Fr. / uovo 10 Stk. 0.58 0.59 +1.4<br />
Patate 3 Fr. 4.55 4.60 +1.0<br />
Resistenti alla cottura Fr. / kg 1.5 kg 1.55 1.57 +1.4<br />
Farinose Fr. / kg 650 g 1.63 1.63 0.0<br />
Raclette Fr. / kg 360 g 1.61 1.64 +1.7<br />
Adatte alle alte temperature Fr. / kg 370 g 1.60 1.62 +1.0<br />
Frutta 3 Fr. 9.58 9.60 +0.2<br />
Mele, Gala, classe I Fr. / kg 630 g 3.35 3.58 +7.1<br />
Banane Fr. / kg 1.2 kg 2.89 2.78 -3.5<br />
Arance Fr. / kg 890 g 2.69 2.66 -1.2<br />
Kiwi Fr. / pz 2.5 Stk. 0.64 0.65 +1.5<br />
Verdura 3 Fr. 23.61 24.00 +1.7<br />
Carote Fr. / kg 1.2 kg 2.44 2.36 -3.1<br />
Pomodori tondi Fr. / kg 450 g 3.78 3.76 -0.4<br />
Pomodori a grappolo Fr. / kg 450 g 3.89 3.94 +1.4<br />
Cetrioli Fr. / pz 1.5 Stk. 1.33 1.29 -3.0<br />
Zucchine Fr. / kg 370 g 3.85 4.27 +11.0<br />
Insalata iceberg Fr. / kg 400 g 3.37 3.40 +0.9<br />
Cipolle (gialle) Fr. / kg 240 g 2.40 2.31 -3.6<br />
Cavolfiore Fr. / kg 330 g 3.78 3.97 +5.0<br />
Finocchi Fr. / kg 260 g 4.10 4.36 +6.3<br />
Broccoli Fr. / kg 250 g 4.42 4.65 +5.1<br />
Lattuga cappuccio Fr. / kg 240 g 1.68 1.56 -6.9<br />
Porri Fr. / kg 160 g 4.28 4.55 +6.3<br />
Funghi prataioli Fr. / kg 210 g 12.05 12.62 +4.7<br />
Barbabietole al vapore Fr. / kg 180 g 3.96 4.19 +5.8<br />
Sedano rapa Fr. / kg 150 g 4.82 4.75 -1.3<br />
Coste Fr. / kg 70 g 5.72 5.73 +0.2<br />
Melanzane Fr. / kg 150 g 4.43 4.51 +1.7<br />
Valerianella Fr. / kg 60 g 28.92 29.84 +3.2<br />
Farina Fr. 2.46 2.52 +2.6<br />
Farina bianca Fr. / kg 1.4 kg 1.76 1.80 +2.6<br />
Paniere delle merci totale Fr. 132.42 132.12 -0.2<br />
1<br />
Non si osserva il consumo totale, bensì quello di una specifica gamma di prodotti (prevalentemente freschi) di cui l'Osservazione del mercato rileva i<br />
prezzi nel commercio al dettaglio. Tali rilevazioni non includono i prezzi dei discount, tranne che nel caso di latte e uova.<br />
2<br />
Le cifre in grassetto indicano una variazione superiore al 3.5%<br />
3<br />
I prezzi medi annuali possono essere composti in parte dal calcolo dei prezzi mensili.<br />
Fonte: UFAG, Settore Osservazione del mercato; Nielsen Svizzera, UFAG Pannello dei consumatori<br />
A32<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
AB16_Markt_Anhang_Tabellen_3_12_Tab_Kpreise_Warenkorb_konv_i.xlsx<br />
Panier-type non bio 18.10.16
Paniere delle merci bio 1<br />
Prodotti Unità Ponderazione 2014 2015<br />
Variazione anno<br />
precedente 2<br />
%<br />
Latte Fr. 36.91 36.88 -0.1<br />
Latte intero Fr. / litro 8.6 l 1.80 1.79 -0.3<br />
Gruyère Fr. / kg 200 g 21.73 21.63 -0.5<br />
Mozzarella Fr. / kg 210 g 14.17 14.02 -1.1<br />
Emmentaler Fr. / kg 150 g 19.34 19.77 +2.3<br />
Burro speciale Fr. / kg 110 g 18.91 18.95 +0.2<br />
Panna intera Fr. / litro 4.5 dl 13.17 13.14 -0.2<br />
Yogurt alla frutta, frutti di bosco Fr. / kg 500 g 4.13 4.15 +0.3<br />
Yogurt naturale Fr. / kg 350 g 3.32 3.33 +0.3<br />
Carne Fr. 67.57 68.13 +0.8<br />
Entrecôte di manzo Fr. / kg 120 g 78.74 82.38 +4.6<br />
Scaloppine di manzo Fr. / kg 100 g 54.66 54.90 +0.4<br />
Bistecche di vitello (lombata) Fr. / kg 60 g 84.21 86.29 +2.5<br />
Scaloppine di vitello (coscia) Fr. / kg 40 g 83.43 83.64 +0.3<br />
Bistecche di maiale (lonza) Fr. / kg 170 g 45.47 43.87 -3.5<br />
Cotolette di maiale Fr. / kg 210 g 26.05 26.61 +2.1<br />
Scaloppine di maiale (coscia) Fr. / kg 180 g 39.11 38.88 -0.6<br />
Salame CH Fr. / 100g 80 g 5.31 5.30 -0.2<br />
Wienerli Fr. / 100g 310 g 1.80 1.95 +8.2<br />
Bratwurst di vitello Fr. / 100g 470 g 2.29 2.26 -1.4<br />
Pollo intero Fr. / kg 720 g 18.74 18.81 +0.4<br />
Petto di pollo Fr. / kg 160 g 52.99 53.47 +0.9<br />
Uova da allevamento all'aperto, fresche Fr. 22.35 22.18 -0.7<br />
Confezione da 6 Fr. / uovo 18 Stk. 0.81 0.81 +0.1<br />
Confezione da 10 Fr. / uovo 10 Stk. 0.78 0.76 -2.3<br />
Patate 3 Fr. 8.62 8.40 -2.5<br />
Resistenti alla cottura Fr. / kg 1.5 kg 2.93 2.89 -1.3<br />
Farinose Fr. / kg 650 g 3.06 2.93 -4.3<br />
Raclette Fr. / kg 360 g 3.09 2.99 -3.3<br />
Adatte alle alte temperature Fr. / kg 370 g 3.02 2.92 -3.2<br />
Frutta 3 Fr. 12.47 12.43 -0.3<br />
Mele, Gala, classe I Fr. / kg 630 g 6.22 6.32 +1.6<br />
Banane Fr. / kg 1.2 kg 3.07 3.11 +1.2<br />
Arance Fr. / kg 890 g 3.41 3.29 -3.5<br />
Kiwi Fr. / pz 2.5 Stk. 0.73 0.71 -2.1<br />
Verdura 3 Fr. 38.60 37.84 -2.0<br />
Carote Fr. / kg 1.2 kg 3.87 3.98 +2.9<br />
Pomodori tondi Fr. / kg 450 g 6.25 6.59 +5.3<br />
Pomodori a grappolo Fr. / kg 450 g 6.36 6.26 -1.6<br />
Cetrioli Fr. / pz 1.5 Stk. 2.59 2.39 -8.0<br />
Zucchine Fr. / kg 370 g 6.18 6.50 +5.3<br />
Insalata iceberg Fr. / kg 400 g 7.11 6.60 -7.1<br />
Cipolle (gialle) Fr. / kg 240 g 5.80 5.86 +1.0<br />
Cavolfiore Fr. / kg 330 g 6.30 6.65 +5.6<br />
Finocchi Fr. / kg 260 g 6.90 6.70 -2.9<br />
Broccoli Fr. / kg 250 g 6.93 6.92 -0.2<br />
Lattuga cappuccio Fr. / kg 240 g 2.92 2.71 -7.3<br />
Porri Fr. / kg 160 g 7.40 7.64 +3.2<br />
Funghi prataioli Fr. / kg 210 g 15.62 13.86 -11.3<br />
Barbabietole al vapore Fr. / kg 180 g 4.88 4.86 -0.3<br />
Sedano rapa Fr. / kg 150 g 8.21 8.38 +2.1<br />
Coste Fr. / kg 70 g 7.61 7.47 -1.9<br />
Melanzane Fr. / kg 150 g 7.40 6.90 -6.7<br />
Valerianella Fr. / kg 60 g 38.07 35.27 -7.3<br />
Farina Fr. 4.13 4.30 +4.1<br />
Farina bianca Fr. / kg 1.4 kg 2.95 3.07 +4.1<br />
Paniere delle merci totale Fr. 190.65 190.16 -0.3<br />
1<br />
Non si osserva il consumo totale, bensì quello di una specifica gamma di prodotti (prevalentemente freschi) di cui l'Osservazione del mercato rileva i<br />
prezzi nel commercio al dettaglio. Tali rilevazioni non includono i prezzi dei discount, tranne che nel caso di latte e uova.<br />
2<br />
Le cifre in grassetto indicano una variazione superiore al 3.5%<br />
3<br />
I prezzi medi annuali possono essere composti in parte dal calcolo dei prezzi mensili.<br />
Fonte: UFAG, Settore Osservazione del mercato; Nielsen Svizzera, UFAG Pannello dei consumatori<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A33<br />
AB16_Markt_Anhang_Tabellen_3_12_Tab_Kpreise_Warenkorb_Bio_i.xlsx<br />
Paniere delle merci bio 18.10.16
Superficie agricola utile secondo le forme di utilizzo<br />
Prodotto 2000/02 2013 2014 2015 1 2000/02–<br />
2013/15<br />
ha ha ha ha %<br />
Cereali 178 576 147 462 141 052 141 417 -19.1<br />
Cereali panificabili 96 527 84 445 82 227 81 827 -13.9<br />
Frumento 91 045 79 134 76 707 75 931 -15.1<br />
Spelta 1 878 3 250 3 541 3 907 89.9<br />
Farro, piccola spelta 46 177 50 67 113.0<br />
Segale 3 518 1 861 1 899 1 890 -46.5<br />
Miscele di cereali panificabili 39 23 30 32 -27.4<br />
Cereali da foraggio 82 049 63 017 58 825 59 590 -26.3<br />
Frumento - 6 517 6 430 6 381<br />
Orzo 42 916 28 574 26 818 27 986 -35.2<br />
Avena 4 342 1 675 1 494 1 556 -63.7<br />
Miscele di cereali da foraggio 311 207 182 192 -37.7<br />
Mais da granella 22 280 16 859 15 713 15 322 -28.4<br />
Triticale 12 201 9 147 8 130 8 090 -30.7<br />
Miglio - 38 58 63<br />
Leguminose 3 514 4 111 4 329 5 016 27.6<br />
Piselli da foraggio (proteici) 3 165 3 619 3 759 4 355 23.6<br />
Favette 294 426 493 556 67.0<br />
Lupini 55 66 77 105 50.3<br />
Sarchiate 34 229 31 558 32 965 31 180 -6.8<br />
Patate (comprese quelle da semina) 13 799 11 039 11 341 10 891 -19.6<br />
Barbabietole da zucchero 17 886 19 893 21 040 19 759 13.1<br />
Barbabietole da foraggio (zuccherine e semizuccherine) 2 544 626 584 530 -77.2<br />
Semi oleosi 18 535 27 106 28 686 29 769 53.9<br />
Colza 13 126 21 726 23 184 23 432 73.6<br />
Girasole 4 389 3 927 3 957 4 568 -5.4<br />
Soia 989 1 407 1 496 1 719 55.8<br />
Zucche per l’estrazione d’olio 32 46 49 50 52.6<br />
Materie prime rinnovabili 1 304 558 6 21 -85.0<br />
Colza 1 137 519 0 0 -84.8<br />
Girasole 35 33 0 0 -68.6<br />
Altre (kenaf, canapa, ecc.) 132 6 6 21 -91.7<br />
Verdure in pieno campo 8 489 9 944 10 432 10 865 22.7<br />
Mais verde e da silo 40 652 46 334 46 399 45 904 13.7<br />
Maggese verde e fiorito 3 392 2 608 2 657 3 014 18.6<br />
Altra superficie coltiva aperta 1 770 2 147 4 948 5 630 139.6<br />
Superficie coltiva aperta 290 462 271 828 271 474 272 816 -6.3<br />
Prati artificiali 117 671 131 073 127 953 125 060 8.8<br />
Altra superficie coltiva 2 427 752 800 477 -72.1<br />
Totale superficie coltiva 410 560 403 653 400 227 398 353 -2.4<br />
Frutticoltura 6 913 6 407 6 321 6 280 -8.4<br />
Viticoltura 15 053 14 883 14 835 14 793 -1.4<br />
Miscanthus sinensis 257 240 206 142 -27.4<br />
Prati naturali, pascoli 627 938 609 686 613 155 612 901 -2.6<br />
Altro utilizzo nonché strame e torba 10 410 15 054 22 760 17 009 55.4<br />
Superficie agricola utile 1 071 131 1 049 923 1 051 183 1 049 478 -2.0<br />
1<br />
Dati provvisori<br />
Fonti: viticoltura e frutticoltura: UFAG (statistica delle superfici / obst.ch, l’anno viticolo); altri prodotti: USC, UST<br />
A34<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
AB16_Markt_Anhang_Tabellen_3_12_Tab3_land_Nutzflaeche_i.xlsx<br />
Tab3 18.10.16
Produzione<br />
Prodotto Unità 2000/02 2013 2014 2015 1 2000/02–<br />
2013/15<br />
%<br />
Latte e latticini<br />
Latte di consumo t 505 764 480 552 471 527 455 368 -7.2<br />
Panna t 68 213 70 820 69 080 70 461 2.8<br />
Burro t 40 247 46 630 48 436 46 844 17.5<br />
Latte in polvere t 47 152 48 101 57 009 50 454 10.0<br />
Formaggio t 166 668 182 705 185 331 188 806 11.4<br />
Carne e uova<br />
Carne di manzo t PM 101 111 111 926 112 900 112 153 11.1<br />
Carne di vitello t PM 34 202 31 026 30 301 29 103 -11.9<br />
Carne suina t PM 231 645 235 483 242 024 241 322 3.4<br />
Carne di agnello t PM 5 787 4 798 4 940 4 776 -16.4<br />
Carne caprina t PM 534 508 466 549 -5.0<br />
Carne equina t PM 1 164 747 691 650 -40.2<br />
Pollame t peso di vendita 29 435 51 013 54 023 55 647 82.0<br />
Uova in guscio mio. di pezzi 689 812 837 868 21.7<br />
Cereali 1 112 267 837 936 963 545 891 386<br />
Frumento panificabile t 521 667 413 068 474 338 456 774 -14.0<br />
Frumento da foraggio t - 53 498 60 406 55 703<br />
Segale t 20 833 10 257 12 939 11 918 -44.0<br />
Orzo t 255 500 164 839 201 091 197 842 -26.0<br />
Avena t 22 533 7 934 8 444 7 772 64.0<br />
Mais da granella t 206 333 123 916 138 474 95 427 -42.0<br />
Triticale t 75 067 50 424 50 477 49 911 -33.0<br />
Altri t 10 333 14 000 17 376 16 039 53.0<br />
Sarchiate<br />
Patate t 539 933 363 800 504 000 365 000 -24.0<br />
Barbabietole da zucchero t 1 288 852 1 376 289 1 924 260 1 355 710 20.0<br />
Semi oleosi 59 956 85 202 107 949 101 199<br />
Colza t 43 684 72 510 93 945 87 004 93.0<br />
Girasole t 12 972 8 641 9 730 9 782 -27.0<br />
Altri t 3 300 4 051 4 274 4 413 28.0<br />
Frutta (da tavola)<br />
Mele t 99 540 (2) 109 242 117 479 112 529 17. (3)<br />
Pere t 15 523 (2) 15 764 19 843 16 839 12.6 (3)<br />
Albicocche t 1 485 (2) 6 565 7 490 5 530 339.6 (3)<br />
Ciliegie t 1 810 (2) 1 643 3 412 2 194 33.5 (3)<br />
Prugne t 2 418 (2) 3 330 3 826 3 147 42.1 (3)<br />
Fragole t 5 064 6 995 8 725 7 326 51.7<br />
Verdure (fresche)<br />
Carote (incl. carote gialle) t 56 474 60 458 60 940 63 815 9.3<br />
Cipolle (tutte) t 26 126 40 459 39 209 39 123 51.6<br />
Sedano rapa t 10 359 10 662 10 885 10 861 4.3<br />
Pomodori (tutti) t 30 398 50 399 48 807 45 728 58.9<br />
Lattuga cappuccio (incl. foglia di quercia) t 16 514 13 646 14 429 13 818 -15.4<br />
Cavolfiore (tutti) t 6 474 7 309 7 263 8 169 17.1<br />
Cetrioli (per insalata / nostrani) t 8 823 12 493 13 754 14 472 53.8<br />
Vino<br />
Vino rosso hl 574 245 440 904 489 721 454 443 -19.6<br />
Vino bianco hl 613 076 397 725 443 928 396 006 -32.7<br />
1<br />
Dati provvisori<br />
2 Media degli anni 2000/03<br />
3<br />
Variazione 2000/03 - 2012/15<br />
Fonti:<br />
Latte e latticini: TSM<br />
Carne: Proviande<br />
Uova: Aviforum<br />
Cereali, sarchiate e semi oleosi: USC<br />
Frutta: Associazione svizzera frutta, Interprofessione frutti e verdure di Vallese<br />
Verdura: Centrale svizzera dell'orticoltura e delle colture speciali<br />
Vino: UFAG, Cantoni<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A35<br />
AB16_Markt_Anhang_Tabellen_3_12_Tab5_Produktion_i.xlsx Tab5 18.10.16
Commercio estero<br />
Prodotto<br />
2000/02<br />
2013<br />
2000/02–<br />
2013/15<br />
Esportazioni<br />
t<br />
Importazioni<br />
Esportazioni<br />
t<br />
Importazioni<br />
Esportazioni<br />
t<br />
Importazioni<br />
Esportazioni<br />
t<br />
Importazioni<br />
Esportazioni<br />
%<br />
Importazioni<br />
Latte e latticini<br />
Latte 19 22 919 3 725 21 742 3 054 22 567 3 767 23 474 18 402 - 1.4<br />
Yogurt 3 494 148 5 156 11 442 4 875 10 505 4 882 10 453 42 7 197.3<br />
Panna 918 246 1 814 1 783 1 322 1 422 3 350 1 582 135 547.8<br />
Burro 447 4 960 61 640 3 126 207 1 890 191 278 - 93.0<br />
Latte in polvere 11 688 1 076 5 658 469 11 717 489 8 536 622 -26 - 51.0<br />
Formaggio e ricotta 52 295 31 087 62 883 52 149 63 677 53 845 64 231 55 432 22 73.1<br />
Carne, uova e pesce 5<br />
Carne di manzo 876 7 849 1 788 25 813 4 638 23 200 4 246 22 563 306 204.0<br />
Carne di vitello 0 1 115 63 573 36 632 56 661 - - 44.2<br />
Carne suina 249 9 753 1 449 14 892 2 404 13 630 2 326 9 174 727 28.8<br />
Carne ovina 0 6 940 3 5 960 1 6 161 1 6 739 - - 9.4<br />
Carne caprina 0 359 9 227 0 270 0 264 - - 29.3<br />
Carne equina 0 4 117 0 4 209 0 3 448 0 3 241 - - 11.8<br />
Pollame 4 332 42 770 1 753 44 532 1 389 46 266 905 46 872 307 7.3<br />
Sottoprodotti della<br />
19 865 16 827 19 264 17 494 18 707 16 558 - -<br />
macellazione 3<br />
Uova (mio. pezzi dal 2014) 6 0 24 831 83 32 483 0 594 - -<br />
Pesce, crostacei e<br />
molluschi<br />
83 34 759 582 73 682 700 71 931 73 344 669 110.0<br />
Cereali<br />
Frumento 74 284 629 167 436 837 908 419 905 1 551 397 284 1 082 46.0<br />
Segale 1 7 250 51 10 293 0 5 856 4 4 976 1 733 - 2.8<br />
Orzo 11 52 079 534 61 267 503 91 129 371 68 988 4 166 41.0<br />
Avena 5 540 50 469 1 44 559 10 44 934 7 48 581 -99 - 8.8<br />
Mais da granella 196 26 496 187 103 998 153 140 922 173 131 495 -13 373.0<br />
Sarchiate<br />
Patate 3 313 30 709 3 326 48 530 3 821 40 161 4 395 37 810 16 35.0<br />
Zucchero 152 572 188 008 143 752 152 787 156 607 145 490 113 822 95 458 -10 - 30.0<br />
Semi oleosi<br />
Semi oleosi 699 105 697 529 43 629 542 41 110 3 081 36 802 1 - 62.0<br />
Oli e grassi vegetali 7 327 95 762 1 550 126 595 1 581 126 150 1 736 124 150 1 31.5<br />
Frutta (fresca)<br />
Mele 1,2 1 352 8 591 1 322 11 181 1 882 6 826 1 168 6 361 12 - 14.5<br />
Pere 1,2 125 8 786 90 11 709 245 9 082 58 7 260 -17 - 0.2<br />
Albicocche 1,2 31 9 154 100 7 859 100 7 621 62 9 421 187 - 10.5<br />
Ciliegie 1,2 7 3 373 17 3 773 137 3 772 13 3 064 512 - 0.2<br />
Prugne e susine 1,2 15 5 249 80 7 537 69 5 746 34 6 422 277 29.6<br />
Fragole 23 11 424 30 14 333 13 13 022 38 14 421 16 21.9<br />
Uva 60 38 447 110 35 145 118 31 970 39 34 018 48 - 12.3<br />
Agrumi 107 124 102 112 135 812 231 133 525 205 143 983 71 11.0<br />
Banane 3 73 363 3 82 901 7 85 412 0 88 619 34 16.7<br />
Verdure (fresche)<br />
Carote (incl. carote<br />
gialle)<br />
26 6 739 3 9 568 1 5 951 1 10 002 -94 26.2<br />
Cipolle (tutte) 51 6 432 345 2 584 42 2 724 151 2 777 254 - 58.1<br />
Sedano rapa 0 287 0 216 1 496 0 255 12.4<br />
Pomodori (tutti) 25 42 449 227 37 009 169 36 885 67 39 064 525 - 11.3<br />
Lattuga cappuccio<br />
(incl. foglia di quercia)<br />
3 2 537 0 3 520 2 3 797 0 3 305 -80 39.5<br />
Cavolfiore (tutti) 1 9 067 5 9 363 13 8 923 18 8 762 1 098 - 0.6<br />
Cetrioli (per insalata /<br />
nostrani)<br />
21 17 046 1 16 159 4 16 444 14 16 608 -70 - 3.8<br />
Vino<br />
Vino rosso (in hl) 6 585 1 417 802 10 727 1 271 667 8 289 1 267 948 6 908 1 252 993<br />
Vino bianco (in hl) 5 997 214 349 6 357 307 006 6 189 336 613 5 094 353 013<br />
2014<br />
2015<br />
1 Media degli anni 2000/03<br />
2<br />
Variazione 2000/03 - 2012/15<br />
3<br />
Voce di tariffa 0206<br />
4<br />
dal 2012 peso alla vendita<br />
5 dal 2014 nuova fonte a causa della ripartizione delle linee della tariffa doganale<br />
6 Cambiamento metodologico dal 2014: uova in milioni di pezzi invece di tonnellate<br />
Fonti:<br />
Latte e latticini, carne, sottoprodotti della macellazione, uova, cereali, sarchiate, semi oleosi e vino: DGD<br />
Frutta e verdura: statistica del commercio estero svizzero dell’amministrazione federale delle dogane AFD<br />
Zucchero: réservesuisse<br />
Pollame: Proviande<br />
A36<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Consumo pro capite<br />
Prodotto 2000/02 2013 2014 2015 1 2000/02–<br />
2013/15<br />
kg kg kg kg %<br />
Latte e latticini<br />
Latte di consumo 84.63 64.98 62.30 59.10 -26.6<br />
Bevande a base di latte 3.53 8.89 9.40 9.90 160.3<br />
Yogurt 16.57 17.84 17.50 17.00 4.9<br />
Burro 5.93 5.47 5.50 5.30 -8.6<br />
Panna 9.27 8.61 8.30 8.20 -10.0<br />
Formaggio e formaggio fuso 19.63 21.05 21.40 21.50 8.6<br />
Carne e uova<br />
Carne di manzo 10.22 11.50 11.47 11.24 11.5<br />
Carne di vitello 3.75 3.02 2.92 2.77 -22.6<br />
Carne suina 25.39 23.46 23.66 22.77 -8.3<br />
Carne ovina 1.51 1.15 1.19 1.23 -21.2<br />
Carne caprina 0.11 0.08 0.08 0.08 -25.0<br />
Carne equina 0.64 0.56 0.46 0.43 -24.1<br />
Pollame 9.46 11.42 11.92 12.08 24.9<br />
Uova in guscio (pz.) 4 187.67 178 178 174 -6.0<br />
Cereali<br />
Pane e prodotti da forno 51.13<br />
Sarchiate<br />
Patate e prodotti a base di patate 43.43 45.70 45.40 45.40 4.7<br />
Zucchero (compr. zucchero nei prodotti trasformati) 40.48 41.60 39.00 39.00 -1.5<br />
Semi oleosi<br />
Oli e grassi vegetali 14.98 17.70 17.90 17.90 19.0<br />
Frutta (fresca) 5<br />
Mele 3 14.66 (2) 14.63 14.86 15.34 2.0<br />
Pere 3 3.32 (2) 3.36 3.48 2.89 -5.3<br />
Albicocche 3 1.46 (2) 1.76 1.82 1.79 22.5<br />
Ciliegie 3 .71 (2) 0.66 0.86 0.63 -5.9<br />
Prugne e susine 3 1.05 (2) 1.33 1.15 1.15 15.0<br />
Fragole 2.27 2.62 2.64 2.61 15.5<br />
Agrumi 17.09 16.67 16.18 17.27 -2.2<br />
Banane 10.11 10.18 10.37 10.64 2.9<br />
Verdure (fresche)<br />
Carote (incl. carote gialle) 8.73 8.60 8.12 8.87 -2.3<br />
Cipolle (tutte) 4.49 5.25 5.09 5.01 13.9<br />
Sedano rapa 1.47 1.34 1.32 1.31 -10.0<br />
Pomodori (tutti) 10.07 10.71 10.38 10.18 3.5<br />
Lattuga cappuccio (incl. foglia di quercia) 2.63 2.11 2.21 2.06 -19.2<br />
Cavolfiore (tutti) 2.15 2.05 1.96 2.03 -6.4<br />
Cetrioli (per insalata / nostrani) 2.81 3.52 3.51 3.73 27.5<br />
Vino<br />
Vino rosso (in l) 28.28 22.47 21.65 21.08 -23.1<br />
Vino bianco (in l) 12.45 11.01 10.70 10.56 -13.6<br />
Totale vino (in l) 40.73 33.48 32.35 31.64 -20.2<br />
1<br />
Dati in parte provvisori<br />
2 Media degli anni 2000/03<br />
3<br />
Variazione 2000/03 - 2012/15<br />
4<br />
Dal 2011 senza traffico di perfezionamento attivo<br />
5 Consumo apparente: produzione indigena (frutta da tavola) più importazioni meno esportazioni (importazioni ed esportazioni secondo la statistica<br />
del commercio estero svizzero)<br />
Fonti:<br />
Latte e latticini, zucchero e semi oleosi: USC<br />
Uova: Aviforum<br />
Carne: Proviande<br />
Cereali, frutta, verdura e vino: UFAG<br />
Patate: swisspatat<br />
Zucchero: USC<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
AB16_Markt_Anhang_Tabellen_3_12_Tab11_Pro_Kopf_Konsum_i.xlsx<br />
Tab11 18.10.16 A37
Valorizzazione del raccolto della produzione vegetale<br />
Prodotto 2000/02 2013 2014 2015 2000/02–<br />
2013/15<br />
t t t t %<br />
Patate 0 363 800 504 000 389 100<br />
Patate da tavola 169 433 174 700 175 100 156 300 -0.4<br />
Patate destinate alla trasformazione 127 500 146 500 150 900 141 000 14.6<br />
Patate da semina 28 300 21 000 23 100 20 100 -24.3<br />
Somministrazione allo stato fresco agli animali 143 067 21 600 144 500 61 400 -46.9<br />
Trasformazione in alimenti per animali 71 633<br />
Mele e pere svizzere da sidro<br />
(trasformazione in stabilimenti industriali) 151 950 (1) 73 883 92 379 73 606 -45.8 (2)<br />
Quantitativo di frutta da sidro per succo grezzo 151 746 (1) 73 883 92 379 73 606 -45.8 (2)<br />
Sidro fresco da torchio 9 376 (1) 6 437 5 456 4 955 -38.5 (2)<br />
Sidro per la fabbricazione di acquavite 418 (1) 0 0 0 -100. (2)<br />
Succo concentrato 140 271 (1) 65 291 75 957 67 203 -48.8 (2)<br />
Altri succhi (compreso l’aceto) 1 682 (1) 2 155 10 964 1 448 178.4 (2)<br />
Frutta pigiata 204 (1) 0 0 0 -100. (2)<br />
Fabbricazione di bevande contenenti alcool di distillazione<br />
Di mele e pere svizzere 21 079 (1) 8 619 8 508 8 821 (3) -54.7 (2)<br />
Di ciliegie e prugne svizzere 12 137 (1) 3 801 8 422 7 759 (3) -43.6 (2)<br />
Verdure svizzere fresche per la trasformazione<br />
Prodotti principali (fagiolini, piselli, carote parigine, spinaci) 28 863 26 696 30 358 29 244 -1.5<br />
Cavolo (cappuccio) per crauti 6 424 4 919 5 010 4 592 -24.7<br />
Altre verdure per la trasformazione 12 468 17 074 20 158 18 959 50.2<br />
1 Media degli anni 2000/03<br />
2 Variazione 2000/03 - 2012/15<br />
3<br />
Provvisorio, stato 16.09.2016<br />
Fonti:<br />
Patate: swisspatat<br />
Frutta da sidro: UFAG; bevande contenenti alcool di distillazione: Regia federale degli alcool<br />
Verdure per la trasformazione: Centrale svizzera dell’orticoltura e delle colture speciali<br />
A38<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
AB16_Markt_Anhang_Tabellen_3_12_Tab8_Verwertung_Ernte_i.xlsx<br />
Tab8 18.10.16
Valorizzazione del latte secondo le componenti (equivalente del latte; EL)<br />
Prodotto 2000/02 2013 2014 2015 2000/02–<br />
2013/15<br />
t t t t %<br />
Formaggio 1 375 908 1 463 090 1 480 970 1 461 319 6.7<br />
Ricotta 19 366 23 251 25 947 31 299 38.6<br />
Latte di consumo 459 605 408 784 405 559 392 304 -12.5<br />
Panna di consumo 258 197 286 420 281 120 289 492 10.6<br />
Yogurt 70 003 113 681 115 287 113 880 63.3<br />
Altri prodotti a base di latte fresco (compreso il gelato) 84 282 106 444 106 578 103 551 25.2<br />
Conserve di latte 331 579 326 734 381 021 358 382 7.2<br />
Burro 476 737 539 606 572 467 559 480 16.9<br />
Altra valorizzazione 122 375 160 601 171 583 176 470 38.6<br />
1 EL corrisponde a 1 kg di latte con una quota del 7,3% di grasso e proteine<br />
Fonte: TSM<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A39<br />
AB16_Markt_Anhang_Tabellen_3_12_Tab7_Milchverwertung_i.xlsx<br />
Tab7 18.10.16
Produzione di latticini<br />
Prodotto 2000/02 2013 2014 2015 2000/02–<br />
2013/15<br />
t t t %<br />
Totale formaggio 166 668 182 705 185 331 188 806 11.4<br />
Formaggio fresco 35 832 45 234 47 582 53 110 35.8<br />
Mozzarella 12 208 21 645 22 693 23 551 85.4<br />
Altro formaggio fresco 23 624 23 589 24 889 29 551 10.1<br />
Formaggio a pasta molle 6 848 6 385 6 182 6 013 -9.6<br />
Tomme 1 229 1 881 1 893 1 857 52.7<br />
Formaggio a crosta fiorita, da semigrasso a grasso 2 122 930 897 871 -57.6<br />
Altro formaggio a pasta molle 3 497 3 574 3 392 3 285 -2.3<br />
Formaggio a pasta semidura 47 176 61 697 63 259 63 891 33.4<br />
Appenzeller 8 505 9 280 8 831 8 782 5.4<br />
Tilsiter 6 135 3 141 3 142 3 182 -48.6<br />
Formaggio da raclette 11 871 13 112 12 698 13 629 10.7<br />
Altro formaggio a pasta semidura 20 665 36 164 38 588 38 298 82.4<br />
Formaggio a pasta dura 76 215 68 260 67 153 64 034 -12.8<br />
Emmentaler 42 171 23 156 20 259 18 843 -50.8<br />
Gruyère 26 072 29 351 29 420 28 552 11.6<br />
Sbrinz 2 940 1 751 1 613 1 546 -44.3<br />
Altro formaggio a pasta dura 5 032 14 002 15 861 15 093 197.8<br />
Prodotti speciali 1 663 1 129 1 155 1 210 75.7<br />
Totale prodotti a base di latte fresco 704 033 746 658 739 820 721 607 4.5<br />
Latte di consumo 505 764 480 552 471 527 455 368 -7.2<br />
Altri 198 270 266 106 268 293 266 239 34.6<br />
Totale burro 40 247 46 631 48 436 46 844 17.5<br />
Totale panna 68 213 70 820 69 080 70 461 2.8<br />
Totale latte in polvere e latte condensato 47 152 48 101 57 009 50 454 10.0<br />
1 Formaggio di solo latte di pecora o di capra<br />
Fonte: TSM<br />
A40<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
AB16_Markt_Anhang_Tabellen_3_12_Tab6_Produktion_Milchprod_i.xlsx<br />
Tab6 18.10.16
Prezzi al consumo in Svizzera e nei Paesi limitrofi – 2015<br />
Prodotto Ø 2015<br />
Germania (D) Francia (F) Austria (A) Svizzera (CH)<br />
Latte e latticini<br />
Latte intero pastorizzato fr./l 0.68 0.86 1.01 1.46<br />
Burro fr./kg 3.79 7.16 5.83 14.97<br />
Yogurt al naturale fr./kg 1.16 1.44 1.96 2.38<br />
Mozzarella fr./kg 5.64 - 7.45 9.90<br />
Emmentaler fr./kg 9.65 8.98 8.09 17.28<br />
Carne<br />
Cotolette di maiale fr./kg 5.61 - 7.69 19.23<br />
Scaloppine di maiale (coscia) fr./kg 7.34 - 7.08 23.81<br />
Carne macinata di manzo fr./kg 7.25 - 9.29 17.99<br />
Entrecôte di manzo fr./kg - 25.88 20.45 69.14<br />
Scaloppine di vitello (coscia) fr./kg - 25.56 29.14 70.45<br />
Pollo intero fr./kg 4.96 - 6.65 8.92<br />
Petto di pollo fr./kg 7.49 - 10.64 29.01<br />
Uova<br />
Uova da allevamento al suolo, conf. da 10 ct./uovo 11.62 - 27.16 41.56<br />
Sarchiate<br />
Patate da tavola resistenti alla cottura fr./kg 0.88 - 0.95 1.56<br />
Patate da tavola farinose fr./kg 0.90 - 1.05 1.64<br />
Patate novelle fr./kg 1.11 1.32 - 1.96<br />
Frutta<br />
Mele da tavola, Golden Delicious, classe I fr./kg 2.04 1.69 1.84 3.25<br />
Pere da tavola, Conférence, classe I fr./kg 2.19 2.29 1.97 3.61<br />
Verdura<br />
Carote fr./kg 1.04 1.37 1.09 2.30<br />
Lattuga cappuccio fr./pz. 0.98 1.09 0.72 1.52<br />
Cetrioli fr./pz. 0.64 1.07 0.95 1.22<br />
Cipolle fr./kg 0.95 1.74 1.06 2.28<br />
Avvertenza: i risultati vanno interpretati con cautela, considerato il limite di comparabilità tra i prodotti. In particolare possono variare i servizi<br />
intrinseci. I prodotti considerati, pertanto, sono quelli che meglio si prestano a un tale confronto dei prezzi e per i quali si dispone di dati accessibili e<br />
comparabili. I prezzi esteri sono stati convertiti applicando i corsi del cambio della Banca nazionale svizzera (2015: 1.00 Euro ≙ 1.07 fr.).<br />
Fonti: Francia (F): FranceAgriMer, Agreste Frankreich, Insee; Austria (A): GfK Austria, Bundesanstalt Statistik Austria, Bundesanstalt für<br />
Agrarwirtschaft Österreich; Germania (D): Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) Deutschland, GfK (D); Svizzera (CH): UFAG<br />
Osservazione del mercato<br />
Spiegazioni dei dati<br />
Latte e latticini: conv. IVA incl; D (mozzarella, self-service, Emmentaler, servito); latte intero past.: F (latte UHT parzialm. scremato)<br />
Carne: qualità: label+QM (CH), label+convenzionale (UE); copertura: nazionale (D, A, CH), Francia metropolitana (F); franco negozio; prezzi realizzati,<br />
IVA incl.<br />
Uova: allevamento al suolo; franco negozio; prezzi spuntati, IVA incl.<br />
Sarchiate: dati economie domestiche (D, A), rilevazioni dei prezzi (F,CH); imballaggio: 1-2,5 kg (D, CH), 5 kg (F), diversi (A); diverse varietà; IVA incl.<br />
Frutta e verdura: D (IVA incl., importazioni e discount incl.); F (importazioni e discount escl.); A (IVA incl., importazioni e discount incl.); CH (IVA incl.,<br />
importazioni incl., se non è disponibile merce CH; discount escl.) D (pere da tavola classe I comune), F e CH (cipolle gialle); A (mele da tavola classe I<br />
comune, pere da tavola classe I comune)<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A41<br />
AB_16_Markt_Internationale_Preisvergleiche_Tabelle_Konsumentenpreise_i.xlsx<br />
05.10.16
Uscite della Confederazione per agricoltura e alimentazione, in 1 000 fr.<br />
Ambito di spesa 2011 2012 2013 2014 2015<br />
Compiti inerenti all’agricoltura e all’alimentazione 3 663 016 3 711 112 3 705 974 3 692 510 3 667 267<br />
Nell’ambito del limite di spesa 3 370 376 3 441 200 3 438 065 3 429 696 3 385 284<br />
Miglioramento delle basi & Misure sociali collaterali 134 666 191 902 189 244 184 090 159 564<br />
Miglioramenti strutturali 83 000 87 000 87 808 89 157 94 659<br />
Crediti d’investimento 13 000 54 000 51 000 45 132 15 283<br />
Aiuti per la conduzione aziendale 1 021 944 689 837 203<br />
Produzione vegetale e animale 37 646 37 958 37 747 36 973 37 549<br />
Consulenza agricola 1 12 000 12 000 11 991 11 870<br />
Produzione e smercio 440 805 440 104 450 089 430 739 430 535<br />
Promozione della qualità e dello smercio 55 385 55 900 56 366 59 736 60 797<br />
Economia lattiera 295 311 300 738 301 329 295 530 295 436<br />
Produzione animale 12 423 11 490 11 846 11 876 11 967<br />
Produzione vegetale 77 686 71 976 80 549 63 597 62 335<br />
Pagamenti diretti 2 794 905 2 809 194 2 798 732 2 814 866 2 795 185<br />
Pagamenti diretti Agricoltura 2 814 866 2 795 185<br />
Pagamenti diretti generali 2 181 905 2 177 894 2 150 471<br />
Pagamenti diretti ecologici 613 000 631 300 648 261<br />
Al di fuori del limite di spesa 292 640 269 912 267 909 262 815 281 982<br />
Amministrazione 55 134 54 577 54 237 55 777 54 664<br />
Consulenza 1 12 039<br />
Protezione delle piante 1 499 1 907 2 113 2 055 1 310<br />
Esecuzione e controllo (Agroscope) 51 189 56 017 55 346 54 807 55 366<br />
Istituto nazionale svizzero d’allevamento equino 8 082 8 844 8 739 8 654 8 742<br />
Prodotti agricoli trasformati (AFD) 76 321 64 167 70 000 70 000 95 600<br />
Assegni familiari nell’agricoltura (UFAS) 88 376 84 400 77 475 71 521 66 300<br />
Altre<br />
Uscite al di fuori dell’agricoltura 146 040 145 102 145 488 146 836 150 022<br />
Ricerca e sviluppo nell’agricoltura 78 174 80 504 81 967 81 881 85 440<br />
Salute degli animali 59 123 57 178 55 971 57 596 57 140<br />
FAO 8 743 7 420 7 550 7 359 7 442<br />
Avvertenza: con l’introduzione, nel 2007, del nuovo modello contabile la Confederazione presenta la propria contabilità con un nuovo<br />
sistema, ragion per cui non sono possibili confronti con gli anni scorsi.<br />
1 Dal 2012 i contributi al settore della consulenza sono contenuti nel limite di spesa agricolo<br />
Fonti: Conto dello Stato, UFAG<br />
A42<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Uscite Promozione della qualità e delle vendite<br />
Settori / Settori di prodotti di mercato Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 1 Fondi stanziati 2016<br />
Fr. Fr. Fr.<br />
Produzione lattiera 28 400 000 29 400 000 27 250 000<br />
Formaggio, svizzero / estero 21 000 000 21 400 000 20 200 000<br />
Latte e burro 7 400 000 8 000 000 7 050 000<br />
Produzione animale 7 767 029 7 219 483 7 303 000<br />
Carne 6 100 000 5 268 934 5 325 000<br />
Uova 1 085 472 1 150 000 1 200 000<br />
Animali vivi 531 557 800 549 778 000<br />
Miele 50 000 0 0<br />
Produzione vegetale 7 558 640 7 884 490 8 280 700<br />
Verdura 724 000 678 290 800 000<br />
Funghi 200 000 230 000 250 000<br />
Frutta 2 047 187 2 250 000 2 300 000<br />
Cereali 265 194 345 000 309 500<br />
Patate 573 500 570 000 570 000<br />
Semi oleosi 440 000 480 000 480 000<br />
Piante ornamentali 400 000 415 000 420 000<br />
Vino 2 908 759 2 916 200 3 151 200<br />
Agriturismo 320 000 320 000 288 000<br />
Montagna et alpe 0 27 500 0<br />
Provvedimenti collettivi 2 580 000 2 860 000 2 420 000<br />
Provvedimenti sovrasettoriali (Bio, PI, DOP / IGP) 4 080 000 4 080 000 4 080 000<br />
Pubbliche relazioni 2 620 000 2 671 500 2 655 720<br />
Progetti a livello sovraregionale 3 003 619 3 030 000 3 030 000<br />
Progetti speciali 1 000 000 65 000 150 000<br />
Iniziativa legata all'esportazione 2 1 509 157 2 885 431 3 980 000<br />
Formaggio 1 129 664 1 963 521 2 950 000<br />
Carne 150 000 703 742 700 000<br />
Piante ornamentali 50 000 55 000 60 000<br />
Prodotti biologici 59 493 43 168 170 000<br />
Genetica bovina 120 000 120 000 100 000<br />
Promozione della qualità e della sostenibilità 3 831 969 662 599 498 510<br />
Totale 59 670 414 61 106 003 59 935 930<br />
1<br />
Chiusura dei conti definitiva ancora pendente in alcuni casi<br />
2<br />
Fino al 2013 come progetti pilota<br />
3<br />
stato maggia 2016<br />
Fonte: UFAG<br />
AB16_produktion_absatz_tabellenanhang_tab26_i.xlsx<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG Tab26 17.10.16<br />
A43
Uscite nel settore dell’economia lattiera<br />
Denominazione Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Preventivo 2016<br />
Fr. Fr. Fr.<br />
Sostegno del mercato (anno civile)<br />
Supplemento per il latte trasformato in formaggio 261 800 963 262 104 429 261 500 000<br />
Supplemento per il foraggiamento senza insilati 31 195 661 30 892 023 31 500 000<br />
292 996 624 292 996 452 293 000 000<br />
Amministrazione produzione e valorizzazione 2 533 007 2 440 044 2 871 200<br />
Totale 295 529 631 295 436 496 295 871 200<br />
Fonti: Conto dello Stato, UFAG<br />
A44<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Uscite nel settore della produzione animale<br />
Denominazione Preventivo 2015 Consuntivo 2015 Preventivo 2016<br />
Fr. Fr. Fr.<br />
Indennità a organizzazioni private per il bestiame da macello<br />
e la carne<br />
6 622 600 6 536 859 6 588 800<br />
Sostegno del mercato della carne<br />
Contributi alle azioni d’immagazzinamento di carne di vitelllo<br />
3 203 000 2 711 829 3 103 000<br />
Sostegno del mercato delle uova<br />
Azioni di spezzatura 400 000 401 149 400 000<br />
Azioni di vendita a prezzo ridotto 1 500 000 1 427 561 1 507 500<br />
1 900 000 1 828 710 1 907 500<br />
Contributi per la valorizzazione della lana di pecora<br />
Contributi per la valorizzazione della lana di pecora 423 399<br />
Contributi per progetti innovativi sulla lana di pecora 444 444<br />
800 000 867 843 800 000<br />
Contributi per apparecchi e/o attrezzature di mercati pubblici<br />
nella regione di montagna<br />
150 000 132 062 150 000<br />
Aiuto finanziario Assicurazione della qualità Carne 0 0 0<br />
Totale 12 675 600 11 967 418 12 549 300<br />
Contributi d’eliminazione 49 553 900 48 398 726 48 788 300<br />
Entrate d’esercizio BDTA -9 946 200 -9 900 794 -9 924 300<br />
Uscite d’esercizio BDTA 10 845 700 8 741 215 10 786 100<br />
Tassa di macellazione -3 000 000 -2 904 909 -2 937 500<br />
Fonti: Conto dello Stato, UFAG<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A45
Uscite nel settore dell’allevamento di animali<br />
Specie animale e provvedimenti<br />
Consuntivo<br />
2014<br />
Consuntivo<br />
2015<br />
Preventivo Organizzazioni<br />
2016 di allevamento<br />
riconosciute<br />
2015<br />
Razze 2015<br />
Fr. Fr. Fr. Numero Numero<br />
Bovini 23 355 865 24 523 214 23 464 513 6 38<br />
Tenuta del libro genealogico 5 367 864 5 576 010 5 895 288<br />
Apprezzamento della conformazione 1 170 472 967 365 999 270<br />
Esami funzionali del latte 16 537 159 17 688 140 16 141 455<br />
Esami funzionali della carne 271 804 264 602 286 000<br />
Esami dello stato di salute 8 566 27 097 142 500<br />
Equini 1 224 290 1 068 550 1 306 700 14 55<br />
Puledri identificati e registrati 1 213 640 1 054 400 1 285 450<br />
Esami funzionali 0<br />
Esami dello stallone in una stazione 9 750 13 000 20 000<br />
Esami dello stallone nell’azienda 900 1 150 1 250<br />
Suini 3 399 997 3 399 750 3 503 120 3 10<br />
Tenuta del libro genealogico 1 224 900 1 190 700 1 220 120<br />
Esami nell’azienda 168 802 186 520 220 000<br />
Esami in una stazione (ultrasuoni, descrizione<br />
lineare, peso)<br />
1 475 250 1 474 020 1 521 000<br />
Esami dei verri nell’azienda (odore) 32 200 48 510 42 000<br />
Infrastruttura 498 845 500 000 500 000<br />
Ovini 1 947 441 1 908 946 2 119 240 6 18<br />
Tenuta del libro genealogico 1 748 104 1 708 965 1 593 365<br />
Esami della capacità di sviluppo 199 337 199 981 525 875<br />
Capre e pecore lattifere 1 799 975 1 536 279 1 874 213 5 14<br />
Tenuta del libro genealogico 1 347 692 1 100 505 1 155 518<br />
Esami funzionali del latte 420 485 403 326 681 775<br />
Esami della capacità di sviluppo dei caprini 31 798 32 448 36 920<br />
Camelidi del nuovo mondo 51 003 55 656 67 000 1 4<br />
Tenuta del libro genealogico 51 003 55 656 67 000<br />
Api mellifere 249 701 224 286 261 905 1 3<br />
Tenuta del libro genealogico 17 995 15 050 19 600<br />
Determinazione della purezza delle regine 5 273 12 240 7 040<br />
Determinazione della purezza della razza, analisi<br />
delle ali<br />
740 1 696 1 185<br />
Esami funzionali nell’apiario sperimentale con<br />
campione reso anonimo<br />
154 269 126 280 156 600<br />
Esami funzionali nell’apiario sperimentale con<br />
campione conosciuto<br />
1 674 2 520 7 000<br />
Stazione di fecondazione A 53 010 51 000 53 200<br />
Stazione di fecondazione B 16 740 15 500 17 280<br />
Conservazione delle razze svizzere 1 392 342 1 479 203 1 609 079<br />
Conservazione della razza delle Franches<br />
Montagnes<br />
1 044 900 1 007 500 1 000 000<br />
Progetti 347 442 414 052 467 454<br />
Progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche 0 57 651 141 625<br />
Totale 33 420 614 34 195 884 34 205 770<br />
Fonti: Conto dello Stato / Organizzazioni di allevamento<br />
A46<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Uscite nel settore della produzione vegetale<br />
Denominazione Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Preventivo 2016<br />
Fr. Fr. Fr.<br />
Contributi nella campicoltura 60 117 628 59 566 175 62 200 000<br />
Contributi di superficie per semi oleosi 20 369 493 21 266 840 21 300 000<br />
Contributi di superficie per leguminose a granelli 4 631 034 5 356 042 6 000 000<br />
Contributi di superficie per piante da fibra 0 0 0<br />
Contributi di superficie per barbabietole da zucchero 33 545 402 31 440 695 33 200 000<br />
Contributi di superficie per sementi (dal 2009) 1 571 699 1 502 598 1 700 000<br />
Provvedimenti della frutta 2 644 954 1 936 224 4 601 400<br />
Valorizzazione della frutta 2 644 954 1 936 224 4 601 400<br />
Promozione della vitivinicoltura 834 909 832 609 868 600<br />
Controllo della vendemmia 834 909 832 609 868 600<br />
Misure di sgravio del vino svizzero 0 0 0<br />
Totale 63 597 491 62 335 008 67 670 000<br />
Fonti: Conto dello Stato, UFAG<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A47
Registro DOP / IGP al 31 dicembre 2015<br />
Denominazione Protezione Aziende Imprese Volume di<br />
produzione<br />
Volume di Ente di<br />
produzione certificazione<br />
certificato certificato<br />
Formaggio Numero Numero t t<br />
L’Etivaz DOP - 70 435 430 OIC<br />
Emmentaler DOP 2 853 150 20 244 18 843 OIC<br />
Gruyère DOP 1 994 232 29 420 28 552 OIC<br />
Sbrinz DOP 90 21 1 520 1 468 ProCert<br />
Tête de Moine DOP 258 9 2 263 2 274 OIC<br />
Formaggio d’alpe ticinese DOP - 41 260 260 OIC<br />
Vacherin fribourgeois DOP 1 025 100 2 935 3 000 OIC<br />
Vacherin Mont-d’Or DOP 123 16 574 585 OIC<br />
Berner Alpkäse / Hobelkäse DOP 48 454 1 070 1 003 OIC<br />
Walliser Raclette DOP 377 75 1 644 1 725 OIC<br />
Bloderkäse-Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner<br />
Sauerkäse<br />
DOP 18 3 21 25 ProCert<br />
Glarner Alpkäse DOP - 14 16 102 ProCert<br />
Prodotti carnei<br />
Bündnerfleisch IGP 17 1 080 2 733 ProCert<br />
Longeole IGP - 13 25 25 OIC<br />
Saucisse d’Ajoie IGP - 11 47.7 47.7 OIC<br />
Walliser Trockenfleisch IGP - 35 584 544 OIC<br />
Saucisson neuchâtelois<br />
IGP<br />
- 10 120 120 OIC<br />
Saucisse neuchâteloise<br />
Saucisson vaudois IGP - 23 961 794 ProCert<br />
Saucisse aux choux vaudoise IGP - 24 634 545 ProCert<br />
St. Galler Bratwurst/ IGP - 13 3 467 3 650 OIC<br />
St. Galler Kalbsbratwurst IGP ProCert<br />
SQS<br />
q.inspecta<br />
Glarner Kalberwurst<br />
IGP<br />
- - 36 39 ProCert<br />
q.inspecta<br />
Bevande contenenti alcool di distillazione<br />
Eau-de-vie de poire du Valais DOP 2 92 608 79 243 OIC<br />
Abricotine / Eau-de-vie d’Abricot du<br />
Valais<br />
DOP 1 9 451 9 586 OIC<br />
Damassine DOP 8 170.5 170.5 OIC<br />
Zuger Kirsch / Rigi Kirsch DOP 5 0 350 ProCert<br />
Altri prodotti<br />
Rheintaler Ribel DOP - 16 35 36 ProCert<br />
Cardon épineux genevois DOP 3 1 70 70 ProCert<br />
Walliser Roggenbrot DOP 60 60 626 616 OIC<br />
Munder Safran DOP - 17 0,001 0,002 OIC<br />
Poire à Botzi DOP 13 4 45 46 ProCert<br />
Fonte: UFAG<br />
A48<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Risultati delle vendite all’asta per il periodo di contingentamento 2015<br />
Settore di produzione e prodotti<br />
messi all’asta<br />
Carne, prodotti carnei e insaccati<br />
inclusi, latticini e animali da<br />
allevamento<br />
Unità<br />
Quantitativi<br />
messi all’asta<br />
Prezzo<br />
d’aggiudicazione<br />
Media<br />
Quota venduta<br />
all’asta<br />
sul totale<br />
Contingente<br />
doganale<br />
(parziale)<br />
Vendite<br />
all'asta 2015<br />
Partecipanti<br />
per bando<br />
1 Numero Unità fr. / unità % Numero Numero o<br />
media<br />
Carne di pollame kg lordi 49 500 000 2,05 100 5 69<br />
Carne di animali della specie ovina kg lordi 3 550 000 2,41 50 7 39<br />
Carne di animali della specie caprina kg lordi 168 000 1,80 60 2 15<br />
Carne di animali della specie equina kg lordi 2 130 000 0,11 60 7 11<br />
Carne di vitello kg lordi 125 000 7,30 50 1 24<br />
Fegato di vitello kg lordi 60 000 0,31 50 4 5<br />
Lombi / High-Quality-Beef kg lordi 2 950 000 12,41 50 14 46<br />
Carcasse di vacche destinate alla<br />
trasformazione<br />
kg lordi 6 162 500 1,31 50 13 26<br />
Carne di salumeria di vacche, surg. kg lordi 77 500 0,34 50 3 14<br />
Lingue kg lordi 70 000 0,03 50 4 3<br />
Muselli di bovini kg lordi 65 000 0,02 50 3 2<br />
Carne bovina (kasher) kg lordi 268 100 0,07 100 4 6<br />
Carne bovina (halal) kg lordi 350 000 1,23 100 4 8<br />
Carne ovina (kasher) kg lordi 19 700 0,07 100 4 6<br />
Carne ovina (halal) kg lordi 175 000 1,11 100 4 8<br />
Prosciutto essiccato all’aria kg lordi 1 100 000 9,14 100 1 66<br />
Carne secca essiccata all’aria kg lordi 220 000 9,99 100 1 35<br />
Insaccati kg lordi 4 086 500 7,64 100 1 86<br />
Prosciutto cotto e in scatola kg lordi 71 500 7,21 100 1 18<br />
Conserve a base di carne di manzo kg lordi 770 000 0,20 100 1 10<br />
Latte in polvere kg netti 300 000 1,08 100 2 11<br />
Burro kg 82% TMG 100 000 3,15 100 1 14<br />
Animali della specie bovina Capi 1 200 379,48 100 2 15<br />
Prodotti di origine vegetale<br />
Fiori recisi kg lordi 200 000 0,64 2 1 41<br />
Prodotti semilavorati a base di patate<br />
per la fabbricazione di salse e kg eq 448 000 0,02 100 1 3<br />
minestre<br />
Altri prodotti semilavorati a base di kg eq 1 052 000 0,02 100 1 14<br />
Prodotti finiti a base di patate kg eq 2 500 000 0,67 100 1 32<br />
Prodotti di frutta a granelli 2 kg eq 244 000 0,54 96 1 11<br />
Frutta da sidro e per la distillazione kg netti 7 000 0,01 100 1 1<br />
1 capi: capi, kg lordi: peso lordo in chilogrammi; kg netti: peso netto; kg eq: equivalente in merce fresca dei prodotti trasformati,<br />
il cui peso netto viene convertito applicando coefficienti fissi; kg 82% TMG: kg netti di burro con un tenore in materie grasse dell’82%,<br />
le importazioni alla voce di tariffa 0405.9010 vengono convertite applicando il coefficiente 1,21 in kg 82% TMG.<br />
2 Contingenti doganali n. 21 e n. 31 (contingente doganale autonomo con assegnazione sulla base della prestazione d'esportazione)<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A49
Ricapitolazione dei pagamenti diretti secondo i tipi e per cantoni 2015<br />
Cant<br />
one<br />
Contr.<br />
paesaggio<br />
rurale<br />
Contr.<br />
sicurezza<br />
approvv.<br />
Contr.<br />
biodiversità<br />
Contr.<br />
qualità del<br />
paesaggio<br />
ZH 6 515 384 69 500 538 29 525 679 6 782 737 25 860 275 743 292 12 072 393 1 155 271 149 845 025<br />
BE 102 842 779 209 582 835 62 598 298 27 706 830 82 176 381 2 115 387 35 454 039 -1 177 688 523 654 238<br />
LU 25 173 167 80 496 943 28 404 941 9 811 872 45 381 323 3 904 156 17 112 396 287 570 209 997 228<br />
UR 12 721 280 7 403 618 4 557 256 1 497 806 2 759 480 0 929 257 22 090 29 846 606<br />
SZ 22 098 403 24 610 625 13 641 435 4 055 117 10 249 015 11 864 4 553 150 104 845 79 114 763<br />
OW 11 651 621 8 500 012 3 653 160 1 643 598 4 541 567 2 791 1 408 121 352 105 31 048 765<br />
NW 6 891 223 6 433 710 2 829 867 1 070 701 2 939 703 0 1 196 693 31 691 21 330 205<br />
GL 8 898 484 7 313 919 3 987 425 1 142 211 3 239 473 4 480 1 242 435 156 489 25 671 938<br />
ZG 3 454 239 10 358 944 6 014 606 1 150 003 5 130 340 120 845 2 121 812 147 314 28 203 475<br />
FR 28 366 534 80 703 734 18 510 941 10 964 405 35 463 128 1 767 319 13 314 165 - 277 594 189 367 820<br />
SO 6 854 731 32 257 121 13 622 310 2 261 590 12 463 522 436 017 5 424 557 12 897 73 306 951<br />
BL 4 824 839 22 688 253 9 682 180 1 447 141 8 617 020 323 911 3 510 019 161 583 50 931 782<br />
SH 931 764 15 303 885 6 321 965 1 460 017 4 458 187 338 710 1 838 828 156 857 30 496 498<br />
AR 8 476 322 13 336 166 2 238 725 1 498 543 5 941 091 2 677 2 555 007 98 714 33 949 817<br />
AI 5 727 980 8 124 900 1 588 593 630 826 4 005 353 1 620 1 579 941 179 257 21 479 956<br />
SG 39 275 219 71 118 642 24 733 430 3 765 715 35 606 767 801 537 14 482 365 434 311 189 349 363<br />
GR 77 449 504 57 770 692 29 075 661 11 153 466 28 527 477 38 562 9 069 239 1 172 342 211 912 259<br />
AG 6 380 366 61 783 735 24 019 956 2 474 894 24 105 085 833 565 10 486 424 1 140 506 128 943 520<br />
TG 2 390 637 47 841 668 14 373 394 3 055 749 23 710 468 1 469 914 8 981 619 517 112 101 306 338<br />
TI 13 312 404 14 077 603 5 320 096 759 194 4 811 812 76 597 1 665 479 107 095 39 916 092<br />
VD 36 898 556 116 434 811 37 460 087 15 971 970 36 571 370 2 517 167 13 138 512 - 41 501 259 033 974<br />
VS 42 528 708 39 199 290 20 617 955 6 595 101 11 105 554 209 196 4 602 045 -2 194 452 127 052 300<br />
NE 13 354 118 35 233 503 7 456 457 1 997 028 12 519 237 489 244 4 263 908 - 279 064 75 592 558<br />
GE 284 428 10 773 751 3 251 633 1 014 034 2 671 286 404 878 735 100 58 543 19 076 566<br />
JU 17 062 842 42 682 019 13 668 190 5 564 992 17 275 898 713 072 6 190 900 66 342 103 091 570<br />
CH 504 365 535 1093 530 915 387 154 239 125 475 540 450 130 809 17 326 800 177 928 403 2 392 634 2 753 519 607<br />
Zona<br />
Pianu 31 718 993 487 296 569 164 129 969 45 121 571 195 271 365 12 804 760 80 898 611 3 415 377 1010 395 789<br />
Collin 40 479 293 157 353 354 52 869 746 14 910 173 70 331 825 2 569 711 26 262 774 670 094 350 123 210<br />
ZM I 63 143 258 132 590 478 33 845 031 14 169 518 57 071 590 1 140 304 21 983 552 304 013 297 997 845<br />
ZM II 108 339 093 172 093 098 49 376 201 18 047 739 68 151 470 699 211 26 751 112 483 424 395 423 715<br />
ZM III 83 367 489 89 421 013 34 690 655 13 609 084 36 410 437 89 721 13 479 414 572 688 240 553 305<br />
ZM 55 008 283 54 776 403 31 155 470 9 877 616 22 894 122 23 093 8 552 939 434 827 162 129 726<br />
ZE 122 309 124 0 21 087 166 9 739 840 0 0 0 -3 487 791 154 404 749<br />
*Contributi per la protezione delle acque e per i programmi sulle risorse esclusi<br />
Contr.<br />
sistemi di<br />
prod.<br />
Contr.<br />
efficienza<br />
risorse<br />
Contr.<br />
transizione<br />
Riduzioni*<br />
/ acconti e<br />
pag.<br />
suppl.<br />
ecc.<br />
Totale<br />
pagamenti<br />
diretti<br />
Fonte: UFAG<br />
A50<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Sintesi pagamenti diretti – 2015<br />
Regione<br />
Svizzera Pianura Collina Montagna Estivazione<br />
1000 fr. 1000 fr. 1000 fr. 1000 fr. 1000 fr.<br />
Contributi per il paesaggio rurale 504 366 37 645 100 713 243 699 122 309<br />
Contributo per la preservazione dell’apertura del paesaggio 140 815 3 453 39 863 97 499<br />
Contributo di declività 108 114 3 202 35 791 69 121<br />
Contributo per le zone in forte pendenza 13 454 6 908 12 540<br />
Contributo di declività per i vigneti 11 945 11 945<br />
Contributo di alpeggio 107 728 19 038 24 152 64 538<br />
Contributo d’estivazione 122 309 122 309<br />
Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento 1 093 531 487 297 289 944 316 291<br />
Contributo di base 820 772 387 823 210 428 222 521<br />
Contributo per le difficoltà di produzione 160 485 5 677 62 829 91 979<br />
Contributo per la superficie coltiva aperta e le colture perenni 112 274 93 797 16 687 1 790<br />
Contributi per la biodiversità 386 555 164 130 86 715 115 222 20 488<br />
Contributo per la qualità 296 093 130 036 66 364 79 205 20 488<br />
Contributo per l’interconnessione 90 463 34 094 20 351 36 017<br />
Contributi per la qualità del paesaggio 125 476 45 122 29 080 41 534 9 740<br />
Contributi per i sistemi di produzione 450 131 195 271 127 403 127 456<br />
Contributo per l’agricoltura biologica 42 466 19 105 8 318 15 043<br />
Contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli<br />
proteici, favette e colza<br />
33 481 25 121 7 794 566<br />
Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla<br />
superficie inerbita<br />
107 866 25 463 31 698 50 705<br />
Contributi per il benessere degli animali 266 319 125 582 79 594 61 143<br />
Contributi per l’efficienza delle risorse 17 327 12 805 3 710 812<br />
Contributo per procedimenti di spandimento a basse emissioni 6 210 3 652 1 901 657<br />
Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo 10 413 8 573 1 705 134<br />
Contributo per una tecnica d’applicazione precisa 704 580 104 21<br />
Contributo di transizione 177 928 80 899 48 246 48 783<br />
Riduzioni / Acconti e versamenti successivi / limitazione ecc. 2 393 3 415 974 1 491 - 3 488<br />
Totale pagamenti diretti 2 752 921 1 019 752 684 837 892 306 156 025<br />
Avvertenza: I contributi per programmi sulla protezione delle acque e sulle risorse non figurano nell’OPD ma rientrano nel preventivo dei pagamenti<br />
diretti e ammontano a 25,5 milioni di franchi.<br />
Fonte: UFAG<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A51
Pagamenti diretti a livello aziendale 1 : per le zone e le classi dimensionali 2015 4<br />
Caratteristica<br />
Aziende di riferimento<br />
Aziende rappresentate<br />
Superficie agricola utile<br />
Pagamenti diretti medi per azienda in virtù dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) 1<br />
Zona di pianura<br />
Zona collinare<br />
10 – 20 20 – 30 30 – 50 10 – 20 20 – 30 30 – 50<br />
Unità ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU<br />
numero 182 245 209 94 105 84<br />
numero 2 930 4 417 3 860 1 673 1 790 967<br />
ha 16.08 24.76 37.65 15.08 24.26 36.69<br />
Contributi per il paesaggio rurale<br />
fr. 604 1 409 2 222 4 532 6 002 9 751<br />
Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento<br />
fr. 16 149 24 984 39 259 17 417 27 960 42 269<br />
Contributi per la biodiversità<br />
fr. 5 562 9 340 13 228 5 408 8 130 14 926<br />
Contributi per la qualità del paesaggio<br />
fr. 1 779 2 442 4 335 2 062 2 977 4 560<br />
Contributi per i sistemi di produzione<br />
fr. 9 666 11 705 16 242 7 670 12 167 17 008<br />
Contributi per l'efficienza delle risorse<br />
fr. 497 630 1 246 163 535 616<br />
Contributo di transizione<br />
fr. 3 468 5 175 6 808 3 438 5 178 6 486<br />
Totale pagamenti diretti giusta l'OPD fr. 37 666 55 743 83 365 40 700 62 899 95 097<br />
Altri pagamenti diretti 2<br />
fr. 1 268 2 542 4 906 231 391 1 016<br />
Risultato operativo agricolo 3 Fr. 229 388 315 636 442 832 180 322 268 192 358 070<br />
di cui pagamenti diretti<br />
fr. 39 977 58 246 88 505 41 568 64 584 98 749<br />
Quota di PD rispetto al risultato operativo agricolo<br />
% 17 18 20 23 24 28<br />
Pagamenti diretti per ha SAU<br />
fr./ha 2 486 2 353 2 351 2 756 2 662 2 692<br />
1<br />
I risultati si basano sui dati inerenti i pagamenti diretti AGIS delle aziende con risultati contabili dell'Analisi centralizzata di Agroscope<br />
2<br />
Contributi per singole colture<br />
3 I risultati si basano sui dati contabili dell'Analisi centralizzata di Agroscope<br />
Eventuali differenze risultano da contributi supplementari (cantonali, ecc.) ed eventuali delimitazioni differenti<br />
4<br />
Esclusi i tipi d'azienda colture speciali e trasformazione<br />
Fonte: Agroscope<br />
A52<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Pagamenti diretti a livello aziendale 1 : per le zone e le classi dimensionali 2015 4<br />
Zona di montagna I<br />
Zona di montagna II<br />
Caratteristica<br />
Aziende di riferimento<br />
Aziende rappresentate<br />
Superficie agricola utile<br />
Pagamenti diretti medi per azienda in virtù dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) 1<br />
10 – 20 20 – 30 30 – 50 10 – 20 20 – 30 30 – 50<br />
Unità ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU<br />
numero 89 63 53 91 80 66<br />
numero 1739 1202 778 2256 1693 933<br />
ha 15.22 24.43 35.28 15.04 24.03 38.11<br />
Contributi per il paesaggio rurale<br />
fr. 9 097 12 931 18 930 12 629 16 722 23 947<br />
Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento<br />
fr. 17 360 28 515 41 545 17 117 26 910 41 445<br />
Contributi per la biodiversità<br />
fr. 5 919 6 704 10 242 4 919 8 683 15 505<br />
Contributi per la qualità del paesaggio<br />
fr. 2 836 3 095 4 848 2 379 3 452 4 716<br />
Contributi per i sistemi di produzione<br />
fr. 7 776 12 052 18 524 6 948 10 921 18 976<br />
Contributi per l'efficienza delle risorse<br />
fr. 81 356 391 11 189 240<br />
Contributo di transizione<br />
fr. 3 424 5 146 5 597 3 139 4 539 6 885<br />
Totale pagamenti diretti giusta l'OPD fr. 46 539 68 737 100 059 47 113 71 500 111 363<br />
Altri pagamenti diretti 2<br />
fr. 51 78 120 2 9 29<br />
Risultato operativo agricolo 3 Fr. 161 556 228 356 314 460 143 681 205 669 326 958<br />
di cui pagamenti diretti<br />
fr. 49 006 71 309 106 754 52 165 75 886 117 451<br />
Quota di PD rispetto al risultato operativo agricolo<br />
% 30 31 34 36 37 36<br />
Pagamenti diretti per ha SAU<br />
fr./ha 3 219 2 919 3 026 3 469 3 158 3 082<br />
1<br />
I risultati si basano sui dati inerenti i pagamenti diretti AGIS delle aziende con risultati contabili dell'Analisi centralizzata di Agroscope<br />
2<br />
Contributi per singole colture<br />
3 I risultati si basano sui dati contabili dell'Analisi centralizzata di Agroscope<br />
Eventuali differenze risultano da contributi supplementari (cantonali, ecc.) ed eventuali delimitazioni differenti<br />
4<br />
Esclusi i tipi d'azienda colture speciali e trasformazione<br />
Fonte: Agroscope<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A53
Pagamenti diretti a livello aziendale 1 : per le zone e le classi dimensionali 2015 4<br />
Caratteristica<br />
Aziende di riferimento<br />
Aziende rappresentate<br />
Superficie agricole utile<br />
Pagamenti diretti medi per azienda in virtù dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) 1<br />
Zona di montagna III<br />
Zona di montagna IV<br />
10 – 20 20 – 30 30 – 50 10 – 20 20 – 30 30 – 50<br />
Unità ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU<br />
numero 45 38 36 25 26 33<br />
numero 1065 1029 705 499 719 791<br />
ha 14.92 24.46 36.14 14.22 25.08 36.92<br />
Contributi per il paesaggio rurale<br />
fr. 18 167 24 771 31 711 19 118 25 345 33 927<br />
Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento<br />
fr. 16 564 27 365 39 546 15 093 26 393 37 885<br />
Contributi per la biodiversità<br />
fr. 6 505 11 335 15 883 9 002 13 188 23 562<br />
Contributi per la qualità del paesaggio<br />
fr. 2 665 4 637 6 879 4 108 5 029 7 231<br />
Contributi per i sistemi di produzione<br />
fr. 6 453 11 028 16 115 4 978 10 765 18 772<br />
Contributi per l'efficienza delle risorse<br />
fr. 10 8 68 3 10 48<br />
Contributo di transizione<br />
fr. 2 567 4 237 6 256 2 659 4 110 6 519<br />
Totale pagamenti diretti giusta l'OPD fr. 52 929 83 278 116 487 54 905 84 612 127 918<br />
Altri pagamenti diretti 2<br />
fr.<br />
Risultato operativo agricolo 3 Fr. 121 924 188 078 247 121 99 126 176 729 220 004<br />
di cui pagamenti diretti<br />
fr. 59 665 89 827 124 388 58 785 95 411 131 972<br />
Quota di PD rispetto al risultato operativo agricolo<br />
% 49 48 50 59 54 60<br />
Pagamenti diretti per ha SAU<br />
fr./ha 4 000 3 673 3 442 4 135 3 805 3 575<br />
1<br />
I risultati si basano sui dati inerenti i pagamenti diretti AGIS delle aziende con risultati contabili dell'Analisi centralizzata di Agroscope<br />
2<br />
Contributi per singole colture<br />
3<br />
I risultati si basano sui dati contabili dell'Analisi centralizzata di Agroscope<br />
Eventuali differenze risultano da contributi supplementari (cantonali, ecc.) ed eventuali delimitazioni differenti<br />
4<br />
Esclusi i tipi d'azienda colture speciali e trasformazione<br />
Fonte: Agroscope<br />
A54<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Pagamenti diretti a livello aziendale 1 : per le zone e le classi dimensionali 2015 4<br />
Caratteristica<br />
Aziende di riferimento<br />
Aziende rappresentate<br />
Superficie agricola utile<br />
Pagamenti diretti medi per azienda in virtù dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) 1<br />
Tutte le Regione di Regione Regione<br />
aziende pianura collinare di montagna<br />
Unità<br />
numero 2 198 975 657 566<br />
numero 36 743 15 542 10 031 11 170<br />
ha 24,91 27,07 22,99 23,63<br />
Contributi per il paesaggio rurale<br />
fr. 9 320 1 622 8 876 20 429<br />
Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento<br />
fr. 26 884 27 836 26 487 25 915<br />
Contributi per la biodiversità<br />
fr. 9 394 9 655 7 958 10 318<br />
Contributi per la qualità del paesaggio<br />
fr. 3 369 3 002 3 215 4 018<br />
Contributi per i sistemi di produzione<br />
fr. 11 743 12 261 11 732 11 032<br />
Contributi per l'efficienza delle risorse<br />
fr. 492 879 356 76<br />
Contributo di transizione<br />
fr. 4 548 4 801 4 485 4 252<br />
Totale pagamenti diretti giusta l'OPD fr. 65 652 59 926 62 997 76 003<br />
Altri pagamenti diretti 2<br />
fr. 1 348 2 967 335 4<br />
Risultato operativo agricolo 3 Fr. 294 028 392 412 251 769 195 087<br />
di cui pagamenti diretti<br />
fr. 69 537 63 475 65 179 81 886<br />
Quota di PD rispetto al risultato operativo agricolo<br />
% 24 16 26 42<br />
Pagamenti diretti per ha SAU<br />
fr./ha 2 791 2 344 2 835 3 465<br />
1<br />
I risultati si basano sui dati inerenti i pagamenti diretti AGIS<br />
delle aziende con risultati contabilidell'Analisi centralizzata di Agroscope<br />
2<br />
Contributi per singole colture<br />
3<br />
I risultati si basano sui dati contabili dell'Analisi centralizzata di Agroscope<br />
Eventuali differenze risultano da contributi supplementari (cantonali, ecc.) ed eventuali delimitazioni differenti<br />
4<br />
Esclusi i tipi d'azienda colture speciali e trasformazione<br />
Fonte: Agroscope<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A55
A56<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Contributi per la qualità del paesaggio: contributo d’estivazione 2015<br />
Ovini (escl. pecore latt.) Vacche latt., pecore latt., capre Altri animali che cons. foraggio<br />
latt. 1<br />
grezzo<br />
Totale<br />
Aziende<br />
Carico<br />
usuale Contr. Aziende<br />
Carico<br />
usuale Contr. Aziende<br />
Carico<br />
usuale Contr. Aziende Contr.<br />
no.<br />
carichi<br />
norm. fr. no.<br />
carichi<br />
norm. fr. no.<br />
carichi<br />
norm. fr. no. fr.<br />
ZH 0 0 0 0 0 0 7 320 127 930 7 127 930<br />
BE 159 1 851 468 781 291 9 570 3 826 125 1 414 48 968 19 572 781 1 501 23 867 687<br />
LU 25 257 78 113 0 0 0 239 6 565 2 620 200 241 2 698 313<br />
UR 42 594 173 476 84 1 874 749 504 226 5 231 2 090 122 284 3 013 102<br />
SZ 44 686 219 853 94 941 373 439 397 11 349 4 519 578 424 5 112 870<br />
OW 21 188 46 126 27 312 111 669 236 8 475 3 382 143 250 3 539 938<br />
NW 5 16 4 499 3 46 18 268 125 4 342 1 736 642 126 1 759 410<br />
GL 13 445 144 276 1 17 6 800 108 6 842 2 736 637 116 2 887 713<br />
ZG 1 33 13 200 2 4 1 600 11 176 70 505 12 85 305<br />
FR 36 579 213 017 11 185 72 604 546 22 923 9 126 998 565 9 412 619<br />
SO 1 3 360 0 0 0 61 2 722 1 078 718 61 1 079 078<br />
BL 0 0 0 0 0 0 9 366 146 404 9 146 404<br />
SH 0 0 0 0 0 0 1 116 46 204 1 46 204<br />
AR 1 6 2 570 19 272 108 892 108 2 478 991 143 110 1 102 605<br />
AI 6 50 10 176 58 911 364 216 133 2 177 868 725 139 1 243 116<br />
SG 11 461 156 207 58 3 158 1 226 343 349 17 791 7 114 667 353 8 497 217<br />
GR 164 7 471 2 622 952 170 9 866 3 946 520 791 40 062 15 997 331 893 22 566 803<br />
AG 0 0 0 0 0 0 3 209 83 695 3 83 695<br />
TG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
TI 74 2 113 556 128 36 2 859 1 134 030 192 6 156 2 448 926 239 4 139 084<br />
VD 29 1 086 418 407 0 0 0 621 33 143 13 131 562 638 13 549 969<br />
VS 140 4 968 1 337 271 46 2 263 904 124 445 20 723 8 250 332 519 10 491 727<br />
NE 1 14 4 374 0 0 0 154 5 583 2 221 325 154 2 225 700<br />
GE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
JU 1 52 16 534 0 0 0 100 11 540 4 616 101 100 4 632 635<br />
Totale 774 20 874 6 486 321 900 32 277 12 844 134 6 276 258 255 102 978 670 6 745 122 309 124<br />
1<br />
Animali munti con una durata d'estivazione di 56–100 giorni<br />
Fonte: UFAG<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A57
A58<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Pagamenti diretti per le aziende d’estivazione – 2015<br />
Contributi Contributi Contributi per la qualità<br />
d’estivazione per la biodiversità 1 del paesaggio 2 Totale 3 A59<br />
Aziende Tot. contr. Aziende Tot. contr. Aziende Tot. contr. Aziende Tot. contr.<br />
Cantone no. fr. no. fr. no. fr. no. fr.<br />
ZH 7 127 930 5 10 856 0 0 7 138 786<br />
BE 1 501 23 867 687 871 3 950 020 1 170 1 380 637 1 504 29 198 344<br />
LU 241 2 698 313 168 459 200 202 303 556 244 3 461 069<br />
UR 284 3 013 102 245 1 453 613 135 273 595 323 4 740 310<br />
SZ 424 5 112 870 373 1 139 813 301 508 650 429 6 761 333<br />
OW 250 3 539 938 233 892 422 183 300 392 251 4 732 752<br />
NW 126 1 759 410 116 427 965 100 170 333 128 2 357 708<br />
GL 116 2 887 713 117 1 374 998 95 138 873 117 4 401 583<br />
ZG 12 85 305 3 2 696 4 3 890 12 91 891<br />
FR 565 9 412 619 380 1 386 337 513 1 606 179 577 12 405 135<br />
SO 61 1 079 078 58 172 496 0 0 64 1 251 574<br />
BL 9 146 404 7 17 805 0 0 9 164 209<br />
SH 1 46 204 0 0 0 0 1 46 204<br />
AR 110 1 102 605 87 123 317 67 154 177 112 1 380 099<br />
AI 139 1 243 116 114 133 695 105 132 928 147 1 509 739<br />
SG 353 8 497 217 259 971 086 176 567 993 361 10 036 296<br />
GR 893 22 566 803 56 788 529 1 5 796 893 23 361 128<br />
AG 3 83 695 0 0 0 0 3 83 695<br />
TG 0 0 0 0 0 0 0<br />
TI 239 4 139 084 127 913 212 48 114 562 239 5 166 858<br />
VD 638 13 549 969 551 2 470 514 554 2 257 494 664 18 277 976<br />
VS 519 10 491 727 508 4 433 645 228 855 663 534 15 781 036<br />
NE 154 2 225 700 91 95 867 0 0 162 2 321 566<br />
GE 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
JU 100 4 632 635 8 4 868 71 981 203 101 5 618 705<br />
Totale 6 745 122 309 124 4 377 21 222 951 3 953 9 755 921 6 882 153 287 996<br />
1 Numero di aziende e contributi sono incompleti per alcuni Cantoni.<br />
2 Contributo federale<br />
3<br />
Prima della riduzione / Pagamenti posticipati<br />
Fonte: UFAG<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento – 2015<br />
Contr. di base Contr. per le difficoltà Contr. per la superficie<br />
di produzione<br />
coltiva aperta e le colt. perenni<br />
Aziende Superficie Tot. contr. Aziende Superficie Tot. contr. Aziende Superficie Tot. contr.<br />
Cantone no. ha fr. no. ha fr. no. ha fr.<br />
ZH 2 944 67 115 54 987 559 806 12 665 3 298 523 2 412 28 036 11 214 456<br />
BE 10 190 185 607 155 052 461 7 501 118 919 36 014 757 6 456 46 289 18 515 617<br />
LU 4 350 73 991 62 830 558 3 061 42 465 11 985 957 2 580 14 201 5 680 428<br />
UR 538 6 530 5 231 209 538 6 478 2 167 976 14 11 4 432<br />
SZ 1 461 22 388 18 658 667 1 356 18 611 5 797 761 192 385 154 196<br />
OW 579 7 566 6 358 530 566 6 927 2 131 682 30 25 9 800<br />
NW 425 5 832 4 839 913 410 5 145 1 584 709 20 23 9 088<br />
GL 347 6 735 5 478 724 327 5 553 1 816 834 27 46 18 360<br />
ZG 488 9 593 8 165 738 334 5 535 1 637 263 240 1 390 555 944<br />
FR 2 542 73 175 61 719 986 1 548 35 588 9 866 976 1 875 22 792 9 116 771<br />
SO 1 188 30 312 24 588 452 591 12 981 3 643 960 903 10 062 4 024 708<br />
BL 820 20 711 16 867 204 672 13 585 3 454 577 681 5 916 2 366 472<br />
SH 488 13 662 11 044 563 162 2 720 593 522 477 9 165 3 665 800<br />
AR 617 11 383 9 829 761 617 11 296 3 498 697 19 19 7 708<br />
AI 436 6 868 5 951 986 436 6 847 2 170 726 7 5 2 188<br />
SG 3 569 67 620 57 447 684 2 666 38 848 11 533 534 1 123 5 344 2 137 424<br />
GR 2 176 53 756 39 678 657 2 103 49 899 17 120 935 590 2 428 971 100<br />
AG 2 609 56 910 46 974 427 1 251 18 043 4 265 836 2 443 26 359 10 543 472<br />
TG 2 136 47 089 39 659 158 186 2 238 619 982 1 854 18 906 7 562 528<br />
TI 744 12 993 10 062 829 664 10 370 3 329 226 420 1 714 685 548<br />
VD 3 239 103 983 84 778 890 1 229 30 700 8 640 109 2 839 57 540 23 015 812<br />
VS 2 661 36 357 26 206 176 2 552 29 808 9 900 782 1 572 7 731 3 092 332<br />
NE 727 31 193 25 255 899 622 25 910 8 119 424 331 4 645 1 858 180<br />
GE 257 9 971 7 732 345 2 12 3 914 249 7 594 3 037 492<br />
JU 951 38 457 31 371 033 728 24 290 7 286 998 680 10 060 4 023 988<br />
CH 46 482 999 797 820 772 410 30 928 535 435 160 484 660 28 034 280 685 112 273 844<br />
Zone<br />
Pianura 19 681 466 223 387 822 942 4 139 22 149 5 676 913 17 941 234 492 93 796 715<br />
Collina 6 719 137 337 114 514 292 6 714 123 995 29 915 291 5 056 32 309 12 923 771<br />
ZM I 6 063 113 685 95 913 869 6 062 110 992 32 913 276 2 674 9 408 3 763 333<br />
ZM II 7 371 150 215 123 551 745 7 370 148 153 47 081 419 1 492 3 650 1 459 934<br />
ZM III 4 196 80 380 62 263 185 4 191 79 439 26 882 310 625 689 275 518<br />
ZM IV 2 452 51 956 36 706 378 2 452 50 707 18 015 452 246 136 54 573<br />
Fonte: UFAG<br />
A60<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Legenda<br />
Numero-progetto Nome-progetto Cantone Numero-progetto Nome-progetto<br />
Cantone<br />
Contenuto<br />
1<br />
Franches-Montagnes et Clos du<br />
Doubs<br />
JU 56 Jorat VD<br />
2 Solothurn Grenchen SO 57 Jura vaudois VD<br />
3 Kanton AI AI 58 Pied du Jura VD<br />
4 Kanton AR AR 59 Pleine de l'Orbe VD<br />
5 Kanton GL GL 60 Plaine du Rhône VD<br />
6 Kanton SH SH 61 Rives lémaiques VD<br />
7 Limmattal AG 62 Broye VD / FR<br />
8 Leimental Dorneckberg SO 63 Binntal VS<br />
9 Valle Verzasca TI 64 Lötschental VS<br />
10 Engadina Bassa Val Müstair GR 65 Regionaler Naturpark Pfyn VS<br />
11 Olten Gösgen Gäu SO 66 Grand Entremont VS<br />
12 Einsiedeln SZ 67 Val d'Anniviers VS<br />
13 Fronalp Pragel SZ 68 Noble et Louable Contrée VS<br />
14 March SZ 69 Hérens VS<br />
15 Rigi Mythen SZ 70 Val-de-Ruz NE<br />
16 Kanton UR UR 71 Vallée de la Brévine NE<br />
17 Kantone BL und BS BL / BS 72 Sense-See<br />
18 Kanton GE teilweise GE 73 Glâne-Sarine-Lac<br />
19 Intyamon Jogne VD 74 Gruyère-Veveyse<br />
20 Entlebuch LU 75 Thal<br />
21 Hochdorf LU 76 Oberthurgau TG<br />
22 Luzern LU 77 Hinterthurgau-Immenberg<br />
23 Sursee LU 78 Region Wynetal Aargau Süd<br />
24 Willisau LU 79 Jurapark<br />
25 Neckertal SG 80 Region Lebensraum Lenzburg AG<br />
26 Kanton OW OW 81 Unteres Bünztal AG<br />
27 Kanton NW NW 82 Rafzerfeld<br />
28 Kanton ZG ZG 83 Winterthur-Andelfingen<br />
29 Mittelthurgau TG 84 Zürich Süd ZH<br />
30 Cadi GR 85 Zürich Unterland ZH<br />
31 Lumnezia Vals GR 86 Berner Mittelland BE<br />
32 Foppa Safiental GR 88 Emmental BE<br />
33 Heinzenberg Domleschg GR 90 Kandertal BE<br />
34 Imboden GR 91 Oberaargau BE<br />
35 Schanfigg Churwalden GR 92 Oberland Ost BE<br />
36 Rheintal GR 93 Obersimmental-Saanenland BE<br />
37 Prättigau GR 94 Seeland BE<br />
38 Hinterrhein GR 95 Trois-Vaux<br />
39 Surses GR 96 Rapperswil-Jona, Eschenbach ZH<br />
40 Albulatal GR 97 Werdenberg Nord<br />
41 Davos GR 98 Obertoggenburg<br />
42 Mesocina Clanca GR 99 Pfäfers<br />
43 Bregaglia GR 100 Rheintal<br />
44 Oberengadin GR 101 Walenstadt<br />
45 Valposchiavo GR 102 Coude du Rhône VS<br />
46 Zürcher Oberland ZH 103 Simplon VS<br />
47 Pfannenstiel Egg ZH 104 Obergoms/ Untergoms nordseitig VS<br />
48 Ajoie JU 105 Blenio TI<br />
49 Delémont JU 106 Luganese TI<br />
50 Chasseral BE 108 Parco Nazionale del Locarnese TI<br />
51 Gantrisch BE / FR 109 Vallemaggia TI<br />
52 Diemtigen BE 111 Mendrisiotto TI<br />
53 Thierstein SO 113 Val-de-Travers Vallon<br />
54 Alpes Vaudoises VD 114 Chaux-de-Fonds-Le Locle<br />
55 Gros-de-Vaud VD<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A61
A62<br />
Contributi per la qualità del paesaggio nel 2015 vista globale<br />
Numeroprogetto<br />
Aziende Partecipazi<br />
one (% le<br />
partecipazi<br />
oni in LQperimetral<br />
e LN)<br />
Nome-progetto Numero %<br />
Aziende gestite tutto l'anno<br />
AVG.<br />
Contributo<br />
per il<br />
funzioname<br />
nto LN<br />
Fr. /<br />
Azienda<br />
Contribut<br />
o per<br />
area<br />
(Holdings<br />
LN)<br />
Aziende d'estivazione<br />
Aziende Partecipaz<br />
ione (% le<br />
partecipaz<br />
ioni in LQperimetra<br />
le<br />
estivazion<br />
Fr. / ha Numero %<br />
AVG.<br />
Contribut<br />
o per il<br />
funziona<br />
mento<br />
d'estivazi<br />
one<br />
Fr. /<br />
Azienda<br />
Contributi<br />
allineati<br />
1<br />
Franches-Montagnes et<br />
Clos du Doubs<br />
271 62% 5'164.00 140 30 81% 24'706 2'140'640<br />
2 Solothurn Grenchen 368 32% 2'702.00 106 0 0% 0 1'113'395<br />
3 Kanton AI 278 62% 1'763.00 104 105 74% 1'266 623'097<br />
4 Kanton AR 433 56% 3'117.00 149 67 66% 2'301 1'503'993<br />
5 Kanton GL 280 80% 3'583.00 170 95 82% 1'462 1'142'211<br />
6 Kanton SH 400 85% 3'435.00 100 0 0% 0 1'460'017<br />
7 Limmattal 42 74% 4'051.00 173 0 0% 0 174'192<br />
8 Leimental Dorneckberg 95 47% 1'987.00 63 0 0% 0 188'792<br />
9 Valle Verzasca 30 37% 1'917.00 140 15 65% 1'082 79'508<br />
10 Engadina Bassa Val Müstair 221 89% 5'680.00 222 1 3% 5'796 1'261'034<br />
11 Olten Gösgen Gäu 230 48% 1'976.00 72 0 0% 0 454'445<br />
12 Einsiedeln 346 82% 3'355.00 163 103 69% 1'224 1'286'913<br />
13 Fronalp Pragel 130 81% 3'273.00 216 85 62% 2'020 597'210<br />
14 March 199 60% 2'851.00 164 38 66% 2'097 647'099<br />
15 Rigi Mythen 421 73% 3'308.00 221 75 65% 1'749 1'523'895<br />
16 Kanton UR 416 75% 2'943.00 222 135 43% 2'027 1'497'806<br />
17 Kantone BL und BS 464 55% 3'119.00 103 0 0% 0 1'447'141<br />
18 Kanton GE teilweise 178 67% 5'665.00 118 0 0% 0 1'014'034<br />
19 Intyamon Jogne 87 13% 2'762.00 91 191 56% 4'207 1'414'373<br />
20 Entlebuch 792 94% 3'005.00 171 164 85% 1'525 2'630'137<br />
21 Hochdorf 509 74% 2'585.00 138 0 0% 0 1'315'721<br />
22 Luzern 434 68% 2'947.00 160 26 76% 1'535 1'318'847<br />
23 Sursee 719 63% 2'571.00 133 0 0% 0 1'848'825<br />
24 Willisau 1'033 83% 2'599.00 154 12 80% 1'125 2'698'342<br />
25 Neckertal 174 44% 2'744.00 122 2 100% 504 492'175<br />
26 Kanton OW 479 81% 2'804.00 200 183 73% 1'641 1'643'598<br />
27 Kanton NW 383 88% 2'351.00 163 100 76% 1'703 1'070'701<br />
28 Kanton ZG 380 77% 3'016.00 139 4 40% 972 1'150'003<br />
29 Mittelthurgau 322 57% 2'922.00 125 0 0% 0 940'845<br />
30 Cadi 141 86% 4'525.00 188 0 0% 0 656'105<br />
31 Lumnezia Vals 131 95% 4'279.00 170 0 0% 0 564'873<br />
32 Foppa Safiental 150 48% 4'805.00 172 0 0% 0 1'235'012<br />
33 Heinzenberg Domleschg 98 84% 5'296.00 184 0 0% 0 757'290<br />
34 Imboden 61 24% 5'372.00 162 0 0% 0 365'296<br />
35 Schanfigg Churwalden 107 66% 5'395.00 157 0 0% 0 577'271<br />
36 Rheintal 111 46% 5'512.00 229 0 0% 0 611'854<br />
37 Prättigau 311 87% 4'370.00 197 0 0% 0 1'359'115<br />
38 Hinterrhein 117 85% 8'522.00 252 0 0% 0 997'106<br />
39 Surses 6 18% 6'296.00 185 0 0% 0 484'820<br />
40 Albulatal 67 29% 5'665.00 196 0 0% 0 628'833<br />
41 Davos 79 52% 3'918.00 172 0 0% 0 309'507<br />
42 Mesocina Clanca 65 79% 4'402.00 266 0 0% 0 338'943<br />
43 Bregaglia 28 82% 6'221.00 261 0 0% 0 174'199<br />
44 Oberengadin 69 37% 5'069.00 154 0 0% 0 349'754<br />
45 Valposchiavo 75 88% 6'433.00 300 0 0% 0 482'454<br />
46 Zürcher Oberland 529 58% 3'107.00 121 0 0% 0 1'746'226<br />
47 Pfannenstiel Egg 123 62% 3'641.00 140 0 0% 0 447'857<br />
48 Ajoie 257 85% 6'641.00 123 11 69% 3'784 1'748'268<br />
49 Delémont 248 83% 5'966.00 137 30 79% 6'613 1'677'980<br />
50 Chasseral 312 48% 2'541.00 72 63 66% 2'270 979'363<br />
51 Gantrisch 963 42% 2'395.00 127 140 67% 1'032 2'451'645<br />
52 Ufficio federale Diemtigen dell’agricoltura 1'026UFAG<br />
42% 2'504.00 152 279 61% 1'022 2'854'507<br />
53 Thierstein 111 40% 1'888.00 54 0 0% 0 209'538<br />
54 Alpes Vaudoises 203 50% 4'382.00 148 284 83% 4'009 2'036'150<br />
Fr
42 Mesocina Clanca 65 79% 4'402.00 266 0 0% 0 338'943<br />
43 Bregaglia 28 82% 6'221.00 261 0 0% 0 174'199<br />
44 Oberengadin 69 37% 5'069.00 154 0 0% 0 349'754<br />
45 Valposchiavo 75 88% 6'433.00 300 0 0% 0 482'454<br />
46 Zürcher Oberland 529 58% 3'107.00 121 0 0% 0 1'746'226<br />
47 Pfannenstiel Egg 123 62% 3'641.00 140 0 0% 0 447'857<br />
48 Ajoie 257 85% 6'641.00 123 11 69% 3'784 1'748'268<br />
49 Delémont 248 83% 5'966.00 137 30 79% 6'613 1'677'980<br />
50 Chasseral 312 48% 2'541.00 72 63 66% 2'270 979'363<br />
51 Gantrisch 963 42% 2'395.00 127 140 67% 1'032 2'451'645<br />
52 Diemtigen 1'026 42% 2'504.00 152 279 61% 1'022 2'854'507<br />
53 Thierstein 111 40% 1'888.00 54 0 0% 0 209'538<br />
54 Alpes Vaudoises 203 50% 4'382.00 148 284 83% 4'009 2'036'150<br />
55 Gros-de-Vaud 453 80% 5'170.00 145 0 0% 0 2'341'847<br />
56 Jorat 397 62% 5'944.00 158 0 0% 0 2'413'388<br />
57 Jura vaudois 79 34% 7'429.00 150 268 85% 4'145 1'697'719<br />
58 Pied du Jura 575 79% 6'107.00 151 0 0% 0 3'511'565<br />
59 Pleine de l'Orbe 107 81% 7'648.00 153 0 0% 0 818'337<br />
60 Plaine du Rhône 82 40% 3'515.00 135 0 0% 0 288'242<br />
61 Rives lémaiques 387 61% 3'994.00 150 0 0% 0 1'565'616<br />
62 Broye 519 55% 5'305.00 148 0 0% 0 3'013'328<br />
63 Binntal 49 51% 6'925.00 277 9 69% 3'366 369'613<br />
64 Lötschental 28 76% 5'419.00 270 11 92% 3'301 204'314<br />
65 Regionaler Naturpark Pfyn 147 33% 4'143.00 261 19 79% 4'248 722'851<br />
66 Grand Entremont 181 46% 6'713.00 341 45 90% 3'466 1'384'356<br />
67 Val d'Anniviers 78 20% 4'070.00 199 22 88% 7'100 494'011<br />
68 Noble et Louable Contrée 139 27% 3'678.00 263 12 92% 3'454 585'789<br />
69 Hérens 98 55% 6'591.00 275 27 79% 3'969 884'943<br />
70 Val-de-Ruz 87 61% 7'075.00 147 0 0% 0 622'560<br />
71 Vallée de la Brévine 97 42% 5'048.00 89 0 0% 0 494'698<br />
72 Sense-See 546 36% 4'887.00 164 32 74% 1'737 2'723'623<br />
73 Glâne-Sarine-Lac 637 41% 4'834.00 137 7 70% 1'668 3'091'232<br />
74 Gruyère-Veveyse 374 44% 4'099.00 115 164 40% 2'246 1'915'842<br />
75 Thal 159 77% 1'857.00 64 0 0% 0 295'285<br />
76 Oberthurgau 343 60% 4'525.00 204 0 0% 0 1'552'202<br />
77 Hinterthurgau-Immenberg 200 58% 2'728.00 104 0 0% 0 545'533<br />
78 Region Wynetal Aargau Süd 71 50% 4'604.00 176 0 0% 0 326'870<br />
79 Jurapark 227 52% 6'062.00 224 0 0% 0 1'418'422<br />
80<br />
Region Lebensraum<br />
Lenzburg<br />
70 44% 4'877.00 170 0 0% 0 341'421<br />
81 Unteres Bünztal 55 43% 3'891.00 148 0 0% 0 213'990<br />
82 Rafzerfeld 38 49% 3'402.00 121 0 0% 0 129'279<br />
83 Winterthur-Andelfingen 540 55% 3'980.00 153 0 0% 0 2'148'937<br />
84 Zürich Süd 310 59% 3'549.00 140 0 0% 0 1'100'128<br />
85 Zürich Unterland 311 60% 3'947.00 143 0 0% 0 1'227'478<br />
86 Berner Mittelland 1'673 36% 2'524.00 128 2 100% 767 4'224'641<br />
88 Emmental 2'038 48% 3'023.00 172 81 78% 818 6'228'071<br />
90 Kandertal 430 51% 3'186.00 210 176 78% 946 1'536'580<br />
91 Oberaargau 969 47% 3'016.00 168 7 50% 1'022 2'929'972<br />
92 Oberland Ost 499 38% 3'295.00 193 122 70% 1'636 1'843'754<br />
93 Obersimmental-Saanenland 600 46% 3'469.00 169 304 62% 983 2'380'902<br />
94 Seeland 781 44% 2'238.00 95 0 0% 0 1'747'747<br />
95 Trois-Vaux 179 31% 3'445.00 100 55 71% 2'184 742'437<br />
96<br />
Rapperswil-Jona,<br />
Eschenbach<br />
99 56% 3'540.00 149 7 58% 1'400 395'647<br />
97 Werdenberg Nord 127 33% 3'716.00 152 25 57% 2'583 539'148<br />
98 Obertoggenburg 218 30% 3'460.00 157 103 71% 3'260 1'103'806<br />
99 Pfäfers 35 85% 3'039.00 129 15 94% 5'281 206'074<br />
100 Rheintal 199 41% 4'252.00 159 14 74% 3'610 900'875<br />
101 Walenstadt 30 16% 2'643.00 126 8 67% 2'407 130'271<br />
102 Coude du Rhône 153 34% 5'213.00 261 25 63% 3'504 940'775<br />
103 Simplon 64 50% 6'025.00 319 36 64% 3'021 560'666<br />
104<br />
Obergoms/ Untergoms<br />
nordseitig<br />
66 53% 6'062.00 198 21 46% 2'272 447'783<br />
105 Blenio 55 49% 3'572.00 143 13 29% 5'231 278'778<br />
106 Luganese 47 52% 3'035.00 132 8 36% 1'816 160'221<br />
108<br />
Parco Nazionale del<br />
Locarnese<br />
24 57% 2'066.00 133 3 60% 441 50'909<br />
109 Vallemaggia 40 60% 2'603.00 132 8 22% 1'638 117'210<br />
111 Mendrisiotto 42 29% 1'695.00 119 1 50% 1'369 72'567<br />
113 Val-de-Travers Vallon 37 21% 6'380.00 126 0 0% 0 242'434<br />
114 Chaux-de-Fonds-Le Locle 121 33% 4'292.00 89 0 0% 0 527'897<br />
Svizzera 31'412 51% 3'612.00 149 3'888 66% 2'455 125'475'541<br />
Fonte: UFAG<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A63
Contributi per la qualità del paesaggio nel 2015<br />
Numero Numero Parte- Parte- Mostra Mostra Contributi Contributi Totale<br />
di di accordo cipazione cipazione media media allineati allineati Contributi<br />
esercizi di AN (% AN (% Contributi Contributi allineati<br />
convenzion (SOEG) aziende) aziende) azienda azienda LN SOEG<br />
Cantone Numero Numero % % Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.<br />
ZH 1 876 0 63% 0% 3 616 #DIV/0! 6 782 737 0 6 782 737<br />
BE 8 901 1 170 87% 78% 2 958 1 180 26 326 194 1 380 637 27 706 830<br />
LU 3 487 202 80% 83% 2 727 1 503 9 508 316 303 556 9 811 872<br />
UR 416 135 77% 42% 2 943 2 027 1 224 210 273 595 1 497 806<br />
SZ 1 096 301 75% 70% 3 236 1 690 3 546 467 508 650 4 055 117<br />
OW 479 183 82% 73% 2 804 1 641 1 343 207 300 392 1 643 598<br />
NW 383 100 89% 78% 2 351 1 703 900 368 170 333 1 070 701<br />
GL 280 95 81% 81% 3 583 1 462 1 003 338 138 873 1 142 211<br />
ZG 380 4 77% 33% 3 016 972 1 146 113 3 890 1 150 003<br />
FR 1 852 513 72% 89% 5 053 3 131 9 358 226 1 606 179 10 964 405<br />
SO 964 0 80% 0% 2 346 0 2 261 590 0 2 261 590<br />
BL 464 0 56% 0% 3 119 0 1 447 141 0 1 447 141<br />
SH 425 0 87% 0% 3 435 0 1 460 017 0 1 460 017<br />
AR 430 67 69% 60% 3 126 2 301 1 344 366 154 177 1 498 543<br />
AI 278 105 62% 71% 1 791 1 266 497 898 132 928 630 826<br />
SG 904 176 25% 49% 3 537 3 227 3 197 721 567 993 3 765 715<br />
GR 2 035 1 93% 0% 5 478 5 796 11 147 670 5 796 11 153 466<br />
AG 473 0 18% 0% 5 232 0 2 474 894 0 2 474 894<br />
TG 867 0 40% 0% 3 525 0 3 055 749 0 3 055 749<br />
TI 244 48 32% 20% 2 642 2 387 644 632 114 562 759 194<br />
VD 2 553 554 78% 83% 5 372 4 075 13 714 476 2 257 494 15 971 970<br />
VS 981 228 37% 43% 5 851 3 753 5 739 438 855 663 6 595 101<br />
NE 361 0 50% 0% 5 532 0 1 997 028 0 1 997 028<br />
GE 179 0 69% 0% 5 665 0 1 014 034 0 1 014 034<br />
JU 775 71 81% 70% 5 915 13 820 4 583 790 981 203 5 564 992<br />
Svizzera 31 083 3 953 66% 57% 3 723 2 468 115 719 620 9 755 921 125 475 541<br />
SAU = aziende annuali<br />
Regione d'estivazione<br />
Nella presente tabella i valori sulle partecipazioni SAU e regione d'estivazione in percentuale si riferiscono al numero di tutte le aziende annuali e<br />
d'estivazione del Cantone. Pertanto ad esempio il Canton Grigioni ha un'elevata partecipazione delle aziende annuali e Appenzello esterno delle<br />
aziende d'estivazione: in questi Cantoni tutte le aziende hanno avuto la possibilità di partecipare a un progetto QP.<br />
Fonte: UFAG<br />
A64<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Qualità del paesaggio: numero di aziende e contributi per progetto<br />
Aziende gestite Aziende Contributi<br />
tutto l'anno d'estivazione versati<br />
Numero-progetto Nome-progetto Cantone Numero Numero Fr<br />
1 Franches-Montagnes et Clos du Doubs JU 271 30 2'140'640<br />
2 Solothurn Grenchen SO 368 0 1'113'395<br />
3 Kanton AI AI 278 105 623'097<br />
4 Kanton AR AR 433 67 1'503'993<br />
5 Kanton GL GL 280 95 1'142'211<br />
6 Kanton SH SH 400 0 1'460'017<br />
7 Limmattal AG 42 0 174'192<br />
8 Leimental Dorneckberg SO 95 0 188'792<br />
9 Valle Verzasca TI 30 15 79'508<br />
10 Engadina Bassa Val Müstair GR 221 1 1'261'034<br />
11 Olten Gösgen Gäu SO 230 0 454'445<br />
12 Einsiedeln SZ 346 103 1'286'913<br />
13 Fronalp Pragel SZ 130 85 597'210<br />
14 March SZ 199 38 647'099<br />
15 Rigi Mythen SZ 421 75 1'523'895<br />
16 Kanton UR UR 416 135 1'497'806<br />
17 Kantone BL und BS BL / BS 464 0 1'447'141<br />
18 Kanton GE teilweise GE 178 0 1'014'034<br />
19 Intyamon Jogne FR 87 191 1'414'373<br />
20 Entlebuch LU 792 164 2'630'137<br />
21 Hochdorf LU 509 0 1'315'721<br />
22 Luzern LU 434 26 1'318'847<br />
23 Sursee LU 719 0 1'848'825<br />
24 Willisau LU 1033 12 2'698'342<br />
25 Neckertal SG 174 2 492'175<br />
26 Kanton OW OW 479 183 1'643'598<br />
27 Kanton NW NW 383 100 1'070'701<br />
28 Kanton ZG ZG 380 4 1'150'003<br />
29 Mittelthurgau TG 322 0 940'845<br />
30 Cadi GR 141 0 656'105<br />
31 Lumnezia Vals GR 131 0 564'873<br />
32 Foppa Safiental GR 150 0 1'235'012<br />
33 Heinzenberg Domleschg GR 98 0 757'290<br />
34 Imboden GR 61 0 365'296<br />
35 Schanfigg Churwalden GR 107 0 577'271<br />
36 Rheintal GR 111 0 611'854<br />
37 Prättigau GR 311 0 1'359'115<br />
38 Hinterrhein GR 117 0 997'106<br />
39 Surses GR 6 0 484'820<br />
40 Albulatal GR 67 0 628'833<br />
41 Davos GR 79 0 309'507<br />
42 Mesocina Clanca GR 65 0 338'943<br />
43 Bregaglia GR 28 0 174'199<br />
44 Oberengadin GR 69 0 349'754<br />
45 Valposchiavo GR 75 0 482'454<br />
46 Zürcher Oberland ZH 529 0 1'746'226<br />
47 Pfannenstiel Egg ZH 123 0 447'857<br />
48 Ajoie JU 257 11 1'748'268<br />
49 Delémont JU 248 30 1'677'980<br />
50 Chasseral BE 312 63 979'363<br />
51 Gantrisch BE / FR 963 140 2'451'645<br />
52 Diemtigen BE 1026 279 2'854'507<br />
53 Thierstein SO 111 0 209'538<br />
54 Alpes Vaudoises VD 203 284 2'036'150<br />
55 Gros-de-Vaud VD 453 0 2'341'847<br />
56 Jorat VD 397 0 2'413'388<br />
57 Jura vaudois VD 79 268 1'697'719<br />
58 Pied du Jura VD 575 0 3'511'565<br />
59 Pleine de l'Orbe VD 107 0 818'337<br />
60 Plaine du Rhône VD 82 0 288'242<br />
Ufficio 61 federale dell’agricoltura Rives UFAG lémaiques VD 387 0 1'565'616<br />
62 Broye VD / FR 519 0 3'013'328<br />
63 Binntal VS 49 9 369'613<br />
A65
48 Ajoie JU 257 11 1'748'268<br />
49 Delémont JU 248 30 1'677'980<br />
50 Chasseral BE 312 63 979'363<br />
51 Gantrisch BE / FR 963 140 2'451'645<br />
52 Diemtigen BE 1026 279 2'854'507<br />
53 Thierstein SO 111 0 209'538<br />
54 Alpes Vaudoises VD 203 284 2'036'150<br />
55 Gros-de-Vaud VD 453 0 2'341'847<br />
56 Jorat VD 397 0 2'413'388<br />
57 Jura vaudois VD 79 268 1'697'719<br />
58 Pied du Jura VD 575 0 3'511'565<br />
59 Pleine de l'Orbe VD 107 0 818'337<br />
60 Plaine du Rhône VD 82 0 288'242<br />
61 Rives lémaiques VD 387 0 1'565'616<br />
62 Broye VD / FR 519 0 3'013'328<br />
63 Binntal VS 49 9 369'613<br />
64 Lötschental VS 28 11 204'314<br />
65 Regionaler Naturpark Pfyn VS 147 19 722'851<br />
66 Grand Entremont VS 181 45 1'384'356<br />
67 Val d'Anniviers VS 78 22 494'011<br />
68 Noble et Louable Contrée VS 139 12 585'789<br />
69 Hérens VS 98 27 884'943<br />
70 Val-de-Ruz NE 87 0 622'560<br />
71 Vallée de la Brévine NE 97 0 494'698<br />
72 Sense-See 546 32 2'723'623<br />
73 Glâne-Sarine-Lac 637 7 3'091'232<br />
74 Gruyère-Veveyse 374 164 1'915'842<br />
75 Thal 159 0 295'285<br />
76 Oberthurgau TG 343 0 1'552'202<br />
77 Hinterthurgau-Immenberg TG 200 0 545'533<br />
78 Region Wynetal Aargau Süd AG 71 0 326'870<br />
79 Jurapark 227 0 1'418'422<br />
80 Region Lebensraum Lenzburg AG 70 0 341'421<br />
81 Unteres Bünztal AG 55 0 213'990<br />
82 Rafzerfeld ZH 38 0 129'279<br />
83 Winterthur-Andelfingen ZH 540 0 2'148'937<br />
84 Zürich Süd ZH 310 0 1'100'128<br />
85 Zürich Unterland ZH 311 0 1'227'478<br />
86 Berner Mittelland BE 1673 2 4'224'641<br />
88 Emmental BE 2038 81 6'228'071<br />
90 Kandertal BE 430 176 1'536'580<br />
91 Oberaargau BE 969 7 2'929'972<br />
92 Oberland Ost BE 499 122 1'843'754<br />
93 Obersimmental-Saanenland BE 600 304 2'380'902<br />
94 Seeland BE 781 0 1'747'747<br />
95 Trois-Vaux 179 55 742'437<br />
96 Rapperswil-Jona, Eschenbach 99 7 395'647<br />
97 Werdenberg Nord 127 25 539'148<br />
98 Obertoggenburg 218 103 1'103'806<br />
99 Pfäfers 35 15 206'074<br />
100 Rheintal 199 14 900'875<br />
101 Walenstadt 30 8 130'271<br />
102 Coude du Rhône 153 25 940'775<br />
103 Simplon 64 36 560'666<br />
104 Obergoms/ Untergoms nordseitig VS 66 21 447'783<br />
105 Blenio TI 55 13 278'778<br />
106 Luganese TI 47 8 160'221<br />
108 Parco Nazionale del Locarnese TI 24 3 50'909<br />
109 Vallemaggia TI 40 8 117'210<br />
111 Mendrisiotto TI 42 1 72'567<br />
113 Val-de-Travers Vallon 37 0 242'434<br />
114 Chaux-de-Fonds-Le Locle 121 0 527'897<br />
Svizzera 31 412 3888 125'475'541<br />
Fonte: UFAG<br />
A66<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Qualità del paesaggio: partecipazione per progetto<br />
Partecipazione<br />
Partecipazione<br />
aziende gestite aziende d'estivazione<br />
tutto l'anno<br />
(% partecipazione (% partecipazione nel<br />
Numeroprogetto<br />
Nome-progetto Cantone nel perimetro QP SAU) perimetro QP estivazione)<br />
1 Franches-Montagnes et Clos du Doubs JU 62% 81%<br />
2 Solothurn Grenchen SO 32% 0%<br />
3 Kanton AI AI 62% 74%<br />
4 Kanton AR AR 56% 66%<br />
5 Kanton GL GL 80% 82%<br />
6 Kanton SH SH 85% 0%<br />
7 Limmattal AG 74% 0%<br />
8 Leimental Dorneckberg SO 47% 0%<br />
9 Valle Verzasca TI 37% 65%<br />
10 Engadina Bassa Val Müstair GR 89% 3%<br />
11 Olten Gösgen Gäu SO 48% 0%<br />
12 Einsiedeln SZ 82% 69%<br />
13 Fronalp Pragel SZ 81% 62%<br />
14 March SZ 60% 66%<br />
15 Rigi Mythen SZ 73% 65%<br />
16 Kanton UR UR 75% 43%<br />
17 Kantone BL und BS BL / BS 55% 0%<br />
18 Kanton GE teilweise GE 67% 0%<br />
19 Intyamon Jogne FR 13% 56%<br />
20 Entlebuch LU 94% 85%<br />
21 Hochdorf LU 74% 0%<br />
22 Luzern LU 68% 76%<br />
23 Sursee LU 63% 0%<br />
24 Willisau LU 83% 80%<br />
25 Neckertal SG 44% 100%<br />
26 Kanton OW OW 81% 73%<br />
27 Kanton NW NW 88% 76%<br />
28 Kanton ZG ZG 77% 40%<br />
29 Mittelthurgau TG 57% 0%<br />
30 Cadi GR 86% 0%<br />
31 Lumnezia Vals GR 95% 0%<br />
32 Foppa Safiental GR 48% 0%<br />
33 Heinzenberg Domleschg GR 84% 0%<br />
34 Imboden GR 24% 0%<br />
35 Schanfigg Churwalden GR 66% 0%<br />
36 Rheintal GR 46% 0%<br />
37 Prättigau GR 87% 0%<br />
38 Hinterrhein GR 85% 0%<br />
39 Surses GR 18% 0%<br />
40 Albulatal GR 29% 0%<br />
41 Davos GR 52% 0%<br />
42 Mesocina Clanca GR 79% 0%<br />
43 Bregaglia GR 82% 0%<br />
44 Oberengadin GR 37% 0%<br />
45 Valposchiavo GR 88% 0%<br />
46 Zürcher Oberland ZH 58% 0%<br />
47 Pfannenstiel Egg ZH 62% 0%<br />
48 Ajoie JU 85% 69%<br />
49 Delémont JU 83% 79%<br />
50 Chasseral BE 48% 66%<br />
51 Gantrisch BE / FR 42% 67%<br />
52 Diemtigen BE 42% 61%<br />
53 Thierstein SO 40% 0%<br />
54 Alpes Vaudoises VD 50% 83%<br />
55 Gros-de-Vaud VD 80% 0%<br />
56 Jorat VD 62% 0%<br />
57 Jura vaudois VD 34% 85%<br />
58 Ufficio federale dell’agricoltura Pied UFAG du Jura VD 79% 0%<br />
59 Pleine de l'Orbe VD 81% 0%<br />
60 Plaine du Rhône VD 40% 0%<br />
A67
45 Valposchiavo GR 88% 0%<br />
46 Zürcher Oberland ZH 58% 0%<br />
47 Pfannenstiel Egg ZH 62% 0%<br />
48 Ajoie JU 85% 69%<br />
49 Delémont JU 83% 79%<br />
50 Chasseral BE 48% 66%<br />
51 Gantrisch BE / FR 42% 67%<br />
52 Diemtigen BE 42% 61%<br />
53 Thierstein SO 40% 0%<br />
54 Alpes Vaudoises VD 50% 83%<br />
55 Gros-de-Vaud VD 80% 0%<br />
56 Jorat VD 62% 0%<br />
57 Jura vaudois VD 34% 85%<br />
58 Pied du Jura VD 79% 0%<br />
59 Pleine de l'Orbe VD 81% 0%<br />
60 Plaine du Rhône VD 40% 0%<br />
61 Rives lémaiques VD 61% 0%<br />
62 Broye VD / FR 55% 0%<br />
63 Binntal VS 51% 69%<br />
64 Lötschental VS 76% 92%<br />
65 Regionaler Naturpark Pfyn VS 33% 79%<br />
66 Grand Entremont VS 46% 90%<br />
67 Val d'Anniviers VS 20% 88%<br />
68 Noble et Louable Contrée VS 27% 92%<br />
69 Hérens VS 55% 79%<br />
70 Val-de-Ruz NE 61% 0%<br />
71 Vallée de la Brévine NE 42% 0%<br />
72 Sense-See 36% 74%<br />
73 Glâne-Sarine-Lac 41% 70%<br />
74 Gruyère-Veveyse 44% 40%<br />
75 Thal 77% 0%<br />
76 Oberthurgau TG 60% 0%<br />
77 Hinterthurgau-Immenberg TG 58% 0%<br />
78 Region Wynetal Aargau Süd AG 50% 0%<br />
79 Jurapark 52% 0%<br />
80 Region Lebensraum Lenzburg AG 44% 0%<br />
81 Unteres Bünztal AG 43% 0%<br />
82 Rafzerfeld ZH 49% 0%<br />
83 Winterthur-Andelfingen ZH 55% 0%<br />
84 Zürich Süd ZH 59% 0%<br />
85 Zürich Unterland ZH 60% 0%<br />
86 Berner Mittelland BE 36% 100%<br />
88 Emmental BE 48% 78%<br />
90 Kandertal BE 51% 78%<br />
91 Oberaargau BE 47% 50%<br />
92 Oberland Ost BE 38% 70%<br />
93 Obersimmental-Saanenland BE 46% 62%<br />
94 Seeland BE 44% 0%<br />
95 Trois-Vaux 31% 71%<br />
96 Rapperswil-Jona, Eschenbach 56% 58%<br />
97 Werdenberg Nord 33% 57%<br />
98 Obertoggenburg 30% 71%<br />
99 Pfäfers 85% 94%<br />
100 Rheintal 41% 74%<br />
101 Walenstadt 16% 67%<br />
102 Coude du Rhône 34% 63%<br />
103 Simplon 50% 64%<br />
104 Obergoms/ Untergoms nordseitig VS 53% 46%<br />
105 Blenio TI 49% 29%<br />
106 Luganese TI 52% 36%<br />
108 Parco Nazionale del Locarnese TI 57% 60%<br />
109 Vallemaggia TI 60% 22%<br />
111 Mendrisiotto TI 29% 50%<br />
113 Val-de-Travers Vallon 21% 0%<br />
114 Chaux-de-Fonds-Le Locle 33% 0%<br />
Svizzera 51% 66%<br />
Fonte: UFAG<br />
A68<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Contributi per la biodiversità – 2015: interconnessione<br />
Prati sfruttati in modo estensivo<br />
Prati sfruttati in modo poco intensivo<br />
Pascoli sfruttati in modo estensivo e<br />
pascoli boschivi<br />
Terreni da strame<br />
Siepi, boschetti campestri e rivieraschi<br />
Prati rivieraschi lungo i corsi d’acqua<br />
Maggesi fioriti<br />
Maggesi da rotazione<br />
Fasce di colture estensive in<br />
campicoltura<br />
Striscia su superficie coltiva<br />
Alberi da frutto ad alto fusto nei campi<br />
Noci<br />
Alberi indigeni isolati adatti al luogo e<br />
viali alberati<br />
Vigneti con biodiversità naturale<br />
Superfici per la promozione della<br />
biodiversità specifiche della regione<br />
Fonte: UFAG<br />
Unità<br />
Regione di<br />
pianura<br />
Regione<br />
collinare<br />
Regione di<br />
montagna Totale<br />
Aziende numero 13 120 8 412 9 326 30 858<br />
Superficie ha 26 485 13 191 20 804 60 480<br />
Superficie per azienda ha 2.02 1.57 2.23 1.96<br />
Aziende numero 647 1 511 4 244 6 402<br />
Superficie ha 648 1 620 7 028 9 297<br />
Superficie per azienda ha 1 1.07 1.66 1.45<br />
Aziende numero 2 491 3 015 6 155 11 661<br />
Superficie ha 4 068 5 631 20 451 30 149<br />
Superficie per azienda ha 1.63 1.87 3.32 2.59<br />
Aziende numero 1 508 1 523 3 039 6 070<br />
Superficie ha 1 843 1 285 3 601 6 730<br />
Superficie per azienda ha 1.22 0.84 1.19 1.11<br />
Aziende numero 5 040 3 540 2 085 10 665<br />
Superficie ha 1 431 961 420 2 812<br />
Superficie per azienda ha 0.28 0.27 0.2 0.26<br />
Aziende numero 65 39 39 143<br />
Superficie ha 16 9 3 28<br />
Superficie per azienda ha 0.25 0.24 0.08 0.2<br />
Aziende numero 1 329 351 6 1 686<br />
Superficie ha 1 327 224 3 1 555<br />
Superficie per azienda ha 1 0.64 0.52 0.92<br />
Aziende numero 216 44 0 260<br />
Superficie ha 271 48 0 319<br />
Superficie per azienda ha 1.25 1.09 0 1.23<br />
Aziende numero 52 28 8 88<br />
Superficie ha 73 68 1 142<br />
Superficie per azienda ha 1.4 2.44 0.12 1.61<br />
Aziende numero 484 176 5 665<br />
Superficie ha 119 31 1 151<br />
Superficie per azienda ha 0.25 0.17 0.21 0.23<br />
Aziende numero 8 539 7 108 3 357 19 004<br />
Superficie ha 575 379 495 967 164 171 1 235 517<br />
Superficie per azienda ha 67.38 69.78 48.9 65.01<br />
Aziende numero 1 569 1 002 520 3 091<br />
Superficie ha 15 479 4 664 3 034 23 177<br />
Superficie per azienda ha 9.87 4.65 5.83 7.5<br />
Aziende numero 4 379 3 859 4 299 12 537<br />
Superficie ha 35 687 30 787 61 274 127 748<br />
Superficie per azienda ha 8.15 7.98 14.25 10.19<br />
Aziende numero 393 69 57 519<br />
Superficie ha 1 165 120 51 1 336<br />
Superficie per azienda ha 2.96 1.73 0.9 2.57<br />
Aziende numero 33 81 1 335 1 449<br />
Superficie ha 18 46 1 261 1 325<br />
Superficie per azienda ha 0.56 0.56 0.94 0.91<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A69
Contributi per la biodiversità – 2015<br />
SPB Qualità I SPB Qualità II SPB Interconnessione<br />
Aziende Contributo Aziende Contributo Aziende Contributo<br />
Cantone numero fr. numero fr. numero fr.<br />
ZH 2 981 17 215 296 1 975 6 848 796 2 030 5 461 587<br />
BE 10 189 28 070 025 6 911 15 813 156 9 347 18 715 117<br />
LU 4 358 13 070 074 3 441 8 755 455 3 269 6 579 412<br />
UR 541 988 118 587 2 304 247 430 1 264 892<br />
SZ 1 463 4 576 636 1 663 6 064 618 1 280 3 000 182<br />
OW 578 1 094 444 637 1 769 547 354 789 170<br />
NW 426 928 705 423 1 287 123 301 614 039<br />
GL 346 939 854 388 2 194 025 291 853 547<br />
ZG 491 2 575 962 437 2 073 857 454 1 364 787<br />
FR 2 538 10 692 905 1 308 3 354 919 1 555 4 463 118<br />
SO 1 202 7 108 854 751 2 901 044 1 028 3 612 412<br />
BL 829 5 358 354 663 2 981 719 679 1 342 107<br />
SH 479 3 491 886 328 1 569 728 320 1 260 351<br />
AR 618 1 072 999 453 796 151 299 369 576<br />
AI 432 620 798 391 604 141 284 363 654<br />
SG 3 579 11 825 572 2 785 8 163 738 2 413 4 744 121<br />
GR 2 180 11 074 076 2 061 11 379 545 2 039 6 622 040<br />
AG 2 620 13 555 679 1 495 6 469 677 1 263 3 994 601<br />
TG 2 146 8 959 314 1 030 3 337 802 1 714 2 076 278<br />
TI 723 2 216 719 486 1 835 596 347 1 267 781<br />
VD 3 140 19 374 091 2 406 7 971 248 2 671 10 114 749<br />
VS 2 298 7 808 770 1 654 7 667 595 1 407 5 141 589<br />
NE 714 3 576 558 550 1 522 201 587 2 357 699<br />
GE 259 2 788 140 66 179 570 73 283 923<br />
JU 954 6 723 699 617 3 138 720 794 3 805 772<br />
Svizzera 46 084 185 707 524 33 506 110 984 214 35 229 90 462 501<br />
Zona<br />
Pianura 19 468 98 312 267 10 796 31 723 339 14 082 34 094 363<br />
Collina 6 680 27 465 371 4 387 13 768 788 5 080 11 635 587<br />
ZM I 6 025 15 292 514 3 849 9 837 018 4 537 8 715 500<br />
ZM II 7 258 19 879 681 4 914 14 773 978 5 727 14 722 543<br />
ZM III 4 190 13 163 051 3 142 10 484 624 3 569 11 042 980<br />
ZM IV 2 463 11 594 639 2 066 9 309 302 2 234 10 251 529<br />
Estivazione 4 156 20 488 192<br />
Fonte: UFAG<br />
A70<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Contributi per la qualità 2015: prati<br />
Prati sfruttati in modo estensivo, Q1 Prati sfruttati in modo estensivo, Q2 Prati sfruttati in modo estensivo,<br />
interconnessione<br />
Totale Totale Totale<br />
Aziende Superficie Contributi Aziende Superficie Contributi Aziende Superficie Contributi<br />
Cantone Numero ha Fr. Numero ha Fr. Numero ha Fr.<br />
ZH 2 871 6 768 9 547 531 1 456 1 734 2 597 020 1 836 3 787 3 406 280<br />
BE 8 711 12 321 12 988 557 3 524 2 698 3 629 923 7 953 10 936 9 842 060<br />
LU 4 191 5 846 6 310 625 1 817 2 134 2 876 450 3 237 4 874 4 386 718<br />
UR 417 837 479 093 291 578 601 530 352 781 702 666<br />
SZ 1 210 1 486 1 189 106 901 1 044 1 323 745 1 036 1 281 1 152 846<br />
OW 538 786 539 894 356 518 637 165 344 622 559 980<br />
NW 382 647 444 937 267 478 596 265 281 541 486 828<br />
GL 326 798 554 768 256 531 595 180 278 687 618 435<br />
ZG 436 603 698 634 228 201 301 255 390 528 475 434<br />
FR 2 067 4 404 5 758 652 685 846 1 222 075 1 381 3 078 2 770 443<br />
SO 1 165 3 382 4 180 991 572 1 033 1 545 352 999 2 809 2 528 053<br />
BL 772 1 895 2 271 091 589 1 056 1 583 520 602 1 171 797 332<br />
SH 463 1 474 2 053 439 311 820 1 230 225 301 1 017 915 705<br />
AR 410 328 238 459 226 135 203 145 186 168 151 128<br />
AI 314 212 151 178 152 90 135 120 206 150 135 369<br />
SG 3 103 4 087 4 521 615 1 348 1 163 1 637 775 2 131 2 721 2 439 554<br />
GR 2 099 10 454 6 057 951 1 957 7 494 7 718 210 2 011 8 285 4 585 740<br />
AG 2 518 5 861 7 971 675 1 394 2 786 4 178 730 1 239 3 333 2 984 427<br />
TG 1 935 2 918 4 304 838 477 476 714 675 1 530 2 054 1 378 665<br />
TI 578 1 061 884 010 263 438 490 802 287 618 556 501<br />
VD 2 832 8 131 10 886 541 1 423 2 117 3 051 740 2 410 6 767 6 090 408<br />
VS 1 371 1 879 1 387 367 523 637 691 839 731 1 024 921 156<br />
NE 512 1 343 1 417 382 268 354 529 225 429 1 037 933 255<br />
GE 251 887 1 321 519 59 109 164 040 65 237 212 994<br />
JU 756 2 350 2 815 121 412 903 1 351 635 643 1 973 1 775 826<br />
Svizzera 40 228 80 754 88 974 972 19 755 30 374 39 606 640 30 858 60 480 50 807 802<br />
Zona<br />
Pianura 18 400 38 678 56 521 716 7 265 9 152 13 669 177 13 120 26 485 23 249 780<br />
Collina 5 961 10 802 12 674 486 2 775 3 931 5 866 755 4 596 8 282 7 223 086<br />
ZM I 4 894 6 170 4 671 481 2 313 2 449 3 528 041 3 816 4 909 4 312 837<br />
ZM II 5 541 8 015 5 572 412 3 185 3 772 5 346 436 4 452 6 642 5 783 978<br />
ZM III 3 353 8 662 4 879 902 2 511 5 570 5 678 689 2 949 7 302 5 381 289<br />
ZM IV 2 079 8 429 4 654 975 1 706 5 499 5 517 542 1 925 6 859 4 856 832<br />
Fonte: UFAG<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A71
Contributi per la biodiversità 2015: prati sfruttati in modo poco intensivo<br />
Prati sfruttati in modo poco Prati sfruttati in modo poco Prati sfruttati in modo poco<br />
intensivo Q1<br />
intensivo Q2<br />
intensivo, interconnessione<br />
Totale Totale Totale<br />
Aziende Superficie Contributi Aziende Superficie Contributi Aziende Superficie Contributi<br />
Cantone Numero ha Fr. Numero ha Fr. Numero ha Fr.<br />
ZH 357 240 107 892 28 10 11 484 20 8 7 407<br />
BE 3 133 3 188 1 434 579 905 671 725 897 2 430 2 610 2 349 226<br />
LU 565 474 213 426 155 196 211 658 128 186 167 175<br />
UR 351 454 204 354 97 115 115 528 259 408 367 101<br />
SZ 204 154 69 480 101 102 108 704 76 79 71 361<br />
OW 134 92 41 337 29 21 22 736 82 66 59 157<br />
NW 102 59 26 748 37 22 24 550 2 1 738<br />
GL 76 72 32 328 26 20 22 064 40 45 40 149<br />
ZG 128 93 42 026 24 15 18 360 106 81 73 242<br />
FR 982 1 454 654 502 61 48 56 018 408 557 500 885<br />
SO 136 171 76 861 11 9 10 966 32 57 51 086<br />
BL 232 263 118 332 54 58 69 156 69 79 38 108<br />
SH 40 45 20 043 9 15 17 460 11 16 14 229<br />
AR 272 170 76 613 75 36 43 404 62 48 43 011<br />
AI 77 42 18 729 20 9 11 076 12 7 5 931<br />
SG 776 494 222 210 90 54 60 474 82 57 51 669<br />
GR 1 761 5 802 2 610 761 822 868 876 630 844 1 673 784 649<br />
AG 356 239 107 375 42 35 42 456 28 26 23 661<br />
TG 364 227 102 186 4 2 2 244 28 15 6 696<br />
TI 281 502 225 784 127 187 189 503 125 264 237 902<br />
VD 609 1 112 500 360 171 207 224 840 389 744 669 690<br />
VS 1 381 2 737 1 231 696 620 722 740 584 841 1 603 1 442 308<br />
NE 171 446 200 619 37 52 62 588 72 165 148 734<br />
GE 7 4 2 007 0 0<br />
JU 362 686 308 628 102 139 165 680 256 502 451 962<br />
Svizzera 12 857 19 220 8 648 874 3 647 3 615 3 834 061 6 402 9 297 7 606 077<br />
Zona<br />
Pianura 2 546 2 060 927 036 166 132 155 139 647 648 571 933<br />
Collina 1 633 1 699 764 520 195 162 192 884 630 660 566 217<br />
ZM I 1 852 1 803 811 286 336 246 289 662 881 961 855 039<br />
ZM II 2 579 3 346 1 505 659 770 675 786 921 1 418 1 972 1 746 486<br />
ZM III 2 345 4 271 1 921 940 1 079 1 115 1 122 101 1 436 1 998 1 557 889<br />
ZM IV 1 902 6 041 2 718 433 1 101 1 285 1 287 356 1 390 3 058 2 308 512<br />
Fonte: UFAG<br />
A72<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Contributi per la biodiversità 2015: pascoli estensivi e pascoli boschivipascoli boschivi<br />
Pascoli estensivi e pascoli boschivi Pascoli estensivi e pascoli boschivi Pascoli estensivi e pascoli boschivi,<br />
Q1<br />
Q2<br />
interconnessione<br />
Totale Totale Totale<br />
Azienda Superficie Contributi Azienda Superficie Contributi Azienda Superficie Contributi<br />
Cantone Numero ha Fr. Numero ha Fr. Numero ha Fr.<br />
ZH 783 963 433 571 139 134 93 828 289 371 166 878<br />
BE 4 176 8 775 3 948 864 1 171 2 598 1 818 551 3 368 7 761 3 492 266<br />
LU 381 542 243 855 131 249 174 377 325 505 227 448<br />
UR 87 147 66 258 31 46 32 410 83 143 64 458<br />
SZ 432 1 210 544 590 310 695 486 815 376 1 020 458 937<br />
OW 78 112 50 499 19 40 27 944 59 98 44 267<br />
NW 81 156 70 056 34 59 41 328 44 66 29 642<br />
GL 173 346 155 520 51 119 83 153 133 246 110 921<br />
ZG 102 134 60 503 20 37 25 746 93 125 56 376<br />
FR 1 041 1 801 810 352 165 276 193 540 576 962 433 090<br />
SO 407 1 398 628 959 156 707 495 174 323 1 238 557 138<br />
BL 279 777 349 700 233 640 447 902 236 647 234 530<br />
SH 67 86 38 597 8 12 8 729 43 66 29 687<br />
AR 382 392 176 391 50 40 27 902 70 68 30 650<br />
AI 234 230 103 442 7 8 5 810 85 105 47 403<br />
SG 1 479 1 857 835 614 326 493 344 834 728 1 117 502 803<br />
GR 1 365 2 835 1 275 930 1 175 1 999 1 399 076 699 1 013 196 162<br />
AG 575 778 349 920 119 124 86 961 429 589 264 861<br />
TG 483 491 221 063 43 63 44 394 87 149 58 280<br />
TI 360 1 109 499 279 111 160 111 670 192 576 259 403<br />
VD 1 701 4 578 2 060 316 475 1 107 775 215 1 279 3 396 1 528 403<br />
VS 1 671 8 688 3 909 828 743 2 182 1 527 284 1 193 5 551 2 497 996<br />
NE 593 3 125 1 406 201 297 967 676 620 448 2 043 919 139<br />
GE 56 90 40 311 0 7 8 3 560<br />
JU 654 2 718 1 222 979 255 1 089 761 992 496 2 284 1 027 845<br />
Svizzera 17 640 43 339 19 502 594 6 069 13 845 9 691 255 11 661 30 149 13 242 139<br />
Zona<br />
Pianura 4 493 6 717 3 022 719 678 1 052 736 251 2 491 4 068 1 820 072<br />
Collina 2 095 3 473 1 562 929 484 839 587 369 1 412 2 355 1 040 159<br />
ZM I 2 526 4 674 2 103 259 647 1 264 884 789 1 603 3 276 1 455 789<br />
ZM II 3 961 12 027 5 412 132 1 491 4 300 3 009 945 2 752 9 024 4 032 538<br />
ZM III 2 749 8 770 3 946 616 1 510 3 273 2 291 030 2 061 6 038 2 563 236<br />
ZM IV 1 816 7 677 3 454 940 1 259 3 117 2 181 871 1 342 5 389 2 330 346<br />
Fonte: UFAG<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A73
Contributi per la biodiversità 2015: striscia su superficie coltiva<br />
Striscia su superficie coltiva, Q1 Striscia su superficie coltiva, Q2 Striscia su superficie coltiva,<br />
interconnessione<br />
Totale Totale Totale<br />
Aziende Superficie Contributi Aziende Superfici Contributi Aziende Superficie Contributi<br />
Cantone Numero ha Fr. Numero ha Fr. Numero ha Fr.<br />
ZH 1 106 1 564 2 934 312 905 1 390 2 085 420 934 1 377 1 238 886<br />
BE 865 729 828 237 210 50 74 973 814 691 622 140<br />
LU 570 373 532 203 380 316 473 250 482 324 292 041<br />
UR 75 74 92 647 53 56 83 460 66 66 59 067<br />
SZ 857 1 291 1 662 053 810 1 241 1 860 945 799 1 229 1 106 208<br />
OW 151 85 123 777 126 74 111 390 117 66 59 832<br />
NW 117 95 124 599 108 89 132 750 105 88 78 921<br />
GL 88 82 96 350 64 64 96 030 77 72 64 845<br />
ZG 309 548 713 686 286 536 803 610 286 515 463 392<br />
FR 152 80 120 586 64 45 67 689 102 53 47 732<br />
SO 15 5 9 513 2 0 465 11 4 3 956<br />
BL 0 0 0<br />
SH 9 6 12 120 3 2 2 340 3 2 1 854<br />
AR 258 198 239 986 188 166 249 555 147 138 124 596<br />
AI 221 225 270 012 187 194 290 865 169 190 170 739<br />
SG 1 635 1 802 2 425 355 1 437 1 661 2 491 080 1 171 1 397 1 256 967<br />
GR 298 150 145 167 271 137 204 750 254 119 49 252<br />
AG 176 176 350 152 108 159 238 185 71 58 51 615<br />
TG 180 105 200 618 93 72 107 415 164 99 88 740<br />
TI 66 69 107 294 38 56 83 390 37 44 39 496<br />
VD 189 191 243 440 98 79 118 530 151 135 121 455<br />
VS 62 25 24 998 13 12 18 400 48 21 18 607<br />
NE 7 7 8 304 2 1 1 215 6 6 5 355<br />
GE 3 5 10 300 0 1 5 4 302<br />
JU 63 36 50 505 24 19 28 230 55 32 28 521<br />
Svizzera 7 472 7 922 11 326 213 5 470 6 416 9 623 936 6 070 6 730 5 998 518<br />
Zona<br />
Pianura 2 005 2 278 4 473 634 1 378 1 878 2 816 609 1 508 1 843 1 657 906<br />
Collina 860 697 1 186 715 627 573 859 123 686 578 519 989<br />
ZM I 1 089 879 1 134 311 847 767 1 150 763 837 708 636 253<br />
ZM II 2 082 2 688 3 192 728 1 717 2 403 3 605 100 1 724 2 343 2 105 806<br />
ZM III 968 915 895 579 666 632 947 622 877 827 714 052<br />
ZM IV 468 465 443 246 235 163 244 719 438 431 364 513<br />
Fonte: UFAG<br />
A74<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Contributi per la biodiversità 2015: siepi, boschetti rivieraschi e campestri<br />
Siepi, boschetti rivieraschi e campesti Siepi, boschetti rivieraschi e Siepi, boschetti rivieraschi e<br />
Q1<br />
Q2<br />
Interconnessione<br />
Totale Totale Totale<br />
Aziende Superficie Contributi Aziende Superficie Contributi Aziende Superficie Contributi<br />
Cantone Numero ha Fr. Numero ha Fr. Numero ha Fr.<br />
ZH 1 145 252 755 190 425 93 185 160 517 114 102 438<br />
BE 2 648 563 1 689 245 1 106 219 437 175 2 217 472 424 707<br />
LU 2 272 497 1 490 826 662 143 285 960 1 971 440 395 750<br />
UR 11 1 3 270 3 0 760 8 1 711<br />
SZ 211 22 65 640 154 16 32 200 188 20 17 631<br />
OW 106 11 31 830 24 2 4 300 87 9 8 055<br />
NW 28 3 8 700 5 1 1 580 8 1 1 125<br />
GL 44 5 14 640 25 3 5 680 38 4 3 924<br />
ZG 316 57 171 810 72 11 22 700 279 49 43 866<br />
FR 1 059 365 1 094 150 235 71 141 015 721 257 231 495<br />
SO 448 127 380 912 223 63 125 897 347 99 89 219<br />
BL 331 115 345 510 255 98 195 860 256 97 87 282<br />
SH 269 94 280 650 148 49 98 540 177 63 57 069<br />
AR 99 16 47 160 37 6 11 360 23 5 4 212<br />
AI 55 6 19 200 3 1 1 340 14 1 1 170<br />
SG 802 132 396 780 143 34 67 720 529 82 73 638<br />
GR 629 105 315 150 82 13 25 540 539 87 78 084<br />
AG 1 428 420 1 260 090 895 251 502 920 892 287 256 955<br />
TG 466 100 301 230 102 24 48 980 270 56 50 270<br />
TI 65 12 36 773 10 2 4 794 43 7 6 257<br />
VD 1 121 448 1 344 720 336 118 235 180 874 323 291 051<br />
VS 204 43 127 886 19 4 8 015 120 25 22 182<br />
NE 175 80 238 800 34 16 32 120 146 68 61 488<br />
GE 117 36 107 880 17 6 11 000 23 7 6 354<br />
JU 498 298 893 940 223 120 240 060 378 238 214 560<br />
Svizzera 14 547 3 807 11 421 982 5 238 1 363 2 725 856 10 665 2 812 2 529 491<br />
Zona<br />
Pianura 7 453 2 065 6 193 981 2 857 764 1 528 503 5 040 1 431 1 287 125<br />
Collina 2 687 755 2 266 092 1 134 319 637 824 2 083 596 535 975<br />
ZM I 1 836 469 1 406 381 622 157 314 530 1 457 365 328 479<br />
ZM II 1 666 383 1 149 019 449 93 185 644 1 298 302 271 519<br />
ZM III 678 110 330 062 150 27 53 796 593 96 86 788<br />
ZM IV 227 25 76 446 26 3 5 559 194 22 19 604<br />
Fonte: UFAG<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A75
Contributi per la biodiversità 2015: maggesi fioriti<br />
Maggesi fioriti,<br />
Maggesi fioriti, interconnessione<br />
Q1<br />
Totale<br />
Totale<br />
Aziende Superficie Contributi Aziende Superficie Contributi<br />
Cantone Numero ha Fr. Numero ha Fr.<br />
ZH 243 175 663 898 125 77 69 309<br />
BE 260 205 778 582 209 164 147 482<br />
LU 105 27 102 030 96 26 22 986<br />
UR 0 0 0 0 0 0<br />
SZ 1 1 4 180 1 1 990<br />
OW 0 0 0 0 0 0<br />
NW 0 0 0 0 0 0<br />
GL 0 0 0 0 0 0<br />
ZG 10 7 25 802 9 7 6 021<br />
FR 220 241 916 428 183 201 180 931<br />
SO 69 79 299 606 53 65 58 646<br />
BL 91 92 349 448 78 64 57 276<br />
SH 184 189 720 024 133 146 131 544<br />
AR 0 0 0 0 0 0<br />
AI 0 0 0 0 0 0<br />
SG 29 37 142 082 14 27 24 561<br />
GR 26 14 51 528 17 10 8 919<br />
AG 334 120 454 176 275 88 79 227<br />
TG 99 95 361 418 73 71 63 585<br />
TI 3 3 12 593 0 0 0<br />
VD 351 500 1 898 898 299 431 388 170<br />
VS 34 34 128 125 24 29 26 061<br />
NE 17 29 110 960 14 28 25 245<br />
GE 80 273 1 036 336 25 47 42 048<br />
JU 70 87 331 436 58 74 66 312<br />
Suisse 2 226 2 207 8 387 550 1 686 1 555 1 399 313<br />
Zona<br />
Pianura 1 818 1 931 7 338 826 1 329 1 327 1 194 459<br />
Collina 371 261 990 498 331 216 194 691<br />
ZM I 26 12 44 670 20 8 7 345<br />
ZM II 8 3 10 545 5 3 2 277<br />
ZM III 3 1 3 012 1 1 540<br />
ZM IV 0 0 0 0 0 0<br />
Fonte: UFAG<br />
A76<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Contributi per la biodiversità 2015: maggesi da rotazione<br />
Maggesi da rotazione, Q1<br />
Maggesi da rotazione, interconnessione<br />
Totale<br />
Totale<br />
Aziende Superficie Contributi Aziende Superficie Contributi<br />
Cantone Numero ha Fr. Numero ha Fr.<br />
ZH 86 86 283 404 41 38 34 371<br />
BE 40 34 110 576 19 17 15 551<br />
LU 26 29 97 218 23 27 24 210<br />
UR 0 0 0 0 0 0<br />
SZ 1 0 1 155 0 0 0<br />
OW 0 0 0 0 0 0<br />
NW 0 0 0 0 0 0<br />
GL 0 0 0 0 0 0<br />
ZG 2 0 1 320 2 0 360<br />
FR 27 29 95 636 15 15 13 500<br />
SO 19 27 88 078 14 20 18 196<br />
BL 27 38 124 080 18 12 11 088<br />
SH 11 9 28 677 5 4 3 807<br />
AR 0 0 0 0 0 0<br />
AI 0 0 0 0 0 0<br />
SG 0 0 0 0 0 0<br />
GR 6 8 26 202 3 6 5 760<br />
AG 71 73 240 372 38 26 23 436<br />
TG 23 20 66 528 2 2 1 449<br />
TI 9 11 34 654 3 4 3 834<br />
VD 77 125 412 632 57 95 85 806<br />
VS 6 21 68 091 3 18 16 144<br />
NE 6 8 24 882 2 2 1 530<br />
GE 28 59 193 809 7 12 10 476<br />
JU 12 35 114 477 8 19 17 478<br />
Svizzera 477 610 2 011 792 260 319 286 996<br />
Zona<br />
Pianura 406 534 1 760 874 216 271 243 726<br />
Collina 68 76 249 819 43 48 43 180<br />
ZM I 2 0 913 1 0 90<br />
ZM II 0 0 0 0 0 0<br />
ZM III 0 0 0 0 0 0<br />
ZM IV 1 0 186 0 0 0<br />
Fonte: UFAG<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A77
Contributi per la biodiversità 2015: striscia su superficie coltiva<br />
Striscia su superficie coltiva<br />
Striscia su superficie coltiva<br />
Totale<br />
Totale<br />
Aziende Superficie Contributi Aziende Superficie Contributi<br />
Cantone Numero ha Fr. Numero ha Fr.<br />
ZH 47 10 32 571 23 6 5 148<br />
BE 63 13 43 963 42 9 8 523<br />
LU 66 7 24 585 64 7 6 120<br />
UR 0 0 0 0 0 0<br />
SZ 0 0 0 0 0 0<br />
OW 0 0 0 0 0 0<br />
NW 0 0 0 0 0 0<br />
GL 0 0 0 0 0 0<br />
ZG 13 3 11 121 12 3 2 835<br />
FR 97 29 95 066 87 26 23 309<br />
SO 13 4 12 043 11 3 3 099<br />
BL 33 12 39 468 30 11 9 576<br />
SH 4 1 3 003 2 1 639<br />
AR 0 0 0 0 0 0<br />
AI 0 0 0 0 0 0<br />
SG 9 2 5 214 3 0 414<br />
GR 2 0 594 1 0 63<br />
AG 307 59 193 611 295 56 50 760<br />
TG 19 4 14 025 8 3 2 457<br />
TI 1 0 403 1 0 110<br />
VD 56 13 44 451 53 13 11 538<br />
VS 17 9 29 615 16 8 7 267<br />
NE 0 0 0 0 0 0<br />
GE 2 0 1 518 0 0 0<br />
JU 23 5 17 160 17 4 3 627<br />
Svizzera 772 172 568 411 665 151 135 485<br />
Zona<br />
Pianura 582 139 459 577 484 119 106 880<br />
Collina 153 24 78 106 145 23 20 396<br />
ZM I 32 8 27 286 31 8 7 271<br />
ZM II 5 1 3 442 5 1 939<br />
ZM III 0 0 0 0 0 0<br />
ZM IV 0 0 0 0 0 0<br />
Fonte: UFAG<br />
A78<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Contributo per la biodiversità 2015: fasce di colture estensive in campicoltura<br />
Fasce di colture estensive in<br />
Fasce di colture estensive in<br />
campicoltura<br />
campicoltura, interconnessione<br />
Totale<br />
Totale<br />
Aziende Superfice Contributi Aziende Superficie Contributi<br />
Cantone Nummero ha Fr. Nummero ha Fr.<br />
ZH 25 18 41 538 12 11 9 576<br />
BE 8 5 10 875 1 3 2 506<br />
LU 5 3 6 509 5 3 2 547<br />
UR 0 0 0 0 0 0<br />
SZ 0 0 0 0 0 0<br />
OW 0 0 0 0 0 0<br />
NW 0 0 0 0 0 0<br />
GL 0 0 0 0 0 0<br />
ZG 11 32 72 864 11 31 27 810<br />
FR 11 10 23 928 10 10 8 837<br />
SO 4 2 5 132 3 2 1 982<br />
BL 0 0 0 0 0 0<br />
SH 0 0 0 0 0 0<br />
AR 0 0 0 0 0 0<br />
AI 0 0 0 0 0 0<br />
SG 3 3 5 888 0 0 0<br />
GR 4 1 1 909 2 0 117<br />
AG 2 0 1 104 0 0 0<br />
TG 5 14 32 522 0 0 0<br />
TI 1 0 46 0 0 0<br />
VD 41 89 205 321 34 73 65 979<br />
VS 4 0 292 4 0 82<br />
NE 0 0 0 0 0 0<br />
GE 0 0 0 0 0 0<br />
JU 7 10 23 736 6 9 8 298<br />
Svizzera 131 188 431 663 88 142 127 734<br />
Zona<br />
Pianura 90 116 266 695 52 73 65 410<br />
Collina 20 38 86 728 17 36 32 506<br />
ZM I 12 33 75 994 11 32 28 989<br />
ZM II 2 1 1 610 2 1 630<br />
ZM III 5 0 583 5 0 196<br />
ZM IV 2 0 54 1 0 3<br />
Fonte: UFAG<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A79
Contributi per la biodiversità 2015: strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili<br />
Strisce fiorite per impollinatori<br />
e altri organismi utili, Q1<br />
Totale<br />
Aziende Superficie Contributi<br />
Cantone Numero ha Fr.<br />
ZH 51 16 40 450<br />
BE 198 33 83 381<br />
LU 10 2 5 625<br />
UR 0 0 0<br />
SZ 1 0 875<br />
OW 0 0 0<br />
NW 0 0 0<br />
GL 0 0 0<br />
ZG 4 1 2 675<br />
FR 21 6 16 142<br />
SO 17 5 11 685<br />
BL 21 12 29 775<br />
SH 23 7 18 700<br />
AR 0 0 0<br />
AI 0 0 0<br />
SG 9 3 7 075<br />
GR 3 2 6 225<br />
AG 43 15 38 450<br />
TG 30 7 16 400<br />
TI 0 0 0<br />
VD 15 4 10 150<br />
VS 0 0 0<br />
NE 2 0 825<br />
GE 0 0 0<br />
JU 1 1 1 250<br />
Svizzera 449 116 289 682<br />
Zona<br />
Pianura 346 98 244 221<br />
Collina 73 17 41 932<br />
ZM I 26 1 3 009<br />
ZM II 4 0 520<br />
ZM III 0 0 0<br />
ZM IV 0 0 0<br />
Fonte: UFAG<br />
A80<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Contributi per la biodiversità 2015: prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua<br />
Prati rivieraschi lungo i corsi<br />
Prati rivieraschi lungo i corsi<br />
d'acqua<br />
d'acqua<br />
Totale<br />
Totale<br />
Azienda Superficie Contributi Azienda Superficie Contributi<br />
Cantone Numero ha Fr. Numero ha Fr.<br />
ZH 6 1 455 1 0 72<br />
BE 93 14 6 107 66 10 9 073<br />
LU 4 0 207 0 0 0<br />
UR 3 1 311 1 0 27<br />
SZ 1 0 27 0 0 0<br />
OW 2 0 117 2 0 234<br />
NW 0 0 0 0 0 0<br />
GL 38 8 3 614 12 1 1 206<br />
ZG 6 3 1 283 5 2 1 755<br />
FR 49 15 6 569 24 6 5 736<br />
SO 10 2 1 098 4 1 1 297<br />
BL 3 1 626 0 0 0<br />
SH 5 2 779 0 0 0<br />
AR 0 0 0 0 0 0<br />
AI 3 0 158 0 0 0<br />
SG 44 7 3 294 12 2 1 638<br />
GR 0 0 0 0 0 0<br />
AG 9 3 1 134 1 0 288<br />
TG 12 2 927 0 0 0<br />
TI 7 1 668 7 1 1 183<br />
VD 7 2 878 5 2 1 377<br />
VS 1 1 302 1 1 603<br />
NE 0 0 0 0 0 0<br />
GE 0 0 0 0 0 0<br />
JU 8 3 1 238 2 1 1 125<br />
Svizzera 311 66 29 786 143 28 25 615<br />
Zona<br />
Pianura 164 38 17 313 65 16 14 369<br />
Collina 53 12 5 242 22 4 3 788<br />
ZM I 35 10 4 615 17 5 4 513<br />
ZM II 33 3 1 509 16 1 1 138<br />
ZM III 18 2 1 032 15 2 1 660<br />
ZM IV 8 0 74 8 0 147<br />
Fonte: UFAG<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A81
Contributi per la biodiversità 2015: terreni di strame<br />
Terreni di strame<br />
Q2<br />
Totale<br />
Aziende Superficie Contributi<br />
Cantone Numero ha Fr.<br />
ZH 5 72 10 856<br />
BE 871 26 333 3 950 020<br />
LU 168 3 061 459 200<br />
UR 245 9 691 1 453 613<br />
SZ 373 7 599 1 139 813<br />
OW 233 5 949 892 422<br />
NW 116 2 853 427 965<br />
GL 117 9 167 1 374 998<br />
ZG 3 18 2 696<br />
FR 380 9 242 1 386 337<br />
SO 58 1 150 172 496<br />
BL 7 119 17 805<br />
SH 0 0 0<br />
AR 87 822 123 317<br />
AI 114 891 133 695<br />
SG 259 6 474 971 086<br />
GR 56 5 257 788 529<br />
AG 0 0 0<br />
TG 0 0 0<br />
TI 127 6 088 913 212<br />
VD 551 16 470 2 470 514<br />
VS 508 29 558 4 433 645<br />
NE 91 639 95 867<br />
GE 0 0 0<br />
JU 8 32 4 868<br />
Svizzera 4 377 141 486 21 222 951<br />
Zona<br />
Pianura 4 61 9 113<br />
Collina 1 39 5 888<br />
ZM I 1 72 10 871<br />
ZM II 4 158 23 703<br />
ZM III 8 437 65 507<br />
ZM IV 7 138 20 704<br />
Estivazione 4 352 140 581 21 087 166<br />
Fonte: UFAG<br />
A82<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Contributi per la biodiversità 2015: vigneti con biodiversità naturale<br />
Vigneti con biodiversità naturale<br />
Vigneti con biodiversità naturale<br />
Totale<br />
Totale<br />
Aziende Superficie Contributi Aziende Superficie Contributi<br />
Unità Numero ha Fr. Numero ha Fr.<br />
ZH 17 25 27 258 15 22 19 908<br />
BE 23 43 47 593 14 25 22 425<br />
LU 15 24 26 290 13 23 20 988<br />
UR 1 0 341 1 0 279<br />
SZ 4 4 4 301 4 5 4 599<br />
OW 0 0 0 0 0 0<br />
NW 0 0 0 0 0 0<br />
GL 0 0 0 1 0 180<br />
ZG 0 0 0 0 0 0<br />
FR 1 1 1 339 6 10 9 426<br />
SO 0 0 0 0 0 0<br />
BL 3 1 726 3 1 594<br />
SH 9 8 8 569 41 62 55 890<br />
AR 1 1 638 1 1 666<br />
AI 0 0 0 0 0 0<br />
SG 33 55 60 104 25 37 33 138<br />
GR 12 15 16 005 30 40 35 910<br />
AG 37 48 52 965 29 42 37 656<br />
TG 10 13 14 454 14 33 29 259<br />
TI 23 32 35 265 46 96 86 504<br />
VD 127 298 327 349 128 522 469 548<br />
VS 120 189 207 462 91 160 144 230<br />
NE 12 52 56 661 53 240 216 306<br />
GE 0 0 0 1 0 396<br />
JU 2 10 10 780 3 16 14 112<br />
Svizzera 450 816 898 100 519 1 336 1 202 014<br />
Zona<br />
Pianura 282 556 611 762 393 1 165 1 048 117<br />
Collina 69 142 156 336 54 94 84 942<br />
ZM I 41 49 54 267 15 25 22 727<br />
ZM II 50 63 68 805 46 46 41 066<br />
ZM III 6 5 5 599 7 4 3 578<br />
ZM IV 2 1 1 332 4 2 1 585<br />
Fonte: UFAG<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A83
Contributi per la biodiversità 2015: alberi da frutto ad alto fusto nei campi<br />
Alberi da frutto ad alto fusto nei Alberi da frutto ad alto fusto nei Alberi da frutto ad alto fusto nei<br />
campi, Q1<br />
nei campi, Q2<br />
campi, interconnessione<br />
Totale Totale Totale<br />
Aziende Superficie Contributi Aziende Superficie Contributi Aziende Superficie Contributi<br />
Cantone Numero ha Fr. Numero ha Fr. Numero ha Fr.<br />
ZH 2 146 153 703 2 305 545 888 60 525 1 815 750 1 279 84 306 379 377<br />
BE 7 107 402 009 6 030 135 3 592 168 829 5 064 870 6 247 339 363 1 527 134<br />
LU 3 709 268 064 4 020 960 2 330 141 051 4 231 530 2 765 202 629 911 831<br />
UR 189 8 318 124 770 13 540 16 200 129 5 054 22 743<br />
SZ 916 67 872 1 018 080 557 36 597 1 097 910 539 35 774 160 983<br />
OW 376 20 283 304 245 76 2 431 72 930 214 11 956 53 802<br />
NW 309 15 794 236 910 46 2 041 61 230 87 3 518 15 831<br />
GL 125 5 482 82 230 15 564 16 920 68 2 596 11 682<br />
ZG 439 50 383 755 745 264 29 771 893 130 380 43 611 196 250<br />
FR 1 557 70 680 1 060 200 223 8 987 269 610 900 39 363 177 134<br />
SO 966 92 036 1 380 540 187 17 918 537 540 631 63 275 284 738<br />
BL 782 114 972 1 724 580 332 22 225 666 750 338 23 005 103 523<br />
SH 305 20 784 311 760 129 6 758 202 740 166 10 504 47 268<br />
AR 325 19 545 293 175 86 4 561 136 830 53 3 083 13 766<br />
AI 65 3 768 56 520 24 874 26 220 15 676 3 042<br />
SG 2 478 213 126 3 196 890 932 83 972 2 519 160 795 74 895 337 028<br />
GR 602 37 654 564 810 286 11 530 345 900 473 21 621 97 295<br />
AG 2 162 169 936 2 549 040 632 45 246 1 357 380 720 47 422 213 399<br />
TG 1 759 219 657 3 294 855 724 79 785 2 393 550 1 065 86 246 388 107<br />
TI 303 25 825 387 375 4 230 6 900 139 14 050 63 225<br />
VD 1 749 108 439 1 626 585 452 23 766 712 980 1 326 69 982 314 919<br />
VS 798 59 364 890 460 37 1 344 40 320 205 8 187 36 842<br />
NE 166 10 737 161 055 42 2 113 63 390 72 4 894 22 023<br />
GE 100 4 661 69 915 3 149 4 470 15 710 3 195<br />
JU 625 61 847 927 705 210 19 053 571 590 383 38 797 174 587<br />
Svizzera 30 058 2 224 939 33 374 085 12 084 770 860 23 125 800 19 004 1 235 517 5 559 719<br />
Zona<br />
Pianura 14 142 1 107 791 16 616 865 5 556 399 984 11 999 520 8 539 575 379 2 589 206<br />
Collina 5 755 497 293 7 459 395 2 754 181 211 5 436 330 3 816 284 025 1 278 113<br />
ZM I 4 892 328 733 4 930 995 2 137 119 418 3 582 540 3 292 211 942 953 631<br />
ZM II 3 649 198 134 2 972 010 1 287 57 949 1 738 470 2 400 120 790 543 555<br />
ZM III 1 292 76 907 1 153 605 289 10 626 318 780 788 37 721 169 745<br />
ZM IV 328 16 081 241 215 61 1 672 50 160 169 5 660 25 470<br />
Fonte: UFAG<br />
A84<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Contributi per la biodiversità 2015: alberi di noce<br />
Alberi di noce, Q1 Alberi di noce, Q2 Alberi di noce, interconnessione<br />
Totale Totale Totale<br />
Aziende Superficie Contributi Aziende Superficie Contributi Aziende Superficie Contributi<br />
Cantone Numero ha Fr. Numero ha Fr. Numero ha Fr.<br />
ZH 741 4 596 68 940 248 1 460 22 020 272 1 737 7 817<br />
BE 1 315 7 795 116 925 277 2 768 64 155 775 5 396 24 282<br />
LU 378 1 467 22 005 358 1 116 16 740 332 1 296 5 832<br />
UR 133 1 161 17 415 5 27 405 88 764 3 438<br />
SZ 237 1 430 21 450 97 676 10 185 98 421 1 895<br />
OW 35 183 2 745 8 38 660 25 147 662<br />
NW 145 1 117 16 755 13 97 1 455 26 210 945<br />
GL 6 27 405 0 0 0 1 3 14<br />
ZG 167 1 233 18 495 60 424 6 360 147 1 086 4 887<br />
FR 403 2 713 40 695 27 633 17 295 207 1 775 7 988<br />
SO 308 2 229 33 435 72 744 13 155 135 1 088 4 896<br />
BL 62 383 5 745 0 0 0 0 0 0<br />
SH 50 273 4 095 15 75 1 125 31 200 900<br />
AR 27 81 1 215 0 0 0 0 0 0<br />
AI 21 104 1 560 1 1 15 0 0 0<br />
SG 880 4 237 63 555 199 759 11 505 119 472 2 124<br />
GR 147 1 190 17 850 38 258 4 905 38 258 1 161<br />
AG 403 2 572 38 580 114 672 10 080 108 543 2 444<br />
TG 370 2 847 42 705 138 806 12 090 168 1 230 5 535<br />
TI 127 1 856 27 840 1 4 60 73 1 052 4 734<br />
VD 650 9 320 139 800 90 1 885 54 900 319 4 323 19 454<br />
VS 112 674 10 110 1 3 45 35 224 1 008<br />
NE 34 502 7 530 6 301 4 515 6 320 1 440<br />
GE 29 303 4 545 1 4 60 6 58 261<br />
JU 171 1 035 15 525 58 229 3 885 82 574 2 583<br />
Svizzera 6 951 49 328 739 920 1 827 12 980 255 615 3 091 23 177 104 297<br />
Zona<br />
Pianura 3 600 31 254 468 810 987 9 314 197 265 1 569 15 479 69 656<br />
Collina 1 222 6 594 98 910 366 1 619 26 280 526 2 573 11 579<br />
ZM I 1 038 5 221 78 315 286 1 372 21 555 476 2 091 9 410<br />
ZM II 760 3 873 58 095 155 572 8 955 362 1 945 8 753<br />
ZM III 276 2 048 30 720 31 99 1 500 133 967 4 352<br />
ZM IV 55 338 5 070 2 4 60 25 122 549<br />
Fonte: UFAG<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A85
Contributi per la biodiversità 2015: alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati<br />
Alberi indigeni isolati<br />
adatti al luogo e viali alberati, interconnessione<br />
Totale<br />
Aziende Superficie Contributi<br />
Cantone Numero ha Fr.<br />
ZH 514 3 138 14 121<br />
BE 4 556 49 417 222 377<br />
LU 2 578 24 680 111 060<br />
UR 57 311 1 400<br />
SZ 391 5 496 24 732<br />
OW 101 707 3 182<br />
NW 1 2 9<br />
GL 41 487 2 192<br />
ZG 320 2 791 12 560<br />
FR 666 6 700 30 150<br />
SO 178 2 246 10 107<br />
BL 8 246 1 107<br />
SH 56 391 1 760<br />
AR 3 8 36<br />
AI 0 0 0<br />
SG 563 4 551 20 480<br />
GR 1 044 13 446 60 507<br />
AG 224 1 199 5 396<br />
TG 80 719 3 236<br />
TI 119 1 918 8 631<br />
VD 762 5 448 24 516<br />
VS 88 1 074 4 833<br />
NE 27 492 2 214<br />
GE 8 75 338<br />
JU 152 2 206 9 927<br />
Svizzera 12 537 127 748 574 866<br />
Zona<br />
Pianura 4 379 35 687 160 592<br />
Collina 1 933 14 273 64 229<br />
ZM I 1 926 16 514 74 313<br />
ZM II 1 953 23 962 107 829<br />
ZM III 1 569 26 294 118 323<br />
ZM IV 777 11 018 49 581<br />
Fonte: UFAG<br />
A86<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Contributi per la biodiversità 2015: superfici per la promozione della biodiversità specifiche della regione, interconnessione<br />
Supercici per la promozione della<br />
biodiversità specifiche della regione, interconnessione<br />
Totale<br />
Aziende Superficie Contributi<br />
Cantone Numero ha Fr.<br />
ZH 0 0 0<br />
BE 36 6 5 366<br />
LU 3 5 4 707<br />
UR 21 48 43 002<br />
SZ 0 0 0<br />
OW 0 0 0<br />
NW 0 0 0<br />
GL 0 0 0<br />
ZG 0 0 0<br />
FR 15 25 22 463<br />
SO 0 0 0<br />
BL 10 2 1 692<br />
SH 0 0 0<br />
AR 6 2 1 512<br />
AI 0 0 0<br />
SG 1 0 108<br />
GR 1 263 1 165 718 421<br />
AG 1 1 477<br />
TG 0 0 0<br />
TI 0 0 0<br />
VD 10 36 32 436<br />
VS 4 3 2 272<br />
NE 45 23 20 970<br />
GE 0 0 0<br />
JU 34 10 9 009<br />
Svizzera 1 449 1 325 862 435<br />
Zona<br />
Pianura 33 18 15 134<br />
Collina 39 22 16 738<br />
ZM I 42 24 18 815<br />
ZM II 121 98 76 030<br />
ZM III 664 692 441 334<br />
ZM IV 550 470 294 386<br />
Fonte: UFAG<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A87
Contributi per i sistemi di produzione – 2015<br />
Agricoltura Produzione estensiva Produzione di latte e carne basata<br />
biologica<br />
di cereali e colza<br />
sulla superficie inerbita<br />
Totale Totale Totale<br />
Aziende Superficie contributi Aziende Superficie contributi Aziende Superficie contributi<br />
Cantone numero ha fr. numero ha fr. numero ha fr.<br />
ZH 348 7 679 3 714 162 1 375 6 903 2 761 100 1 306 21 841 4 271 095<br />
BE 1 162 20 276 6 085 531 3 702 13 131 5 252 446 6 826 103 627 20 614 485<br />
LU 336 5 750 1 812 378 1 038 3 160 1 264 100 3 105 45 308 8 999 901<br />
UR 55 944 190 724 0 0 0 522 6 341 1 267 507<br />
SZ 163 2 767 575 406 7 9 3 400 1 262 19 457 3 876 985<br />
OW 180 2 464 497 996 0 0 0 538 7 187 1 436 757<br />
NW 69 1 026 210 852 0 0 0 383 5 380 1 073 905<br />
GL 80 1 747 351 190 3 4 1 508 335 6 525 1 298 112<br />
ZG 79 1 513 390 740 64 190 76 168 337 5 911 1 170 412<br />
FR 154 4 045 1 849 450 1 057 6 876 2 750 232 1 598 37 971 7 556 182<br />
SO 125 3 664 1 232 437 600 3 557 1 422 639 608 12 968 2 542 903<br />
BL 123 2 983 1 044 020 485 2 447 978 868 425 8 730 1 706 229<br />
SH 29 743 457 368 317 2 405 961 948 87 1 326 248 401<br />
AR 106 2 210 445 802 0 0 0 576 10 581 2 111 705<br />
AI 23 378 75 814 0 0 0 406 6 455 1 288 637<br />
SG 431 8 097 1 944 588 220 542 216 768 3 009 54 442 10 830 446<br />
GR 1 302 32 884 7 092 660 241 738 295 020 1 861 45 545 9 104 997<br />
AG 233 4 945 2 679 330 1 464 7 831 3 132 332 1 298 17 850 3 474 370<br />
TG 277 5 561 3 029 140 800 3 825 1 530 164 992 17 078 3 377 736<br />
TI 128 2 372 576 830 47 202 80 744 497 9 531 1 870 258<br />
VD 204 5 936 3 138 286 1 884 21 695 8 677 840 1 432 31 951 6 272 501<br />
VS 331 5 851 1 828 977 120 339 135 447 1 467 24 531 4 878 746<br />
NE 67 2 208 753 108 235 2 396 958 484 552 22 967 4 571 072<br />
GE 18 637 504 586 188 3 629 1 451 588 50 1 042 184 395<br />
JU 125 4 738 1 984 328 464 3 825 1 530 096 622 19 354 3 837 948<br />
Svizzera 6 148 131 419 42 465 703 14 311 83 702 33 480 891 30 094 543 901 107 865 682<br />
Zone<br />
Pianura 1 452 32 170 19 105 346 9 163 62 803 25 121 260 8 461 129 616 25 462 991<br />
Collina 647 12 955 4 751 323 3 119 14 254 5 701 565 4 588 77 211 15 242 480<br />
ZM I 753 13 861 3 566 342 1 435 5 231 2 092 369 4 701 82 885 16 455 518<br />
ZM II 1 153 22 626 4 800 057 424 1 182 472 792 6 275 132 154 26 342 201<br />
ZM III 1 215 26 812 5 595 194 117 188 75 239 3 789 74 330 14 830 490<br />
ZM IV 928 22 995 4 647 442 53 44 17 667 2 280 47 706 9 532 003<br />
Fonte: UFAG<br />
A88<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Partecipazione al programma URA – 2015<br />
Dati di base 1 Dati URA Partecipazione URA<br />
UBG Aziende UBG Aziende UBG Aziende<br />
Categorie di animali numero numero numero numero % %<br />
Vacche lattifere 576 131 29 796 479 961 20 944 83.3% 70.3%<br />
Altre vacche 116 528 14 089 105 621 8 035 90.6% 57.0%<br />
Animali di sesso femminile, di età superiore a<br />
365 giorni, fino al primo parto<br />
145 404 34 811 119 470 25 419 82.2% 73.0%<br />
Animali di sesso femminile, di età compresa tra 160<br />
e 365 giorni<br />
46 242 33 733 35 561 23 260 76.9% 69.0%<br />
Animali di sesso femminile, di età inferiore a<br />
160 giorni<br />
18 241 34 483 7 353 13 545 40.3% 39.3%<br />
Animali di sesso maschile, di età superiore a<br />
730 giorni<br />
5 008 9 368 3 159 5 351 63.1% 57.1%<br />
Animali di sesso maschile, di età compresa tra 365<br />
e 730 giorni<br />
12 677 14 164 8 100 7 421 63.9% 52.4%<br />
Animali di sesso maschile, di età compresa tra 160<br />
e 365 giorni<br />
25 706 21 487 16 624 10 880 64.7% 50.6%<br />
Animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni 17 267 33 424 6 370 11 264 36.9% 33.7%<br />
Totale animali della specie bovina 963 204 36 767 782 220 30 386 81.2% 82.6%<br />
Animali di sesso femminile e animali di sesso<br />
maschile castrati, di età superiore a 30 mesi<br />
34 020 8 955 28 932 6 893 85.0% 77.0%<br />
Stalloni, di età superiore a 30 mesi 1 426 1 816 792 766 55.5% 42.2%<br />
Animali di età inferiore a 30 mesi 2 378 2 223 1 871 1 084 78.7% 48.8%<br />
Totale animali della specie equina 37 825 9 590 31 595 7 029 83.5% 73.3%<br />
Animali di sesso femminile, di età superiore a un anno 10 576 5 869 8 267 3 207 78.2% 54.6%<br />
Animali di sesso maschile, di età superiore a un 490 1 874 347 1 162 70.9% 62.0%<br />
Totale animali della specie caprina 11 067 5 904 8 615 3 225 77.8% 54.6%<br />
Animali di sesso femminile, di età superiore a un anno 36 151 7 474 31 899 5 558 88.2% 74.4%<br />
Animali di sesso maschile, di età superiore a un anno 1 426 5 230 1 118 3 798 78.4% 72.6%<br />
Agnelli magri 548 980 375 429 68.5% 43.8%<br />
Totale animali della specie ovina 38 125 7 553 33 392 5 584 87.6% 73.9%<br />
Verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi 584 1 697 329 961 56.4% 56.6%<br />
Scrofe da allevamento non in lattazione, di età<br />
superiore a 6 mesi<br />
21 057 1 983 14 636 1 136 69.5% 57.3%<br />
Scrofe da allevamento in lattazione 15 801 2 197 818 190 5.2% 8.6%<br />
Suinetti svezzati 17 704 2 154 687 168 3.9% 7.8%<br />
Rimonte, di età inferiore a 6 mesi e suini da 103 262 6 297 63 881 2 986 61.9% 47.4%<br />
Totale animali della specie suina 158 408 7 059 80 351 3 484 50.7% 49.4%<br />
Coniglie da riproduzione, inclusi gli animali giovani<br />
di età inferiore a 35 giorni circa<br />
316 713 10 45 3.1% 6.3%<br />
Animali giovani, di età superiore a circa 35 giorni 655 603 3 22 0.5% 3.6%<br />
Totale conigli 971 845 13 48 1.3% 5.7%<br />
Galline e galli da allevamento (produzione di uova<br />
da cova per razze ovaiole e da ingrasso)<br />
1 261 1 051 280 99 22.2% 9.4%<br />
Galline ovaiole 26 121 9 872 19 555 2 426 74.9% 24.6%<br />
Pollastrelle, galletti e pulcini (escl. i polli da 4 795 654 886 99 18.5% 15.1%<br />
Polli da ingrasso 31 522 1 084 2 035 166 6.5% 15.3%<br />
Tacchini 1 303 245 1 215 87 93.3% 35.5%<br />
Totale pollame da reddito 65 002 11 623 23 971 2 710 36.9% 23.3%<br />
Totale di tutte le categorie di animali 1274 601 42 270 960 156 35 401 75.3% 83.7%<br />
1 Aziende aventi diritto ai contributi (tutte le aziende che hanno potuto partecipare al programma URA)<br />
Fonte: UFAG<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A89
Partecipazione al programma URA - 2015<br />
Dati di base 1 Dati URA Partecipazione URA<br />
UBG Aziende UBG Aziende UBG Aziende<br />
Categorie di animali Numero Numero Numero Numero % %<br />
Vacche lattifere 579 730 30 559 477 195 21 162 82.3% 69.2%<br />
Altre vacche 116 055 14 283 103 302 7 875 89.0% 55.1%<br />
Animali di sesso femminile, di oltre 365 giorni, fino<br />
al primo parto<br />
147 173 35 419 119 769 25 375 81.4% 71.6%<br />
Animali di sesso femminile, di età compresa da 160 e 365 giorni 46 021 34 360 34 956 23 155 76.0% 67.4%<br />
Animali di sesso femminile, di età inferore à 160 giorni 18 245 35 096 7 074 13 224 38.8% 37.7%<br />
Animali di sesso maschile, di età superiore à 730 giorni 4 894 9 388 3 019 5 249 61.7% 55.9%<br />
Animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni 12 459 14 450 7 718 7 281 61.9% 50.4%<br />
Animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni 25 935 22 272 16 439 10 717 63.4% 48.1%<br />
Animali di sesso maschile, di età inferiore à 160 giorni 17 495 34 097 5 830 10 871 33.3% 31.9%<br />
Totale animali della specie bovina 968 006 37 440 775 302 30 493 80.1% 81.4%<br />
Animali di sesso femminile e animali di sesso<br />
maschile castrati, di età superiore a 30 mesi<br />
33 959 9 035 28 564 6 907 84.1% 76.4%<br />
Stalloni, di età superiore a 30 mesi 1 422 1 834 761 778 53.5% 42.4%<br />
Animali di età inferiore a 30 mesi 2 628 2 557 2 045 1 133 77.8% 44.3%<br />
Totale animali della specie equina 38 010 9 671 31 370 7 039 82.5% 72.8%<br />
Animali di sesso femminile, di età superiore a un anno 10 651 5 848 8 096 3 153 76.0% 53.9%<br />
Animali di sesso maschile, di età superore a un 497 1 863 340 1 118 68.5% 60.0%<br />
Totale animali della specie caprina 11 148 5 879 8 436 3 166 75.7% 53.9%<br />
Animali di sesso femminile, di età superiore a un anno 37 106 7 617 32 165 5 591 86.7% 73.4%<br />
Animali di sesso maschile, di età superiore a un anno 1 463 5 324 1 151 3 866 78.7% 72.6%<br />
Agnelli magri 391 541 268 247 68.6% 45.7%<br />
Totale animali della specie ovina 38 959 7 680 33 584 5 615 86.2% 73.1%<br />
Verri da allevamento, di età superiore à 6 mesi 596 1 729 335 966 56.3% 55.9%<br />
Scrofe da allevamento non in lattazione, di età 20 932 2 024 14 452 1 146 69.0% 56.6%<br />
Scrofe da allevamento in lattazione 15 697 2 244 830 195 5.3% 8.7%<br />
Suinetti svezzati 17 487 2 202 671 170 3.8% 7.7%<br />
Rimonte, di età inferiore a 6 mesi e suini da 102 651 6 273 64 176 2 985 62.5% 47.6%<br />
Totale animali della specie suina 157 363 7 095 80 465 3 499 51.1% 49.3%<br />
Coniglie da riproduzione, inclusi gli animali giovani<br />
di età inferior à 35 giorni circa<br />
316 743 11 42 3.4% 5.7%<br />
Animali giovani, di età superiore à circa 35 giorni 659 675 3 16 0.4% 2.4%<br />
Totale conigli 975 899 13 43 1.4% 4.8%<br />
Galline e galli da allevamento (produzione di uova<br />
da cova per razze ovaiole e da ingrasso)<br />
1 253 955 196 84 15.6% 8.8%<br />
Legehennen 24 200 9 696 17 717 2 325 73.2% 24.0%<br />
Pollastrelle, galletti e pulcini (escl. I polli da<br />
ingrasso<br />
4 327 742 898 96 20.7% 12.9%<br />
Polli da ingrasso 29 632 1 069 2 270 167 7.7% 15.6%<br />
Tacchini 1 238 236 1 125 76 90.8% 32.2%<br />
Totale pollame da reddito 60 651 11 432 22 205 2 602 36.6% 22.8%<br />
Totale di tutte le categorie di animali 1 275 113 42 983 951 376 35 535 74.6% 82.7%<br />
1 Aziende aventi diritto ai contributi (tutte le aziende che hanno potuto partecipare al programma URA)<br />
Fonte: UFAG<br />
A90<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Partecipazione al programma SSRA – 2015<br />
Dati di base 1 Dati SSRA Partecipazione SSRA<br />
UBG Aziende UBG Aziende UBG Aziende<br />
Categorie di animali numero numero numero numero % %<br />
Vacche lattifere 576 131 29 796 264 012 8 189 45.8% 27.5%<br />
Altre vacche 116 528 14 089 97 919 6 608 84.0% 46.9%<br />
Animali di sesso femminile, di età superiore a<br />
365 giorni, fino al primo parto<br />
145 404 34 811 74 236 14 493 51.1% 41.6%<br />
Animali di sesso femminile, di età compresa tra 160<br />
e 365 giorni<br />
46 242 33 733 26 454 14 489 57.2% 43.0%<br />
Animali di sesso maschile, di età superiore a<br />
730 giorni<br />
5 008 9 368 2 665 4 337 53.2% 46.3%<br />
Animali di sesso maschile, di età compresa tra 365<br />
e 730 giorni<br />
12 677 14 164 8 151 5 644 64.3% 39.8%<br />
Animali di sesso maschile, di età compresa tra 160<br />
e 365 giorni<br />
25 706 21 487 17 582 8 417 68.4% 39.2%<br />
Totale animali della specie bovina 927 696 36 751 491 019 18 570 52.9% 50.5%<br />
Animali di sesso femminile e animali di sesso<br />
maschile castrati, di età superiore a 30 mesi<br />
34 020 8 955 6 008 1 642 17.7% 18.3%<br />
Stalloni, di età superiore a 30 mesi 1 426 1 816 165 153 11.5% 8.4%<br />
Totale animali della specie equina 35 447 9 463 6 172 1 674 17.4% 17.7%<br />
Animali di sesso femminile, di età superiore a un anno 10 576 5 869 4 335 1 180 41.0% 20.1%<br />
Animali di sesso maschile, di età superiore a un anno 490 1 874 153 479 31.2% 25.6%<br />
Totale animali della specie caprina 11 067 5 904 4 487 1 187 40.5% 20.1%<br />
Verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi 584 1 697 111 329 19.0% 19.4%<br />
Scrofe da allevamento non in lattazione, di età<br />
superiore a 6 mesi<br />
21 057 1 983 14 841 1 097 70.5% 55.3%<br />
Scrofe da allevamento in lattazione 15 801 2 197 10 566 1 221 66.9% 55.6%<br />
Suinetti svezzati 17 704 2 154 11 747 1 145 66.4% 53.2%<br />
Rimonte, di età inferiore a 6 mesi e suini da 103 262 6 297 67 628 3 031 65.5% 48.1%<br />
Totale animali della specie suina 158 408 7 059 104 893 3 636 66.2% 51.5%<br />
Coniglie da riproduzione, inclusi gli animali giovani<br />
di età inferiore a 35 giorni circa<br />
316 713 161 81 50.8% 11.4%<br />
Animali giovani, di età superiore a circa 35 giorni 655 603 537 97 82.0% 16.1%<br />
Totale conigli 971 845 698 132 71.9% 15.6%<br />
Galline e galli da allevamento (produzione di uova<br />
da cova per razze ovaiole e da ingrasso)<br />
1 261 1 051 625 64 49.5% 6.1%<br />
Galline ovaiole 26 121 9 872 23 715 1 802 90.8% 18.3%<br />
Pollastrelle, galletti e pulcini (escl. i polli da 4 795 654 4 030 158 84.1% 24.2%<br />
Polli da ingrasso 31 522 1 084 29 650 920 94.1% 84.9%<br />
Tacchini 1 303 245 1 222 67 93.8% 27.3%<br />
Totale pollame da reddito 65 002 11 623 59 242 2 851 91.1% 24.5%<br />
Totale di tutte le categorie di animali 1198 590 40 969 666 511 21 906 55.6% 53.5%<br />
1 Aziende aventi diritto ai contributi (tutte le aziende che hanno potuto partecipare al programma SSRA)<br />
Fonte: UFAG<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A91
Partecipazione al programma SSRA -<br />
1<br />
Base Partecipazione SSRA<br />
UBG Aziende UBG Aziende UBG UBG<br />
Categorie di animali Numero Numero Numero Numero % %<br />
Vacche lattifere 579 730 30 559 253 543 7 931 43.7% 26.0%<br />
Altre vacche 116 055 14 283 95 538 6 435 82.3% 45.1%<br />
Animali di sesso femminile, di oltre 365 giorni, fino<br />
al primo parto<br />
147 173 35 419 72 949 14 048 49.6% 39.7%<br />
Animali di sesso femminile, di età compresa da 160<br />
e 365 giorni<br />
46 021 34 360 25 587 14 120 55.6% 41.1%<br />
Animali di sesso maschile, di oltre 730 giorni 4 894 9 388 2 552 4 209 52.2% 44.8%<br />
Animali di sesso maschile, di età compresa tra 365<br />
e 730 giorni<br />
12 459 14 450 7 785 5 477 62.5% 37.9%<br />
Animali di sesso maschile, di età compresa tra 160<br />
e 365 giorni<br />
25 935 22 272 17 509 8 249 67.5% 37.0%<br />
Totale animali della specie bovina 932 267 37 426 475 464 18 168 51.0% 48.5%<br />
Animali di sesso femminile e animali castrati di<br />
sesso maschile di oltre 30 mesi<br />
33 959 9 035 5 445 1 493 16.0% 16.5%<br />
Stalloni, di oltre 30 mesi 1 422 1 834 146 150 10.3% 8.2%<br />
Totale animali della specie equina 35 382 9 521 5 591 1 522 15.8% 16.0%<br />
Animale di sesso femminile, di età superiore a un<br />
anno<br />
10 651 5 848 4 103 1 127 38.5% 19.3%<br />
Animali di sesso maschile, die età superiore a un<br />
anno<br />
497 1 863 142 445 28.6% 23.9%<br />
Totale animali della specie caprina 11 148 5 879 4 245 1 131 38.1% 19.2%<br />
Verri da allevamento, di oltre 6 mesi 596 1 729 113 322 18.9% 18.6%<br />
Scrofe da allevamento non in lattazione, di oltre 6<br />
mesi<br />
20 932 2 024 14 666 1 113 70.1% 55.0%<br />
Scrofe da allevamento in lattazione 15 697 2 244 10 481 1 242 66.8% 55.3%<br />
Suinetti svezzati 17 487 2 202 11 554 1 149 66.1% 52.2%<br />
Suini da rimonta, fino a 6 mesi e suini da ingrasso 102 651 6 273 67 339 3 024 65.6% 48.2%<br />
Totale animali della specie suina 157 363 7 095 104 153 3 643 66.2% 51.3%<br />
Coniglie da riproduzione, inlusi gli animali giovani di<br />
età inferiore a 35 giorni circa<br />
316 743 134 70 42.3% 9.4%<br />
Animali giovani, di età superiore à circa 35 giorni 659 675 442 86 67.1% 12.7%<br />
Totale Conigli 975 899 576 122 59.1% 13.6%<br />
Galline e galli da allevamento (produzione di uova<br />
da cova per razze ovaiole e da allevamento<br />
1 253 955 594 57 47.4% 6.0%<br />
Galline ovaiole 24 200 9 696 21 703 1 716 89.7% 17.7%<br />
Pulcini, galletti e pollastrelle (escl. I polli da<br />
ingrasso)<br />
4 327 742 3 722 156 86.0% 21.0%<br />
Polli da ingrasso 29 632 1 069 27 477 883 92.7% 82.6%<br />
Tacchini 1 238 236 1 156 65 93.4% 27.5%<br />
Totale pollame 60 651 11 432 54 652 2 732 90.1% 23.9%<br />
Totale di tutte le categorie di animali 1197 785 41 665 644 682 21 504 53.8% 51.6%<br />
1 Aziende aventi diritto ai contributi (aziende che hanno<br />
ottenuto pagamenti diretti<br />
Fonte: UFAG<br />
A92<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Partecipazione a sistemi di stabulazione rispettosi degli animali 2015<br />
Sistemi di stabulazione<br />
particolarmente rispettosi degli<br />
Uscita regolare all'aperto<br />
Detenzione particolarmente<br />
rispettosa degli animali da reddito<br />
(SSRA und URA)<br />
animali<br />
Aziende UBG Contributi Aziende UBG Contributi<br />
Cantone Numero Numero Fr. Numero Numero Fr.<br />
Aziende UGB Contributi<br />
ZH 1 407 43 580 4671 615 1 913 52992 10442303 2'004 96'572 15'113'918<br />
BE 4 330 101 778 12367 642 8 437 193496 37856277 8'584 295'274 50'223'919<br />
LU 2 868 95 607 11890 357 3 683 108325 21414587 3'776 203'931 33'304'944<br />
UR 142 1 882 175 123 426 5880 1126125 427 7'762 1'301'249<br />
SZ 552 11 722 1311 254 1 151 23012 4481971 1'170 34'734 5'793'224<br />
OW 301 6 372 658 182 476 10091 1948633 480 16'463 2'606'815<br />
NW 185 4 287 491 386 282 6037 1163560 292 10'324 1'654'946<br />
GL 127 2 673 265 443 302 6829 1323220 303 9'502 1'588'663<br />
ZG 312 10 399 1084 917 401 12272 2408103 414 22'670 3'493'020<br />
FR 1 510 58 742 7180 637 2 146 83134 16126626 2'201 141'875 23'307'263<br />
SO 674 19 518 2106 250 954 26338 5159293 982 45'856 7'265'543<br />
BL 470 13 440 1454 544 636 17114 3433359 652 30'555 4'887'903<br />
SH 217 9 125 1252 823 231 7604 1537647 272 16'729 2'790'470<br />
AR 235 5 397 614 796 567 14253 2768787 568 19'650 3'383'583<br />
AI 180 4 767 706 898 384 9657 1934004 391 14'424 2'640'902<br />
SG 1 669 52 181 6205 422 2 932 83732 16409543 2'990 135'912 22'614'965<br />
GR 1 222 28 279 2675 038 2 055 47943 9359763 2'057 76'222 12'034'801<br />
AG 1 357 44 258 5588 925 1 658 46231 9230129 1'788 90'489 14'819'054<br />
TG 1 172 47 252 5980 479 1 478 49574 9792948 1600 96'826 15'773'427<br />
TI 236 4 638 425 820 560 9653 1858161 562 14'291 2'283'981<br />
VD 1 284 49 029 5805 685 1 941 64725 12677059 2'014 113'753 18'482'744<br />
VS 341 6 031 658 542 1 219 18631 3603841 1'230 24'662 4'262'384<br />
NE 397 15 691 1540 272 601 24218 4696301 604 39'908 6'236'573<br />
GE 40 1 283 143 466 82 2002 387251 82 3'285 530'717<br />
JU 670 28 396 2860 351 863 36260 7063175 871 64'656 9'923'525<br />
Svizzera 21'898 666'326 78'115'866 35'378 959'999 188'202'666 36'314 1'626'325 266'318'532<br />
Zone<br />
Pianura 9'845 359'984 44'331'752 13'021 411'593 81'250'017 13'730 771'577 125'581'769<br />
Collina 3775 115237 13685138 5418 157367 30951319 5552 272605 44636456<br />
ZM I 3'035 78'497 8'713'733 5'100 134'838 26'243'628 5'150 213'334 34'957'361<br />
ZM II 2998 71211 7534754 6123 149340 29001667 6157 220552 36536421<br />
ZM III 1'434 26'786 2'515'759 3'580 68'964 13'393'755 3'582 95'749 15'909'514<br />
ZM IV 811 14611 1334730 2136 37897 7362280 2143 52508 8697010<br />
Fonte: UFAG<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A93
Contributi per l’efficienza delle risorse – 2015<br />
Procedimenti di spandimento Lavorazione rispettosa Tecnica di applicazione<br />
a basse emissioni del suolo precisa<br />
Totale Totale Totale<br />
Aziende Superficie contributi Aziende Superficie contributi Aziende Superficie contributi<br />
Cantone numero ha fr. numero ha fr. numero ha fr.<br />
ZH 0 0 0 574 3 594 703 274 12 12 40 018<br />
BE 1 803 204 704 648 614 115 1 697 8 037 1 467 695 10 10 33 576<br />
LU 1 948 897 389 200 2 692 168 1 245 5 336 1 169 057 11 11 42 932<br />
UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
SZ 0 0 0 34 55 11 014 1 1 850<br />
OW 5 930 400 2 791 0 0 0 0 0 0<br />
NW 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
GL 0 0 0 9 21 4 480 0 0 0<br />
ZG 8 780 000 2 340 92 514 118 505 0 0 0<br />
FR 641 295 527 422 886 583 566 4 454 876 486 1 1 4 250<br />
SO 42 7 001 308 21 004 325 2 037 404 412 3 3 10 602<br />
BL 197 50 927 300 152 782 104 501 132 556 8 8 38 573<br />
SH 0 0 0 183 1 613 327 305 5 5 11 405<br />
AR 6 892 300 2 677 0 0 0 0 0 0<br />
AI 0 0 0 1 3 1 620 0 0 0<br />
SG 514 193 460 700 580 382 264 825 194 670 5 5 26 485<br />
GR 0 0 0 18 91 28 139 2 2 10 423<br />
AG 0 0 0 654 4 074 795 218 11 11 38 347<br />
TG 691 265 626 800 796 880 494 2 595 553 910 31 31 119 124<br />
TI 18 8 318 300 24 955 8 63 28 580 7 7 23 063<br />
VD 0 0 0 832 11 869 2 351 852 44 44 165 316<br />
VS 37 15 384 123 46 156 18 159 65 441 32 32 97 599<br />
NE 137 58 860 800 176 582 122 1 104 298 393 3 3 14 269<br />
GE 13 2 273 400 6 820 83 1 702 370 933 7 7 27 125<br />
JU 183 67 857 000 203 571 164 1 846 509 501 0 0 0<br />
Svizzera 6 243 2069 933 6 209 807 7 487 50 493 10 413 037 193 193 703 956<br />
Zone<br />
Pianura 3 370 1217 243 3 651 732 5 627 42 927 8 573 269 154 154 579 760<br />
Collina 1 170 402 784 710 1 208 357 1 261 5 476 1 275 474 25 25 85 880<br />
ZM I 786 230 902 049 692 706 464 1 651 429 910 5 5 17 687<br />
ZM II 681 183 793 452 551 381 125 411 128 050 8 8 19 779<br />
ZM III 158 27 586 566 82 760 9 27 6 111 1 1 850<br />
ZM IV 78 7 623 310 22 870 1 1 223 0 0 0<br />
Fonte: UFAG<br />
A94<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Contributo di transizione – 2015<br />
Aziende<br />
Totale contributi<br />
Cantone numero fr.<br />
ZH 2 937 12 072 393<br />
BE 10 084 35 454 039<br />
LU 4 309 17 112 396<br />
UR 440 929 257<br />
SZ 1 428 4 553 150<br />
OW 549 1 408 121<br />
NW 418 1 196 693<br />
GL 339 1 242 435<br />
ZG 483 2 121 812<br />
FR 2 526 13 314 165<br />
SO 1 174 5 424 557<br />
BL 800 3 510 019<br />
SH 479 1 838 828<br />
AR 612 2 555 007<br />
AI 430 1 579 941<br />
SG 3 525 14 482 365<br />
GR 2 115 9 069 239<br />
AG 2 568 10 486 424<br />
TG 2 137 8 981 619<br />
TI 617 1 665 479<br />
VD 3 172 13 138 512<br />
VS 2 175 4 602 045<br />
NE 711 4 263 908<br />
GE 249 735 100<br />
JU 938 6 190 900<br />
Svizzera 45 215 177 928 403<br />
Zone<br />
Pianura 19 581 80 898 611<br />
Collina 6 530 26 262 774<br />
ZM I 5 823 21 983 552<br />
ZM II 6 934 26 751 112<br />
ZM III 3 990 13 479 414<br />
ZM IV 2 357 8 552 939<br />
Fonte: UFAG<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A95
Cambiamento dei contributi 2013-2015 per zona<br />
2013 2015 Cambiamento 2013-2015<br />
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. %<br />
Zona di pianura 1 084 1 014 - 70 -6.5%<br />
Zona collinare 380 364 - 16 -4.2%<br />
ZM I 333 324 - 9 -2.7%<br />
ZM II 445 443 - 2 -0.4%<br />
ZM III 259 271 12 4.6%<br />
ZM IV 167 182 15 9.0%<br />
Zona d'estivazione 101 156 55 54.5%<br />
Totale (senza contributo per 'lArt. 77a/b LAgr risp. Art. 62a 2 769 2 754 - 15 -0.5%<br />
Fonte: UFAG<br />
A96<br />
000000 1<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Contributi versati ai Cantoni – 2015<br />
Cantone Bonifiche fondiarie Edifici rurali Totale contributi<br />
Fr. Fr. Fr.<br />
ZH 4 065 752 657 889 4 723 641<br />
BE 8 461 740 4 823 535 13 285 275<br />
LU 4 118 578 1 280 630 5 399 208<br />
UR 803 733 365 600 1 169 333<br />
SZ 2 629 769 833 900 3 463 669<br />
OW 444 090 437 704 881 794<br />
NW 149 468 305 350 454 818<br />
GL 669 156 799 461 1 468 617<br />
ZG 362 175 206 220 568 395<br />
FR 5 184 429 2 994 400 8 178 829<br />
SO 1 854 434 406 161 2 260 595<br />
BL 350 393 520 200 870 593<br />
SH 1 230 767 41 200 1 271 967<br />
AR 446 569 802 300 1 248 869<br />
AI 113 564 315 380 428 944<br />
SG 3 566 650 2 154 900 5 721 550<br />
GR 13 478 245 2 980 500 16 458 745<br />
AG 1 147 827 454 700 1 602 527<br />
TG 1 213 603 126 000 1 339 603<br />
TI 1 882 527 801 300 2 683 827<br />
VD 2 097 487 2 535 700 4 633 187<br />
VS 5 716 315 1 811 100 7 527 415<br />
NE 984 888 2 952 400 3 937 288<br />
GE 995 000 995 000<br />
JU 2 971 805 1 150 000 4 121 805<br />
Diversi<br />
Totale 64 938 964 29 756 530 94 695 494<br />
Fonte: UFAG<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A97
Contributi a progetti approvati, secondo i provvedimenti e le regioni – 2015<br />
Provvedimenti<br />
Costi<br />
Regione di Regione Regione di<br />
complessivi<br />
Totale<br />
pianura collinare montagna<br />
Totale<br />
1 000 fr.<br />
Bonifiche fondiarie<br />
Ricomposizioni particellari<br />
1 311 570 10 111 11 992 27 288<br />
(infrastrutture incluse)<br />
Costruzione di strade agricole 3 982 5 791 13 978 23 751 82 278<br />
Altri impianti di trasporto<br />
571 571 2 433<br />
Provvedimenti in relazione al bilancio idrico del<br />
suolo<br />
1 079 409 1 789 3 278 13 622<br />
Acquedotti 67 2 450 6 122 8 639 48 495<br />
Approvvigionamento elettrico 15 57 679 751 3 330<br />
Ripristino e consolidamento 1 507 256 3 531 4 293 13 758<br />
Acquisto dei dati di base 367 165 532 1 699<br />
Ripristino periodico 1 226 752 2 450 4 428 26 117<br />
Progetti di sviluppo regionale 3 308 462 1 418 5 189 24 733<br />
Totale intermedio 11 862 10 748 40 813 63 423 243 752<br />
Edifici rurali<br />
Edifici rurali per animali che consumano<br />
9 431 13 586 23 017 219 385<br />
foraggio grezzo<br />
Edifici alpestri 1 438 1 438 15 037<br />
Piccole aziende artigianali<br />
172 172 920<br />
Conformemente all'iniziativa per la riduzione<br />
dei costi di produzione<br />
Edifici e installazioni comuni per lo stoccaggio e<br />
la commercializzazione di prodotti agricoli<br />
Contributi<br />
1 1 2 6<br />
1 903 1 744 3 647 34 134<br />
Totale intermedio 1 11 334 16 940 28 275 269 482<br />
Totale 11 863 22 082 57 754 91 698 513 234<br />
1 Danni provocati dal maltempo inclusi<br />
Fonte: UFAG<br />
A98<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Crediti d'investimento accordati dai Cantoni – 2015<br />
Cantone<br />
Bonifiche fondiarie Edifici rurali Totale<br />
Provvedimenti collettivi P. collettivi P. individuali<br />
Crediti di costruzione Crediti d'investimento Crediti d'investimento Crediti d'investimento<br />
Numero 1 000 fr. Numero 1 000 fr. Numero 1 000 fr. Numero 1 000 fr. Numero 1 000 fr.<br />
ZH 1 1 200 5 1 169 71 13 590 77 15 959<br />
BE 5 565 11 3 430 246 36 977 262 40 972<br />
LU 9 4 595 12 1 119 6 1 317 207 31 195 234 38 226<br />
UR 2 120 11 1 366 13 1 486<br />
SZ 10 3 781 2 188 40 6 081 52 10 050<br />
OW 2 182 13 1 992 15 2 174<br />
NW 18 2 671 18 2 671<br />
GL 14 2 035 14 2 035<br />
ZG 17 2 200 17 2 200<br />
FR 3 606 13 5 212 123 25 087 139 30 905<br />
SO 2 277 2 110 43 7 552 47 7 939<br />
BL 5 179 35 4 918 40 5 097<br />
SH 1 700 12 2 063 13 2 763<br />
AR 1 70 37 4 394 38 4 464<br />
AI 14 1 809 14 1 809<br />
SG 2 99 6 412 138 19 025 146 19 536<br />
GR 9 4 797 9 1 845 101 14 856 119 21 498<br />
AG 97 13 331 97 13 331<br />
TG 1 52 78 12 219 79 12 271<br />
TI 1 66 7 1 363 21 3 347 29 4 776<br />
VD 1 62 64 10 732 131 22 790 196 33 584<br />
VS 2 1 000 7 442 42 5 865 51 7 307<br />
NE 1 2 000 8 2 474 36 6 825 45 11 299<br />
GE 2 201 2 610 4 811<br />
JU 2 994 1 369 5 378 55 8 385 63 10 126<br />
Totale 37 19 345 29 3 116 154 29 646 1 602 251 182 1 822 303 288<br />
Fonte: UFAG<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A99
Crediti d'investimento secondo le categorie di provvedimenti – 2015<br />
(crediti di costruzione esclusi)<br />
Cantone Aiuto<br />
iniziale<br />
Acquisto<br />
dell'azien<br />
da da<br />
parte<br />
dell'affittu<br />
ario<br />
Edifici<br />
d'abitazio<br />
ne<br />
Edifici<br />
rurali<br />
Diversificazione<br />
Ortofloro<br />
vivaismo<br />
Piccole<br />
aziende<br />
artigianali<br />
Energia<br />
rinnovabile<br />
1<br />
Provvedi<br />
menti<br />
collettivi 2<br />
Bonifiche<br />
fondiarie<br />
1 000 fr.<br />
ZH 3 180 175 2 891 7 277 67 0 0 800 369 0 14 759<br />
BE 13 060 330 8 529 14 583 475 0 0 0 3 430 565 40 972<br />
LU 8 054 0 8 112 14 347 478 0 204 0 1 317 1 119 33 631<br />
UR 240 0 660 446 20 0 0 0 0 120 1 486<br />
SZ 2 410 0 1 214 2 338 119 0 0 0 188 0 6 269<br />
OW 860 0 560 572 0 0 0 0 182 0 2 174<br />
NW 110 0 2 000 561 0 0 0 0 0 0 2 671<br />
GL 820 0 195 1 020 0 0 0 0 0 0 2 035<br />
ZG 750 0 280 1 070 100 0 0 0 0 0 2 200<br />
FR 6 054 261 2 779 15 993 0 0 0 0 5 212 606 30 905<br />
SO 1 800 0 1 379 3 744 629 0 0 0 0 110 7 662<br />
BL 2 000 0 525 2 393 0 0 0 0 179 0 5 097<br />
SH 380 0 1 483 200 0 0 0 0 0 2 063<br />
AR 1 780 370 735 1 429 80 0 0 0 70 0 4 464<br />
AI 250 0 1 160 399 0 0 0 0 0 0 1 809<br />
SG 7 200 0 5 405 6 365 55 0 0 0 412 99 19 536<br />
GR 5 020 0 4 339 5 188 159 0 150 0 1 845 0 16 701<br />
AG 4 819 0 2 056 5 972 349 0 135 0 0 0 13 331<br />
TG 6 790 0 1 670 3 760 0 0 0 0 52 0 12 271<br />
TI 780 283 1 040 1 095 149 0 0 859 504 66 4 776<br />
VD 4 865 0 3 335 14 417 174 0 0 2 232 8 500 62 33 584<br />
VS 2 630 0 608 2 289 338 0 0 0 442 0 6 307<br />
NE 1 960 574 495 3 577 219 0 0 0 2 474 0 9 299<br />
GE 0 0 0 610 0 0 0 0 201 0 811<br />
JU 2 920 0 1 888 3 477 100 0 0 0 378 369 9 132<br />
Totale 78 733 1 993 51 854 114 403 3 710 0 489 3 891 25 755 3 116 283 944<br />
Totale<br />
1 Impianti comuni per la produzione d'energia rinnovabile da biomassa<br />
2 Acquisto in comune di macchine e veicoli, aiuto iniziale per organizzazioni contadine di solidarietà,<br />
edifici e installazioni comuni per la lavorazione e lo stoccaggio di prodotti agricoli<br />
Fonte: UFAG<br />
A100<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Ricapitolazione dei contributi<br />
Provvedimenti<br />
Progetti approvati in 1 000 fr.<br />
2013 2014 2015<br />
Totale 83 393 87 793 91 697<br />
Ricomposizioni particellari (infrastrutture incluse) 10 957 11 416 11 992<br />
Costruzione di strade agricole 24 011 24 789 23 751<br />
Acquedotti 8 149 5 396 8 639<br />
Progetti di sviluppo regionale 4 140 4 031 5 189<br />
Altri provvedimenti del genio civile (danni provocati dal maltempo inclusi) 10 153 14 508 13 853<br />
Edifici rurali per animali che consumano foraggio grezzo 22 763 24 386 24 455<br />
Altri provvedimenti nel settore delle costruzioni rurali 3 220 3 267 3 819<br />
Ricapitolazione dei crediti d'investimento e dei mutui per l'aiuto alla conduzione aziendale<br />
1 Crediti accordati in 1 000 fr.<br />
Crediti d'investimento<br />
2013 2014 2015<br />
Totale 321 540 292 850 283 944<br />
Aiuto iniziale 87 131 79 238 78 733<br />
Acquisto dell'azienda da parte dell'affittuario 2 343 4 701 1 993<br />
Edifici d'abitazione 49 076 47 951 51 854<br />
Edifici rurali 140 967 127 905 114 403<br />
Diversificazione 16 644 4 917 3 710<br />
Ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale<br />
Piccole aziende artigianali 1 876 5 835 489<br />
Impianti comuni per la produzione d'energia rinnov. da biomassa 1 200 3 100 3 891<br />
Provvedimenti collettivi 2 19 815 16 925 25 755<br />
Bonifiche fondiarie, crediti di costruzione esclusi 2 489 2 278 3 116<br />
Mutui per l'aiuto alla conduzione aziendale 1 12 947 15 055 16 900<br />
1 Accordati dal Cantone<br />
2 Acquisto in comune di macchine e veicoli, aiuto iniziale per organizzazioni contadine di solidarietà,<br />
edifici e installazioni comuni per la lavorazione e lo stoccaggio di prodotti agricoli<br />
Fonte: UFAG<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A101
Mutui accordati dai Cantoni nel quadro dell'aiuto alla conduzione aziendale – 2015<br />
(quote federali e cantonali)<br />
Cantone Numero Importo Per singolo caso Durata ammortamento<br />
Fr. Fr. Anni<br />
ZH 9 1 737 000 193 000 14.1<br />
BE 16 2 812 500 175 781 13.1<br />
LU 8 1 640 000 205 000 11.4<br />
UR 1 160 000 160 000 10.0<br />
SZ 3 682 000 227 333 13.7<br />
OW<br />
NW<br />
GL<br />
ZG<br />
FR 9 800 000 88 889 9.2<br />
SO 5 632 500 126 500 15.8<br />
BL 1 45 000 45 000 12.0<br />
SH 4 430 000 107 500 10.0<br />
AR 6 778 000 129 667 11.3<br />
AI 1 80 000 80 000 10.0<br />
SG 4 450 000 112 500 11.0<br />
GR 12 1 114 810 92 901 13.5<br />
AG 4 618 000 154 500 9.5<br />
TG<br />
TI 6 757 758 126 293 12.0<br />
VD 11 1 568 000 142 545 14.5<br />
VS 4 1 075 000 268 750 16.8<br />
NE 1 40 000 40 000 8.0<br />
GE<br />
JU 29 1 479 200 51 007 6.6<br />
Totale 134 16 899 768<br />
Media 126 118 11.3<br />
Fonte: UFAG<br />
A102<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Aiuti per la riqualificazione – 2015<br />
Cantone<br />
Contributi prospettati Contributi versati 1<br />
Numero Fr. Numero Fr.<br />
ZH<br />
BE 1 15 775<br />
LU<br />
UR<br />
SZ<br />
OW 1 123 564<br />
NW<br />
GL<br />
ZG<br />
FR<br />
SO<br />
BL<br />
SH<br />
AR<br />
AI<br />
SG<br />
GR<br />
AG<br />
TG 1 24 000<br />
TI<br />
VD<br />
VS<br />
NE<br />
GE<br />
JU<br />
Total 1 123 564 2 39 705<br />
1 Degli importi prospettati l'anno precedente<br />
Fonte: UFAG<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A103
Tonnellate di Ntot trasferite<br />
Cantone acquirente<br />
Cantone fornitore<br />
AG BE FR LU SG TG VD ZH<br />
AG 1300.4 17.5 5.2 13.3 0.0 3.6 21.0 38.3<br />
BE 5.9 1988.7 35.7 6.3 1.4 5.0 13.3 9.3<br />
FR 0.4 14.7 1074.5 0.0 0.0 0.0 55.1 0.0<br />
LU 389.9 422.3 5.8 1392.2 2.1 11.2 12.3 81.2<br />
SG 15.4 0.0 0.0 0.0 1255.8 194.1 1.3 219.1<br />
TG 11.6 0.5 0.0 0.8 68.1 1495.8 0.0 100.3<br />
VD 0.0 0.4 20.2 0.0 0.0 0.0 643.7 0.0<br />
ZH 41.0 0.0 0.0 0.0 46.3 85.7 0.0 1510.0<br />
Fonte: UFAG<br />
A104<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Tonnellate di P2O5 trasferite<br />
Cantone acquirente<br />
Cantone fornitore<br />
AG BE FR LU SG TG VD ZH<br />
AG 618.8 12.0 2.2 7.8 0.0 1.8 8.0 18.7<br />
BE 3.1 1050.0 21.7 3.3 0.7 2.5 5.6 3.2<br />
FR 0.2 6.7 520.7 0.0 0.0 0.0 23.6 0.0<br />
LU 185.6 232.3 3.3 654.5 0.8 6.5 7.5 44.7<br />
SG 9.7 0.0 0.0 0.0 569.9 89.9 0.5 112.2<br />
TG 7.6 0.3 0.0 0.2 34.8 713.8 0.0 62.2<br />
VD 0.0 0.2 11.4 0.0 0.0 0.0 340.9 0.0<br />
ZH 20.9 0.0 0.0 0.0 31.2 42.2 0.0 744.6<br />
Fonte: UFAG<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A105
Ricapitolazione dei progetti – 2015<br />
Cantone Regione, Durata prev. Sostanza Comprensorio Contributi<br />
Comune del progetto del progetto 2015<br />
Anno ha fr.<br />
AG Baldingen 2004 - 2021 Nitrati 58 35 539<br />
AG Birrfeld 2002 - 2015 2 Nitrati 801 288 036<br />
AG Wohlenschwil 2003 - 2020 Nitrati 62 67 782<br />
AG Klingnau 2008 - 2015 Nitrati 101 56 710<br />
BE Gimmiz 2010 - 2022 Nitrati 180 214 790<br />
BL Buus 2010 - 2022 Nitrati 220 76 320<br />
FR Avry-sur-Matran 2000 - 2017 Nitrati 37 23 695<br />
FR Courgevaux 2003 - 2020 Nitrati 38 24 900<br />
FR Domdidier 2004 - 2021 Nitrati 26 23 242<br />
FR Fétigny 2004 - 2015 2 Nitrati 109 129 662<br />
FR Lurtigen 2005 - 2016 Nitrati 286 107 692<br />
FR Torny (Middes) 2001 - 2018 Nitrati 53 18 946<br />
FR Neyruz 2009 - 2021 Nitrati 8 8 858<br />
FR Gurmels 2011 - 2016 Nitrati 81 67 920<br />
GE Charmilles 2008 - 2017 PF 202 9 278<br />
LU<br />
Lago di Sempach 1<br />
1999 - 2018<br />
Lago di<br />
2000 - 2018<br />
Baldegg 1 Lago di Hallwil 1 2001 - 2018<br />
Fosforo 12 900 -<br />
NE Valangin 2008 - 2020 Nitrati 178 72 211<br />
SH Klettgau 2001 - 2019 Nitrati 520 217 520<br />
SO Gäu I und ll 2000 - 2020 Nitrati 1 508 615 981<br />
VD Bofflens 2005 - 2022 Nitrati 112 129 470<br />
VD Boiron / Morges 2005 - 2022 PF 2 250 111 167<br />
VD Bussy sur Moudon 2009 - 2021 Nitrati 34 47 204<br />
VD Curtilles 2009 - 2021 Nitrati 29 22 852<br />
VD Lucens 2012 - 2018 Nitrati 250 206 268<br />
VD Morand / Montricher 2002 - 2019 Nitrati 399 245 516<br />
VD Thierrens 2000 - 2017 Nitrati 16 30 596<br />
VD Sugnens (Montilliez) 2007 - 2018 Nitrati 16 16 473<br />
VD Peney-le-Jorat / Villars-Tiercelin 2008 - 2020 Nitrati 28 44 914<br />
ZH Baltenswil 2000 - 2017 Nitrati 130 56 938<br />
Totale 2015 2 970 480<br />
Totale 2014 5 079 201<br />
1 Dal 2011 i progetti dei laghi di Baldegg, Sempach e Hallwil vengono portati avanti come un unico progetto. Nel 2015 il progetto è<br />
stato sospeso a causa delle misure di risparmio prese dal Canton Lucerna. L'ultima tappa va dal 2016 al 2018.<br />
2<br />
Progetto concluso nel 2015.<br />
Fonte: UFAG<br />
A106<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Progetti sulle risorse in corso<br />
Promotore Risorsa Durata progetto 1 Preventivo progetto Contributi<br />
Totale Contr. fed. 2015<br />
Anno mio. fr. mio. fr. fr.<br />
Turgovia Ammoniaca 2008 – 2013 (2015) 12 9 -<br />
Lucerna Ammoniaca 2009 – 2014 (2016) 23,9 19,6 -<br />
Basilea Campagna Suolo 2009 – 2014 (2016) 0,2 0,1 -<br />
Associazione SMARAGD Biodiversità 2009 – 2014 (2016) 1,7 0,8 -<br />
Friburgo Ammoniaca 2009 – 2014 (2016) 10,7 8,5 -<br />
Berna Suolo / ammoniaca 2010 – 2015 (2017) 71,2 54,3 9 881 618<br />
Argovia Ammoniaca 2010 – 2015 (2017) 7,5 6,0 970 998<br />
Appenzello Esterno Ammoniaca 2010 – 2015 (2017) 3,8 3,1 475 807<br />
Appenzello Interno Ammoniaca 2010 – 2015 (2017) 2,7 2,0 268 270<br />
Soletta Ammoniaca 2010 – 2015 (2017) 3,2 2,6 570 452<br />
Cantoni della Svizzera centrale 2 Ammoniaca 2010 – 2015 (2017) 16,6 13,2 3 466 286<br />
Soletta Suolo 2010 – 2015 (2017) 3,2 2,4 316 395<br />
Prométerre, ProConseil Sàrl Ammoniaca 2011 – 2016 (2018) 9,9 7,9 994 709<br />
Camera neocastellana dell’agricoltura e<br />
della viticoltura<br />
Ammoniaca 2011 – 2016 (2018) 3,7 2,8 27 304<br />
Glarona Ammoniaca 2011 – 2016 (2018) 2,4 1,8 110 739<br />
Grigioni Ammoniaca 2011 – 2016 (2018) 7,6 5,9 1 138 108<br />
Diversi Cantoni 3 Flora segetale 2011 – 2017 (2019) 2,5 1,8 178 804<br />
Sciaffusa Ammoniaca 2012 – 2017 (2019) 2,6 2,0 153 289<br />
Zurigo Ammoniaca 2012 – 2017 (2019) 26,1 20,9 2 451 328<br />
Associazione Val Nature Pro Energia 2012 – 2017 (2019) 2,1 1,4 156 967<br />
Basilea Campagna Ammoniaca 2012 – 2017 (2019) 1,2 0,9 104 326<br />
Giura Suolo / aria / acqua 2013 – 2018 (2020) 12,1 9,4 320 189<br />
Associazione VITIVAL Suolo 2013 – 2018 (2020) 5,8 4,0 354 775<br />
Vaud Suolo 2014 – 2019 (2021) 26,9 21,2 971 349<br />
Totale 2015 22 911 713<br />
Totale 2014 26 575 646<br />
1<br />
Tra parentesi: ultimo anno del monitoraggio dell'efficacia (mantenuto per due anni dopo la fine del progetto)<br />
2<br />
Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Zugo<br />
3<br />
Argovia, Basilea Campagna, Ginevra, Grigioni, Lucerna, Vaud, Vallese, Zurigo<br />
Fonte: UFAG<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A107
Prezzi alla produzione in Svizzera e nei Paesi limitrofi – 2015<br />
Prodotto Ø 2015<br />
Germania (D) Francia (F) Austria (A) Svizzera (CH)<br />
Latte ct./kg 31.79 32.77 34.61 60.33<br />
Carne<br />
Torelli T3 (R3; R) fr./kg PM 4.04 4.13 4.15 9.06<br />
Vitelli fr./kg PM 5.78 6.23 6.06 13.88<br />
Suini fr./kg PM 1.49 1.50 1.56 3.73<br />
Agnelli fr./kg PM 5.65 6.75 5.76 12.25<br />
Vacche fr./kg PM 3.12 3.48 2.89 6.90<br />
Uova<br />
Uova da allevamento al suolo ct./uovo 7.66 - 9.85 23.93<br />
Cereali e semi oleosi<br />
Frumento panificabile fr./q 17.28 - 17.88 48.11<br />
Orzo da foraggio fr./q 15.55 - 13.32 34.05<br />
Mais da granella fr./q 16.80 - 14.35 37.56<br />
Colza fr./q 37.40 - 33.34 74.53<br />
Sarchiate<br />
Patate da tavola resistenti alla cottura fr./q 15.98 - 16.00 50.73<br />
Patate da tavola farinose fr./q - - 15.82 45.64<br />
Patate destinate alla trasformazione fr./q - - 11.88 43.01<br />
Patate novelle fr./q 42.27 - 23.93 80.84<br />
Frutta<br />
Mele da tavola Golden Delicious, classe I fr./kg 0.41 0.80 0.40 1.17<br />
Pere da tavola Conférence, classe I fr./kg 0.58 1.11 0.71 1.33<br />
Verdura<br />
Carote fr./kg 0.30 0.50 0.50 0.90<br />
Lattuga cappuccio fr./pz. 0.32 0.48 0.28 0.72<br />
Cetrioli fr./pz. 0.40 0.49 0.37 0.84<br />
Cipolle fr./kg 0.20 0.37 0.22 0.84<br />
Avvertenza: i risultati vanno interpretati con cautela, considerato il limite di comparabilità tra i prodotti. In particolare possono variare i servizi<br />
intrinseci. I prodotti considerati, pertanto, sono quelli che meglio si prestano a un tale confronto dei prezzi e per i quali si dispone di dati accessibili e<br />
comparabili. I prezzi esteri sono stati convertiti applicando i corsi del cambio della Banca nazionale svizzera (2015: 1.00 Euro ≙ 1.07 fr.).<br />
Fonti: Francia (F): FranceAgriMer, Agreste Frankreich; Austria (A): Agrarmarkt Austria (AMA), Bundesanstalt Statistik Austria, Bundesanstalt für<br />
Agrarwirtschaft Österreich, GfK Austria; Germania (D): Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) Deutschland, MEG; Svizzera (CH): UFAG<br />
Osservazione del mercato, Swisspatat (CH), Proviande, centri regionali di contrattazione della verdura, CSO, ASF.<br />
Spiegazioni dei dati<br />
Latte: franco fattoria; IVA escl.<br />
Carne: conv. (UE), QM (CH); tassazione: SEUROP (UE), CHTAX (CH); franco macello; prezzi spuntati; IVA escl.<br />
Uova: allevamento al suolo; M 53–63g (UE) , 53+ (CH); franco centro d'imballaggio; prezzi spuntati; IVA escl.<br />
Cereali e semi oleosi: prezzo commerciale (D), prezzo contabile (A, F), prezzo alla produzione lordo (CH); IVA escl.; prezzo franco centro di raccolta<br />
(CH, F, A), commercio e cooperative (D)<br />
Sarchiate: prezzi netti IVA escl., franco fattoria (A), entrata addetto alla registrazione (D); prezzi indicativi delle varietà principali IVA escl. (CH); costi<br />
di trasporto e logistica: esclusi (CH, A), inclusi (D); periodo di rilevamento patate da tavola: set.-dic. (A, D); periodo di rilevamento patate novelle:<br />
mag.-ago. (A, D, CH); merce: convenzionale (D, CH), bio (quota 20–30 %) e convenzionale (A), sfusa e cernita (D, A, CH), non lavata (D, A, CH)<br />
Frutta e verdura: frutta: prezzi indicativi alla produzione dell’ASF; verdura: prezzi indicativi alla produzione dei centri regionali di contrattazione della<br />
verdura calcolati in valore franco caricatore; D, F, A e CH (IVA escl.); F e CH (cipolle gialle); A (mele da tavola classe I comune, pere da tavola classe I<br />
comune)<br />
A108<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
AB_16_Internationale_Preisvergleiche_Tabelle_Produzentenpreise_i.xlsx<br />
Produzentenpreise 25.10.16
Prezzi al consumo in Svizzera e nei Paesi limitrofi – 2015<br />
Prodotto Ø 2015<br />
Germania (D) Francia (F) Austria (A) Svizzera (CH)<br />
Latte e latticini<br />
Latte intero pastorizzato fr./l 0.68 0.86 1.01 1.46<br />
Burro fr./kg 3.79 7.16 5.83 14.97<br />
Yogurt al naturale fr./kg 1.16 1.44 1.96 2.38<br />
Mozzarella fr./kg 5.64 - 7.45 9.90<br />
Emmentaler fr./kg 9.65 8.98 8.09 17.28<br />
Carne<br />
Cotolette di maiale fr./kg 5.61 - 7.69 19.23<br />
Scaloppine di maiale (coscia) fr./kg 7.34 - 7.08 23.81<br />
Carne macinata di manzo fr./kg 7.25 - 9.29 17.99<br />
Entrecôte di manzo fr./kg - 25.88 20.45 69.14<br />
Scaloppine di vitello (coscia) fr./kg - 25.56 29.14 70.45<br />
Pollo intero fr./kg 4.96 - 6.65 8.92<br />
Petto di pollo fr./kg 7.49 - 10.64 29.01<br />
Uova<br />
Uova da allevamento al suolo, conf. da 10 ct./uovo 11.62 - 27.16 41.56<br />
Sarchiate<br />
Patate da tavola resistenti alla cottura fr./kg 0.88 - 0.95 1.56<br />
Patate da tavola farinose fr./kg 0.90 - 1.05 1.64<br />
Patate novelle fr./kg 1.11 1.32 - 1.96<br />
Frutta<br />
Mele da tavola, Golden Delicious, classe I fr./kg 2.04 1.69 1.84 3.25<br />
Pere da tavola, Conférence, classe I fr./kg 2.19 2.29 1.97 3.61<br />
Verdura<br />
Carote fr./kg 1.04 1.37 1.09 2.30<br />
Lattuga cappuccio fr./pz. 0.98 1.09 0.72 1.52<br />
Cetrioli fr./pz. 0.64 1.07 0.95 1.22<br />
Cipolle fr./kg 0.95 1.74 1.06 2.28<br />
Avvertenza: i risultati vanno interpretati con cautela, considerato il limite di comparabilità tra i prodotti. In particolare possono variare i servizi<br />
intrinseci. I prodotti considerati, pertanto, sono quelli che meglio si prestano a un tale confronto dei prezzi e per i quali si dispone di dati accessibili e<br />
comparabili. I prezzi esteri sono stati convertiti applicando i corsi del cambio della Banca nazionale svizzera (2015: 1.00 Euro ≙ 1.07 fr.).<br />
Fonti: Francia (F): FranceAgriMer, Agreste Frankreich, Insee; Austria (A): GfK Austria, Bundesanstalt Statistik Austria, Bundesanstalt für<br />
Agrarwirtschaft Österreich; Germania (D): Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) Deutschland, GfK (D); Svizzera (CH): UFAG<br />
Osservazione del mercato<br />
Spiegazioni dei dati<br />
Latte e latticini: conv. IVA incl; D (mozzarella, self-service, Emmentaler, servito); latte intero past.: F (latte UHT parzialm. scremato)<br />
Carne: qualità: label+QM (CH), label+convenzionale (UE); copertura: nazionale (D, A, CH), Francia metropolitana (F); franco negozio; prezzi realizzati,<br />
IVA incl.<br />
Uova: allevamento al suolo; franco negozio; prezzi spuntati, IVA incl.<br />
Sarchiate: dati economie domestiche (D, A), rilevazioni dei prezzi (F,CH); imballaggio: 1-2,5 kg (D, CH), 5 kg (F), diversi (A); diverse varietà; IVA incl.<br />
Frutta e verdura: D (IVA incl., importazioni e discount incl.); F (importazioni e discount escl.); A (IVA incl., importazioni e discount incl.); CH (IVA incl.,<br />
importazioni incl., se non è disponibile merce CH; discount escl.) D (pere da tavola classe I comune), F e CH (cipolle gialle); A (mele da tavola classe I<br />
comune, pere da tavola classe I comune)<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG<br />
A109<br />
AB_16_Internationale_Preisvergleiche_Tabelle_Konsumentenpreise_i.xlsx<br />
25.10.16
A110<br />
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
A111