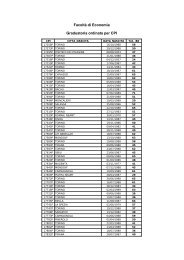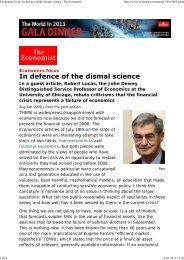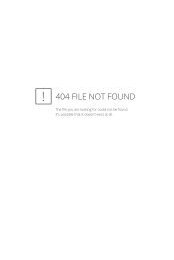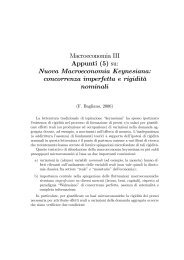Il modello istituzionale corporativo a Torino nel Settecento ...
Il modello istituzionale corporativo a Torino nel Settecento ...
Il modello istituzionale corporativo a Torino nel Settecento ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
sui mercati internazionali la competitività del prodotto grazie all’alta qualità e alla sua<br />
standardizzazione 27 .<br />
Anche <strong>nel</strong>la tessitura si avverte l'ingerenza del potere politico che va ad interporsi tra il mercante e il<br />
fabbricatore per fare valere le ragioni della produzione su quelle del commercio . I mercanti, infatti,<br />
in gran parte legati agli interessi lionesi preferivano esportare semilavorato e importare prodotto<br />
finito, quindi commercializzare prodotto straniero piuttosto di impegnarsi a fondo <strong>nel</strong>la tessitura<br />
nazionale.<br />
Così <strong>nel</strong> 1752 venne costituita direttamente dal sovrano e dall'alta aristocrazia, attraverso un ente<br />
assistenziale pubblico, la Fabbrica della Carità, una Compagnia reale del Piemonte per le opere e<br />
negozi in seta su <strong>modello</strong> delle compagnie nord-europee (olandesi in particolare) per la produzione e<br />
distribuzione sul mercato nazionale ed estero di tessuti ottenuti dalla trasformazione della seta<br />
indigena. Sorse <strong>nel</strong>la forma azionaria e venne aperta ai privati, nobili e corporazioni, sia pure con<br />
una limitazione alle quote individualmente sottoscritte, ma escludeva tassativamente da qualunque<br />
partecipazione i mercanti ossia coloro che «facessero fabbricare le stoffe in seta oppure avessero<br />
bottega aperta per la vendita delle medesime» 28 .<br />
Tale società operò per circa quarant 'anni, dapprima sotto il controllo dell'aristocrazia e poi dei<br />
banchieri finanziatori. Fu in grado di distribuire saltuariamente dividendi oscillanti tra il 4 e il 6%<br />
(livello medio dell'interesse pagato sui censi), costituire fondi di riserva, ma accumulò anche perdite<br />
consistenti che vennero ripianate con progressive riduzioni di capitale sociale.<br />
La Compagnia reale rientra <strong>nel</strong>la tipologia della compagnia commerciale più che in quella della<br />
manifattura privilegiata. Nata con lo scopo di «servire da stimolo agli altri [fabbricatori e mercanti<br />
riuniti in corporazione] per dilatare e assicurare questo genere di commercio ostacolato da gravezze<br />
di costo degli operai [per questo fece ampio ricorso al lavoro coatto della Fabbrica della carità] e<br />
ristrettezza del mercato interno» doveva stabilire una rete di corrispondenze sulle principali piazze<br />
europee, Lione, Amsterdam, Londra.<br />
L'ingerenza dello stato <strong>nel</strong>la vita economica,infatti, andava oltre il mondo della produzione per<br />
pianificare interventi mirati a una dilatazione del mercato che potesse giustificare una maggiore<br />
specializzazione produttiva <strong>nel</strong> paese. L’attenzione era rivolta ai mezzi più idonei per inserire il<br />
commercio del regno <strong>nel</strong>le grandi correnti del traffico internazionale: l’apertura di collegamenti<br />
essenziali e la stipulazione dei trattati . I trattati commerciali conclusi 29 o semplicemente progettati 30<br />
dai Savoia rispondevano innanzitutto a ragioni politiche e militari. La fragile strategia economica<br />
che caratterizzava i progetti formulati <strong>nel</strong> Sei - <strong>Settecento</strong> poggiava sul comune denominatore<br />
dell'ipotetico sviluppo del porto franco di Nizza e Villafranca e della marineria sabauda. La<br />
progettazione e le realizzazioni seicentesche si erano concentrate sul potenziamento, mediante<br />
investimenti pubblici, delle infrastrutture portuali e viarie e segnatamente sulla costruzione di<br />
moli,di magazzini di stoccaggio, del “lazzaretto” per le merci provenienti dal Levante, sulla<br />
realizzazione di strade carreggiabili, sul traforo del Colle di Tenda, sul naviglio da Cuneo a<br />
Moncalieri, presso la capitale 31 . Nel <strong>Settecento</strong> l’interesse si focalizzò prevalentemente sugli aspetti<br />
di relazione e istituzionali. Così, a nome della città di <strong>Torino</strong> fu tentato il riscatto dei pedaggi per<br />
introdurre la libera navigazione sul fiume Po fino a Venezia, la stipulazione di una tregua <strong>nel</strong><br />
Mediterraneo con i pirati barbareschi del Nord Africa, sorsero progetti e iniziative intesi alla<br />
27 Vale a tale proposito la testimonianza fornita dal Vaucanson che <strong>nel</strong> corso degli anni quaranta aveva studiato a fondo i sistemi di<br />
lavorazione piemontesi su incarico del Conseil du Commerce ( G. Chicco,La seta in Piemonte…, cit.,p. 253)<br />
28 Asto Corte, Materie economiche, cat. IV, maz . 9, nn. 16 e 18.La Compagnia verrà sciolta <strong>nel</strong> 1793 e sostituita dall’Associazione<br />
reale per la manifattura della seta ( G. Prato,La vita economica in Piemonte a mezzo il secolo XVIII, <strong>Torino</strong> 1908, p. 227)<br />
29 Con l'Inghilterra, firmato a Firenze <strong>nel</strong> 1669,( cfr. Contessa, Aspirazioni commerciali intrecciate ad alleanze politiche della casa di<br />
Savoia con l'Inghilterra nei secoli XVII e XVIII, in «Memorie della regia Accademia delle scienze di <strong>Torino</strong>»,serie II, vol. LXIV<br />
(1913), n. 3);con l'Ungheria <strong>nel</strong> 1743; con Modena <strong>nel</strong> 1752 ( F. Duboin , Raccolta per ordine di materia delle leggi, editti, manifesti<br />
ecc., <strong>Torino</strong>,1850, tomo XV, p. 1293 e sgg); con Basilea <strong>nel</strong> 1731, con il Levante e con Smirne <strong>nel</strong> 1749 e 1788, con la Danimarca <strong>nel</strong><br />
1786, con Malta <strong>nel</strong> 1797 (Asto Corte, Materie economiche,cat. II, maz. 2 da ordinare).<br />
30 Con il Portogallo 1678-1682, cfr , C. Contessa, Progetti economici della seconda Madama Reale di Savoia fondati sopra un<br />
contratto nuziale (1678-1682), <strong>Torino</strong> 1914; con la Russia <strong>nel</strong> 1770-'83, cfr., Asto,Corte,Materie economiche, cat. III, maz. II, n. 27 e<br />
maz. III. Ma<br />
31 Cfr. L. Bulferetti, Sogni e realtà <strong>nel</strong> mercantilismo di Carlo Emanuele II, in "Nuova rivista storica",XXXVII (1953)<br />
16