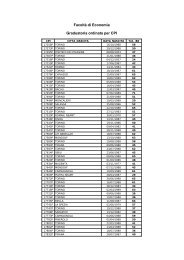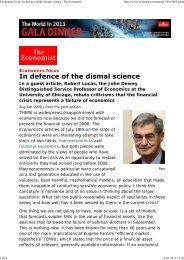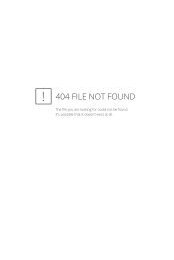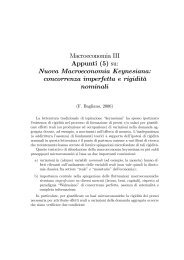Il modello istituzionale corporativo a Torino nel Settecento ...
Il modello istituzionale corporativo a Torino nel Settecento ...
Il modello istituzionale corporativo a Torino nel Settecento ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
In effetti, anteriormente al 1750 i mercanti e fabbricatori torinesi avevano effettuato “grandiose “<br />
spedizioni di moelle, taffettà, damaschi e altre “stoffe di gusto” oltre a calze di seta in Germania e<br />
soprattutto a Vienna. La successiva chiusura del mercato austriaco, in connessione agli eventi<br />
bellici,mise però in difficoltà il settore e la nascita della Compagnia reale e della Fabbrica reale della<br />
Venaria servirono a rilanciarlo. La ricerca e l’apertura dei nuovi mercati Nord -orientali fino a quello<br />
russo, raggiunto per gli scali di Milano, Como, Coiro, Lindò, Norimberga o Francoforte avrebbe<br />
portato i telai battenti <strong>nel</strong>la capitale a 1300 .All’inizio degli anni ottanta dal 45 al 48% delle stoffe<br />
prodotte a <strong>Torino</strong> erano spedite all’estero; buona parte prendeva la via di Milano e di Ginevra. A<br />
quel tempo , tuttavia, come si è già avuto occasione di osservare, il 62- 63% dei tessuti serici<br />
esportati dal Regno di Sardegna, proveniva dalla città di Vigevano 51 . Dopo il 1798 si ebbe una<br />
nuova battuta d’arresto con la proibizione introdotta dal re di Prussia di importare stoffe in seta nei<br />
propri stati 52<br />
Come si è visto, il commercio delle stoffe che si affermò nei primi decenni del secolo lasciava<br />
ampio spazio alle forme di scambio non monetario attraverso le quali i produttori riuscivano ad<br />
affrontare i problemi connessi a scarsa liquidità.<br />
Proprio in ordine a tali modalità di pagamento, tuttavia, sorse un conflitto di interesse tra la<br />
corporazione dei droghisti e fondichieri 53 che dal 1734 riuniva i commercianti all’ingrosso e al<br />
minuto di prodotti coloniali , le cosiddette “robe vive”, come il pepe, lo zucchero, la can<strong>nel</strong>la, e<br />
l'Università dei mercanti fabbricatori di stoffe in seta. I primi ,in quanto acquirenti delle piazze con<br />
le quali ottenevano dall'autorità sovrana la privativa di vendita tanto all'ingrosso che al minuto di tali<br />
generi , ricorsero al Consolato contro la pratica invalsa di barattare le merci che li escludeva dal<br />
commercio delle materie coloranti.<br />
L'ente pubblico ,per onorare gli obblighi contrattuali assunti all’atto della vendita della privativa ai<br />
droghieri, procedette, secondo l'uso, alla “tassa delle tinture” ovvero alla fissazione ,in<br />
contraddittorio delle parti interessate, del prezzo massimo delle fatture indicizzato alla variazione<br />
del prezzo delle materie coloranti, “alla prorata del valore delle droghe”. I conti tra i mercanti<br />
fabbricatori e i tintori andavano quindi regolati non già con il baratto , ma a denari sulla base della<br />
tariffa fissata e ogni quattro mesi.<br />
Per i trasgressori erano previste penalità severissime che la maggior parte dei contraenti non aveva i<br />
mezzi di affrontare trattandosi di multe pari al quadruplo del valore delle fatture . Ciò che<br />
preoccupava maggiormente i produttori, tuttavia, era il dover abbandonare le compensazioni in<br />
natura poiché il sistema di commercio ancora in uso sul mercato torinese non garantiva loro<br />
sufficienti flussi di cassa:<br />
«per dare le facilità necessarie et opportune quante volte ci accontentiamo, e anche con gusto grande, di<br />
prendere da cavalieri, massime in pagamento, grano, vino e legna in forti quantità a quali effetti noi ,con le<br />
nostre semplici famiglie, non possiamo dar spaccio e per forza conviene scaricarsene coi nostri creditori e<br />
usar con essi ciò che si usa con noi» 54 .<br />
<strong>Il</strong> timore nutrito dall'Università, che fece ricorso al sovrano per opporsi alle disposizioni del<br />
Consolato, era che le aziende artigiane potessero cadere <strong>nel</strong>l'insolvenza fino a giungere alla<br />
liquidazione, di fronte alla perentoria fissazione dei quattro mesi come termine ultimo di dilazione<br />
<strong>nel</strong> pagamento delle fatture ai tintori,poiché i due terzi dei fabbricatori erano "deboli, con poco<br />
capitale, vend[evano] poco e esig[evano] stentatamente”.<br />
La fragilità della struttura produttiva <strong>nel</strong> primo quarto del <strong>Settecento</strong> dipendeva in buona misura dal<br />
fatto che , all’interno come all’estero, l'economia di scambio in cui i mercanti fabbricatori torinesi si<br />
trovavano ad operare era ancora insufficientemente sviluppata :<br />
51 Asto Corte, Materie economiche, cat. IV, maz. 10<br />
52 Asto Corte, Materie economiche, cat. 3, maz. 1 da ordinare, n. 2<br />
53 F.A. Duboin, Raccolta delle leggi, editti, manifesti ecc., <strong>Torino</strong> 1849, tomo X,p.153<br />
54 Asto,Corte, Materie economiche,cat.IV, m. 7<br />
22