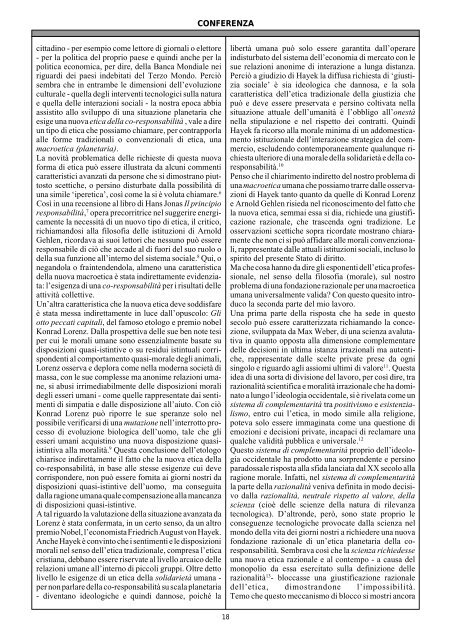Anno Numero 1993 11 - Studi Filosofici
Anno Numero 1993 11 - Studi Filosofici
Anno Numero 1993 11 - Studi Filosofici
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
cittadino - per esempio come lettore di giornali o elettore<br />
- per la politica del proprio paese e quindi anche per la<br />
politica economica, per dire, della Banca Mondiale nei<br />
riguardi dei paesi indebitati del Terzo Mondo. Perciò<br />
sembra che in entrambe le dimensioni dell’evoluzione<br />
culturale - quella degli interventi tecnologici sulla natura<br />
e quella delle interazioni sociali - la nostra epoca abbia<br />
assistito allo sviluppo di una situazione planetaria che<br />
esige una nuova etica della co-responsabilità , vale a dire<br />
un tipo di etica che possiamo chiamare, per contrapporla<br />
alle forme tradizionali o convenzionali di etica, una<br />
macroetica (planetaria).<br />
La novità problematica delle richieste di questa nuova<br />
forma di etica può essere illustrata da alcuni commenti<br />
caratteristici avanzati da persone che si dimostrano piuttosto<br />
scettiche, o persino disturbate dalla possibilità di<br />
una simile ‘iperetica’, così come la si è voluta chiamare. 6<br />
Così in una recensione al libro di Hans Jonas Il principio<br />
responsabilità, 7 opera precorritrice nel suggerire energicamente<br />
la necessità di un nuovo tipo di etica, il critico,<br />
richiamandosi alla filosofia delle istituzioni di Arnold<br />
Gehlen, ricordava ai suoi lettori che nessuno può essere<br />
responsabile di ciò che accade al di fuori del suo ruolo o<br />
della sua funzione all’interno del sistema sociale. 8 Qui, o<br />
negandola o fraintendendola, almeno una caratteristica<br />
della nuova macroetica è stata indirettamente evidenziata:<br />
l’esigenza di una co-responsabilità per i risultati delle<br />
attività collettive.<br />
Un’altra caratteristica che la nuova etica deve soddisfare<br />
è stata messa indirettamente in luce dall’opuscolo: Gli<br />
otto peccati capitali, del famoso etologo e premio nobel<br />
Konrad Lorenz. Dalla prospettiva delle sue ben note tesi<br />
per cui le morali umane sono essenzialmente basate su<br />
disposizioni quasi-istintive o su residui istintuali corrispondenti<br />
al comportamento quasi-morale degli animali,<br />
Lorenz osserva e deplora come nella moderna società di<br />
massa, con le sue complesse ma anonime relazioni umane,<br />
si abusi irrimediabilmente delle disposizioni morali<br />
degli esseri umani - come quelle rappresentate dai sentimenti<br />
di simpatia e dalle disposizione all’aiuto. Con ciò<br />
Konrad Lorenz può riporre le sue speranze solo nel<br />
possibile verificarsi di una mutazione nell’interrotto processo<br />
di evoluzione biologica dell’uomo, tale che gli<br />
esseri umani acquistino una nuova disposizione quasiistintiva<br />
alla moralità. 9 Questa conclusione dell’etologo<br />
chiarisce indirettamente il fatto che la nuova etica della<br />
co-responsabilità, in base alle stesse esigenze cui deve<br />
corrispondere, non può essere fornita ai giorni nostri da<br />
disposizioni quasi-istintive dell’uomo, ma conseguita<br />
dalla ragione umana quale compensazione alla mancanza<br />
di disposizioni quasi-istintive.<br />
A tal riguardo la valutazione della situazione avanzata da<br />
Lorenz è stata confermata, in un certo senso, da un altro<br />
premio Nobel, l’economista Friedrich August von Hayek.<br />
Anche Hayek è convinto che i sentimenti e le disposizioni<br />
morali nel senso dell’etica tradizionale, compresa l’etica<br />
cristiana, debbano essere riservate al livello arcaico delle<br />
relazioni umane all’interno di piccoli gruppi. Oltre detto<br />
livello le esigenze di un etica della solidarietà umana -<br />
per non parlare della co-responsabilità su scala planetaria<br />
- diventano ideologiche e quindi dannose, poiché la<br />
CONFERENZA<br />
18<br />
libertà umana può solo essere garantita dall’operare<br />
indisturbato del sistema dell’economia di mercato con le<br />
sue relazioni anonime di interazione a lunga distanza.<br />
Perciò a giudizio di Hayek la diffusa richiesta di ‘giustizia<br />
sociale’ è sia ideologica che dannosa, e la sola<br />
caratteristica dell’etica tradizionale della giustizia che<br />
può e deve essere preservata e persino coltivata nella<br />
situazione attuale dell’umanità è l’obbligo all’onestà<br />
nella stipulazione e nel rispetto dei contratti. Quindi<br />
Hayek fa ricorso alla morale minima di un addomesticamento<br />
istituzionale dell’interazione strategica del commercio,<br />
escludendo contemporaneamente qualunque richiesta<br />
ulteriore di una morale della solidarietà e della coresponsabilità.<br />
10<br />
Penso che il chiarimento indiretto del nostro problema di<br />
una macroetica umana che possiamo trarre dalle osservazioni<br />
di Hayek tanto quanto da quelle di Konrad Lorenz<br />
e Arnold Gehlen risieda nel riconoscimento del fatto che<br />
la nuova etica, semmai essa si dia, richiede una giustificazione<br />
razionale, che trascenda ogni tradizione. Le<br />
osservazioni scettiche sopra ricordate mostrano chiaramente<br />
che non ci si può affidare alle morali convenzionali,<br />
rappresentate dalle attuali istituzioni sociali, incluso lo<br />
spirito del presente Stato di diritto.<br />
Ma che cosa hanno da dire gli esponenti dell’etica professionale,<br />
nel senso della filosofia (morale), sul nostro<br />
problema di una fondazione razionale per una macroetica<br />
umana universalmente valida? Con questo quesito introduco<br />
la seconda parte del mio lavoro.<br />
Una prima parte della risposta che ha sede in questo<br />
secolo può essere caratterizzata richiamando la concezione,<br />
sviluppata da Max Weber, di una scienza avalutativa<br />
in quanto opposta alla dimensione complementare<br />
delle decisioni in ultima istanza irrazionali ma autentiche,<br />
rappresentate dalle scelte private prese da ogni<br />
singolo e riguardo agli assiomi ultimi di valore <strong>11</strong> . Questa<br />
idea di una sorta di divisione del lavoro, per così dire, tra<br />
razionalità scientifica e moralità irrazionale che ha dominato<br />
a lungo l’ideologia occidentale, si è rivelata come un<br />
sistema di complementarità tra positivismo e esistenzialismo,<br />
entro cui l’etica, in modo simile alla religione,<br />
poteva solo essere immaginata come una questione di<br />
emozioni e decisioni private, incapaci di reclamare una<br />
qualche validità pubblica e universale. 12<br />
Questo sistema di complementarità proprio dell’ideologia<br />
occidentale ha prodotto una sorprendente e persino<br />
paradossale risposta alla sfida lanciata dal XX secolo alla<br />
ragione morale. Infatti, nel sistema di complementarità<br />
la parte della razionalità veniva definita in modo decisivo<br />
dalla razionalità, neutrale rispetto al valore, della<br />
scienza (cioè delle scienze della natura di rilevanza<br />
tecnologica). D’altronde, però, sono state proprio le<br />
conseguenze tecnologiche provocate dalla scienza nel<br />
mondo della vita dei giorni nostri a richiedere una nuova<br />
fondazione razionale di un’etica planetaria della coresponsabilità.<br />
Sembrava così che la scienza richiedesse<br />
una nuova etica razionale e al contempo - a causa del<br />
monopolio da essa esercitato sulla definizione delle<br />
razionalità 13 - bloccasse una giustificazione razionale<br />
dell’etica, dimostrandone l’impossibilità.<br />
Temo che questo meccanismo di blocco si mostri ancora