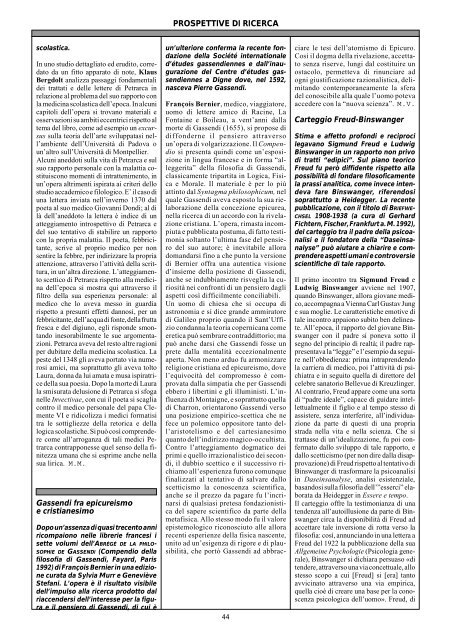Anno Numero 1993 11 - Studi Filosofici
Anno Numero 1993 11 - Studi Filosofici
Anno Numero 1993 11 - Studi Filosofici
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
scolastica.<br />
In uno studio dettagliato ed erudito, corredato<br />
da un fitto apparato di note, Klaus<br />
Bergdolt analizza passaggi fondamentali<br />
dei trattati e delle lettere di Petrarca in<br />
relazione al problema del suo rapporto con<br />
la medicina scolastica dell’epoca. In alcuni<br />
capitoli dell’opera si trovano materiali e<br />
osservazioni su ambiti eccentrici rispetto al<br />
tema del libro, come ad esempio un excursus<br />
sulla teoria dell’arte sviluppatasi nell’ambiente<br />
dell’Università di Padova o<br />
un’altro sull’Università di Montpellier.<br />
Alcuni aneddoti sulla vita di Petrarca e sul<br />
suo rapporto personale con la malattia costituiscono<br />
momenti di intrattenimento, in<br />
un’opera altrimenti ispirata ai criteri dello<br />
studio accademico e filologico. E’ il caso di<br />
una lettera inviata nell’inverno 1370 dal<br />
poeta al suo medico Giovanni Dondi; al di<br />
là dell’aneddoto la lettera è indice di un<br />
atteggiamento introspettivo di Petrarca e<br />
del suo tentativo di stabilire un rapporto<br />
con la propria malattia. Il poeta, febbricitante,<br />
scrive al proprio medico per non<br />
sentire la febbre, per indirizzare la propria<br />
attenzione, attraverso l’attività della scrittura,<br />
in un’altra direzione. L’atteggiamento<br />
scettico di Petrarca rispetto alla medicina<br />
dell’epoca si mostra qui attraverso il<br />
filtro della sua esperienza personale: al<br />
medico che lo aveva messo in guardia<br />
rispetto a presunti effetti dannosi, per un<br />
febbricitante, dell’acqua di fonte, della frutta<br />
fresca e del digiuno, egli risponde smontando<br />
inesorabilmente le sue argomentazioni.<br />
Petrarca aveva del resto altre ragioni<br />
per dubitare della medicina scolastica. La<br />
peste del 1348 gli aveva portato via numerosi<br />
amici, ma soprattutto gli aveva tolto<br />
Laura, donna da lui amata e musa ispiratrice<br />
della sua poesia. Dopo la morte di Laura<br />
la smisurata delusione di Petrarca si sfoga<br />
nelle Invectivae, con cui il poeta si scaglia<br />
contro il medico personale del papa Clemente<br />
VI e ridicolizza i medici formatisi<br />
tra le sottigliezze della retorica e della<br />
logica scolastiche. Si può così comprendere<br />
come all’arroganza di tali medici Petrarca<br />
contrapponesse quel senso della finitezza<br />
umana che si esprime anche nella<br />
sua lirica. M.M.<br />
Gassendi fra epicureismo<br />
e cristianesimo<br />
Dopo un’assenza di quasi trecento anni<br />
ricompaiono nelle librerie francesi i<br />
sette volumi dell’ABRÉGÉ DE LA PHILO-<br />
SOPHIE DE GASSENDI (Compendio della<br />
filosofia di Gassendi, Fayard, Paris<br />
1992) di François Bernier in una edizione<br />
curata da Sylvia Murr e Geneviève<br />
Stefani. L’opera è il risultato visibile<br />
dell’impulso alla ricerca prodotto dal<br />
riaccendersi dell’interesse per la figura<br />
e il pensiero di Gassendi, di cui è<br />
PROSPETTIVE DI RICERCA<br />
un’ulteriore conferma la recente fondazione<br />
della Société internationale<br />
d’études gassendiennes e dall’inaugurazione<br />
del Centre d’études gassendiennes<br />
a Digne dove, nel 1592,<br />
nasceva Pierre Gassendi.<br />
François Bernier, medico, viaggiatore,<br />
uomo di lettere amico di Racine, La<br />
Fontaine e Boileau, a vent’anni dalla<br />
morte di Gassendi (1655), si propose di<br />
diffonderne il pensiero attraverso<br />
un’opera di volgarizzazione. Il Compendio<br />
si presenta quindi come un’esposizione<br />
in lingua francese e in forma “alleggerita”<br />
della filosofia di Gassendi,<br />
classicamente tripartita in Logica, Fisica<br />
e Morale. Il materiale è per lo più<br />
attinto dal Syntagma philosophicum, nel<br />
quale Gassendi aveva esposto la sua rielaborazione<br />
della concezione epicurea,<br />
nella ricerca di un accordo con la rivelazione<br />
cristiana. L’opera, rimasta incompiuta<br />
e pubblicata postuma, di fatto testimonia<br />
soltanto l’ultima fase del pensiero<br />
del suo autore; è inevitabile allora<br />
domandarsi fino a che punto la versione<br />
di Bernier offra una autentica visione<br />
d’insieme della posizione di Gassendi,<br />
anche se indubbiamente risveglia la curiosità<br />
nei confronti di un pensiero dagli<br />
aspetti così difficilmente conciliabili.<br />
Un uomo di chiesa che si occupa di<br />
astronomia e si dice grande ammiratore<br />
di Galileo proprio quando il Sant’Uffizio<br />
condanna la teoria copernicana come<br />
eretica può sembrare contraddittorio; ma<br />
può anche darsi che Gassendi fosse un<br />
prete dalla mentalità eccezionalmente<br />
aperta. Non meno arduo fu armonizzare<br />
religione cristiana ed epicureismo, dove<br />
l’equivocità del compromesso è comprovata<br />
dalla simpatia che per Gassendi<br />
ebbero i libertini e gli illuministi. L’influenza<br />
di Montaigne, e soprattutto quella<br />
di Charron, orientarono Gassendi verso<br />
una posizione empirico-scettica che ne<br />
fece un polemico oppositore tanto dell’aristotelismo<br />
e del cartesianesimo<br />
quanto dell’indirizzo magico-occultista.<br />
Contro l’atteggiamento dogmatico dei<br />
primi e quello irrazionalistico dei secondi,<br />
il dubbio scettico e il successivo richiamo<br />
all’esperienza furono comunque<br />
finalizzati al tentativo di salvare dallo<br />
scetticismo la conoscenza scientifica,<br />
anche se il prezzo da pagare fu l’incrinarsi<br />
di qualsiasi pretesa fondazionistica<br />
del sapere scientifico da parte della<br />
metafisica. Allo stesso modo fu il valore<br />
epistemologico riconosciuto alle allora<br />
recenti esperienze della fisica nascente,<br />
unito ad un’esigenza di rigore e di plausibilità,<br />
che portò Gassendi ad abbrac-<br />
44<br />
ciare le tesi dell’atomismo di Epicuro.<br />
Così il dogma della rivelazione, accettato<br />
senza riserve, lungi dal costituire un<br />
ostacolo, permetteva di rinunciare ad<br />
ogni giustificazione razionalistica, delimitando<br />
contemporaneamente la sfera<br />
del conoscibile alla quale l’uomo poteva<br />
accedere con la “nuova scienza”. M.V.<br />
Carteggio Freud-Binswanger<br />
Stima e affetto profondi e reciproci<br />
legavano Sigmund Freud e Ludwig<br />
Binswanger in un rapporto non privo<br />
di tratti “edipici”. Sul piano teorico<br />
Freud fu però diffidente rispetto alla<br />
possibilità di fondare filosoficamente<br />
la prassi analitica, come invece intendeva<br />
fare Binswanger, riferendosi<br />
soprattutto a Heidegger. La recente<br />
pubblicazione, con il titolo di BRIEFWE-<br />
CHSEL 1908-1938 (a cura di Gerhard<br />
Fichtern, Fischer, Frankfurt a. M. 1992),<br />
del carteggio tra il padre della psicoanalisi<br />
e il fondatore della “Daseinsanalyse”<br />
può aiutare a chiarire e comprendere<br />
aspetti umani e controversie<br />
scientifiche di tale rapporto.<br />
Il primo incontro tra Sigmund Freud e<br />
Ludwig Binswanger avviene nel 1907,<br />
quando Binswanger, allora giovane medico,<br />
accompagna a Vienna Carl Gustav Jung<br />
e sua moglie. Le caratteristiche emotive di<br />
tale incontro appaiono subito ben delineate.<br />
All’epoca, il rapporto del giovane Binswanger<br />
con il padre si poneva sotto il<br />
segno del principio di realtà; il padre rappresentava<br />
la “legge” e l’esempio da seguire<br />
nell’obbedienza: prima intraprendendo<br />
la carriera di medico, poi l’attività di psichiatra<br />
e in seguito quella di direttore del<br />
celebre sanatorio Bellevue di Kreuzlinger.<br />
Al contrario, Freud appare come una sorta<br />
di “padre ideale”, capace di guidare intellettualmente<br />
il figlio e al tempo stesso di<br />
assistere, senza interferire, all’individuazione<br />
da parte di questi di una propria<br />
strada nella vita e nella scienza. Che si<br />
trattasse di un’idealizzazione, fu poi confermato<br />
dallo sviluppo di tale rapporto, e<br />
dallo scetticismo (per non dire dalla disapprovazione)<br />
di Freud rispetto al tentativo di<br />
Binswanger di trasformare la psicoanalisi<br />
in Daseinsanalyse, analisi esistenziale,<br />
basandosi sulla filosofia dell’”esserci” elaborata<br />
da Heidegger in Essere e tempo.<br />
Il carteggio offre la testimonianza di una<br />
tendenza all’autoillusione da parte di Binswanger<br />
circa la disponibilità di Freud ad<br />
accettare tale inversione di rotta verso la<br />
filosofia: così, annunciando in una lettera a<br />
Freud del 1922 la pubblicazione della sua<br />
Allgemeine Psychologie (Psicologia generale),<br />
Binswanger si dichiara persuaso «di<br />
tendere, attraverso una via concettuale, allo<br />
stesso scopo a cui [Freud] si [era] tanto<br />
avvicinato attraverso una via empirica,<br />
quella cioè di creare una base per la conoscenza<br />
psicologica dell’uomo». Freud, di