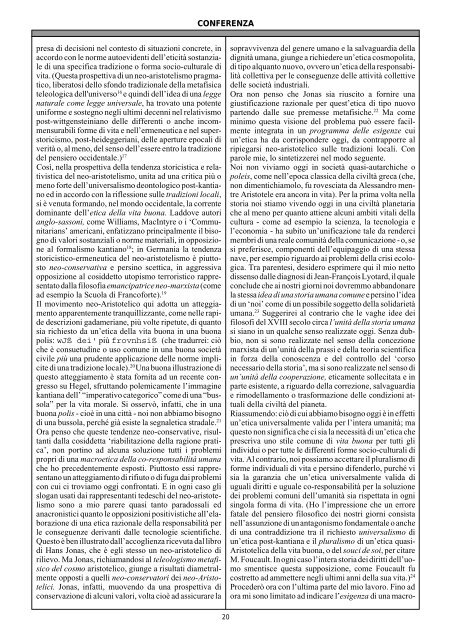Anno Numero 1993 11 - Studi Filosofici
Anno Numero 1993 11 - Studi Filosofici
Anno Numero 1993 11 - Studi Filosofici
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
presa di decisioni nel contesto di situazioni concrete, in<br />
accordo con le norme autoevidenti dell’eticità sostanziale<br />
di una specifica tradizione o forma socio-culturale di<br />
vita. (Questa prospettiva di un neo-aristotelismo pragmatico,<br />
liberatosi dello sfondo tradizionale della metafisica<br />
teleologica dell'universo 16 e quindi dell’idea di una legge<br />
naturale come legge universale, ha trovato una potente<br />
uniforme e sostegno negli ultimi decenni nel relativismo<br />
post-wittgensteiniano delle differenti o anche incommensurabili<br />
forme di vita e nell’ermeneutica e nel superstoricismo,<br />
post-heideggeriani, delle aperture epocali di<br />
verità o, al meno, del senso dell’essere entro la tradizione<br />
del pensiero occidentale.) 17<br />
Così, nella prospettiva della tendenza storicistica e relativistica<br />
del neo-aristotelismo, unita ad una critica più o<br />
meno forte dell’universalismo deontologico post-kantiano<br />
ed in accordo con la riflessione sulle tradizioni locali,<br />
si è venuta formando, nel mondo occidentale, la corrente<br />
dominante dell’etica della vita buona. Laddove autori<br />
anglo-sassoni, come Williams, MacIntyre o i ‘Communitarians’<br />
americani, enfatizzano principalmente il bisogno<br />
di valori sostanziali o norme materiali, in opposizione<br />
al formalismo kantiano 18 ; in Germania la tendenza<br />
storicistico-ermeneutica del neo-aristotelismo è piuttosto<br />
neo-conservativa e persino scettica, in aggressiva<br />
opposizione al cosiddetto utopismo terroristico rappresentato<br />
dalla filosofia emancipatrice neo-marxista (come<br />
ad esempio la Scuola di Francoforte). 19<br />
Il movimento neo-Aristotelico qui adotta un atteggiamento<br />
apparentemente tranquillizzante, come nelle rapide<br />
descrizioni gadameriane, più volte ripetute, di quanto<br />
sia richiesto da un’etica della vita buona in una buona<br />
polis: wJß dei' più frovnhsiß (che tradurrei: ciò<br />
che è consuetudine o uso comune in una buona società<br />
civile più una prudente applicazione delle norme implicite<br />
di una tradizione locale). 20 Una buona illustrazione di<br />
questo atteggiamento è stata fornita ad un recente congresso<br />
su Hegel, sfruttando polemicamente l’immagine<br />
kantiana dell’ “imperativo categorico” come di una “bussola”<br />
per la vita morale. Si osservò, infatti, che in una<br />
buona polis - cioè in una città - noi non abbiamo bisogno<br />
di una bussola, perché già esiste la segnaletica stradale. 21<br />
Ora penso che queste tendenze neo-conservative, risultanti<br />
dalla cosiddetta ‘riabilitazione della ragione pratica’,<br />
non portino ad alcuna soluzione tutti i problemi<br />
propri di una macroetica della co-responsabilità umana<br />
che ho precedentemente esposti. Piuttosto essi rappresentano<br />
un atteggiamento di rifiuto o di fuga dai problemi<br />
con cui ci troviamo oggi confrontati. E in ogni caso gli<br />
slogan usati dai rappresentanti tedeschi del neo-aristotelismo<br />
sono a mio parere quasi tanto paradossali ed<br />
anacronistici quanto le opposizioni positivistiche all’elaborazione<br />
di una etica razionale della responsabilità per<br />
le conseguenze derivanti dalle tecnologie scientifiche.<br />
Questo è ben illustrato dall’accoglienza ricevuta dal libro<br />
di Hans Jonas, che è egli stesso un neo-aristotelico di<br />
rilievo. Ma Jonas, richiamandosi al teleologismo metafisico<br />
del cosmo aristotelico, giunge a risultati diametralmente<br />
opposti a quelli neo-conservatori dei neo-Aristotelici.<br />
Jonas, infatti, muovendo da una prospettiva di<br />
conservazione di alcuni valori, volta cioè ad assicurare la<br />
CONFERENZA<br />
20<br />
sopravvivenza del genere umano e la salvaguardia della<br />
dignità umana, giunge a richiedere un’etica cosmopolita,<br />
di tipo alquanto nuovo, ovvero un’etica della responsabilità<br />
collettiva per le conseguenze delle attività collettive<br />
delle società industriali.<br />
Ora non penso che Jonas sia riuscito a fornire una<br />
giustificazione razionale per quest’etica di tipo nuovo<br />
partendo dalle sue premesse metafisiche. 22 Ma come<br />
minimo questa visione del problema può essere facilmente<br />
integrata in un programma delle esigenze cui<br />
un’etica ha da corrispondere oggi, da contrapporre al<br />
ripiegarsi neo-aristotelico sulle tradizioni locali. Con<br />
parole mie, lo sintetizzerei nel modo seguente.<br />
Noi non viviamo oggi in società quasi-autarchiche o<br />
poleis, come nell’epoca classica della civiltà greca (che,<br />
non dimentichiamolo, fu rovesciata da Alessandro mentre<br />
Aristotele era ancora in vita). Per la prima volta nella<br />
storia noi stiamo vivendo oggi in una civiltà planetaria<br />
che al meno per quanto attiene alcuni ambiti vitali della<br />
cultura - come ad esempio la scienza, la tecnologia e<br />
l’economia - ha subito un’unificazione tale da renderci<br />
membri di una reale comunità della comunicazione - o, se<br />
si preferisce, componenti dell’equipaggio di una stessa<br />
nave, per esempio riguardo ai problemi della crisi ecologica.<br />
Tra parentesi, desidero esprimere qui il mio netto<br />
dissenso dalle diagnosi di Jean-François Lyotard, il quale<br />
conclude che ai nostri giorni noi dovremmo abbandonare<br />
la stessa idea di una storia umana comune e persino l’idea<br />
di un ‘noi’ come di un possibile soggetto della solidarietà<br />
umana. 23 Suggerirei al contrario che le vaghe idee dei<br />
filosofi del XVIII secolo circa l’unità della storia umana<br />
si siano in un qualche senso realizzate oggi. Senza dubbio,<br />
non si sono realizzate nel senso della concezione<br />
marxista di un’unità della prassi e della teoria scientifica<br />
in forza della conoscenza e del controllo del ‘corso<br />
necessario della storia’, ma si sono realizzate nel senso di<br />
un’unità della cooperazione, eticamente sollecitata e in<br />
parte esistente, a riguardo della correzione, salvaguardia<br />
e rimodellamento o trasformazione delle condizioni attuali<br />
della civiltà del pianeta.<br />
Riassumendo: ciò di cui abbiamo bisogno oggi è in effetti<br />
un’etica universalmente valida per l’intera umanità; ma<br />
questo non significa che ci sia la necessità di un’etica che<br />
prescriva uno stile comune di vita buona per tutti gli<br />
individui o per tutte le differenti forme socio-culturali di<br />
vita. Al contrario, noi possiamo accettare il pluralismo di<br />
forme individuali di vita e persino difenderlo, purché vi<br />
sia la garanzia che un’etica universalmente valida di<br />
uguali diritti e uguale co-responsabilità per la soluzione<br />
dei problemi comuni dell’umanità sia rispettata in ogni<br />
singola forma di vita. (Ho l’impressione che un errore<br />
fatale del pensiero filosofico dei nostri giorni consista<br />
nell’assunzione di un antagonismo fondamentale o anche<br />
di una contraddizione tra il richiesto universalismo di<br />
un’etica post-kantiana e il pluralismo di un’etica quasi-<br />
Aristotelica della vita buona, o del souci de soi, per citare<br />
M. Foucault. In ogni caso l’intera storia dei diritti dell’uomo<br />
smentisce questa supposizione, come Foucault fu<br />
costretto ad ammettere negli ultimi anni della sua vita.) 24<br />
Procederò ora con l’ultima parte del mio lavoro. Fino ad<br />
ora mi sono limitato ad indicare l’esigenza di una macro-