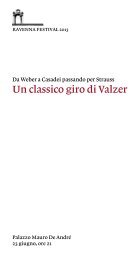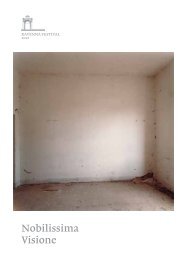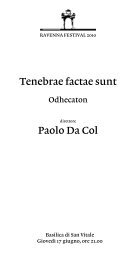Programma di sala - Ravenna Festival
Programma di sala - Ravenna Festival
Programma di sala - Ravenna Festival
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
74<br />
vennero proibite a prove iniziate,<br />
ufficialmente per motivi <strong>di</strong> censura,<br />
in realtà per le gelosie della prima<br />
donna, Letizia Cortesi, che non aveva<br />
accettato la presenza e l’importanza<br />
del ruolo affidato all’altra grande<br />
cantante, Isabella Fabbrica. L’opera<br />
rimase carta muta fino al gennaio<br />
del 1835, quando venne eseguita al<br />
Teatro Príncipe <strong>di</strong> Madrid per la prima<br />
ed ultima volta fino alla rinascita <strong>di</strong><br />
quest’anno.<br />
Quasi come omaggio verso il nuovo<br />
pubblico, nonché per la fascinazione<br />
nei confronti dell’universo musicale<br />
spagnolo appena conosciuto,<br />
Mercadante impiegò in quest’opera<br />
melo<strong>di</strong>e assorbite ascoltando<br />
attentamente tona<strong>di</strong>llas e sainetes,<br />
che coloravano ogni spettacolo<br />
teatrale madrileno, e usò danze<br />
caratteristiche dal ritmo marcato e<br />
dal forte sapore folklorico. Il nostro<br />
compositore seppe, con I due Figaro,<br />
“permearsi del carattere della musica<br />
spagnola” – come ebbe a <strong>di</strong>re un<br />
cronista coevo – trovando un’ottima<br />
fusione tra forme rossiniane e<br />
contenuti caratteristici.<br />
Tra tutti i personaggi dell’opera<br />
Mercadante personalizzò con<br />
musica propriamente spagnola la<br />
coppia Figaro-Susanna. Lei, nella sua<br />
cavatina (“Colle dame più brillanti”)<br />
si presenta in scena con un bolero<br />
in cui emerge la sua indole <strong>di</strong> donna<br />
astuta, capace <strong>di</strong> manovrare a suo<br />
vantaggio i piani altrui, uno “spirito<br />
folletto”, come <strong>di</strong>rà Figaro nel corso<br />
dell’opera. Il bolero trova le sue<br />
lontane origini in Spagna, alla fine<br />
del xviii secolo, nella contraddanza<br />
in tempo ternario, solitamente<br />
caratterizzato da uno spiccato ritmo<br />
puntato che gli conferisce un tocco<br />
malizioso e spigliato. Questa danza<br />
affascinerà parecchi compositori nel<br />
corso dell’Ottocento: Weber, Auber,<br />
Chopin, Berlioz, Ver<strong>di</strong>, useranno il suo<br />
ostinato ritmico per impreziosire con<br />
colori spagnoli melo<strong>di</strong>e dal carattere<br />
robusto ed energico. Da notare, in<br />
questa sede, che l’assimilazione<br />
della musica spagnola da parte <strong>di</strong><br />
Mercadante, in loco e <strong>di</strong> prima mano,<br />
fu anche favorita dall’amicizia con<br />
il napoletano Federico Moretti, ex<br />
militare italiano <strong>di</strong> stanza a Madrid,<br />
de<strong>di</strong>catosi completamente alla<br />
musica, sia come insegnante <strong>di</strong><br />
chitarra che come compositore, con<br />
all’attivo la pubblicazione <strong>di</strong> numerosi<br />
ballabili, soprattutto bolero e tirana.<br />
Un altro momento <strong>di</strong> musica<br />
propriamente spagnola ne I due<br />
Figaro si trova nel battibecco del<br />
Secondo atto tra Figaro e Susanna<br />
(“In quegl’occhi oh bricconcella”),<br />
nel quale il soprano, lamentandosi,<br />
canta “brutta cosa è l’esser moglie<br />
d’un marito seccatore” in un Andante<br />
in 6/8 in fa minore, dalla melo<strong>di</strong>a<br />
fortemente popolare. Si tratta <strong>di</strong><br />
un polo, un canto andaluso nato<br />
nel xviii secolo, in seguito co<strong>di</strong>ficato<br />
come uno dei moduli base del canto<br />
flamenco, nello specifico rientrante<br />
nella categoria <strong>di</strong> quelli dal metro <strong>di</strong><br />
soleá. Il brano richiamò l’attenzione<br />
del pubblico e della critica, che,<br />
dopo la prima esecuzione del 1835,<br />
notò il “bellissimo polo, cantato con<br />
particolare fascino”. Il polo, nel corso<br />
dell’Ottocento, conobbe anch’esso<br />
una ragguardevole <strong>di</strong>ffusione grazie<br />
soprattutto a Manuel García (il primo<br />
Almaviva nel Barbiere rossiniano,<br />
nonché padre <strong>di</strong> María Malibrán), che<br />
ne compose numerosi, tra i quali il<br />
celeberrimo Polo del contraban<strong>di</strong>sta<br />
che perfino Liszt e Schumann<br />
utilizzarono.