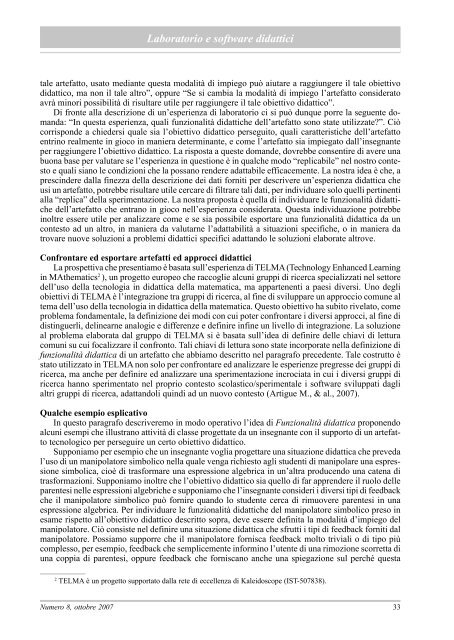Il laboratorio matematico-scientifico: suggerimenti ed esperienze
Il laboratorio matematico-scientifico: suggerimenti ed esperienze
Il laboratorio matematico-scientifico: suggerimenti ed esperienze
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Laboratorio e software didattici<br />
tale artefatto, usato m<strong>ed</strong>iante questa modalità di impiego può aiutare a raggiungere il tale obiettivo<br />
didattico, ma non il tale altro”, oppure “Se si cambia la modalità di impiego l’artefatto considerato<br />
avrà minori possibilità di risultare utile per raggiungere il tale obiettivo didattico”.<br />
Di fronte alla descrizione di un’esperienza di <strong>laboratorio</strong> ci si può dunque porre la seguente domanda:<br />
“In questa esperienza, quali funzionalità didattiche dell’artefatto sono state utilizzate?”. Ciò<br />
corrisponde a chi<strong>ed</strong>ersi quale sia l’obiettivo didattico perseguito, quali caratteristiche dell’artefatto<br />
entrino realmente in gioco in maniera determinante, e come l’artefatto sia impiegato dall’insegnante<br />
per raggiungere l’obiettivo didattico. La risposta a queste domande, dovrebbe consentire di avere una<br />
buona base per valutare se l’esperienza in questione è in qualche modo “replicabile” nel nostro contesto<br />
e quali siano le condizioni che la possano rendere adattabile efficacemente. La nostra idea è che, a<br />
prescindere dalla finezza della descrizione dei dati forniti per descrivere un’esperienza didattica che<br />
usi un artefatto, potrebbe risultare utile cercare di filtrare tali dati, per individuare solo quelli pertinenti<br />
alla “replica” della sperimentazione. La nostra proposta è quella di individuare le funzionalità didattiche<br />
dell’artefatto che entrano in gioco nell’esperienza considerata. Questa individuazione potrebbe<br />
inoltre essere utile per analizzare come e se sia possibile esportare una funzionalità didattica da un<br />
contesto ad un altro, in maniera da valutarne l’adattabilità a situazioni specifiche, o in maniera da<br />
trovare nuove soluzioni a problemi didattici specifici adattando le soluzioni elaborate altrove.<br />
Confrontare <strong>ed</strong> esportare artefatti <strong>ed</strong> approcci didattici<br />
La prospettiva che presentiamo è basata sull’esperienza di TELMA (Technology Enhanc<strong>ed</strong> Learning<br />
in MAthematics 2 ), un progetto europeo che raccoglie alcuni gruppi di ricerca specializzati nel settore<br />
dell’uso della tecnologia in didattica della matematica, ma appartenenti a paesi diversi. Uno degli<br />
obiettivi di TELMA è l’integrazione tra gruppi di ricerca, al fine di sviluppare un approccio comune al<br />
tema dell’uso della tecnologia in didattica della matematica. Questo obiettivo ha subito rivelato, come<br />
problema fondamentale, la definizione dei modi con cui poter confrontare i diversi approcci, al fine di<br />
distinguerli, delinearne analogie e differenze e definire infine un livello di integrazione. La soluzione<br />
al problema elaborata dal gruppo di TELMA si è basata sull’idea di definire delle chiavi di lettura<br />
comuni su cui focalizzare il confronto. Tali chiavi di lettura sono state incorporate nella definizione di<br />
funzionalità didattica di un artefatto che abbiamo descritto nel paragrafo prec<strong>ed</strong>ente. Tale costrutto è<br />
stato utilizzato in TELMA non solo per confrontare <strong>ed</strong> analizzare le <strong>esperienze</strong> pregresse dei gruppi di<br />
ricerca, ma anche per definire <strong>ed</strong> analizzare una sperimentazione incrociata in cui i diversi gruppi di<br />
ricerca hanno sperimentato nel proprio contesto scolastico/sperimentale i software sviluppati dagli<br />
altri gruppi di ricerca, adattandoli quindi ad un nuovo contesto (Artigue M., & al., 2007).<br />
Qualche esempio esplicativo<br />
In questo paragrafo descriveremo in modo operativo l’idea di Funzionalità didattica proponendo<br />
alcuni esempi che illustrano attività di classe progettate da un insegnante con il supporto di un artefatto<br />
tecnologico per perseguire un certo obiettivo didattico.<br />
Supponiamo per esempio che un insegnante voglia progettare una situazione didattica che prev<strong>ed</strong>a<br />
l’uso di un manipolatore simbolico nella quale venga richiesto agli studenti di manipolare una espressione<br />
simbolica, cioè di trasformare una espressione algebrica in un’altra producendo una catena di<br />
trasformazioni. Supponiamo inoltre che l’obiettivo didattico sia quello di far apprendere il ruolo delle<br />
parentesi nelle espressioni algebriche e supponiamo che l’insegnante consideri i diversi tipi di fe<strong>ed</strong>back<br />
che il manipolatore simbolico può fornire quando lo studente cerca di rimuovere parentesi in una<br />
espressione algebrica. Per individuare le funzionalità didattiche del manipolatore simbolico preso in<br />
esame rispetto all’obiettivo didattico descritto sopra, deve essere definita la modalità d’impiego del<br />
manipolatore. Ciò consiste nel definire una situazione didattica che sfrutti i tipi di fe<strong>ed</strong>back forniti dal<br />
manipolatore. Possiamo supporre che il manipolatore fornisca fe<strong>ed</strong>back molto triviali o di tipo più<br />
complesso, per esempio, fe<strong>ed</strong>back che semplicemente informino l’utente di una rimozione scorretta di<br />
una coppia di parentesi, oppure fe<strong>ed</strong>back che forniscano anche una spiegazione sul perché questa<br />
——————<br />
2 TELMA è un progetto supportato dalla rete di eccellenza di Kaleidoscope (IST-507838).<br />
Numero 8, ottobre 2007 33