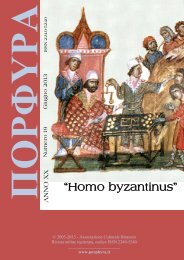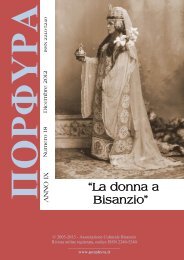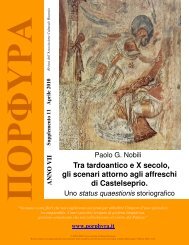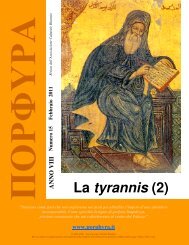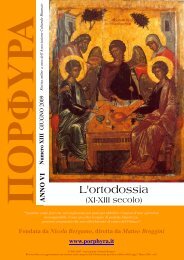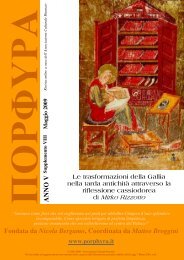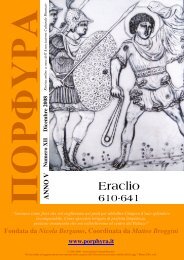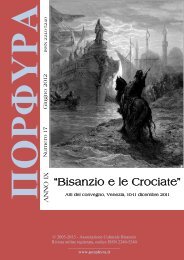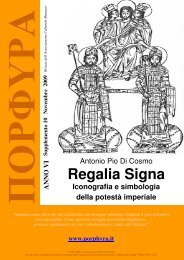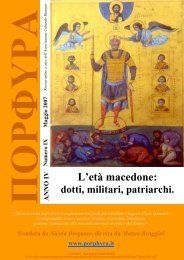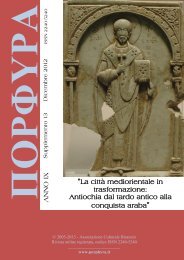Qui - Porphyra
Qui - Porphyra
Qui - Porphyra
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2.2. Orazioni.<br />
Costantino Manasse era un puro intellettuale di corte: 19 la<br />
sua fortuna presso i notabili veniva da lui gestita attraverso<br />
panegirici e orazioni celebrative o funebri dirette a un numero<br />
limitato di persone di alto rango: l'imperatore Manuele I<br />
Comneno, il diplomatico e militare Giovanni Contostefano,<br />
protettore del poeta, e la sua consorte, Teodora Contostefanina,<br />
la sebastocratorissa Irene, cognata dell'imperatore, e Alessio<br />
Ducas, governatore di Cipro (cfr. Hodoiporikon, II, 57-69). Ci<br />
sono pervenute cinque orazioni: una monodia funebre per la<br />
morte di Teodora Contostefanina, 20 il cui inizio verte<br />
sull'opposizione tra il matrimonio gioioso e la separazione<br />
definitiva per poi proseguire con immagini che sottolineano il<br />
vuoto lasciato dalla defunta e la commozione del poeta; la<br />
seconda è una lunga e incoraggiante consolatoria 21 al vedovo<br />
Giovanni Contostefano. 22 Segue una orazione funebre per il<br />
cugino del governatore di Cipro Alessio Ducas, Niceforo<br />
Comneno, lunga riflessione sulla nobiltà del personaggio. 23<br />
Intorno al 1170, 24 Costantino Manasse cade in disgrazia presso<br />
l'imperatore a causa di alcune calunnie. Allora si rivolge al<br />
logothetes tou dromou e poeta Michele Agiotheodorites 25 con<br />
un elogio in cui cita l'aneddoto di Apelle, 26 che divenne<br />
famoso dipingendo un impressionante ritratto della dea Atena.<br />
Così il poeta giustifica le lodi al potente funzionario attraverso<br />
la metafora dell'orto, che rappresenta la sua condizione<br />
economica e sociale e che viene fertilizzato dalla reputazione,<br />
la quale a sua volta dipende dall'opinione dei potenti: chiede<br />
quindi aiuto affinché la chiara fama del dignitario cui si rivolge<br />
venga in aiuto alla sua reputazione. 27 Comincia quindi<br />
un'autodifesa: il poeta è di libera nascita e educazione, si lega a<br />
persone miti e sagge e non ambigue e sfrontate, ha iniziato<br />
19<br />
«A professional parasite» lo definisce MAGUIRE, Court Intellectuals…, cit., p. 161; lo stesso Costantino Manasse,<br />
nell'elogio di Michele Agiotheodorites (v. infra, nota 7), ammette di essersi istruito «nelle aule imperiali e nelle case<br />
illustri».<br />
20<br />
Cfr. KURTZ, in “Vizantijskij Vremennik” 7 (1900), pp. 630-635. Per ulteriori dettagli sulle orazioni funebri di<br />
Costantino Manasse cfr. SIDERAS A., Die byzantinischen Grabreden. Prosographie, Diaterung, Uberlieferung 142<br />
Epitaphien und Monodien aus dem byzantinischen Jahrtausend, Wien 1994, pp. 191-195.<br />
21<br />
Cfr. KURTZ, in “Vizantijskij Vremennik” 7 (1900), pp. 636-645.<br />
22<br />
Giovanni Contostefano è chiamato ἀνὴρ Ἕλλην (p. 637) a sottolinearne il coraggio e la forza d'animo; il termine<br />
(“greco”), che fino al XI secolo era usato per indicare i pagani (ancora Michele Psello lo usa riferendosi ai Cinesi; cfr.<br />
PAGE G., Being Byzantine, Cambridge 2008, pp. 63-82), torna ad avere un significato non negativo, e piuttosto etnico,<br />
proprio a partire dal XII secolo, in età comnena. Anche il discorso per Michele Agiotheodorithes è definito «ἑλλήνιος<br />
perché περιττοὶ τὴν σύνεσιν Ἕλλήνες» («Eccelsi sono i Greci per sagacia»).<br />
23<br />
Cfr. KURTZ, in “Vizantijskij Vremennik” 17 (1910), pp. 302-322.<br />
24<br />
Cfr. MAGUIRE, Court Intellectuals…, cit., p. 162.<br />
25<br />
Cfr. HORNA K., in “Wiener Studien” 28 (1906), pp. 173-184; alle pp. 194-197 è pubblicato un poemetto mutilo di<br />
Agiotheodorites sul carnevale nell'ippodromo di Costantinopoli (1. febbraio, 1168).<br />
26<br />
Il celebre pittore del quadro allegorico che raffigurava la Calunnia personificata, al quale Costantino Manasse<br />
accenna.<br />
27<br />
Cfr. p. 175, 71: «Φήμη ψευδὴς καὶ διαβολὴ δύο κακὰ συγγενῆ· θυγάτηρ ἡ φήμη διαβολῆς» («La falsa<br />
fama e la calunnia sono parenti: la fama è figlia della calunnia»).<br />
5