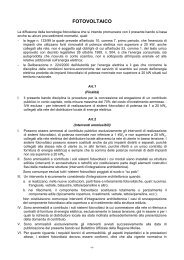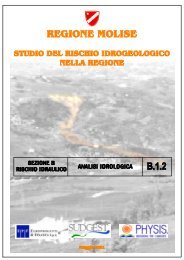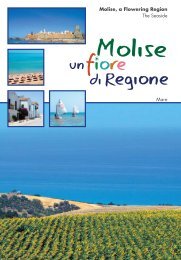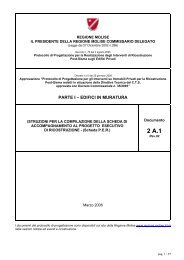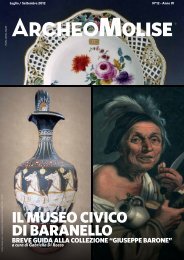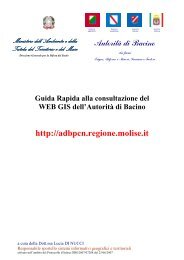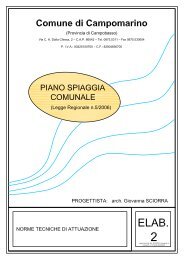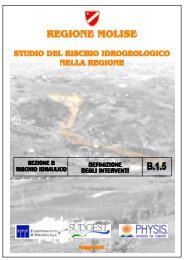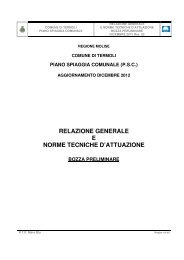PARTE I – EDIFICI IN MURATURA - Regione Molise
PARTE I – EDIFICI IN MURATURA - Regione Molise
PARTE I – EDIFICI IN MURATURA - Regione Molise
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Elementi che concorrono<br />
alla organizzazione delle<br />
strutture verticali<br />
1 Ammorsamento tra le<br />
pareti ortogonali<br />
2 Presenza di collegamenti<br />
di piano in acciaio o<br />
calcestruzzo armato<br />
Dettagli costruttivi che contribuiscono alla efficacia dei singoli elementi della organizzazione<br />
del sistema resistente<br />
− Risultano legate tra di loro mediante ammorsamenti agli innesti e agli incroci;<br />
− Risultano legate tra di loro, ma lungo le pareti sono presenti canne fumarie o cavità di altro<br />
genere che ne interrompono la continuità;<br />
− Non sono legate tra di loro.<br />
− Presenza di collegamenti di piano in profili di acciaio disposti lungo tutte le pareti portanti<br />
dell’edificio ancorati alle murature perimetrali e all’esterno;<br />
− Presenza di cordoli di piano in c.a. di larghezza pari a quella della muratura sottostante e di<br />
altezza minima pari a quella del solaio e comunque non inferiore a cm 15 adeguatamente<br />
armati;<br />
− Presenza di catene ancorate all’esterno;<br />
− Assenza di collegamenti in acciaio o cordoli di piano e presenza di catene soltanto in una<br />
direzione adeguatamente collegate alle pareti;<br />
− Assenza di cordoli e catene.<br />
3 Distanza tra i muri − Distanza inferiore a 7 m;<br />
− Distanza superiore a 7 m.<br />
4 Altezza massima di − Inferiore a 5 m;<br />
interpiano<br />
− Superiore a 5 m.<br />
5 Aperture nei muri maestri − Sono delimitare da zone di murature di dimensioni pari ad almeno la metà della larghezza<br />
del vano stesso. Inoltre due aperture sono separate da una zona di muratura di larghezza<br />
almeno pari a quella del vano più largo;<br />
− Rispettano i parametri ottimali oppure sono rinforzate da una intelaiatura formata<br />
dall’architrave, dai ritti e dal traverso superiore;<br />
− Non rispettano i parametri ottimali e non sono riquadrate da intelaiature.<br />
6 La dimensione dei maschi − di larghezza pari ad almeno 1 m;<br />
d’angolo;<br />
− di larghezza inferiore a 1 m ma comunque maggiore del solo spessore del muro ortogonale;<br />
− coincidenti con il solo spessore del muro ortogonale.<br />
7 La consistenza o la<br />
− presenza di arcitravi efficaci;<br />
presenza degli architravi; − assenza di architravi.<br />
8 presenza di archi e volte. − Nell’edificio non sono presenti archi e volte staticamente significativi;<br />
− Archi e volte scarichi;<br />
− Nell’edificio sono presenti archi e volte muniti di chiavi, tiranti atti ad assorbire le spinte<br />
loro imposte;<br />
− Archi e volte impostati su murature aventi spessori sufficienti ad accogliere le spinte senza<br />
che vengano sforzi di trazione;<br />
− Archi e volte che non hanno la spinta eliminata e che non si impostano su pareti aventi<br />
sufficienti spessori.<br />
Tab n. 3 <strong>–</strong> Organizzazione del sistema resistente e dettagli costruttivi<br />
In alcuni casi è utile poter disporre di uno strumento semplice di analisi che consenta di effettuare una<br />
classificazione sismica attraverso un punteggio rappresentativo delle capacità antisismiche dell’edificio in<br />
modo da guidare efficacemente il processo di progettazione attraverso la valutazione della vulnerabilità<br />
sismica dello stato di fatto e dello stato post-intervento.<br />
Pertanto l’intervento di miglioramento sismico dovrà corrispondere ad un aumento della resistenza sismica<br />
dell’edificio in termini di punteggio rapportabile ai valori della PGA minima di collasso della struttura.<br />
Se il valore della vulnerabilità conseguita non è soddisfacente allora occorre apportare modifiche alle<br />
soluzioni progettuali adottate finchè la vulnerabilità risulti accettabile anche attraverso un confronto diretto<br />
con i valori di PGA indicati dalla normativa.<br />
Attraverso questa metodologia è possibile valutare il livello di miglioramento conseguito dall’edificio e la<br />
procedura diviene una guida per le scelte progettuali.<br />
In tale contesto è possibile calcolare localmente la vulnerabilità dei singoli meccanismi di collasso e con il<br />
metodo GNDT di II livello quella dell’intero edificio.<br />
Attraverso una analisi accurata sono stati individuati tutti gli elementi costruttivi che concorrono a<br />
determinare l’efficacia dei parametri della scheda correlati ai possibili meccanismi di collasso attivabili<br />
nell’edificio.<br />
L’analisi dei meccanismi di collasso viene condotta mediante la individuazione dei presidi sismici e degli<br />
indicatori di vulnerabilità che conduce alla scelta degli interventi di miglioramento sismico intesi come<br />
presidi o mitigatori della stessa vulnerabilità<br />
Ad ogni intervento è associato un costo e una potenziale riduzione della vulnerabilità.<br />
Per valutare l’efficacia dei singoli meccanismi è possibile utilizzare metodi semplificati basati sull’analisi<br />
dell’equilibrio limite dei corpi rigidi.<br />
III - 7