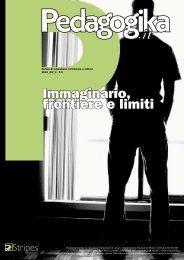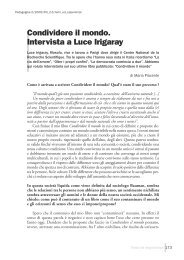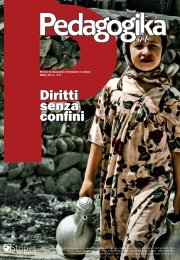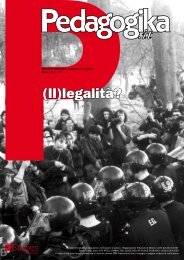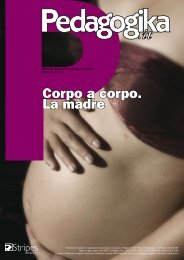...erranze ...migrazioni - Pedagogika
...erranze ...migrazioni - Pedagogika
...erranze ...migrazioni - Pedagogika
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Pedagogika</strong>.it/2010/XIV_1/...<strong>erranze</strong>...<strong>migrazioni</strong>/l’intercultura_e_l’idea_di_confine<br />
14<br />
tura per la cultura europea, ma si chiuse senza rinnovarne affatto la mentalità, connessa<br />
all’esclusione e al dominio, anche i dibattiti che accompagnarono l’avventura furono di<br />
alto valore culturale, in modo tale che ancora oggi si offrono come esemplari. E esemplari<br />
anche e proprio per dirimere la quaestio dei confini tra le culture, in una stessa societas e<br />
quindi capaci di illuminare anche i problemi culturali del nostro tempo. Lo ricordava<br />
Savignano di recente, dichiarando tali posizioni ancora esemplari, nell’oggi.<br />
Già con Colombo, come ci ha sottolineato Todorov, gli indigeni amerindi, così<br />
radicalmente altri rispetto all’Homo occidentalis o europeus, vengono degradati a<br />
barbari (“nudi e non cristiani”) e quindi da sottomettere. Con Cortés fu la logica<br />
dell’oro a rendere il dominio più cinico, più costrittivo, più serrato, producendo<br />
un genocidio ineguagliato (si è parlato di centocinquanta milioni di uomini<br />
e donne indios uccisi!). Imponendo così un’idea imperialistica del dominio sui<br />
popoli altri che ha fatto scuola a tutta la colonizzazione moderna. Ma quell’evento<br />
esemplare (la scoperta e poi la conquista) attivò anche riflessioni, denunce, prese<br />
di posizioni diverse e aprì un dibattito. A Valladolid nel 1550 tre posizioni si confrontarono:<br />
quella imperialistica, quella giuridica, quella pedagogica. Se la prima<br />
– con Sepùlveda – sottolineava la condizione barbara degli indigeni, da ridurre in<br />
schiavitù e da emancipare attraverso la conversione coatta e la pratica occidentale<br />
del lavoro, la seconda – con De Vitoria – guardava a un riconoscimento di diritti<br />
umani comuni tra occidentali e indigeni, e quindi richiamava il loro rispetto e la<br />
partecipazione degli indigeni, ma tenendo ferma la guida degli europei, interpreti<br />
naturaliter dello jus gentium. La terza, invece, con Las Casas, si inoltrava sul terreno<br />
di una pedagogia del dialogo e chiamava in causa la convinzione e l’uso della nonviolenza.<br />
Postulava nell’uomo la ragione e indica nella persuasione la stessa via<br />
per la conversione e esige un’opera educativa diffusa e capillare, l’unica capace di<br />
“attrarre, incamminare, muovere la creatura razionale al bene, alla verità, alla virtù,<br />
alla giustizia”, sempre in modo “dolce, blando, delicato e soave”, in modo che si<br />
creda “ma volendolo”, per interiore adesione. Qui va sottolineato il principio di razionalità<br />
reso universale (senza gerarchizzazioni tra etnie, fedi, etc.) poi il principio<br />
pedagogico del formare (e non del conformare) e la prassi “dolce e soave” che parla<br />
ai cuori e alle menti e lì opera la metamorfosi. La via di rispetto e di aiuto di Las<br />
Casas non ebbe seguito, fu il “realismo cinico” ad aver la meglio, come sappiamo.<br />
Purtuttavia la disputa del 1550 disegna un quadro esemplare e esemplare ancora<br />
oggi e fa ben risaltare la ricchezza e attualità della via pedagogica, e anche la sua difficoltà,<br />
che vale ancora per l’oggi. Quel lavoro in interiore homine ha bisogno di formatori,<br />
di esperti di qualità, capaci di stare tra i confini e nelle culture per attivarne il dialogo,<br />
senza preordinarne le uscite, ma tenendo fermo che comunicare e dialogare è già un<br />
valore, un traguardo, poiché implica già anche un’etica e produce un ethos. Bartolomeo<br />
de Las Casas ci sta davanti ancora come un maestro, anche se noi oggi dobbiamo rileggerlo<br />
in modo laico: pensando a tutto il quadro dei valori e non solo a quello religioso.<br />
Ma su questo piano Las Casas ci indica a quale ethos dobbiamo ancora guardare. Ethos<br />
di reciprocità e di costruzione di frontiere comuni sempre più avanzate, dentro un mutamento<br />
squisitamente antropologico basato proprio sulla pratica del dialogo.