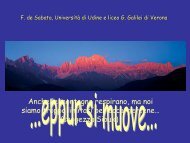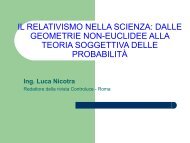Comunicare fisica.07 - proceedings alta risoluzione
Comunicare fisica.07 - proceedings alta risoluzione
Comunicare fisica.07 - proceedings alta risoluzione
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I PERCHÉ E I COME DELLA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA DALLE LEZIONI<br />
PUBBLICHE DI FARADAY<br />
ALLA IMMERSIVITÀ DEI SCIENCE CENTRE<br />
>Vincenzo Lipardi (a) (b) , Luigi Amodio (c)<br />
(a) Presidente ECSITE European Network of Science Center & Museum;<br />
(b) Membro del CDA della Fondazione IDIS-Città della Scienza<br />
(c) Direttore della Fondazione IDIS-Città della Scienza<br />
Cari amici, inizio questa mia conversazione ricordando che nel mondo della scienza, la divulgazione è stata<br />
spesso intesa più come tecnica di “semplificazione e popolarizzazione della complessità della ricerca scientifica”<br />
che come strumento per fornire delle “chiavi” utili a comprendere “i segreti della natura”; come mezzo capace<br />
di costruire tecniche e modelli di coinvolgimento sociale ed integrazione culturale tra la cultura umanistica e<br />
quella più propriamente scientifica; insomma a perseguire il fine di democratizzare la società.<br />
Nel corso dei secoli, del resto, è cambiato sia il perché, che il come, della divulgazione, ma io preferisco usare il<br />
termine “comunicazione”, scientifica.<br />
Un primo perché, ovviamente, risiede nella natura intersoggettiva della scienza come attività umana: la scienza<br />
nel suo farsi – osservazioni, esperimenti, formalizzazioni, ecc. – non ha senso se non viene comunicata ad altri,<br />
quindi verificata, discussa, validata o meno, ecc.<br />
Questo aspetto della comunicazione scientifica, la cosiddetta Comunicazione intrascientifica, non è<br />
sostanzialmente mutato nonostante il cambiamento degli strumenti, alludo qui all’introduzione di Internet,<br />
abbia avuto un grande impatto che è intervenuto non solo sui tempi e gli strumenti ma anche, come vedremo più<br />
avanti, sugli attori coinvolti<br />
Per quanto riguarda invece la comunicazione pubblica della scienza, al di fuori cioè della comunità degli<br />
scienziati, le cose sono mutate radicalmente.<br />
Ma prima di giungere all’oggi e forse utile dare un rapido sguardo al passato.<br />
Credo sia giusto partire ricordando che una delle opere che più hanno rivoluzionato la cultura (non solo<br />
scientifica) italiana è, al tempo stesso, un esempio mirabile di comunicazione scientifica, tanto che la radicalità<br />
del contenuto si collega fortemente a quella dell’espressione. Sto parlando del Dialogo sui massimi sistemi di<br />
Galileo, in cui la scelta della forma dialogica, che è parte della tradizione, fa da strumento d’introduzione di<br />
teorie innovative ed ardite.<br />
La divulgazione nel 1500 vede affermarsi una modalità di comunicazione ripresa poi ai giorni d’oggi, e cioè le<br />
conferenze spettacolo. Un nome per tutti è quello di Bernard Palissy, un vasaio francese famoso tra l’altro per<br />
le sue letture pubbliche di storia naturale. Voglio ricordare che, per ascoltare una sua lezione, si imponeva il<br />
pagamento di un biglietto che costava una corona, una cifra notevole in quei giorni.<br />
Ma è nel 1600 che la divulgazione scientifica si afferma, grazie al proliferare degli esperimenti nei cabinet de<br />
curiosité e nei salotti.<br />
Nell’800, però, si afferma la divulgazione scientifica così come la intendiamo oggi. Tra gli spiriti del tempo è<br />
emblematico Michael Faraday, che con le sue conferenze del venerdì o in quelle di Natale, ci mostra l’esempio<br />
forse più importante della divulgazione scientifica “pre-avvento” dei moderni media. Le sue conferenze alla<br />
Royal Institution of Great Britain, tra cui la famosa “Storia chimica di una candela”, divenne un cult per le letture<br />
di Natale dei giovani inglesi. E non è un caso che, dal 1825, le Royal Institution Christmas Lectures, da lui<br />
iniziate, continuino sino ai nostri giorni.<br />
Faraday colse anzitempo l’importanza dell’educazione e fu molto attento al rapporto con il sistema scolastico<br />
del suo paese. Nel 1862 tenne un famoso incontro con la Commissione delle Scuole Pubbliche per esporre le<br />
sue idee innovative sul sistema educativo della Gran Bretagna. Ed infine, da scienziato moderno, si rifiutò di<br />
partecipare alla produzione di armi chimiche nella Guerra di Crimea, per ragioni etiche.<br />
Ciò che accomuna queste esperienze è sicuramente la tensione positivista e illuministica di accrescere la<br />
cultura scientifica del “volgo”; così come l’idea utilitarista, che maturò nell’800, per cui l’accrescimento delle<br />
competenze scientifiche potesse qualificare la classe operaia.<br />
Per quanto riguarda invece i musei – la cui natura è soprattutto, passata l’epoca delle “camere delle meraviglie”,<br />
di supporto alla ricerca scientifica – è interessante ricordare qui una descrizione che Leibniz fa del suo museo<br />
scientifico ideale, praticamente un moderno science centre: “…lanterne magiche, voli, meteore artificiali e ogni<br />
sorta di meraviglie ottiche; una rappresentazione dei cieli, delle stelle e delle comete, fuochi d’artificio, fontane<br />
d’acqua, barche dalla forma strana, automi bevitori d’acqua, dimostrazioni sul telescopio, macchine calcolatrici,<br />
esposizioni della camera oscura, fino all’esperimento consistente nell’infrangere un vetro gridando e nel<br />
29 COMUNICARE FISICA.07<br />
TRIESTE 1/6 OTTOBRE 2007