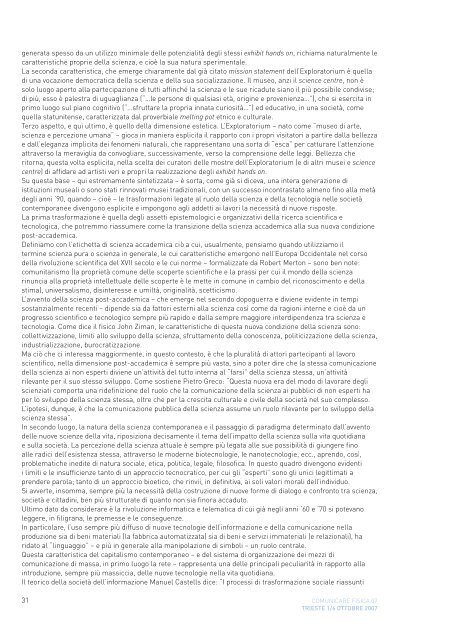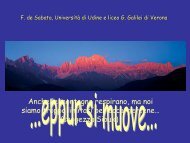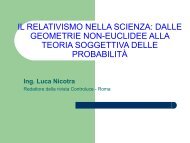Comunicare fisica.07 - proceedings alta risoluzione
Comunicare fisica.07 - proceedings alta risoluzione
Comunicare fisica.07 - proceedings alta risoluzione
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
generata spesso da un utilizzo minimale delle potenzialità degli stessi exhibit hands on, richiama naturalmente le<br />
caratteristiche proprie della scienza, e cioè la sua natura sperimentale.<br />
La seconda caratteristica, che emerge chiaramente dal già citato mission statement dell’Exploratorium è quella<br />
di una vocazione democratica della scienza e della sua socializzazione. Il museo, anzi il science centre, non è<br />
solo luogo aperto alla partecipazione di tutti affinché la scienza e le sue ricadute siano il più possibile condivise;<br />
di più, esso è palestra di uguaglianza (“…le persone di qualsiasi età, origine e provenienza…”), che si esercita in<br />
primo luogo sul piano cognitivo (“…sfruttare la propria innata curiosità…”) ed educativo, in una società, come<br />
quella statunitense, caratterizzata dal proverbiale melting pot etnico e culturale.<br />
Terzo aspetto, e qui ultimo, è quello della dimensione estetica. L’Exploratorium – nato come “museo di arte,<br />
scienza e percezione umana” – gioca in maniera esplicita il rapporto con i propri visitatori a partire dalla bellezza<br />
e dall’eleganza implicita dei fenomeni naturali, che rappresentano una sorta di “esca” per catturare l’attenzione<br />
attraverso la meraviglia da convogliare, successivamente, verso la comprensione delle leggi. Bellezza che<br />
ritorna, questa volta esplicita, nella scelta dei curatori delle mostre dell’Exploratorium (e di altri musei e science<br />
centre) di affidare ad artisti veri e propri la realizzazione degli exhibit hands on.<br />
Su questa base – qui estremamente sintetizzata – è sorta, come già si diceva, una intera generazione di<br />
istituzioni museali o sono stati rinnovati musei tradizionali, con un successo incontrastato almeno fino alla metà<br />
degli anni ’90, quando – cioè – le trasformazioni legate al ruolo della scienza e della tecnologia nelle società<br />
contemporanee divengono esplicite e impongono agli addetti ai lavori la necessità di nuove risposte.<br />
La prima trasformazione è quella degli assetti epistemologici e organizzativi della ricerca scientifica e<br />
tecnologica, che potremmo riassumere come la transizione della scienza accademica alla sua nuova condizione<br />
post-accademica.<br />
Definiamo con l’etichetta di scienza accademica ciò a cui, usualmente, pensiamo quando utilizziamo il<br />
termine scienza pura o scienza in generale, le cui caratteristiche emergono nell’Europa Occidentale nel corso<br />
della rivoluzione scientifica del XVII secolo e le cui norme – formalizzate da Robert Merton – sono ben note:<br />
comunitarismo (la proprietà comune delle scoperte scientifiche e la prassi per cui il mondo della scienza<br />
rinuncia alla proprietà intellettuale delle scoperte è le mette in comune in cambio del riconoscimento e della<br />
stima), universalismo, disinteresse e umiltà, originalità, scetticismo.<br />
L’avvento della scienza post-accademica – che emerge nel secondo dopoguerra e diviene evidente in tempi<br />
sostanzialmente recenti – dipende sia da fattori esterni alla scienza così come da ragioni interne e cioè da un<br />
progresso scientifico e tecnologico sempre più rapido e dalla sempre maggiore interdipendenza tra scienza e<br />
tecnologia. Come dice il fisico John Ziman, le caratteristiche di questa nuova condizione della scienza sono:<br />
collettivizzazione, limiti allo sviluppo della scienza, sfruttamento della conoscenza, politicizzazione della scienza,<br />
industrializzazione, burocratizzazione.<br />
Ma ciò che ci interessa maggiormente, in questo contesto, è che la pluralità di attori partecipanti al lavoro<br />
scientifico, nella dimensione post-accademica è sempre più vasta, sino a poter dire che la stessa comunicazione<br />
della scienza ai non esperti diviene un’attività del tutto interna al “farsi” della scienza stessa, un’attività<br />
rilevante per il suo stesso sviluppo. Come sostiene Pietro Greco: “Questa nuova era del modo di lavorare degli<br />
scienziati comporta una ridefinizione del ruolo che la comunicazione della scienza ai pubblici di non esperti ha<br />
per lo sviluppo della scienza stessa, oltre che per la crescita culturale e civile della società nel suo complesso.<br />
L’ipotesi, dunque, è che la comunicazione pubblica della scienza assume un ruolo rilevante per lo sviluppo della<br />
scienza stessa”.<br />
In secondo luogo, la natura della scienza contemporanea e il passaggio di paradigma determinato dall’avvento<br />
delle nuove scienze della vita, riposiziona decisamente il tema dell’impatto della scienza sulla vita quotidiana<br />
e sulla società. La percezione della scienza attuale è sempre più legata alle sue possibilità di giungere fino<br />
alle radici dell’esistenza stessa, attraverso le moderne biotecnologie, le nanotecnologie, ecc., aprendo, così,<br />
problematiche inedite di natura sociale, etica, politica, legale, filosofica. In questo quadro divengono evidenti<br />
i limiti e le insufficienze tanto di un approccio tecnocratico, per cui gli “esperti” sono gli unici legittimati a<br />
prendere parola; tanto di un approccio bioetico, che rinvii, in definitiva, ai soli valori morali dell’individuo.<br />
Si avverte, insomma, sempre più la necessità della costruzione di nuove forme di dialogo e confronto tra scienza,<br />
società e cittadini, ben più strutturate di quanto non sia finora accaduto.<br />
Ultimo dato da considerare è la rivoluzione informatica e telematica di cui già negli anni ’60 e ’70 si potevano<br />
leggere, in filigrana, le premesse e le conseguenze.<br />
In particolare, l’uso sempre più diffuso di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella<br />
produzione sia di beni materiali (la fabbrica automatizzata) sia di beni e servizi immateriali (e relazionali), ha<br />
ridato al “linguaggio” – e più in generale alla manipolazione di simboli – un ruolo centrale.<br />
Questa caratteristica del capitalismo contemporaneo – e del sistema di organizzazione dei mezzi di<br />
comunicazione di massa, in primo luogo la rete – rappresenta una delle principali peculiarità in rapporto alla<br />
introduzione, sempre più massiccia, delle nuove tecnologie nella vita quotidiana.<br />
Il teorico della società dell’informazione Manuel Castells dice: “I processi di trasformazione sociale riassunti<br />
31 COMUNICARE FISICA.07<br />
TRIESTE 1/6 OTTOBRE 2007