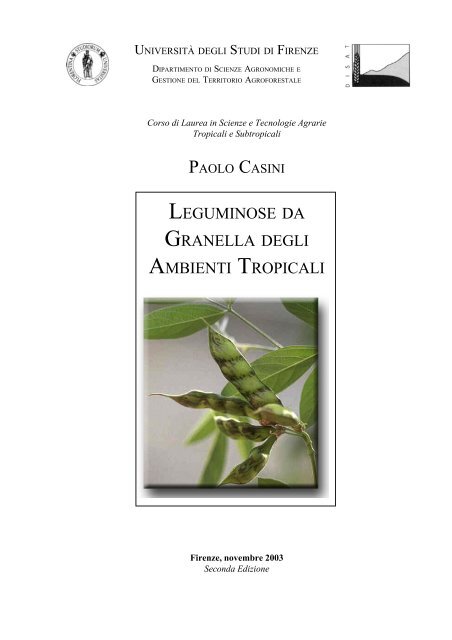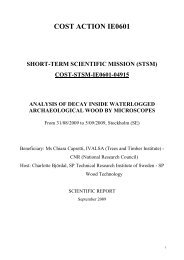Formato PDF (3077 Kb) - Facoltà di Agraria - Università degli Studi ...
Formato PDF (3077 Kb) - Facoltà di Agraria - Università degli Studi ...
Formato PDF (3077 Kb) - Facoltà di Agraria - Università degli Studi ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE<br />
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRONOMICHE E<br />
GESTIONE DEL TERRITORIO AGROFORESTALE<br />
Corso <strong>di</strong> Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie<br />
Tropicali e Subtropicali<br />
PAOLO CASINI<br />
LEGUMINOSE DA<br />
GRANELLA DEGLI<br />
AMBIENTI TROPICALI<br />
Firenze, novembre 2003<br />
Seconda E<strong>di</strong>zione<br />
1
INDICE<br />
1. PREMESSA 5<br />
2. IMPORTANZA NELL’ALIMENTAZIONE UMANA 6<br />
3 RICHIAMI SULLA FISSAZIONE SIMBIONTICA DELL’AZOTO 7<br />
4. LIMITI DELLA COLTIVAZIONE 14<br />
5. DISTRIBUZIONE 14<br />
6. RICHIAMI DI BOTANICA E TASSONOMIA 15<br />
7. CLASSIFICAZIONE 18<br />
8. UTILIZZAZIONI 20<br />
9. LA COLTIVAZIONE DI ALCUNE SPECIE RAPPRESENTATIVE 25<br />
Pisello del Tropico 27<br />
Voandzeia 35<br />
Fagiolo Alato 41<br />
Fagiolo d’Egitto 47<br />
Fagiolo <strong>di</strong> Lima 53<br />
Fagiolo Mungo 59<br />
Fagiolo dall’Occhio 65<br />
TABELLA 1 - COMPOSIZIONE MEDIA DELLA GRANELLA E<br />
DI ALCUNE PARTI DI PIANTA 72<br />
TABELLA 2 - SPETTRO AMINOACIDICO DEI SEMI 73<br />
3
1. PREMESSA<br />
C on il termine leguminose da granella viene in<strong>di</strong>cato un gruppo <strong>di</strong> specie in grado <strong>di</strong> fornire<br />
granella altamente proteica utilizzabile per l’alimentazione umana.<br />
Sono circa 24 le specie maggiormente coltivate nei tropici in estensioni variabili secondo<br />
la loro utilizzazione ed i sistemi agricoli nei quali sono inserite. La maggior parte delle leguminose<br />
da granella sono in grado <strong>di</strong> produrre in una grande varietà <strong>di</strong> climi ed in terreni poveri senza<br />
ricorrere a concimazioni azotate; caratteristica, che risulta particolarmente utile nell’agricoltura<br />
<strong>di</strong> sussistenza in molte aree depresse.<br />
I semi delle leguminose hanno un contenuto <strong>di</strong> proteine piuttosto elevato (dal 20 al 40%),<br />
superiore a quello dei cereali (8-10%) e delle piante da tubero o da ra<strong>di</strong>ce (2-9%). Le proteine<br />
delle leguminose sono ricche in lisina tanto che possono integrare e completare adeguatamente<br />
quelle dei cereali. In alcune specie i semi contengono, oltre alle proteine, anche grassi in quantità<br />
tali (arachide 45-48%, soia 18-20%) da rendere conveniente la loro estrazione industriale<br />
per essere utilizzati come olii alimentari o come materia prima per l’industria.<br />
L’accrescimento rapido <strong>di</strong> alcune specie annuali come il fagiolo dall’occhio (Vigna<br />
unguiculata), l’elevata produttività della soia (Glycine max) e dell’arachide (Arachis hypogaea),<br />
le specie caratterizzate da lunghi perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> fruttificazione (es.: Fagiolo <strong>di</strong> Lima - Phaseolus<br />
lunatus) e quelle semi-legnose perenni (es.: Pisello del tropico - Cajanus cajan) conferiscono<br />
alle leguminose la caratteristica <strong>di</strong> specie “plastiche” ed insostituibili in tutti i sistemi agricoli<br />
tropicali. Le leguminose presentano molti vantaggi rispetto ad altre piante alimentari e risiedono<br />
soprattutto nella loro semplicità <strong>di</strong> preparazione e nella varietà <strong>di</strong> parti eduli. Alcune specie,<br />
come Sphenocarpus stenocarpa (Yam bean), oltre ai semi producono ra<strong>di</strong>ci ingrossate che possono<br />
essere utilizzate per l’alimentazione umana. La stessa caratteristica si riscontra nel fagiolo<br />
alato (Psophocarpus tetragonolobus) del quale, oltre ai semi ver<strong>di</strong> e secchi, sono utilizzabili i<br />
germinelli, le giovani foglie, i baccelli ver<strong>di</strong> e le ra<strong>di</strong>ci.<br />
5
6<br />
L’eccellente valore nutrizionale della maggior parte delle leguminose in termini <strong>di</strong> proteine,<br />
calorie, vitamine e minerali le caratterizza come preziose fonti alimentari complementari<br />
delle <strong>di</strong>ete nei tropici che comprendono frutta, ra<strong>di</strong>ci, cereali, ortaggi e poche proteine animali.<br />
Tra gli alimenti proteici non lavorati o concentrati, i semi delle leguminose possono essere<br />
ottenuti a bassi costi e risultano facilmente trasportabili ed immagazinabili per il consumo sia in<br />
ambito rurale che urbano.<br />
Secondo le statistiche FAO nel mondo si coltivano ogni anno circa 68,4 Mha <strong>di</strong> leguminose<br />
da granella con una produzione stimata in 55,2 Mt. I Paesi maggiori produttori sono: Cina,<br />
In<strong>di</strong>a, Sri Lanka e Pakistan in Asia; Tanzania, Burun<strong>di</strong>, Zaire, Etiopia e Algeria in Africa; Brasile<br />
e Messico in America.<br />
Nell’ultimo mezzo secolo la produzione delle leguminose da granella è aumentata a un<br />
ritmo inferiore a quello dei cereali; per frumento e riso, ad esempio, c’è stato un raddoppiamento,<br />
mentre le leguminose sono aumentate solo del 25%. Da evidenziare, inoltre, che mentre<br />
l’incremento <strong>di</strong> produzione dei cereali è stato conseguito prevalentemente con aumenti delle<br />
rese, quello delle leguminose da granella è stato ottenuto aumentando le superfici.<br />
2. IMPORTANZA NELL’ALIMENTAZIONE UMANA<br />
Le popolazioni <strong>di</strong> molti Paesi in via <strong>di</strong> sviluppo (PVS) si basano la loro alimentazione su<br />
prodotti ricchi in amido, come cereali e tuberi, ma carenti per le proteine sia sotto l’aspetto<br />
quantitativo che qualitativo. Ottenere un miglioramento della loro <strong>di</strong>eta esclusivamente con<br />
prodotti zootecnici (carne, formaggio, latte) non è pensabile perché troppo costosi in termini <strong>di</strong><br />
energia spesa per produrli. Considerando le modeste con<strong>di</strong>zioni socio-economiche in cui solitamente<br />
versano queste popolazioni e il carico demografico sempre superiore alle risorse del territorio,<br />
un notevole contributo alla soluzione del problema potrebbe essere trovato in un maggior<br />
consumo <strong>di</strong> legumi espandendone la coltivazione e migliorandone la tecnica colturale.<br />
Il fabbisogno proteico giornaliero dell’uomo è <strong>di</strong> circa 55 g d -1 . Gli alimenti <strong>di</strong> origine<br />
vegetale contribuiscono per circa il 70% alle necessità proteiche mon<strong>di</strong>ali, ma in molti PVS<br />
questa proporzione può essere maggiore fino ad arrivare anche al 90%. I cereali costituiscono<br />
circa il 68% <strong>di</strong> tutte le proteine <strong>di</strong> origine vegetale consumate <strong>di</strong>rettamente; le leguminose da<br />
granella il 18,5% ed altre fonti (ra<strong>di</strong>ci, tuberi, noci, frutta ed ortaggi) il 13,5%. La produzione <strong>di</strong><br />
proteine <strong>di</strong> origine vegetale ammonta a circa 153 Mt equivalenti, su base mon<strong>di</strong>ale, a circa 43.0<br />
kg pro capite anno -1 ma, per i PVS tale quota scende a 24-26 kg pro capite anno -1 .<br />
La qualità della nutrizione umana è spesso collegata al clima: ad esempio, può decrescere<br />
proporzionalmente con la <strong>di</strong>minuzione dell’altitu<strong>di</strong>ne ed aumentare con la me<strong>di</strong>a annuale delle<br />
precipitazioni. In Nigeria la <strong>di</strong>sponibilità sia <strong>di</strong> proteine che <strong>di</strong> energia calorica, <strong>di</strong>minuisce dal<br />
Nord più arido all’Ovest sub-umido ed al Sud-est umido. Alcuni stu<strong>di</strong> hanno messo in evidenza<br />
che sia l’energia (2719 cal pro capite d -1 ) che le proteine (80 g pro capite d -1 ) sono adeguate<br />
nella regione semi-arida del nord, ma risultano al <strong>di</strong>sotto dei livelli nutrizionali minimi nell’ovest<br />
(1909 cal e 40 g <strong>di</strong> proteine pro capite d -1 ) e nel sud-est (1774 cal e 33 g pro capite <strong>di</strong><br />
proteine per d). Mentre i cereali rappresentano il 64% dell’apporto calorico nel nord, le ra<strong>di</strong>ci ed<br />
i tuberi costituiscono rispettivamente il 53% ed il 68% delle risorse energetiche nell’ovest e<br />
nell’est.
Gli effetti della nutrizione non bilanciata nelle aree dove le risorse energetiche potrebbero<br />
essere adeguate, possono essere drammatici. In alcune aree <strong>di</strong> altitu<strong>di</strong>ne interme<strong>di</strong>a a clima<br />
umido o sub-umido come l’Uganda (1000-1200 m slm) dove i carboidrati sono più che adeguati<br />
(3000-4000 cal pro capite d -1 ), ma non le proteine, si può registrare una mortalità infantile fino<br />
al 5% soprattutto nei bambini in <strong>di</strong>vezzamento. In generale sembra che le aree semi-aride e le<br />
altitu<strong>di</strong>ni maggiori con bassa pressione <strong>di</strong> popolazione, dove cereali e legumi sono più facilmente<br />
coltivati ed immagazzinati, siano migliori per una nutrizione bilanciata. Tuttavia, queste statistiche<br />
spesso non tengono conto delle variabilità climatiche e delle carestie cicliche delle regioni<br />
sub-umide e semi-aride. In questo contesto, il settore delle attività agricole più vulnerabile<br />
è quello dei noma<strong>di</strong> poiché, la loro sopravvivenza, <strong>di</strong>pende principalmente dagli animali domestici<br />
allevati nelle regioni più aride climaticamente incostanti.<br />
3. RICHIAMI SULLA FISSAZIONE SIMBIONTICA DELL’AZOTO<br />
L’azoto (N) è un elemento essenziale per la vita sia vegetale che animale. E’ quasi inerte e<br />
quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile da legare chimicamente con altri elementi. I composti azotati sono continuamente<br />
prodotti o demoliti come risultato <strong>di</strong> vari processi biologici e chimici; la figura 1 ne evidenzia<br />
alcuni. L’N elementare o gassoso (N 2 ) può essere fissato o combinato con altri elementi soprattutto<br />
dai batteri (Rhizobium sp. e Frankia sp.) e dai cianobatteri in simbiosi con l’Azolla, una<br />
piccola felce. Anche i prodotti secondari della combustione comportano la formazione naturale<br />
dell’N. L’N atmosferico può essere incluso nelle proteine delle piante che possono in seguito<br />
essere utilizzate dagli animali che le convertono a loro volta in proteine o carne. Parte dell’N<br />
trasformato dagli animali torna nel terreno e quin<strong>di</strong>, alle piante sottoforma <strong>di</strong> escrementi. L’N<br />
<strong>di</strong>stribuito al terreno con i fertilizzanti può essere utilizzato dalle colture o perduto con la<br />
percolazione profonda o con lo scorrimento superficiale. Infine, alcuni batteri possono riconvertire<br />
l’N contenuto nel terreno o nelle piante in composti gassosi che possono ritornare nell’atmosfera.<br />
L’N rappresenta uno dei principali nutrienti delle piante come si può osservare dalla figura<br />
2, nella quale sono riportate le esigenze <strong>di</strong> N e la produzione <strong>di</strong> granella per unità <strong>di</strong> prodotto<br />
fotosintetizzato delle principali specie alimentari. La linea tratteggiata orizzontale rappresenta<br />
l’assorbimento massimo <strong>di</strong> N <strong>di</strong> molte colture che corrisponde a 5 kg ha -1 d -1 per una produzione<br />
<strong>di</strong> fotosintati pari a 250 kg ha -1 d -1 . Nella figura, le specie situate sopra la linea <strong>di</strong> 20 mg <strong>di</strong> N<br />
per g <strong>di</strong> prodotto fotosintetizzato, necessitano quantitativi <strong>di</strong> N superiori a quelli normalmente<br />
ottenibili dal terreno e quin<strong>di</strong>, in natura, costrette ad approvvigionarsi da altre fonti (fissazione<br />
simbiontica).<br />
In base alla loro esigenza <strong>di</strong> N, le colture riportate nella figura 2 possono essere sud<strong>di</strong>vise<br />
in 4 gruppi:<br />
1. cereali produttori <strong>di</strong> granella in modo efficiente;<br />
2. leguminose, altrettanto efficienti produttrici <strong>di</strong> granella, sebbene necessitano<br />
<strong>di</strong> quantitativi <strong>di</strong> N superiori al gruppo 1.<br />
3. oleaginose che producono granella meno efficientemente dei gruppi 1 e 2 in<br />
cambio della produzione <strong>di</strong> lipi<strong>di</strong>;<br />
4. soia, che per il suo contenuto <strong>di</strong> lipi<strong>di</strong> e proteine si colloca tra le leguminose e<br />
le oleaginose.<br />
7
8<br />
Sebbene il ruolo delle leguminose nel miglioramento e mantenimento della fertilità del<br />
terreno sia conosciuto fin dall’antichità, è soltanto verso la fine del XIX secolo che tale fenomeno<br />
è stato approfon<strong>di</strong>tamente stu<strong>di</strong>ato. Quasi tutte le leguminose sono provviste <strong>di</strong> noduli sull’apparato<br />
ra<strong>di</strong>cale contententi batteri che hanno la caratteristica <strong>di</strong> fissare l’azoto atmosferico in<br />
cambio <strong>di</strong> carboidrati da parte della pianta. Una quota dell’N è <strong>di</strong>sponibile per la pianta e, con la<br />
degradazione dei noduli, parte <strong>di</strong> questo elemento viene rilasciato nel terreno. Questa caratteristica<br />
ha fatto sì che le leguminose hanno assunto una grande importanza nell’agricoltura; infatti,<br />
oltre ad arricchire il terreno in azoto e costituire una preziosa fonte <strong>di</strong> proteine per l’uomo, hanno<br />
un ruolo prioritario nelle rotazioni colturali, nella costituzione <strong>di</strong> pascoli (in consociazione con<br />
le graminacee), nella funzione <strong>di</strong> specie da copertura del terreno e per la concimazione verde<br />
(sovescio o “green manuring”). Queste caratteristiche sono state stu<strong>di</strong>ate approfon<strong>di</strong>tamente nei<br />
Paesi a clima temperato ma, relativamente pochi stu<strong>di</strong> sono stati condotti sul valore delle<br />
leguminose nel mantenimento della fertilità nei tropici.<br />
Figura 1. Ruolo delle leguminose nel ciclo dell’azoto (10 6 t).
Figura 2. Relazione tra la quantità <strong>di</strong> N richiesto ed il peso della granella per unità <strong>di</strong> prodotto<br />
fotosintetizzato delle principali specie alimentari.<br />
I batteri del genere Rhizobium che si trovano normalmente nel terreno, quando non fissano<br />
l’azoto sono attratti verso le ra<strong>di</strong>ci delle leguminose in sta<strong>di</strong>o <strong>di</strong> plantule (figura 3a). I batteri<br />
penetrano nelle ra<strong>di</strong>ci attraverso i peli ra<strong>di</strong>cali e passano nella corteccia dove provocano la <strong>di</strong>visione<br />
cellulare (figura 3a). Tali cellule sono tetraploi<strong>di</strong> e producono i noduli che appaiono sulla<br />
superficie delle ra<strong>di</strong>ci. I primor<strong>di</strong> dei noduli sono circondati da un meristema le cui cellule non<br />
sono infettate dal Rhizobium ma si moltiplicano provvedendo all’accrescimento del nodulo (figura<br />
3b). Nell’area interme<strong>di</strong>a fra la superficie del nodulo ed il suo centro, si trova l’area <strong>di</strong><br />
fissazione (figura 3c). Qui i tessuti sono costituiti da batterioi<strong>di</strong>, cellule delle piante con i<br />
Rhizobium che hanno assunto una forma globulare. I batteri contengono un enzima, la nitrogenasi,<br />
che li rendono capaci <strong>di</strong> fissare l’N atmosferico. La nitrogenasi contiene Fe e Mo, metalli in<strong>di</strong>spensabili<br />
per il trasporto <strong>degli</strong> elettroni necessari alla reazione <strong>di</strong> riduzione. Le cellule attive<br />
sono colorate <strong>di</strong> rosso per la presenza della legemoglobina, il pigmento che trasporta ossigeno ai<br />
batterioi<strong>di</strong>. Al centro dei noduli si trova l’area <strong>di</strong> degenerazione (figura 3d), <strong>di</strong> colore verde o<br />
marrone, all’interno della quale non avviene alcun processo <strong>di</strong> fissazione. Il sistema vascolare<br />
derivato dai vasi della ra<strong>di</strong>ce (figura 3e) ha funzione trofica trasportando i carboidrati necessari<br />
per la reazione <strong>di</strong> fissazione ed i composti azotati elaborati dal nodulo alle foglie.<br />
I noduli si possono osservare ad occhio nudo dopo 10-14 d <strong>di</strong> accrescimento della piantina<br />
in un substrato privo <strong>di</strong> N. Il tempo necessario tuttavia, <strong>di</strong>pende dalla leguminosa e dalla <strong>di</strong>mensione<br />
del seme. In campo, me<strong>di</strong>amente, i noduli sono visibili dopo 21-28 d dall’emergenza. Le<br />
<strong>di</strong>mensioni e la morfologia dei noduli variano considerevolmente ma la loro forma è costante<br />
9
10<br />
per ogni specie <strong>di</strong> leguminosa. La crescita (figura 4) e l’efficienza dei noduli è influenzata dal<br />
rapporto C:N della pianta e dalla presenza nel terreno <strong>di</strong> P, Ca, Mg, Mo e B. La presenza ed il<br />
numero dei noduli non è in<strong>di</strong>ce della loro efficacia. Se i noduli non sono efficaci, per la pianta i<br />
batteri costituiscono solo dei parassiti nei riguar<strong>di</strong> dell’N e le leguminose devono approvvigionarsi<br />
<strong>di</strong> questo elemento <strong>di</strong>rettamente dal terreno. In questo caso le leguminose esauriscono le<br />
riserve <strong>di</strong> N più rapidamente dei cereali e delle graminacee in genere.<br />
Figura 3. Processo <strong>di</strong> infezione e sviluppo del nodulo nelle ra<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> soia (Glycine max).<br />
Trifolium repens Glycine max Arachis hypogaea Cajanus sp. Lupinus sp.<br />
Figura 4. Vari tipi <strong>di</strong> noduli.
I noduli efficaci contengono la legemoglobina, <strong>di</strong> colore rossastro, che può essere in<strong>di</strong>viduata<br />
tagliando trasversalmente i noduli. I noduli non efficienti appaiono invece piccoli, consistenti,<br />
sferici e <strong>di</strong> colore verdastro internamente.<br />
In presenza <strong>di</strong> elevate quantità <strong>di</strong> N nel terreno od in caso <strong>di</strong> fertilizzazioni, lo sviluppo dei<br />
noduli viene ritardato. Nei climi tropicali tuttavia, la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> piccole dosi <strong>di</strong> N vengono<br />
spesso impiegate per stimolare l’accrescimento iniziale della coltura. L’effetto complessivo <strong>di</strong><br />
questa concimazione sullo sviluppo della pianta può talvolta risultare positivo.<br />
Nei tropici le leguminose hanno la capacità <strong>di</strong> produrre noduli in terreni aci<strong>di</strong> carenti in P,<br />
Ca ed altri nutrienti, in maggior misura rispetto a quanto avviene nelle aree temperate. In quest’ultime<br />
la nodulazione risulta carente nelle stagioni con fotoperiodo breve e scarsa intensità<br />
luminosa.<br />
Sono stati in<strong>di</strong>viduati molti ceppi <strong>di</strong> Rhizobium alcuni dei quali specifici per un certo<br />
numero <strong>di</strong> leguminose. Ogni ceppo è in grado <strong>di</strong> produrre noduli ra<strong>di</strong>cali su qualsiasi gruppo <strong>di</strong><br />
leguminose botanicamente vicine a quella specifica ma non su altre. Per esempio, il ceppo <strong>di</strong><br />
Rhizobium japonicum della Vigna unguiculata è molto <strong>di</strong>ffuso nei tropici ed è in grado <strong>di</strong> provocare<br />
la nodulazione in molti generi <strong>di</strong> leguminose tropicali. Questo è possibile poiché tale ceppo<br />
è probabilmente quello ancestrale ed il meno specializzato dei Rhizobium.<br />
Quando si introducono leguminose in nuovi ambienti è sempre consigliabile inoculare i semi<br />
con il ceppo appropriato; questo, se la specie introdotta non risulta essere in simbiosi con il R.<br />
japonicum. La soia, per esempio, necessita del batterio specifico. Poche specie della famiglia<br />
Caesalpinoideae producono noduli mentre questi vengono largamente prodotti dalle specie delle<br />
famiglie Mimosoideae e Papilionoideae.<br />
La fissazione simbiontica dell’N riveste una grande importanza nel complesso sistema<br />
suolo-pianta-atmosfera. Non deve essere sottovalutato l’aspetto energetico <strong>di</strong> tale processo. Infatti,<br />
da alcuni calcoli sulla energia libera <strong>di</strong> Gibbs necessaria per la fissazione simbiontica<br />
dell’N, è emerso che per questo processo sono necessarie circa 85 Kcal mole -1 +<br />
<strong>di</strong> NH4 fissato<br />
contro le 163 Kcal mole -1 +<br />
<strong>di</strong> NH4 prodotto industrialmente con la sintesi <strong>di</strong> Haber-Bosch.<br />
Il fenomeno della fissazione simbiontica dell’N in ambienti tropicali deve ancora essere<br />
aprofon<strong>di</strong>tamente stu<strong>di</strong>ato soprattutto in relazione ai ceppi specifici <strong>di</strong> Rhizobium occorrenti per<br />
le numerose specie <strong>di</strong> leguminose.<br />
Leucaena leucocephala<br />
Erba me<strong>di</strong>ca<br />
Pisello del tropico<br />
Fagiolo dal’occhio<br />
Pisello mungo<br />
Stylosanthes<br />
Soia<br />
Cece<br />
Arachide<br />
Cyamopsis sp.<br />
Figura 5. Quantitativi me<strong>di</strong> <strong>di</strong> azoto fissati da alcune leguminose (kg N ha -1 anno -1 ).<br />
11
12<br />
Figura 6. Pianta <strong>di</strong> fagiolo comune (Phaseolus vulgaris) ben nodulata.
Presenza <strong>di</strong> noduli ra<strong>di</strong>cali su piantine <strong>di</strong> cece a 30 giorni dall’emergenza.<br />
Sezioni <strong>di</strong> noduli ra<strong>di</strong>cali a <strong>di</strong>fferente sta<strong>di</strong>o <strong>di</strong> accrescimento. La colorazione rossastra in<strong>di</strong>ca la<br />
presenza <strong>di</strong> legemoglobina e la conseguente efficienza del nodulo.<br />
13
14<br />
4. LIMITI DELLA COLTIVAZIONE<br />
Le leguminose da granella tropicali si sono evolute in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> forti stress e non<br />
risultano geneticamente idonee ad adattarsi a con<strong>di</strong>zioni ambientali particolarmente favorevoli<br />
nelle quali, generalmente, non raggiungono sod<strong>di</strong>sfacenti rese sia dal punto <strong>di</strong> vista quantitativo<br />
che qualitativo. Tuttavia, l’adattabilità a con<strong>di</strong>zioni ambientali sfavorevoli costituisce uno dei<br />
principali pregi <strong>di</strong> molte leguminose.<br />
Tra i fattori che limitano la produttività delle leguminose nei tropici si ricordano le avversità,<br />
le umi<strong>di</strong>tà estreme, le alte temperature, la bassa insolazione, l’inadeguata o sbilanciata<br />
<strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> nutrienti e la scarsa fertilità del terreno. Quando non è possibile ridurre i limiti<br />
ambientali attraverso una migliore tecnica colturale, come il controllo delle avversità, risulta<br />
importante fare ricorso a specie o varietà caratterizzate da meccanismi genetici <strong>di</strong> tolleranza<br />
come ad esempio l’interruzione od il rallentamento dell’accrescimento durante i perio<strong>di</strong> ari<strong>di</strong>.<br />
Sebbene le leguminose rivestano una notevole importanza nell’alimentazione umana, non risultano<br />
prive <strong>di</strong> qualche caratteristica negativa come la carenza <strong>di</strong> aminoaci<strong>di</strong> solforati (cistina e<br />
metionina), il contenuto <strong>di</strong> alcuni fattori <strong>di</strong> flatulenza (soprattutto oligosaccari<strong>di</strong>), la presenza <strong>di</strong><br />
odori sgradevoli, il contenuto <strong>di</strong> inibitori metabolici (come quelli della tripsina). Inoltre, i semi<br />
<strong>di</strong> molte specie contengono sostanze tossiche, come alcaloi<strong>di</strong>, amminoaci<strong>di</strong> non proteici,<br />
neurotossine od emolisine. Comunque, molte <strong>di</strong> queste sostanze possono essere allontanate o<br />
inattivate con semplici trattamenti come cottura, ammollo e tostatura.<br />
Alcune leguminose caratterizzate da elevate rese e con ottime caratteristiche nutritive vengono<br />
scarsamente utilizzate soprattutto in conseguenza <strong>di</strong> ignoranza o <strong>di</strong> scarsa famigliarità con<br />
i meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> coltivazione e <strong>di</strong> preparazione. È il caso della soia, caratterizzata da un contenuto <strong>di</strong><br />
proteine e <strong>di</strong> olio superiore rispetto alla maggioranza delle altre specie, che non è stata accettata<br />
nei tropici africani nonostante i vari tentativi <strong>di</strong> una sua introduzione ripetutasi a partire dal<br />
1920. Tuttavia, la crescente richiesta a livello mon<strong>di</strong>ale <strong>di</strong> olii vegetali e <strong>di</strong> mangimi ha favorito<br />
l’espansione della soia in molte aree tropicali suprattutto a livello industriale (come “cash crop”)<br />
e poco per uso domestico.<br />
La risposta alla concimazione delle leguminose non è così pronta e, a volte, spettacolare<br />
come nei cereali; in particolare l’azoto non ha effetti apprezzabili, mentre con il fosforo si riescono<br />
ad ottenere incrementi <strong>di</strong> produzione talvolta anche notevoli.<br />
La produttività delle leguminose è più bassa rispetto a quella <strong>di</strong> altre specie (es. cereali)<br />
per la maggior quantità <strong>di</strong> energia necessaria per sintetizzare proteine e grassi, rispetto a quella<br />
impiegata per i carboidrati.<br />
5. DISTRIBUZIONE<br />
Più <strong>di</strong> una dozzina <strong>di</strong> specie contribuisce alla produzione <strong>di</strong> leguminose da granella nelle<br />
regioni tropicali. Di queste, il fagiolo comune (Phaseolus vulgaris), il cece (Cicer arietinum), la<br />
soia (Glycine max), il pisello (Pisum sativum), la lenticchia (Lens esculenta), la fava (Vicia<br />
faba) ed il lupino (Lupinus sp.) sono specie adatte anche a climi freschi e quin<strong>di</strong> da considerare<br />
specie per aree <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a od alta altitu<strong>di</strong>ne nei tropici. Similmente, il pisello del tropico (Cajanus<br />
cajan), il fagilo dall’occhio (Vigna unguiculata), l’arachide (Arachys hipogaea) ed altre specie
come fagiolo mungo (Vigna ra<strong>di</strong>ata), rice bean (Vigna umbellata = Phaseolus calcaratus),<br />
moth bean (Vigna aconitifolia = Phaseolus aconitifolius) sono solitamente coltivati ad altitu<strong>di</strong>ni<br />
inferiori.<br />
La maggioranza delle leguminose tropicali si riscontrano soprattutto nelle aree a clima<br />
sub-umido o semi-arido. Il pisello del tropico, una delle specie più conosciute, si riscontra in una<br />
grande variabilità <strong>di</strong> climi. Generalmente le leguminose non sono coltivate estensivamente andando<br />
a costituire per la maggior parte, fonti <strong>di</strong> alimento complementare ad altri prodotti <strong>di</strong><br />
origine vegetale e/o animale nell’agricoltura <strong>di</strong> sussistenza. Soprattutto nei tropici umi<strong>di</strong> si riscontra<br />
una grande varietà <strong>di</strong> leguminose ma, in genere, la loro produzione a livello mon<strong>di</strong>ale<br />
risulta sempre <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile determinazione. La descrizione dettagliata della <strong>di</strong>stribuzione delle<br />
singole specie è riportata nelle schede monografiche.<br />
6. RICHIAMI DI BOTANICA E TASSONOMIA<br />
Le leguminose appartengono all’Or<strong>di</strong>ne Leguminosae e la maggioranza delle specie è<br />
classificata nella grande famiglia delle Papilionaceae che comprende 480 generi e 12.000 specie<br />
ampiamente <strong>di</strong>stribuite nei climi sia tropicali che temperati. Poche specie <strong>di</strong> importanza<br />
economica si riscontrano invece nelle famiglie Caesalpinieceae (152 generi e 2800 specie) e<br />
Mimosaceae (56 generi e 2800 specie).<br />
Le caratteristiche botaniche che <strong>di</strong>stinguono le leguminose sono le seguenti:<br />
1. foglie solitamente alternate e composte, pinnate o trifogliate;<br />
2. fiori ermafro<strong>di</strong>ti solitamente con 5 petali e 5 sepali;<br />
3. ovario supero con un unico carpello ed uno stilo;<br />
4. il frutto è un baccello formato da un unico carpello e deiscente in corrispondenza<br />
<strong>di</strong> entrambe le suture dorsale e ventrale che separano le due valve;<br />
5. semi costituiti da due cotiledoni e un embrione che contiene un endosperma<br />
molto piccolo (spesso assente).<br />
Le Papilionaceae si <strong>di</strong>stinguono dalle altre due famiglie soprattutto per i fiori zigomorfi a<br />
simmetria bilaterale <strong>di</strong> tipo pentamero. Il petalo superiore, sessile, è solitamente il più grande e<br />
costituisce il vessillo. I due petali laterali sono paralleli fra <strong>di</strong> loro e formano le ali; i due petali<br />
inferiori, solitamente uniti per il margine inferiore, costituiscono la carena che protegge gli stami<br />
e l’ovario. Normalmente gli stami sono 10 e possono essere monoadelfi (saldati insieme) o<br />
<strong>di</strong>adelfi (9 stami uniti ed uno libero). Le antere hanno due loculi e deiscono per il senso della<br />
lunghezza. L’ovario è supero costituito da un carpello e qualche volta provvisto <strong>di</strong> un falso<br />
setto; gli ovuli possono essere da 1 ad oltre 20 e sono attacchati alla sutura ventrale del frutto. La<br />
fecondazione è incrociata e/o autogama. Il frutto è il tipico legume o baccello, normalmente<br />
deiscente, <strong>di</strong> forma, colore e <strong>di</strong>mensionmi variabilissime; in alcune specie si accrescono sotto il<br />
livello del terreno (es. arachide e Voandzeia subterranea).<br />
15
16<br />
I semi sono estremamente <strong>di</strong>versificati per forma, colore e <strong>di</strong>mensioni; presentano tegumenti<br />
consistenti e a volte impermeabili all’acqua (semi duri). Il loro interno è totalmente occupato<br />
dall’embrione, costituito in massima parte da due cotiledoni ripieni <strong>di</strong> sostanze <strong>di</strong> riserva<br />
(carboidrati, proteine e grassi); il seme, nella maggior parte delle specie, non contiene endosperma<br />
perchè riassorbito durante la formazione dell’embrione. Un elemento caratteristico, <strong>di</strong> una certa<br />
importanza tassonomica in alcune leguminose, è l’ilo. Esso rappresenta l’area dove era inserito<br />
il funicolo che sosteneva il seme al baccello e lo alimentava; alla maturazione fisiologica nel<br />
punto <strong>di</strong> contatto seme-funicolo si forma uno strato suberificato <strong>di</strong> colore, forma e posizione<br />
caratteristici per le <strong>di</strong>verse specie. L’ilo funziona come una valvola che permette la <strong>di</strong>sidratazione<br />
del seme quando è in ambiente asciutto e ne impe<strong>di</strong>sce la reidratazione quando l’atmosfera si<br />
arricchisce <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà; in questo caso la chiusura è quasi istantanea.<br />
Figura 7. Fiore tipico <strong>di</strong> una Papilionacea (Cicer arietinum). a. fiore intero; b. ala; c. carena; d. vessillo<br />
o stendardo.<br />
Figura 8. Gineceo ed androceo <strong>di</strong> una Papilionacea (Cicer arietinum). a. stilo e stigma; b. ovario, stilo<br />
e stigma; c. stami; d. stame; e. colonna staminale.
L’apparato ra<strong>di</strong>cale è sempre fittonante ma può accrescersi in mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi:<br />
a. asse principale ben sviluppato con ramificazioni piuttosto corte (es. lupino);<br />
b. asse e ramificazioni ben sviluppati, ma le seconde più corte dell’asse (es. cece);<br />
c. asse e ramificazioni ben sviluppati che raggiungono pressoché la stessa profon<strong>di</strong>tà<br />
(es. vigna, soia, fagiolo).<br />
Le famiglia delle Papilionaceae è sud<strong>di</strong>visa in 12 tribù ma quasi tutte le leguminose da<br />
granella <strong>di</strong> importanza economica appartangono alla tribù delle Phaseoleae. Poche appartengono<br />
alla Cicereae ed altre, come le arachi<strong>di</strong>, alle Hedysareae. Le specie delle Phaseoleae possono<br />
essere piante erbacee, erette, rampicanti o prostrate oppure arbustive o semi-arbustive. Le<br />
foglie sono imparipennate; le stipole sono presenti e gli stami non sono allargati all’apice. La<br />
tribù delle Hedysareae si <strong>di</strong>stingue dalle altre per avere i baccelli riuniti a grappoli; inoltre, le<br />
pareti dei bacceli sono compressi nello spazio fra seme e seme e si rompono facilmente in senso<br />
trasversale; in qualche specie sono presenti le stipole fogliari.<br />
Una chiave botanica semplificata per le leguminose tropicali è stata approntata da <strong>di</strong>versi<br />
autori. I generi Cicer, Lens, Pisum, Vicia, Lathyrus e Lupinus sono omessi poichè, come già<br />
riportato, sono piante delle aree più temperate e spesso utilizzate in semina autunno-vernina<br />
nelle regioni subtropicali e temperate.<br />
In seguito ad approfon<strong>di</strong>ti stu<strong>di</strong> sulla morfologia delle foglie e del polline, sulla struttura<br />
del fiore ed analisi elettroforetiche <strong>degli</strong> estratti dei semi, in questa classificazione, Phaseolus<br />
mungo, P. aureus, P. ra<strong>di</strong>atus, P. acontifolius, P. anguralis e P. calcaretus sono stati inseriti in<br />
Vigna sp..<br />
A. FRUTTI CHE MATURANO SOTTO IL LIVELLO DEL TERRENO<br />
B. Foglie pinnate con quattro foglioline; foglioline senza stipole; stami monoadelfi, fiori<br />
ascellari e solitari; baccelli raggruppati con pareti compresse nello spazio fra i semi<br />
Arachis<br />
BB. Foglie trifogliate, glabre, stami liberi dalla prossimità della base alla parte superiore;<br />
stilo peloso; calice con denti corti e larghi ............................................... Voandzeia<br />
C. Stilo glabro, calice <strong>di</strong>viso in due lobi stretti ....................... ........Kerstingiella<br />
AA. FRUTTI CHE MATURANO SOPRA IL TERRENO<br />
B. Foglie trifogliate<br />
C. Stame libero dalla base alla sommità<br />
E. Carena e stilo spiralati a 360° per 1-5 volte; morfologia del polline non ben definita;<br />
vessillo con scalanatura trasversa alla sommità dell’attaccatura al calice, <strong>di</strong><br />
solito privo <strong>di</strong> appen<strong>di</strong>ci (se presenti in numero <strong>di</strong> due) ................ Phaseolus<br />
EE. Carena e stilo arcuati o curvati ma non spiralati a 360°; stipole cordate o con<br />
appen<strong>di</strong>ci alla base; polline fortemente reticolato<br />
F. Stigma obliquo o introrso; ra<strong>di</strong>ci non tuberose........................ Vigna<br />
FF. Stigma subgloboso situato sulla faccia interna dello stilo; ra<strong>di</strong>ci tuberose<br />
Pachyrrhizus<br />
D. Stilo glabro con stigma terminale<br />
E. Carena e stilo rostrati piegati all’interno<br />
F. Stigma peloso. ....................................................................... ..Dolichos<br />
17
18<br />
DD. Stilo peloso da una parte, stigma glabro ........................................... Lablab<br />
F. Stigma peloso, lateralmente obliquo, incappucciato o piatto e largo più o meno<br />
spatolato ma privo <strong>di</strong> appen<strong>di</strong>ci; carena non piegata; stami eretti o sinuosi<br />
Sphenostylis<br />
BB. Foglie trifogliate con glandole puntiformi nella parte inferiore; oblungo-lanceolate<br />
C. Fiori gialli od arancioni attaccati in racemi ascellari subcapitati; stame vessillario<br />
libero dalla prossimità della base alla sommità; più <strong>di</strong> 4 ovuli; arbusti eretti perennanti<br />
Cajanus<br />
BBB. Foglie trifogliate, prive <strong>di</strong> glandole puntiformi nella parte inferiore<br />
C. Stame vessilario libero dalla base in su<br />
E. Brattee e bratteole piccole e caduche:<br />
F. Carena più lunga del vessillo; baccello ispido con peli pungenti; fiori in racemi<br />
a zigzag corti o talvolta umbellati.............................................Stizolobium<br />
FF. Carena più corta del vessillo<br />
CC. Stilo glabro; calice con 4 lobi, lobo superiore parzialmente o totalmente bidentato;<br />
no<strong>di</strong> dei racemi non gonfi; vessillo quasi totalmente pubescente; fiori piccoliGlycine<br />
D. Stame vessillare unito nella parte <strong>di</strong>stale con gli altri stami, libero nella parte<br />
inferiore<br />
E. Baccello squadrato con 4 ali longitu<strong>di</strong>nali con 5-6 semi; foglie 1-3 fogliate;<br />
rampicante erbacea............................................................... Psophocarpus<br />
EE. Baccello non alato; molti semi; foglie trifogliate<br />
CCC. No<strong>di</strong> dei racemi rigonfi, apice del frutto non uncinato, stami tutti fertili<br />
D. Calice con lobi <strong>di</strong>seguali in <strong>di</strong>mensioni; i due lobi superiori arrotondati e più gran<strong>di</strong><br />
dei tre inferiori; baccello largo, solcato lungo la sutura superiore...................Canavalia<br />
E. Baccello con 1-3 semi, no<strong>di</strong> dei racemi rigonfi, rampicante, legnosa....Dioclea<br />
7. CLASSIFICAZIONE<br />
Le leguminose da granella tropicali possono essere <strong>di</strong>stinte in due categorie:<br />
1. oleaginose (arachide, soia);<br />
2. da granella (pisello del tropico, fagiolo dall’occhio ecc).<br />
Un gruppo secondario <strong>di</strong> leguminose include molte specie <strong>di</strong> uso locale con potenziale<br />
produttivo non determinato. Le principali specie del secondo gruppo sono: Lablab purpureus,<br />
Dolichos biflorus, Phaseolus lunatus, Sphenostylis stenocarpa, Vigna umbellata, Cajanus cajan,<br />
Vigna acontifolia e Mucuna sp.(=Stizolobium). In termini <strong>di</strong> adattamento queste specie potrebbero<br />
essere classificate nelle seguenti categorie:<br />
I. Regioni semiaride, precipitazioni annuali
II. Regioni da semi-aride a sub-umide, precipitazioni 600-900 mm<br />
1. Arachide a me<strong>di</strong>o e lungo ciclo<br />
2. Fagiolo dall’occhio a me<strong>di</strong>o e lungo ciclo<br />
3. Pisello del tropico (Cajanus cajan)<br />
4. Pisello mungo (Vigna ra<strong>di</strong>ata)<br />
5. Hyacinth bean (Lablab purpureus)<br />
6. Horse gram (Dolichos biflorus)<br />
III. Regioni da sub-umide ad umide, precipitazioni 900-1500 mm<br />
1. Pisello del tropico a me<strong>di</strong>o e lungo ciclo<br />
2. Fagiolo dall’occhio a me<strong>di</strong>o e lungo ciclo<br />
3. Fagiolo mungo a me<strong>di</strong>o e lungo ciclo<br />
4. Fagiolo <strong>di</strong> Lima (Phaseolus lunatus)<br />
5. Fagiolo comune (Phaseolus vulgaris)<br />
6. Soia (Glycine max)<br />
IV. Regioni a umide a molto umide, precipitazioni >1500 mm<br />
1. Fagiolo <strong>di</strong> Lima, tipo rampicante<br />
2. Yam bean (Sphenostylis stenocarpa)<br />
3. Rice bean (Vigna umbellata;<br />
syn. Phaseolus calcaretus)<br />
4. Velvet bean (Mucuna pruriens var. utilis<br />
= Stizolobium aterrimum)<br />
5. Pisello del tropico a lungo e me<strong>di</strong>o ciclo<br />
Una classificazione più dettagliata dell’ecologia delle leguminose risulta <strong>di</strong>fficile poiché<br />
l’adattabilità è con<strong>di</strong>zionata da altri fattori, oltre alle precipitazioni annuali come:<br />
1. andamento delle precipitazioni (mono- o bimodale);<br />
2. <strong>di</strong>stribuzione dell’umi<strong>di</strong>tà;<br />
3. temperature e nuvolosità;<br />
4. umi<strong>di</strong>tà relativa;<br />
5. capacità <strong>di</strong> ritenzione idrica del terreno;<br />
6. fertilità del terreno e struttura fisica;<br />
7. eventuali attacchi <strong>di</strong> patogeni e <strong>di</strong> insetti;<br />
8. interazione del genotipo con l’ambiente.<br />
La <strong>di</strong>versità genetica all’interno <strong>di</strong> una specie è notevole, spesso in misura maggiore rispetto<br />
alla variabilità riscontrabile fra le specie. Caratteristiche come tolleranza alle avversità,<br />
rapida germinazione e primo accrescimento, precocità, tolleranza alle alte temperature, apparato<br />
ra<strong>di</strong>cale profondo, accrescimento indeterminato, sensibilità al fotoperiodo, capacità produttiva<br />
ed altri fattori ere<strong>di</strong>tabili hanno una profonda influenza sull’adattabilità a situazioni ecologiche<br />
specifiche. Nell’adattabilità all’ambiente, vi sono altre caratteristiche da prendere in considerazione<br />
come la preferenza per alcune specie rispetto ad altre da parte dell’uomo e le relative<br />
necessità. Infatti, spesso vengono coltivate alcune specie o varietà con bassa resa solo per motivi<br />
<strong>di</strong> gusto, <strong>di</strong> utilizzazioni specifiche e <strong>di</strong> esigenze <strong>di</strong> mercato. A causa delle notevoli fluttuazioni<br />
dei molti fattori legati all’ambiente molto spesso vengono consocitate due o più colture come:<br />
leguminosa + cereale, leguminosa + specie da ra<strong>di</strong>ce o da tubero, leguminosa + pianta da frutto<br />
o, più raramente, leguminosa + leguminosa.<br />
19
20<br />
8. UTILIZZAZIONI<br />
Oltre che per la granella, alcune leguminose possono essere coltivate anche per altri scopi<br />
la cui importanza economica o <strong>di</strong> sussistenza, può talvolta essere pari o superiore a quella del<br />
seme. Alcuni prodotti hanno rivestito o rivestono tuttora una grande importanza sul mercato<br />
mon<strong>di</strong>ale. E’ sufficiente ricordare la produzione <strong>di</strong> alcuni legnami pregiati o la possibilità <strong>di</strong><br />
rivalutare l’utilizzazione <strong>di</strong> alcune specie tintorie. Qui <strong>di</strong> seguito, a titolo esemplificativo, si<br />
riportano in sintesi le varie utilizzazioni alle quali possono andare incontro alcune leguminose<br />
tropicali.<br />
8.1 Colture da copertura<br />
Soprattutto nei tropici umi<strong>di</strong> molte leguminose assumono una grande importanza come<br />
specie da copertura (“cover crops”). Tale importante funzione è loro conferita soprattutto dal<br />
rapido accrescimento e dall’architettura della pianta che permette una uniforme copertura del<br />
terreno. Questa caratteristica viene soprattutto sfruttata nelle piantagioni <strong>di</strong> specie perenni, sotto<br />
le quali, la copertura <strong>di</strong> leguminose assolve molteplici funzioni:<br />
1. Controllo delle infestanti: esercitato in seguito alla forte competizione <strong>di</strong><br />
queste specie nei confronti della luce, dell’acqua e <strong>degli</strong> elementi nutritivi.<br />
Inoltre, il controllo delle avventizie, è favorito anche dalla proprietà <strong>di</strong> alcune<br />
specie <strong>di</strong> emettere sostanze allelopatiche inibitrici l’accrescimento delle infestanti.<br />
L’esempio più conosciuto è quello della Canavalia ensiformis nei confronti<br />
del Cyperus rotundus, graminacea che, generalmente, presenta <strong>di</strong>fficoltà<br />
<strong>di</strong> controllo;<br />
2. Controllo dell’erosione idrica: tale effetto è assicurato dalla notevole massa<br />
<strong>di</strong> vegetazione che ricopre il terreno e che, principalmente, impe<strong>di</strong>sce l’azione<br />
battente delle pioggie e lo scorrimento superficiale dell’acqua;<br />
3. Mantenimento della fertilità del terreno: <strong>di</strong>rettamente per la fissazione<br />
simbiontica dell’N e per i residui della vegetazione che cadono al suolo ed<br />
in<strong>di</strong>rettamente per la limitazione dell’erosione superficiale e <strong>di</strong> quella profonda.<br />
La copertura del terreno con la Pueraria phaseoloides è comune nelle piantagioni <strong>di</strong> gomma<br />
(Hevea brasiliensis) e <strong>di</strong> palmito da frutto (Bactris gasipaes) ma è generalmente sconsigliata<br />
durante i primi anni dell’impianto a causa della sua eccessiva aggressività. In questo caso si<br />
preferisce fare riscorso a specie con accrescimento prostrato come il Desmo<strong>di</strong>um ovalifolium.<br />
Le specie utilizzate per questo scopo sono molte, fra le principali, oltre a quelle già in<strong>di</strong>cate si<br />
ricordano: Pueraria lobata, Calopogonium mucunoides, Centrosema plumieri, Centrosema<br />
pubescens, Stizolobium aterrimum, Stizolobium deeringianum e Stylosanthes guianensis.
8.2 Sovescio o “green manuring”<br />
Per apportare elementi minerali al terreno in<br />
mancanza <strong>di</strong> fertilizzanti, si può fare ricorso all’interramento<br />
<strong>di</strong> leguminose coltivate appositamente per<br />
tale scopo. L’interramento delle piante in piena fioritura<br />
consente <strong>di</strong> sfruttare al massimo soprattutto<br />
l’elevato contenuto <strong>di</strong> N delle parti ver<strong>di</strong> oltre ad<br />
utilizzare i residui <strong>di</strong> questo elemento lasciato nel<br />
terreno dall’attività dei batteri azotofissatori. La pratica<br />
del “green manuring” prevede anche l’apporto<br />
<strong>di</strong> residui vegetali delle leguminose non coltivate<br />
<strong>di</strong>rettamente sul posto. Infatti, tale materiale può essere<br />
reperito da specie spontanee o da coltivazioni<br />
vicine. In quest’ultimo caso ad esempio, il materiale<br />
verde può essere ricavato dal perio<strong>di</strong>co lavoro <strong>di</strong> taglio<br />
della Pueraria phaseoloides sotto le piantagioni<br />
arboree.<br />
8.3 Specie ornamentali<br />
Molte delle più belle piante da fiore del mondo<br />
sono leguminose. Per esempio, nei climi temperati<br />
si possono riscontrare la wisteria (Wisteria sp.),<br />
il laburno (Luburnum sp.), il pisello odoroso<br />
(Lathyrus odoratus) e la Clitoria ternatea. Ma è soprattutto<br />
nei tropici che si incontra il maggior numero<br />
<strong>di</strong> leguminose ornamentali. Fra queste si ricordano:<br />
la poinciana reale (Delonix regia), la pioggia<br />
d’oro o “chuva de oiro” (Cassia fistula), “pik and<br />
white shower” (Cassia nodosa), “l’orgoglio delle<br />
Barbados” (Caesalpinia pulcherrima), gli alberi delle<br />
orchidee (Bauhinia sp., B. purpurea, B. variegata e<br />
B. monandra) ed il “cocks comb coral tree”<br />
(Erythrina crista-galli).<br />
8.4 Legname<br />
Leguminose ornamentali: Laburnum sp.<br />
Leguminose ornamentali: Lathyrus odoratus<br />
Molte leguminose arboree producono legname<br />
<strong>di</strong> pregio che riesce a spuntare ottimi prezzi sul<br />
mercato internazionale. Alcune specie (Baphia nitida,<br />
Pterocarpus spp., Dalbergia spp.) hanno avuto<br />
un importanza mercantile notevole per secoli e sono<br />
tuttora tra i legnami da costruzione universalmente<br />
noti. La maggioranza <strong>di</strong> queste specie sono a lento<br />
accrescimento e la loro coltivazione specializzata<br />
rimane ancora non sperimentata. Leguminose ornamentali: Caesalpinia sp.<br />
21
22<br />
8.5 Coloranti<br />
Nei secoli passati le leguminose hanno rivestito una notevole importanza come piante<br />
coloranti. Attualmente, dopo l’incontrastata ascesa dei coloranti sintetici durata per decenni, il<br />
ricorso alle piante come fonti <strong>di</strong> coloranti sia per tessuti che per alimenti ha ripreso vigore.<br />
L’indaco è sempre stato il colorante <strong>di</strong> origine vegetale maggiormente utilizzato ed estratto dalla<br />
leguminosa del genere In<strong>di</strong>gofera prodotto soprattutto in In<strong>di</strong>a ed esportato in Cina ed in Europa.<br />
In Africa orientale, invece, l’indaco viene ancora ottenuto dalla leguminosa arborescente<br />
Lonchocarpus cyanescens. Oltre alle spezie, proprio la possibilità <strong>di</strong> produrre coloranti fu uno<br />
dei fattori che spinsero Portoghesi, Tedeschi ed Inglesi a colonizzare l’In<strong>di</strong>a. Allo stesso modo,<br />
nel 1638 il brasiletto (o campeggio), legno dell’Haematoxylon campechianum, spinse gli inglesi<br />
nel Belize. I colori estratti da questo legno hanno costituito il maggior prodotto <strong>di</strong> esportazione<br />
spagnolo dall’America centrale per oltre un secolo. In Sud America i Portoghesi<br />
commercializzavano il legno tintorio della Caesalpinia echinata (legno del Brasile o pernambuco),<br />
con il quale si era in grado <strong>di</strong> ottenere un colore rosso-vinoso per tingere stoffe <strong>di</strong> cotone. Tale<br />
prodotto aveva un grande mercato in Europa dove, fino ad allora, si importava il sapan, legno<br />
della Caesalpinia sappan importato dall’Asia fino dal Me<strong>di</strong>oevo. Attualmente, sia il brasiletto<br />
che il sapan sono richiesti per la costruzione <strong>di</strong> archetti per violino o per piccoli lavori fini.<br />
8.6 Altri usi<br />
Leguminose da legno:<br />
la pianta ed il campione <strong>di</strong><br />
legname <strong>di</strong><br />
Pterocarpus in<strong>di</strong>cus.<br />
Altri prodotti che si possono ottenere dalle leguminose sono la senna (Cassia angustifolia<br />
e specie affini), ampiamente utilizzata per la sua proprietà lassativa; il rotenone, insetticida,<br />
estratto da Derris sp., Lonchocarpus sp. e Tephrosia sp..
Leguminose coloranti. SOPRA: la pianta <strong>di</strong> Haematoxylon.<br />
SOTTO: lana colorata con l’estratto <strong>di</strong> In<strong>di</strong>gofora (indaco).<br />
Nell’Asia sud-orientale ed In<strong>di</strong>a, i giovani rami <strong>di</strong> leguminose, in seguito all’attacco <strong>di</strong> un<br />
insetto, sono impiegati per la produzione <strong>di</strong> gommalacca in scaglie utilizzata in passato come<br />
isolante elettrico e come ingre<strong>di</strong>ente per la lacca per capelli.<br />
I semi <strong>di</strong> tonka o “tonka bean” (Dipteryx odorata) sono stati esportati per secoli dal Sud<br />
America come spezia per conferire l’odore <strong>di</strong> vaniglia al tabacco o ad alcuni alimenti. Tuttavia,<br />
recenti considerazioni sulla sicurezza alimentare della cumarina, l’ingre<strong>di</strong>ente attivo della D.<br />
odorata, ha comportato la cessazione del commercio.<br />
I semi del fieno greco (Trigonella foenum-graecum), fortemente aromatizzanti, sono utilizzati<br />
come spezia nel curry, nelle salamoie e nella salsa in<strong>di</strong>ana.<br />
Alcune delle migliori resine per coppali rinomate per la loro resistenza e durata nel tempo<br />
sono prodotte da alcune leguminose come Hymeneae sp. e Copaifera sp.. Gli olii essenziali <strong>di</strong><br />
quest’ultima specie sono anche utilizzati come balsamico per la tosse ed altre preparazioni me-<br />
23
24<br />
<strong>di</strong>cinali.<br />
Molti alimenti <strong>di</strong> preparazione<br />
industriale come la maionese<br />
ed i gelati, contengono gomme<br />
estratte da leguminose; fra<br />
queste si riscordano Acacia<br />
senegal (gomma arabica) e<br />
Cyamopsis tetragonoloba<br />
(guar). Alcune sostanze inoltre,<br />
come quelle estratte dalla<br />
Acacia farnesiana, sono utilizzate<br />
come base nei profumi.<br />
La corteccia <strong>di</strong> Acacia<br />
mearnsii serve per l’estrazione<br />
<strong>di</strong> tannini per la lavorazione<br />
Cassia angustifolia dalla quale si estrae la senna (lassativo).<br />
della pelle.<br />
Molte leguminose sono importanti<br />
per la produzione <strong>di</strong> miele sia nelle aree temperate che<br />
nei tropici. Per le zone tropicali si ricordano: Pithecellobium sp.,<br />
Hymenea courbaril, Inga sp., Gliciri<strong>di</strong>a sepium, An<strong>di</strong>ra inermis<br />
ed alcune specie <strong>di</strong> Acacia.<br />
Infine si ricorda la Glycyrrhiza glabra, piccolo arbusto dalle<br />
cui ra<strong>di</strong>ci si estrae la liquirizia.<br />
Un prodotto farmaceutico<br />
contro le<br />
fermentazioni intestinali<br />
a base <strong>di</strong> estratto<br />
<strong>di</strong> Cassia senegal.
LA COLTIVAZIONE DI ALCUNE<br />
SPECIE RAPPRESENTATIVE<br />
9.<br />
25
Sinonimi: Cajanus in<strong>di</strong>cus Spreng.<br />
Cromosomi: 2n = 22, 44, 66<br />
PISELLO DEL TROPICO<br />
Cajanus cajan (L.) Millsp.<br />
Nomi comuni: Italiano: caiano, pisello del tropico. Inglese: pigeon pea, red gram, gungo pea,<br />
no-eye pea, Congo pea, Angola pea, yellow dhal. Francese: Pois d’Angole. Spagnolo: guando.<br />
Portoghese: guandu.<br />
Altri nomi: ads sudani, lubia adassi (Sudan); burusa, apena, lopena (Uganda), mbani (Tanzania);<br />
ohota-farengota (Etiopia); vio-vio (Nigeria); adhaki, arahar, ihora, kandalu, cror, rahan<br />
thuraran, dhal, guandu (In<strong>di</strong>a); ca<strong>di</strong>os, ka<strong>di</strong>os (Filippine); goode, katjang goode (Indonesia);<br />
ihora parippu thoraroy (Sri Lanka); kachang dal (Malesia); pay-inchang (Birmania); togare (Tailan<strong>di</strong>a);<br />
guando, puso-poroto (America Latina); gandul (America Centrale); chicoro de arbol<br />
(Messico); chinchancho (Venezuela).<br />
Origine e <strong>di</strong>ffusione: L’origine del pisello del tropico è incerta. Duke (1981) in<strong>di</strong>ca il probabile<br />
centro <strong>di</strong> origine in In<strong>di</strong>a da dove fu introdotto in Africa alcuni millenni fa evolvendosi in vari<br />
ceppi <strong>di</strong>versi. Quest’ultimi furono introdotti nel Nuovo Mondo dopo Colombo probabilmente<br />
nel XVI secolo. Tuttavia, un ampia <strong>di</strong>ffusione della leguminosa avvenne soltanto a partire dalla<br />
fine del ‘700.<br />
Del tutto <strong>di</strong>versa invece l’ipotesi <strong>di</strong> Rachie e Roberts i quali in<strong>di</strong>cano l’Africa come area <strong>di</strong><br />
origine ed i ceppi in<strong>di</strong>cati da Duke <strong>di</strong>ffusi nelle regioni sub-sahariane, come specie spontanee. In<br />
Madagascar il caiano sarebbe coltivato fin dai tempi più remoti e da qui in seguito sarebbe stato<br />
introdotto in In<strong>di</strong>a. Sempre secondo Duke la specie spontanea <strong>di</strong> Cajanus non sarebbe mai stata<br />
trovata e quelle in<strong>di</strong>cate fino ad ora potrebbero essere costituite soltanto da in<strong>di</strong>vidui sfuggiti<br />
alle coltivazioni.<br />
In alcune foreste tropicali dell’In<strong>di</strong>a orientale si riscontrano popolazioni <strong>di</strong> Cajanus e quella<br />
che è considerata la specie spontanea più vicina a quella coltivata: l’Atylosa cajanifolia Haines..<br />
Altre specie <strong>di</strong> Atylosia sono state riscontrate in In<strong>di</strong>a e nel nord dell’ Australia. In Africa il<br />
Cajanus kerstingii cresce nelle aree più aride del Senegal, Ghana, Togo e Nigeria.<br />
27
28<br />
Figura 9. Cajanus cajan: A. stelo con fiori e frutti; B. fiore in sezione<br />
longitu<strong>di</strong>nale; C. semi .<br />
Semi <strong>di</strong> caiano sono<br />
stati trovati nelle tombe<br />
egizie della XII Dinastia<br />
e ciò in<strong>di</strong>ca che<br />
questo legume era<br />
coltivato nell’Africa<br />
Nord-orientale fino<br />
dal 2000 AC quando<br />
cioè, relazioni commerciali<br />
erano state<br />
già avviate con altri<br />
Paesi africani e con<br />
quelli arabi orientali.<br />
Attualmente il pisello<br />
del tropico si<br />
colloca al quinto posto<br />
nel mondo fra le<br />
leguminose da<br />
granella destinate alla<br />
utilizzazione umana,<br />
sebbene la sua coltivazione<br />
sia soltanto <strong>di</strong><br />
tipo familiare e la<br />
granella consumata<br />
quasi esclusivamente<br />
per la sussistenza.<br />
La produzione<br />
mon<strong>di</strong>ale <strong>di</strong> semi secchi<br />
è pari a circa 2 Mt<br />
<strong>di</strong> cui l’87% prodotta<br />
esclusivamente in In<strong>di</strong>a<br />
su una superficie<br />
<strong>di</strong> 2,5 Mha. l’Africa<br />
produce in me<strong>di</strong>a<br />
70.000 t <strong>di</strong> semi secchi,<br />
il Nord America<br />
41.000 t ed il Sud<br />
America 4.000 t. Si<br />
pensa tuttavia che le<br />
statistiche che si rife-<br />
riscono all’Africa siano sottostimate <strong>di</strong> 2-4 volte poiché il caiano viene frequentemente coltivato<br />
negli orti famigliari (kitchen gardens), dalle aree umide a quelle semiaride, sia a basse che<br />
elevate altitu<strong>di</strong>ni. Coltivazioni leggermente più estese rispetto agli orti famigliari si riscontrano<br />
in Mali, Uganda ed in altri Paesi dell’Africa Centrale. Anche nei tropici americani il caiano<br />
riveste una grande importanza nell’alimentazione essendo consumato sia come verdura (semi<br />
freschi bolliti) che come granella secca. I maggiori produttori sono la Repubblica Dominicana,<br />
Trinidad, Porto Rico, Hawaii, Bahamas e Venezuela; in misura minore la coltura è <strong>di</strong>ffusa anche<br />
in altri Paesi del Caribe e del resto dell’America Latina dove la produzione del caiano è anche<br />
industriale per la produzione <strong>di</strong> semi in conserva.
A sinistra: semi immaturi <strong>di</strong> Cajanus in conserva. A destra: semi secchi pronti per la<br />
consumazione.<br />
Importanza ed utilizzazione: Il pisello del tropico riveste una grande importanza per molte<br />
popolazioni dei tropici sia per la sua adattabilità alle più <strong>di</strong>sparate con<strong>di</strong>zioni ambientali che per<br />
le varie utilizzazione a cui è soggetto. Semi e baccelli freschi costituiscono una importante fonte<br />
alimentare. La granella secca può essere utilizzata per sfarinati od i semi brillati come principale<br />
costituente del “dhal”, piatto tipico in<strong>di</strong>ano, consumato generalmente insieme al riso. Secondo<br />
la varietà coltivata e la preparazione il dhal contiene circa il 22% <strong>di</strong> proteine:<br />
Del caiano si utilizzano anche le giovani foglie come spezia. I semi maturi sono impiegati<br />
per la produzione <strong>di</strong> germinelli.<br />
Le piante <strong>di</strong> caiano producono una grande quantità <strong>di</strong> biomassa verde e quin<strong>di</strong> sono largamente<br />
impiegate come foraggera perennante o per sovescio. Spesso il pisello del tropico è impiegato<br />
come specie da ombra (cacao, vaniglia, kola, palma da olio ecc.), da copertura, per la<br />
costituzione delle file della coltura a vialetti (“alley cropping”) ed occasionalmente anche come<br />
frangivento. In Tailan<strong>di</strong>a il caiano funge da ospite per l’insetto che produce la gommalacca. In<br />
Madagascar le foglie sono utilizzate come alimento per i bachi da seta mentre, gli steli essiccati,<br />
come combustibile e per la costruzione <strong>di</strong> tetti e cesti.<br />
Molte sono le utilizzazioni del caiano nella me<strong>di</strong>cina popolare. Fra le più importanti si<br />
ricordano: giovani foglie per lenire le ferite, polvere delle foglie per eliminare i calcoli della<br />
vescica, succo delle foglie con aggiunta <strong>di</strong> sale per l’itterizia, decotto delle foglie per molte<br />
irritazioni cutanee, decotto dei fiori per le bronchiti ed affezioni respiratorie in generale, semi<br />
decorticati aggiunti al caffè come analgesico, ra<strong>di</strong>ci essiccate come antielmintico, espettorante,<br />
sedativo e vulnerario.<br />
Caratteristiche botaniche e morfologiche: Questa leguminosa ha l’aspetto <strong>di</strong> un arbusto perenne<br />
alto da 1 a 4 m. L’apparato ra<strong>di</strong>cale è profondo con ra<strong>di</strong>ci laterali molto allungate nelle<br />
varietà semierette o prostrate, più corte nelle varietà erette. Il numero, la posizione ed angolo <strong>di</strong><br />
inserzione delle ramificazioni cambia con le varietà. La prima ramificazione si può riscontrare<br />
dal VI al XVI nodo e l’angolo <strong>di</strong> inserzione è <strong>di</strong> circa 30° nelle varietà erette e <strong>di</strong> 60° in quelle<br />
prostrate.<br />
29
30<br />
Cajnuas cajan - Le foglie composte ed i racemi con i<br />
fiori dalla tipica colorazione gialla quando aperti e<br />
rossastra quando ancora in boccio.<br />
Cajnuas cajan -<br />
SOPRA: baccelli<br />
immaturi.<br />
SOTTO: semi<br />
maturi..<br />
Le foglie trifogliate, <strong>di</strong>sposte a spirale<br />
con una fillotassi <strong>di</strong> 2/5, hanno la tendenza<br />
ad essere decidue; picciolo<br />
solcato ventralmente lungo 2-8 cm;<br />
stipole piccole, ovate, pelose, lunghe<br />
circa 4 mm; pulvini presenti alla base<br />
dei piccioli ed a quella delle foglioline;<br />
foglioline da lanciolate a quasi<br />
ellittiche con angolo acuto in entrambe<br />
le estremità, margine intero, pelose<br />
sia sulla pagina inferiore che superiore;<br />
in quella inferiore, <strong>di</strong> colore<br />
grigiastro, si osserva la presenza <strong>di</strong> piccole<br />
glandole resinose giallastre; la fogliolina<br />
centrale (6-15 x 2-6 cm) è<br />
provvista <strong>di</strong> un picciolo generalmente<br />
più lungo rispetto a quello delle foglioline<br />
laterali. Le infiorescenze sono piccoli<br />
racemi terminali e/o ascellari lunghe<br />
circa 4-12 cm provviste <strong>di</strong> molti<br />
fiori. La fioritura è indeterminata e si<br />
prolunga anche per alcuni mesi. I fiori<br />
sono lunghi circa 2,5 cm; il calice presenta<br />
4 lobi, i due superiori risultano<br />
saldati insieme; vessillo provvisto <strong>di</strong><br />
auricole, <strong>di</strong> colore giallo, talvolta rosso<br />
o viola nella parte dorsale o giallo<br />
striato <strong>di</strong> rosso o viola; ali e carena, <strong>di</strong><br />
lunghezza identica, sono <strong>di</strong> colore giallo;<br />
la carena risulta ricurva all’apice ed<br />
obtusa; gli stami <strong>di</strong>adelfi; antere uniformi,<br />
piccole, oblunghe, gialle,<br />
dorsifisse; ovario e base dello stilo<br />
provvisti <strong>di</strong> peli; stigma a forma <strong>di</strong> pomello.<br />
La fecondazione è prevalentemente<br />
autogama; la percentuale <strong>di</strong><br />
allogamia è del 20% circa, ma con<br />
oscillazioni tra il 5 e il 40% a seconda<br />
della presenza dei pronubi.<br />
I legumi sono appiattiti, lunghi<br />
5-10 cm, <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso colore, spesso ricoperti<br />
<strong>di</strong> peli; sui due lati sono evidenti<br />
strozzature oblique tra i semi. I<br />
semi sono roton<strong>di</strong> od ovali, leggermente<br />
schiacciati lunghi 5-8 mm, <strong>di</strong>versamente<br />
colorati (bianchi, grigi, rossi,<br />
bruni), ma tutti con piccolo ilo bianco;<br />
il peso <strong>di</strong> 100 semi oscilla tra 5 e 28 g;<br />
germinazione ipogea.
Del C. cajan sono<br />
<strong>di</strong>stinguibili due varietà botaniche:<br />
flavus e bicolor. La prima<br />
è piuttosto precoce, bassa,<br />
con fiori gialli, legumi glabri,<br />
ver<strong>di</strong>, contenenti solitamente<br />
tre semi; è <strong>di</strong>ffusa in quasi tutta<br />
l’In<strong>di</strong>a dove è conosciuta<br />
come “tur”. La seconda è perenne,<br />
tar<strong>di</strong>va, <strong>di</strong> grande sviluppo.<br />
Il fiore ha lo stendardo<br />
con venature rosse; i legumi<br />
sono pelosi, screziati, con 4-6<br />
semi; <strong>di</strong>ffusa nel nord dell’In<strong>di</strong>a<br />
con il nome “arhar”. Le due<br />
varietà sono interfeconde.<br />
Ecologia: Il caiano presenta<br />
una notevole adattabilità sia<br />
nei riguar<strong>di</strong> del clima che del<br />
terreno. E’ tollerante alle alte<br />
temperature ed ai terreni poveri.<br />
Nei riguar<strong>di</strong> della ari<strong>di</strong>tà il<br />
pisello del tropico mostra una<br />
elevata tolleranza e riesce a<br />
Cajnuas cajan var bicolor - Questa specie può raggiungere le<br />
<strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> un albero e può essere utilizzata come pianta da<br />
ombra, come frangivento o inserita in sistemi agroforestali a più<br />
livelli. Sottoposta a taglio è in grado <strong>di</strong> emettere ricacci.<br />
vegetare ed a produrre in presenza <strong>di</strong> una pluviometria me<strong>di</strong>a annuale <strong>di</strong> 500-650 mm. Tale<br />
caratteristica gli è conferita dall’apparato ra<strong>di</strong>cale molto profondo. Questa leguminosa tuttavia,<br />
si adatta molto bene anche a climi umi<strong>di</strong> (700-1000 mm) nei quali le con<strong>di</strong>zioni più favorevoli<br />
alla coltivazione sono umi<strong>di</strong>tà durante i primi 60-65 giorni dalla semina e perio<strong>di</strong> più ari<strong>di</strong><br />
durante la fioritura ed il riempimento dei baccelli. Nei tropici più umi<strong>di</strong> il pisello del tropico<br />
evidenzia un lussureggiamento della vegetazione a scapito della produzione <strong>di</strong> granella; se la<br />
fioritura avviene durante la stagione delle piogge si possono riscontrare <strong>di</strong>minuzioni<br />
dell’allegagione ed attacchi <strong>di</strong> insetti sui baccelli.<br />
Il caiano risulta sensibile al fotoperiodo ma tale caratteristica varia notevolmente con le<br />
varietà. In ambienti a giorno corto si riscontra l’anticipo della fioritura.<br />
Le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> accrescimento ottimali sono temperature comprese fra 18 e 29°C anche<br />
se alcune varietà tollerano 10°C in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> ari<strong>di</strong>tà e 35°C in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà. Il<br />
caiano cresce in vari tipi <strong>di</strong> suoli, dai sabbiosi a quelli argillosi ma quest’ultimi devono essere<br />
ben drenati poichè la leguminosa non tollera ristagni idrici. Il C. cajan tollera con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
salinità pari a 0.6-1.2 mS cm -1 . Il pH ottimale è compreso fra 4.5 e 8.4.<br />
Le fasi vegetative sono <strong>di</strong> durata estremamente variabile. L’antesi può iniziare in un periodo<br />
compreso fra 60 e 200 d dalla semina secondo il genotipo, il fotoperiodo, la temperatura<br />
me<strong>di</strong>a e lo stato idrico del terreno. Il primo accrescimento del caiano è molto lento e per questo<br />
viene spesso consociato con specie a ciclo corto (cereali o leguminose). La competizione nei<br />
riguar<strong>di</strong> delle infestanti risulta scarsa durante le prime 4-6 settimane dalla semina ma <strong>di</strong>venta<br />
eccellente una volta che la pianta riesce a coprire il terreno. La notevole massa <strong>di</strong> foglie che<br />
cadono al suolo non solo impe<strong>di</strong>scono l’accrescimento delle avventizie ma contribuiscono validamente<br />
ad ostacolare l’erosione superficiale.<br />
31
32<br />
Tecnica colturale: Il pisello del tropico può essere propagato per talea, tuttavia l’impiego del<br />
seme è il metodo <strong>di</strong> gran lunga più utilizzato. Nelle semine a fila vengono utilizzati in me<strong>di</strong>a 10-<br />
22 kg ha -1 <strong>di</strong> granella anche se, molto spesso, la semina avviene a spaglio e la quantità <strong>di</strong> seme<br />
occorrente risulta notevolmente più elevata. La germinazione ha luogo dopo circa 10-15 d.<br />
In coltura pura il seme viene posto ad una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> circa 2,5-5,0 cm ed in file <strong>di</strong>stanti<br />
30-90 cm con piante intervallate da 30-45 cm. La <strong>di</strong>stanza tra le file <strong>di</strong>pende dalla utilizzazione<br />
prevalente che si vuol fare della coltura: foraggio, coltura da sovescio o produzione <strong>di</strong> seme. Le<br />
<strong>di</strong>stanze maggiori devono essere impiegate per la produzione <strong>di</strong> granella con una densità <strong>di</strong> 6-10<br />
piante per m 2 .<br />
La coltura è frequentemente consociata con sorgo, sesamo, arachide, manioca, ananas,<br />
cotone, miglio e mais. In questo caso si seminano 1-3 file <strong>di</strong> caiano alternate con 3-10 file della<br />
coltura consociata. A seconda della specie in consociazione, le file <strong>di</strong> caiano possono essere<br />
<strong>di</strong>stanziate <strong>di</strong> 1,2-2,1 m e la semina può essere affettuata a postarelle utilizzando 3-4 semi per<br />
buchetta e, a germinazione avvenuta, <strong>di</strong>radando a 2 piante.<br />
In coltura pura il controllo delle infestanti risulta in<strong>di</strong>spensabile e deve essere effettuato<br />
fino alla chiusura dell’interfila.<br />
Il caiano presenta una scarsa risposta alla concimazione ed in alcune ricerche è stata osservata<br />
una relazione negativa alla somministrazione <strong>di</strong> N quando consociato con cereali. Le<br />
asportazioni <strong>di</strong> macroelementi per ogni 100 kg <strong>di</strong> granella sono <strong>di</strong> 3,5 kg <strong>di</strong> N, 0,3 kg <strong>di</strong> P 2 O 5 e<br />
1,4 kg <strong>di</strong> K 2 O. La somministrazione <strong>di</strong> 20-80 kg ha -1 <strong>di</strong> P 2 O 5 associata a quella <strong>di</strong> S contribuisce<br />
in genere ad un incremento delle rese e ad un incremento della fissazione dell’N.<br />
Le varietà precoci maturano in 150-180 d mentre quelle tar<strong>di</strong>ve in 270-360 d. Il caiano<br />
può essere anche sottoposto a perio<strong>di</strong>che sfalciature per la produzione <strong>di</strong> foraggio ed in questo<br />
caso la coltura può assumere la caratteristica <strong>di</strong> poliennale (3-5 anni); la produzione <strong>di</strong> granella<br />
però <strong>di</strong>minuisce dopo il primo anno e la coltura <strong>di</strong>viene soggetta ad attacchi parassitari.<br />
Raccolta: Uno dei maggiori problemi della raccolta del caiano è la maturazione scalare, accentuata<br />
soprattutto nelle varietà molto tar<strong>di</strong>ve. Secondo i genotipi, il clima e l’epoca <strong>di</strong> semina, la<br />
fioritura può avere una durata molto <strong>di</strong>versa. Nel caso <strong>di</strong> maturazione spiccatamente scalare, la<br />
prima produzione <strong>di</strong> baccelli risulta relativamente scarsa e, generalmente, si procede con una<br />
raccolta manuale. Quando la coltura risulta matura si può procedere al taglio della pianta intera<br />
lasciando completare l’essiccamento in campo. Per la trebbiatura si procede alla battitura con<br />
correggiati <strong>di</strong> legno od al calpestio delle piante effettuato da animali domestici su appositi pavimenti;<br />
con l’utilizzazione <strong>di</strong> questi meto<strong>di</strong>, la pulitura dei semi avviene con la vagliatura. Il<br />
caiano può essere raccolto anche meccanicamente facendo attenzione alla regolazione delle<br />
macchine soprattutto nei riguar<strong>di</strong> della velocità del battitore e della <strong>di</strong>stanza fra questo ed il<br />
controbattitore.<br />
La resa in baccelli freschi può variare da 1 a 9 t ha -1 e la produzione <strong>di</strong> granella secca può<br />
arrivare a 2,5 t ha -1 in coltura pura, ma la me<strong>di</strong>a mon<strong>di</strong>ale si aggira intorno alle 0,6 t ha -1 .<br />
Come già ricordato la principale forma <strong>di</strong> utilizzazione del caiano è il “dhal” che può<br />
essere preparato con due meto<strong>di</strong>:<br />
Metodo secco: la granella viene fatta asciugare al sole per 3-4 d dopo<strong>di</strong>ché i semi vengono<br />
parzialmente lavorati con macine <strong>di</strong> pietra e trattati con olii vegetali per la conservazione. Per<br />
perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> conservazione che non superano il mese viene adoperato olio <strong>di</strong> sesamo o <strong>di</strong> cocco<br />
(quest’ultimo utilizzato soprattutto in Sri Lanka). Per lunghi perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> conservazione viene<br />
impiegato l’olio <strong>di</strong> ricino. L’olio viene assorbito dai semi e facilita le successive lavorazioni <strong>di</strong><br />
preparazione. I semi lavorati vengono separati dai rivestimenti esterni tramite setacciatura. Il
dhal preparato con questo metodo risulta <strong>di</strong> forma sub-globulare e riesce a spuntare prezzi più<br />
elevati rispetto al dhal preparato con il metodo umido. La resa in dhal è <strong>di</strong> circa 45%.<br />
Metodo umido: i semi vengono sciacquati in acqua per circa 6 ore, scolati e mischiati con terra<br />
fine ben setacciata nella proporzione 1:20. Questa mistura viene sistemata in piccoli cumuli ed<br />
essiccata al sole per qualche giorno. In seguito vengono tolte le impurità ed i semi lavorati in<br />
macine <strong>di</strong> pietra. La resa in dhal è del 75%.<br />
Il dhal preparato con entrambi i meto<strong>di</strong> viene venduto senza ulteriore aggiunta <strong>di</strong> olio ma,<br />
per la preparazione casalinga, ne viene aggiunto circa 40 g ogni kg <strong>di</strong> prodotto. Il prodotto si<br />
conserva per circa 2-3 mesi.<br />
Avversità: Il caiano è interessato da molte avversità le principali delle quali sono fungine e<br />
provocate da insetti.<br />
Funghi: la fusariosi provocata dal Fusarium udum è la più grave. Causa un avvizzimento generalizzato<br />
della pianta; si in<strong>di</strong>vidua per un imbrunimento della base dello stelo e della parte interna<br />
delle ra<strong>di</strong>ci. L’insorgenza della malattia è favorito da una temperatura del terreno 17-20°C. Il<br />
patogeno penetra nella pianta attraverso le ra<strong>di</strong>ci e può persistere nel terreno per lunghi perio<strong>di</strong>.<br />
L’unico metodo <strong>di</strong> lotta efficace è quello preventivo con l’utilizzazione <strong>di</strong> genotipi tolleranti (C-<br />
11, C-36, NP-15, NP-38, T-17) od il ricorso alle rotazioni (ad esempio in rotazione con il tabacco<br />
ed in consociazione con il sorgo).<br />
Di minore importanza, ma particolarmente dannosa nella zona dei Caraibi è Physalospora<br />
cajanae, agente del cancro dello stelo.<br />
Altri patogeni fungini possono colpire il caiano, ma l’entità dei danni è quasi sempre<br />
trascurabile e <strong>di</strong> importanza locale. Tra questi si ricordano: Cercosposa spp., Colletotrichum<br />
cajaneae, Corticium solani, Diploi<strong>di</strong>a cajani, Macrophomina phaseoli, Phoma cajani,<br />
Phyllosticta cajani, Rhizoctonia bataticola, Rosellinia sp., Sclerotium rolfsii.<br />
Insetti: L’insetto più dannoso è l’Heliothis armigera, lepidottero che colpisce i baccelli in tutta<br />
l’Asia e l’Africa. Questo insetto è particolarmente dannoso quando colpisce i baccelli giovani.<br />
In In<strong>di</strong>a gravi danni ai baccelli si osservano frequentemente in seguito all’attacco del <strong>di</strong>ttero<br />
Melanagromyza obtusa.<br />
Virosi: Le uniche virosi che si riscontrano con una certa frequenza sul caiano ed in grado <strong>di</strong><br />
provocare ripercussioni negative sulle rese sono: SMV (sterility mosaic virus) e l’YMV (yellow<br />
mosaic virus).<br />
Nemato<strong>di</strong>: Raramente provocano danni gravi alle colture. Fra le principali specie si ricordano:<br />
Helicotylenchus cavevessi, H. <strong>di</strong>hiptera, H. pseudorobustus, Heterodera sp., Meloidogine<br />
javanica, M. incognita acrita, M. hapla, Scutellonema bradys.<br />
Composizione: La composizione me<strong>di</strong>a del seme secco è: acqua 10%, proteine 21,6%, carboidrati<br />
72,7%, grassi 1,4%, ceneri 4,2%, fibra 8,1%. Ulteriori dettagli sulla composizine chimica sono<br />
riportati nelle tabelle 1 e 2.<br />
33
VOANDZEIA<br />
Voandzeia subterranea (L.) Thouars<br />
Sinonimi: Voandzeia subterranea (L.) var. subterranea, Voandzeia subterranea forma sativa<br />
Jacques-Felix, Vigna subterranea, Glycine subterra L.<br />
Cromosomi: 2n = 22<br />
Nomi comuni: Inglese: bambara groundnut, ground bean, earth nut, Madagascar groundnut,<br />
baffin pea, Congo goober, kaffir pea, tugo bean, stone groundnut. Francese: bambara erdnuss,<br />
bambara d’Angole.<br />
Altri nomi: njugo bean (Sud Africa), voandzou (Madagascar), pararu (Africa Occidentale),<br />
aboboi (Ghana), epi rorojgujuya (Nigeria), intoyoj ntoyo (Zambia), njama o nzama (Malawi),<br />
nlubu o nyimo (Burkina Faso), manila bean (Malesia), kachang bogor (In<strong>di</strong>a), okpa otuanya<br />
(Ibo), juijiya (Hausa), njugu mawe (Swahili), guerte o gertebe (Arabo).<br />
Origine e <strong>di</strong>ffusione: La Voandzeia subterranea (VS) si ritiene originaria dell’Africa Occidentale<br />
con alcuni centri <strong>di</strong> origine in<strong>di</strong>viduati in Nigeria e nel Cameroun del Nord. Altro centro <strong>di</strong><br />
origine sembra quello localizzato lungo le rive del Nilo, mentre l’Africa Centrale costituirebbe<br />
un importante area <strong>di</strong> <strong>di</strong>versificazione della leguminosa.<br />
Harper (1963) in<strong>di</strong>ca in V. subterranea var. spontanea (Harms) (sinonimo <strong>di</strong> V. subterranea<br />
forma spontanea) la specie spontanea da cui sarebbe originata quella attualmente coltivata.<br />
Nel XVII secolo la VS raggiunge il Brasile ed il Surinam dai quali, più tar<strong>di</strong>, venne importata<br />
in America Centrale ed in Asia (Filippine ed Indonesia).<br />
Attualmente la coltura è <strong>di</strong>ffusa in tutta l’Africa tropicale dal Senegal al Kenya e dal Sahara al<br />
Sud Africa compreso il Madagascar dove, insieme all’arachide, pisello del tropico, fagiolo e<br />
fagiolo dall’occhio rappresenta la leguminosa da granella più conosciuta ed apprezzata essendo<br />
coltivata su una superficie <strong>di</strong> circa 400.000 ha. I maggiori produttori sono: Nigeria (330.000 t),<br />
Burkina Faso (65.000 t), Niger (30.000 t), Ghana (20.000 t), Togo (8.000 t), Costa D’Avorio<br />
(7000 t ). In questi Paesi, tuttavia, la coltura viene praticata quasi esclusivamente su piccole<br />
superfici per consumo familiare; superfici più estese si riscontrano invece in Zambia. La VS è<br />
anche coltivata nei seguenti Paesi: Mauritius, In<strong>di</strong>a, Sri Lanka, Malesia, Nuova Caledonia, Australia<br />
del Nord, America Centrale, Suriname e Brasile.<br />
35
36<br />
Figura 10. Voandzeia subterranea: A. pianta con fiori e frutti; B. fiore in sezione longitu<strong>di</strong>nale; C.<br />
seme.
Importanza ed utilizzazione: Della VS vengono<br />
utilizzati soprattutto i semi i quali contengono<br />
un <strong>di</strong>screto contenuto <strong>di</strong> proteine ed<br />
un elevato tenore <strong>di</strong> carboidrati che conferiscono<br />
a questa specie la caratteristica <strong>di</strong> vera<br />
e propria pianta “energetica”. Infatti, 100 g<br />
<strong>di</strong> semi essiccati forniscono in me<strong>di</strong>a 400 calorie.<br />
Il contenuto in grassi è basso; tuttavia,<br />
alcune popolazioni del Congo usano arrostire<br />
i semi i quali, in un secondo momento,<br />
vengono macinati e pestati in appositi attrezzi<br />
per estrarre l’olio.<br />
Generalmente vengono consumati i<br />
semi freschi e immaturi prima che <strong>di</strong>ventino<br />
troppo duri. La granella matura invece, deve<br />
essere tenuta a mollo e poi bollita oppure,<br />
molto spesso viene essiccata per la preparazione<br />
<strong>di</strong> dolci. I semi immaturi, con o senza<br />
guscio, vengono anche ridotti in poltiglia con<br />
la quale si prepara un tipo <strong>di</strong> “porridge” molto<br />
compatto che si conserva per molto tempo;<br />
in questo modo, può essere consumato<br />
quando si affrontano lunghi viaggi.<br />
La granella cucinata in vari mo<strong>di</strong> può<br />
essere servita come con<strong>di</strong>mento, antipasto o<br />
accompagnata con manioca o platano; oppure,<br />
pestando i semi insieme a vari tipi <strong>di</strong> spe-<br />
Ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> legumi essicati <strong>di</strong> bambara groundnut in<br />
un mercato africano.<br />
zie, si ottiene una specie <strong>di</strong> ripieno che viene avvolto in foglie <strong>di</strong> banano o <strong>di</strong> amaranto.<br />
In Africa non mancano esempi <strong>di</strong> utilizzazioni industriali della VS; per esempio in Ghana,<br />
vengono prodotti annualmente circa 40.000 t <strong>di</strong> semi in conserva. I baccelli, infine, possono<br />
essere utili come succedanei del caffè. Talvolta, le foglie, ricche <strong>di</strong> azoto e fosforo, sono lasciate<br />
pascolare dagli animali domestici oppure somministrate insieme al foraggio fresco.<br />
Non esiste un mercato mon<strong>di</strong>ale della VS, tuttavia questa leguminosa assume un ruolo <strong>di</strong><br />
primaria importanza come coltura alimentare locale soprattutto per le aree più povere dell’Africa.<br />
In questi ambienti, l’importanza della coltivazione della VS è seconda soltanto al fagiolo<br />
dall’occhio ed all’arachide.<br />
Questa leguminosa può avere anche una utilizzazione come coltura “ristoratrice” della<br />
fertilità. Grazie alla elevata capacità <strong>di</strong> fissazione dell’N atmosferico ed alla qualità dei suoi<br />
residui colturali, risulta una ottima coltura in rotazione con il mais. I suoi residui infatti, possono<br />
essere agevolmente sfruttati dal cereale grazie alla loro più rapida mineralizzazione rispetto ad<br />
altre leguminose come ad esempio l’arachide.<br />
Caratteristiche botaniche e morfologiche: È una specie annuale che raggiunge l’altezza massima<br />
<strong>di</strong> circa 25 cm e può presentarsi in <strong>di</strong>versi habitus vegetativi: da prostato ad eretto, con<br />
molte ramificazioni ad interno<strong>di</strong> ravvicinati che fanno assumere alla pianta l’aspetto a rosetta.<br />
Dai no<strong>di</strong> vengono emesse facilmente le ra<strong>di</strong>ci. Apparentemente la VS è molto simile all’arachide<br />
dalla quale si <strong>di</strong>fferenzia per avere foglie con tre foglioline pinnatiformi con picciolo peloso,<br />
37
38<br />
eretto, scanalato, infossato alla base con<br />
stipole che si inseriscono sullo stelo con un<br />
angolo molto ampio. Secondo la varietà, i<br />
piccioli e gli steli possono assumere <strong>di</strong>versi<br />
colori quali rosa, viola o grigio-bluastro. La<br />
fogliolina terminale è sottesa da due stipole<br />
mentre le laterali ne hanno una ciascuna. Le<br />
foglioline sono caratterizzate dal margine intero;<br />
quelle laterali hanno una forma meno<br />
regolare e risultano anche più corte rispetto a<br />
quella terminale.<br />
In corrispondenza dei no<strong>di</strong> dello stelo vengono<br />
emessi i bottoni fiorali (che risultano<br />
quin<strong>di</strong> molto vicini al terreno) portati da un<br />
peduncolo peloso che, generalmente, portano<br />
da 1 a 3 fiori che possono essere provvisti<br />
Piante <strong>di</strong> voandzeia con baccelli immaturi.<br />
<strong>di</strong> un corto pe<strong>di</strong>cello.<br />
I fiori sono cleistogami e nella maggior<br />
parte delle varietà i petali sono <strong>di</strong> colore bianco-giallastro<br />
mentre, in altre, può essere giallo scuro con striature rosso-scuro o, più raramente,<br />
rosa chiaro. Lo stilo, corto, ricurvo e peloso, porta uno stigma piccolo in posizione laterale. A<br />
fecondazione avvenuta il pe<strong>di</strong>cello si curva verso il terreno e vi penetra trascinando con se il<br />
baccello in accrescimento che conclude la sua maturazione a circa 1 cm <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà.<br />
Il baccello è rotondeggiante, circa 1,2-2,5 cm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro, costituito da due valve,<br />
indeiscente, <strong>di</strong> colore bianco e con superficie liscia appena maturo, per <strong>di</strong>ventare progressivamente<br />
brunastro e rugoso con l’approssimarsi del processo <strong>di</strong> essiccazione naturale. A maturazione<br />
i baccelli si staccano dal lungo peduncolo con il quale erano uniti allo stelo. All’interno dei<br />
baccelli sono contenuti 1 o 2 semi rotondeggianti o leggermente appiattiti da un lato, qualche<br />
volta con ilo ben evidente, duri e con superficie liscia, gran<strong>di</strong> circa 1-1,5 cm e con un peso <strong>di</strong> 100<br />
semi pari a 50-75 g. I semi possono essere <strong>di</strong> colore bianco, rosso, viola, marrone o nero con<br />
screziature <strong>di</strong> varie tonalità.<br />
Ecologia: La VS è <strong>di</strong>ffusa negli areali della savana o nelle aree <strong>di</strong> transizione foresta pluvialesavana<br />
in Africa. Tuttavia, questa specie risulta molto adattabile e tollera con<strong>di</strong>zioni pedo-climatiche<br />
avverse meglio <strong>di</strong> altre leguminose. Infatti, riesce a fornire produzioni interessanti in<br />
ambienti troppo ari<strong>di</strong> per arachide, mais o sorgo, vegetando con una precipitazione annuale<br />
anche <strong>di</strong> soli 50 mm. Per questa sua caratteristica “Bambara” è chiamato un <strong>di</strong>stretto vicino a<br />
Timbuktu nella fascia meri<strong>di</strong>onale del deserto del Sahara. In definitiva la VS risulta una specie<br />
preziosissima in regioni caldo-aride dove la coltivazione <strong>di</strong> altre leguminose può incontrare<br />
qualche <strong>di</strong>fficoltà<br />
Per la già ricordata adattabilità questa pianta viene coltivata anche in regimi a foresta<br />
pluviale e negli altopiani a clima fresco e umido fino ad una altitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> 1.500 m s.l.m..<br />
La VS cresce rigogliosa e fornisce i risultati produttivi migliori in ambienti con forte<br />
illuminazione, alte temperature (me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 20-28°C) e pioggie frequenti dalla semina alla fioritura.<br />
E’ una specie brevi<strong>di</strong>urna e compie il proprio ciclo colturale in un periodo compreso fra 90 e<br />
120 d per le varietà a portamento compatto e fra 120 e 150 d per quelle a portamento lasso.<br />
Per quanto riguarda il terreno, la VS tollera terreni poveri; quelli troppo fertili stimolano la<br />
specie ad un eccessivo rigoglio vegetativo a scapito della produzione <strong>di</strong> baccelli e <strong>di</strong> semi.
Cresce bene in terreni sabbiosi, con pH <strong>di</strong> 5,0-6,5 ma a patto che i terreni siano ben drenati. La<br />
VS ha <strong>di</strong>mostrato <strong>di</strong> non avere preferenze nei riguar<strong>di</strong> della tessitura.<br />
Tecnica colturale: La tecnica colturale della VS è molto simile a quella dell’arachide e viene<br />
spesso inserita in rotazione per permettere alle colture successive <strong>di</strong> usufruire dell’arricchimento<br />
in azoto del terreno favorito dalla leguminosa. La VS produce meglio in coltura pura ma<br />
molto spesso si trova consociata con cereali (miglio perlato, mais, canna da zucchero), specie da<br />
ra<strong>di</strong>ce o da tubero e con altre leguminose. Nei tropici, con l’utilizzazione <strong>di</strong> varietà precoci sono<br />
possibili due coltivazioni annuali. La prima semina si può effettuare in Maggio-Giugno mentre,<br />
la seconda in Luglio-Agosto. L’epoca <strong>di</strong> semina varia a secondo della <strong>di</strong>stanza dall’equatore e,<br />
generalmente, avviene durante la stagione delle pioggie. Per esempio, in Tanzania si considera<br />
una semina precoce della VS quella effettuata entro la prima decade <strong>di</strong> Febbraio mentre in Sud<br />
Africa risulta tar<strong>di</strong>va se effettuata alla metà <strong>di</strong> Novembre.<br />
La quantità <strong>di</strong> seme e le <strong>di</strong>stanze fra le piante sono molto variabili. In me<strong>di</strong>a si utilizzano<br />
25-75 kg ha -1 <strong>di</strong> seme sgusciato in file <strong>di</strong>stanti da 15 fino a 95 cm; le <strong>di</strong>stanze maggiori vengono<br />
utilizzate per consentire una agevole operazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>serbo. A questo scopo, la VS può anche<br />
essere seminata a file binate <strong>di</strong>stanti 20 cm alla sommità <strong>di</strong> solchi <strong>di</strong>stanti 0,60 m. Lungo la fila<br />
i semi si <strong>di</strong>spongono ogni 10-55 cm secondo la <strong>di</strong>stanza fra le file al fine <strong>di</strong> ottenere una densità<br />
<strong>di</strong> circa 15 piante per m 2 . Per la semina, nella maggior parte dei casi, vengono utilizzati i semi<br />
sgusciati posti ad una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> circa 7 cm secondo la tesitura del terreno. Tuttavia, possono<br />
essere utilizzati anche i baccelli interi. I semi sgusciati germinano dopo circa 6-8 giorni.<br />
Per consentire ai fiori fecondati <strong>di</strong> penetrarvi e <strong>di</strong> permettere una regolare maturazione dei<br />
baccelli, il terreno deve essere lavorato abbastanza in profon<strong>di</strong>tà ed in modo tale da risultare<br />
leggero.<br />
Il controllo delle infestanti viene praticato manualmente quasi ovunque. La prima scerbatura<br />
viene eseguita quando le piante hanno raggiunto un’altezza <strong>di</strong> circa 10 cm. Un secondo intervento<br />
viene praticato poco prima od al momento della fioritura al fine <strong>di</strong> non ostacolare il normale<br />
sviluppo dei baccelli che poco più avanti si troveranno nel terreno. Oltre al controllo delle<br />
avventizie, altra pratica a cui si fa ricorso frequentemente è quella della rincalzatura al fine <strong>di</strong><br />
favorire lo sviluppo dei baccelli.<br />
Gran parte delle varietà <strong>di</strong> VS riescono a nodulare in presenza del Rhizobium in<strong>di</strong>geni. La<br />
<strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> N minerale provoca un ingrossamento dei noduli ed un loro incremento <strong>di</strong> peso<br />
secco ma l’efficienza della fissazione viene notevolmente ridotta. Ciò non accade in presenza <strong>di</strong><br />
basse dosi <strong>di</strong> N equivalenti a circa 10-20 kg ha -1 . Riflessi positivi sulla resa si ottengono soltanto<br />
con elevate dosi <strong>di</strong> N anche se è stata riscontrata una certa varibilità del comportamento delle<br />
varietà. Un incremento delle rese può essere ottenuto inoculando i semi con ceppi selezionati <strong>di</strong><br />
Rhizobium. Alcune ricerche hanno constatato che ceppi selezionati <strong>di</strong> batteri incrementano significativamente<br />
il numero dei noduli, il peso secco delle ra<strong>di</strong>ci oltre alla resa. In Africa sono<br />
stati selezionati molti ceppi idonei per la VS, fra questi si ricordano TAL 169, TAL 1380 e<br />
NifTAL isolati dalla Vigna unguiculata.<br />
La <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> fertilizzanti minerali non è pratica comune. Tuttavia, sensibili incrementi<br />
<strong>di</strong> resa si possono ottenere con la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> 30-40 kg ha -1 <strong>di</strong> P 2 O 5 effettuata alla<br />
semina o dopo circa 10-15 d dalla emergenza. In terreni estremamente poveri, è sempre<br />
consigliabile, oltre alla <strong>di</strong>stribuzione alla semina <strong>di</strong> P 2 O 5 , anche quella <strong>di</strong> circa 20 kg ha -1 <strong>di</strong> N<br />
effettuata dopo circa 3 settimane dalla semina.<br />
Raccolta: La raccolta si effettua quando le foglie iniziano a colorarsi <strong>di</strong> giallo. Se il prodotto è<br />
destinato all’alimentazione umana, i semi non devono essere completamente maturi. Per la pro-<br />
39
40<br />
duzione <strong>di</strong> seme le piante vengono sra<strong>di</strong>cate a mano o con l’ausilio <strong>di</strong> una zappa. In questo modo<br />
la maggioranza dei baccelli rimane attacata alla pianta ma, generalmente, si procede anche ad<br />
una ricerca dei baccelli rimasti nel terreno. Le piante, poste su appositi sostegni o graticci, vengono<br />
lasciate ad essiccare in campo per 1-2 giorni.<br />
Ai fini della raccolta il clima deve essere asciutto. Infatti, in presenza <strong>di</strong> eccessiva umi<strong>di</strong>tà<br />
i semi possono germinare all’interno dei baccelli che, in più, possono andare incontro a deiscenza<br />
anche subito dopo la raccolta. I baccelli possono essere sgusciati imme<strong>di</strong>atamente o lasciati ad<br />
essiccare al sole per 1-4 settimane.<br />
Generalmente la sgusciatura viene eseguita manualmente ed i semi conservati in sacchi <strong>di</strong><br />
paglia o vasi <strong>di</strong> terracotta. Per limitare i danni dagli attacchi <strong>di</strong> tonchi, ai semi immagazzinati<br />
può essere aggiunta cenere od olii vegetali come quelli <strong>di</strong> palma e <strong>di</strong> karité.<br />
Le rese in semi sgusciati sono molto variabili e possono essere compresa fra 0.5 e 1.1 t ha -<br />
1 . In letteratura sono state riscontrate rese massime <strong>di</strong> 4.4 t ha -1 . In consociazione con la canna<br />
da zucchero la VS può fornire circa 2.0-2.4 t ha -1 <strong>di</strong> semi freschi (50% <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà). In Africa si<br />
ritengono me<strong>di</strong>e le rese <strong>di</strong> 0.6-0.8 t ha -1 con minimi <strong>di</strong> <strong>di</strong> 0.05-0.11 t ha -1 registrati in Zambia e<br />
massimi <strong>di</strong> 3.6 t ha -1 registrate in Zimbabwe.<br />
Avversità: La colture <strong>di</strong> VS non sono generalmente attaccate da particolari avversità; Tuttavia,<br />
fra le principali si ricordano:<br />
Funghi: Ascochyta phaseolorum (colpisce prevalentemente le foglie), Cercospoea canescens,<br />
C. voandzeia, Coletotrichum capsici, Corticium solani, Elsinoe sp., Erysiphe polygoni, Fusarium<br />
oxysporium, Leptosphaerulina trifolii, Meliola vignaegrauilis, Phaseolus manihotis (marciumi<br />
ra<strong>di</strong>cali), Phyllostica voandzeiae, Sclerotium rolfsii, Rhizoctonia bataticola, Sphaerotheca<br />
voandzeiae, Synchytrium dolichi.<br />
Insetti: Cica<strong>di</strong><strong>di</strong> come Empoasca facialis, Hilda patruelis, Diacrisia maculosa, Lamprosema<br />
in<strong>di</strong>cata. Fra gli insetti che colpiscono i semi immagazzinati: Callosobruchus maculatus, C.<br />
subinnotatus, Ctenocampa hilda, Piezotrachelus ugandanus.<br />
Virosi: virus del mosaico dell’erba me<strong>di</strong>ca, del fagiolo e del trifoglio bianco.<br />
Nemato<strong>di</strong>: Meloidogyne javanica, Meloidogyne sp..<br />
Composizione: I semi maturi contengono in me<strong>di</strong>a: 17,8% <strong>di</strong> proteine, 6,7% <strong>di</strong> grassi, 72,2% <strong>di</strong><br />
carboidrati, 3,3% <strong>di</strong> ceneri. Ulteriori dettagli sulla composizine chimica sono riportati nelle<br />
tabelle 1 e 2.
Cromosomi: 2n = 18<br />
FAGIOLO ALATO<br />
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.<br />
Nomi comuni: Inglese: winged bean, asparagus pea, four-angled bean, goa bean, Manila bean,<br />
princess pea; Francese: haricot de Birmanie.<br />
Origine e <strong>di</strong>ffusione: Il centro <strong>di</strong> origine <strong>di</strong> questa leguminosa non è stato ancora ben definito<br />
ma si sostiene che sia proveniente dalle Mauritius e dal Madagascar. La prima segnalazione <strong>di</strong><br />
questa leguminosa risale alla prima metà del XVII secolo nell’arcipelago delle Molucche da<br />
dove, secondo alcuni autori ne sarebbe originaria e da cui si sarebbe <strong>di</strong>ffusa nelle altre parti del<br />
mondo. È estesamente coltivato in In<strong>di</strong>a, Birmania, Indonesia e Nuova Guinea mentre, solo<br />
recentemente è stato introdotto in Africa. Nel mondo è <strong>di</strong>ffusa un’altra specie <strong>di</strong> Psophocarpus,<br />
P. palustris. Tuttavia, la prima è quella più utilizzata soprattutto per la sua maggiore produzione.<br />
Spesso il fagiolo alato viene confuso con una specie morfologicamente molto simile (Lotus<br />
tetragonolobus L. sin. Tetragonolobus purpureus Moench.) che cresce spontaneamente nel bacino<br />
del Me<strong>di</strong>terraneo. Di questa specie si utilizzano occasionalmente i baccelli immaturi o<br />
viene utilizzata come verdura.<br />
Non sono <strong>di</strong>sponibili dati sulla produzione mon<strong>di</strong>ale poiché lo Psophocarpus è una specie<br />
coltivata quasi esclusicamente per consumo locale e per la sussistenza.<br />
Importanza ed utilizzazione: Il fagiolo alato è principalmnete coltivato per la produzione <strong>di</strong><br />
baccelli freschi (consumati cru<strong>di</strong>) e per la sua utilizzazione come verdura cotta. Foglie, germogli<br />
e fiori sono utilizzati come componenti <strong>di</strong> zuppe. La granella secca è utilizzata per la preparazione<br />
<strong>di</strong> un alimento fermentato, il “tampeh”, popolare soprattutto in Indonesia. L’olio estratto dai<br />
semi, molto simile a quello <strong>di</strong> soia, è utilizzato per cucinare, come combustibile per l’illuminazione<br />
e per la fabbricazione <strong>di</strong> sapone. I panelli <strong>di</strong> sansa sono utilizzati come foraggio.<br />
Nell’Isola <strong>di</strong> Giava i semi arrostiti sono consumati insieme al riso ed i fiori sono aggiunti<br />
in varie pietanze per conferirgli un colore bluastro e per aromatizzare i funghi. Sempre nell’Isola<br />
<strong>di</strong> Giava le giovani piantine attaccate dal fungo Synchytrium psophocarpi sono considerate una<br />
ghiottoneria.<br />
41
42<br />
Distribuzione geografica del fagiolo alato.<br />
Figura 11. Psophocarpus tetragonolobus: A. foglia; B. fiore visto ventralmente; C. fiore in sezione<br />
longitu<strong>di</strong>nale; D. baccello; E. seme.
In Nuova Guinea le ra<strong>di</strong>ci tuberizzate sono consumate crude o bollite. Le piante intere<br />
trinciate sono utilizzate come fertilizzante e per la pacciamatura.<br />
A causa della eccezionale nodulazione il fagiolo alato è considerato anche una buona<br />
coltura per ripristinare la fertilità. Alcune esperienze hanno messo in evidenza notevoli incrementi<br />
<strong>di</strong> resa (fino al 50%) della canna da zucchero in succesione con lo Psophocarpus. Questa<br />
specie può essere utilizzata anche come coltura da copertura nelle piantagioni <strong>di</strong> gomma.<br />
Il fagiolo alato viene utilizzato anche nella me<strong>di</strong>cina popolare. In Birmania i semi sono<br />
considerati afro<strong>di</strong>siaci e le ra<strong>di</strong>ci vengono impiegate come cataplasma per curare le vertigini. Le<br />
foglie sono utilizzate in Malesia contro il vaiolo.<br />
Caratteristiche botaniche e morfologiche: Pianta perenne rampicante, glabra, comunemente<br />
utilizzata come annuale; ra<strong>di</strong>ci numerose, quelle laterali crescono orizzontalmente al terreno a<br />
modesta profon<strong>di</strong>tà, in seguito si ingrossano <strong>di</strong>ventando tuberizzate <strong>di</strong> aspetto nodoso; gli steli<br />
crescono circa 2-3 m per anno; le foglie sono trifogliate, foglioline ampiamente ovate, sottili,<br />
margine intero, lunghe 8-15 cm, larghe 4-12 cm, provviste <strong>di</strong> stipole bipartite; fiori posti in<br />
racemi ascellari (lunghi fino a 15 cm) in numero <strong>di</strong> 2-10; corolla grande, vessillo ampio, solcato,<br />
auricolato alla base, <strong>di</strong> colore grigio chiaro sul retro, bianco o blu chiaro all’interno, <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong><br />
2,5-4,0 cm; ali irregolarmente obovate; stame vessillare libero alla base saldato con gli altri a<br />
In senso orario: pianta rampicante con baccelli<br />
immaturi, particolare del baccello, particolare del fiore.<br />
43
44<br />
Del fagiolo alato si consumano anche le ra<strong>di</strong>ci<br />
tuberizzate che si raccolgono alla fine del ciclo<br />
riproduttivo.<br />
metà lunghezza; antere uniformi; stilo lungo,<br />
ricurvo; stigma globoso terminale, peloso;<br />
baccelli lunghi 15-30 cm e larghi 2,5-3,5<br />
cm, sud<strong>di</strong>visi in 2 valve, a sezione più o meno<br />
quadrata, presenza <strong>di</strong> 4 rilievi irregolarmente<br />
seghettati nel senso della lunghezza; presenza<br />
<strong>di</strong> 8-17 semi parzialmente immersi nel<br />
tessuto dei baccelli, <strong>di</strong> forma globosa, lunghi<br />
fino ad 1 cm, <strong>di</strong> colore bianco, giallo,<br />
marrone o nero, con la superficie liscia e lucida;<br />
peso <strong>di</strong> 100 semi circa 30 g.<br />
Ecologia: Lo Psophocarpus è coltivato nei<br />
tropici umi<strong>di</strong> dal livello del mare fino ad altitu<strong>di</strong>ni<br />
<strong>di</strong> 2000 m. Si adatta a molti tipi <strong>di</strong><br />
suolo ma necessita <strong>di</strong> un ottimo drenaggio.<br />
Si considera che il fagiolo alato necessiti <strong>di</strong><br />
una pluviometria annua minima superiore ai<br />
1500 mm e che quella ottimale superi i 2500<br />
mm (fino a 4100 mm). Può essere coltivato<br />
anche nei tropici semi-ari<strong>di</strong> con il ricorso<br />
all’irrigazione E’ una specie sensibile alla<br />
ari<strong>di</strong>tà ed alla salinità. L’induzione a fiore<br />
avviene in regime <strong>di</strong> giorno corto mentre la<br />
temperatura non sembra influire in maniera<br />
determinante su questo parametro.<br />
Nelle aree <strong>di</strong> maggiore <strong>di</strong>ffusione della<br />
leguminosa, la nodulazione è molto abbondante<br />
(in me<strong>di</strong>a più <strong>di</strong> 400 noduli per per<br />
pianta); il ceppo <strong>di</strong> Rhizobium è quello della Vigna unguiculata spp. unguiculata. I noduli possono<br />
raggiungere il <strong>di</strong>ametro 1,2 cm ed un peso <strong>di</strong> 0,6 g.<br />
La temperatura me<strong>di</strong>a richiesta dalla specie è <strong>di</strong> 15,4-27,5°C mentre per il pH i valori sono<br />
<strong>di</strong> 4,3-7,5.<br />
Tecnica colturale: Come molte altre colture <strong>di</strong>ffuse prevalentemente nei tropici, il fagiolo alato<br />
viene spesso coltivato in consociazione. In Nuova Guinea viene consociato con patata dolce,<br />
canna da zucchero, taro, banana, ortaggi ed altri legumi. In Indonesia viene coltivato ai bor<strong>di</strong><br />
delle risaie.<br />
La semina avviene prima della stagione <strong>di</strong> maggiore pluviometria. I semi vengono posti<br />
ad una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> 2,5-7,5 cm in buchette <strong>di</strong>stanti 60 x 120 cm vicino a supporti per consentire<br />
alla pianta <strong>di</strong> arrampicarsi. Nel caso che il fagiolo alato venga utilizzato come copertura i sostegni<br />
sono necessari. Per la produzione <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ci tuberizzate le piante sono <strong>di</strong>stanziate sulla fila da<br />
10 cm. Per favorire la produzione <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ci tuberizzate è pratica comune il <strong>di</strong>radamento dei fiori.<br />
La produzione delle piante coltivate su supporti è quasi doppia rispetto a quelle prive.<br />
Durante il primo mese dalla semina la coltura richiede molte attenzioni soprattutto nei<br />
riguar<strong>di</strong> del controllo delle infestanti, della concimazione e delle lavorazione del terreno. In<br />
seguito le piante crescono molto velocemente. Dopo la fruttificazione le estremità delle piante<br />
muoiono ma nuovi germogli vengono emessi lateralmente consentendo alla pianta <strong>di</strong> compor-
tarsi come perenne. Inoltre, le riserve <strong>di</strong> nutrienti immagazzinati nelle ra<strong>di</strong>ci consentono la ripresa<br />
della vegetazione dopo un periodo <strong>di</strong> pluviometria sub-ottimale per la specie o dopo la<br />
raccolta.<br />
Raccolta:<br />
Baccelli freschi e semi secchi: I primi baccelli freschi sono pronti per la raccolta dopo circa 6-10<br />
settimane dalla semina (2 settimane dopo la fecondazione). Dopo altre 3 settimane i baccelli<br />
<strong>di</strong>ventano fibrosi e non più commestibili e, trascorse ulteriori 3 settimane i semi raggiungono la<br />
maturità. In me<strong>di</strong>a, la produzione <strong>di</strong> granella secca si può ottenere dopo circa 160-270 d dalla<br />
semina. In seguito alla prima raccolta la pianta prosegue la produzione <strong>di</strong> baccelli ma con una<br />
resa progressivamente decrescente. Per questo motivo, il fagiolo alato viene spesso coltivato<br />
come specie annuale. Nel caso si intenda sfruttare le caratteristiche <strong>di</strong> pianta perenne, <strong>di</strong>venta<br />
necessaria una somministrazione <strong>di</strong> fertilizzanti ogni 2-3 settimane al fine <strong>di</strong> garantire una produzione<br />
<strong>di</strong> circa 25 baccelli per pianta ogni 5-6 d.<br />
Le rese me<strong>di</strong>e sono <strong>di</strong> 0,5-1,0 t ha -1 ; quelle maggiori, fino a 2,0 t ha -1 si registrano in<br />
Nigeria, Malesia, Nuova Guinea ed Australia occidentale.<br />
Ra<strong>di</strong>ci tuberizzate: Le ra<strong>di</strong>ci si raccolgono dopo circa 4-8 mesi dalla semina quando hanno<br />
raggiunto il <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> 2-4 cm e la lunghezza <strong>di</strong> 8-12 cm. Le rese sono molto variabili, da 2 a 10<br />
t ha-1<br />
Avversità: In colture consociate per orti famigliari o nell’agricoltura itinerante la specie, generalmente,<br />
non subisce particolari danni da attacchi parassitari. Tuttavia, i patogeni e gli insetti<br />
più frequentemente riscontrati sul fagiolo alato sono i seguenti:<br />
Funghi: Cercospora arantae, C. canescens, C. psophocarpi, C. cruenta, Corticium solani,<br />
Erysiphe cichoracearum, Oi<strong>di</strong>um sp., Synchytrium psophocarpi.<br />
Insetti: Occasionalmente si riscontrano danni da minatori <strong>di</strong> baccelli o delle foglie. Altrettanto<br />
occasionali risultano gli attacchi da ragnetti.<br />
Virosi: Virus del mosaico della Crotolaria hirsuta, YMV (yellow mosaic virus) del Cajanus<br />
cajan.<br />
Nemato<strong>di</strong>: Meloidogyne javanica, M. incognita; quest’ultimo in grado <strong>di</strong> provocare gravi ripercussioni<br />
negative sia sulla resa che sulla qualità del seme.<br />
Composizione:<br />
Semi secchi: acqua 6-25%, proteine 36,4%, grassi 18,8%, carboidrati 40,5%, fibra 5-12%, ceneri<br />
4,4%.<br />
Baccelli freschi: acqua 76-92%, proteine 18,1%, grassi 1,0%, carboidrati 72,5%, fibra 15,2%,<br />
ceneri 5,7%.<br />
Ulteriori dettagli sulla composizine chimica sono riportati nelle tabelle 1 e 2.<br />
45
FAGIOLO D’EGITTO<br />
Lablab purpureus (L.) Sweet<br />
Sinonimi: Dolichos lablab L., Dolichos purpureus L., Lablab niger Me<strong>di</strong>k., Lablab vulgaris<br />
Savi., Dolichos albus Lour., Dolichos cultratus Thumb., Dolichos lablab var. hortensis Schwenf<br />
& Muschler, Lablab leucocarpus Davi, Lablab nankinikus Davi, Lablab perennans DC., Lablab<br />
vulgaris var. niger DC.<br />
Cromosomi: 2n = 22, 24<br />
Nomi comuni: Inglese: hyacinth bean, bonavist chicaros, chink, egyptian bean, pharao, seem,<br />
val; Francese: dolique, pois d’Egypte; Spagnolo: dolico lablab.<br />
Altri nomi: fiwi (Africa orientale); kashrengeig (Sudan); amora-guaya (Etiopia); anunula, ararai,<br />
chapprada, chikkudu, field bean, mochair, parta (In<strong>di</strong>a); agaya, apikat, batao, hab (Filippine);<br />
kara-karci (Malesia); kerana (Indonesia); tua nang (Tailan<strong>di</strong>a); caraota chivata, gallinazo blanco<br />
(Venezuela); finjol bocon (Perù); poroto bombero (Cile).<br />
Origine e <strong>di</strong>ffusione: Alcuni autori in<strong>di</strong>cano l’origine del Lablab purpureus (LP) in In<strong>di</strong>a o<br />
nell’Asia sud orientale. Altri invece in<strong>di</strong>cano l’Africa come centro <strong>di</strong> <strong>di</strong>versificazione. E’ una<br />
specie <strong>di</strong>ffusa in tutte le aree tropicali e subtropicali del pianeta. Negli Stati Uniti è principalmente<br />
coltivata come specie ornamentale annuale nei giar<strong>di</strong>ni dai quali spesso sfugge naturalizzandosi<br />
nelle aree limitrofe.<br />
Importanza ed utilizzazione: Questa specie viene coltivata principalmente per l’alimentazione<br />
umana. I baccelli possono essere consumati freschi o cucinati come verdura. Anche i semi secchi<br />
possono essere utilizzati per l’alimentazione umana; in In<strong>di</strong>a per esempio, insieme ad altri<br />
legumi, vengono impiegati per la preparazione <strong>di</strong> dolci fritti (“tanniah”). Le piante inoltre possono<br />
essere coltivate per foraggio per l’alimentazione <strong>di</strong> caprini, bovini, suini e, in miscela con<br />
avena somministrate ai cavalli. La produzione <strong>di</strong> biomassa fresca è quasi doppia rispetto a quella<br />
prodotta dal fagiolino dall’occhio (v.); gli steli sono consistenti e più fibrosi e le foglie molto<br />
succulente. In alcune aree, dopo aver tenuto a bagno i semi per una notte, si fanno germinare ed<br />
in seguito, i germinelli così ottenuti, vengono essiccati al sole e conservati. I semi freschi contengono<br />
acido prussico e sono considerati velenosi; per questo motivo, prima della loro consumazione<br />
devono essere sottoposti a processi <strong>di</strong> cottura. Molto spesso i semi più scuri contengono<br />
anche cianuro.<br />
47
48<br />
Figura 12. Lablab purpureus: A. foglia; B. fiore in sezione longitu<strong>di</strong>nale; C. baccello; D. seme.
A sinistra: semi e baccelli immaturi. A destra: semi maturi.<br />
Nella me<strong>di</strong>cina popolare i semi sono utilizzati contro l’alessia (afasia sensoriale), come<br />
antispasmotico, afro<strong>di</strong>siaco, antipiretico e stomachico ed utilizzati nella menopausa. Le infusioni<br />
<strong>di</strong> foglie sono utilizzate contro le coliche e la gonorrea. In Malesia le foglie <strong>di</strong> LP, insieme a<br />
farina <strong>di</strong> riso e curcuma, vengono impiegate per la preparazione <strong>di</strong> un cataplasma. Il succo<br />
estratto dai baccelli freschi viene usato per applicazioni locali su orecchi infiammati e per il mal<br />
<strong>di</strong> gola.<br />
Caratteristiche botaniche e morfologiche: Il fagiolo d’Egitto può comportarsi come perenne<br />
ma viene coltivato soprattutto come specie annuale o biennale. Il portamento è molto variabile:<br />
l’aspetto è generalmente arbustivo rampicante.<br />
Gli steli sono volubili, pelosi o glabri, lunghi 2-3 m ma spesso raggiungono anche i 10 m;<br />
si possono riscontrare genotipi nani ed arborescenti. Le foglie sono pinnate e trifogliate con<br />
foglioline obovate; quelle laterali <strong>di</strong> forma irregolare, lunghe 7,5-15 cm e larghe quasi altrettanto,<br />
acuminate. Fiori da viola a rosa o bianchi in numero <strong>di</strong> 2-4 posti su un lungo racemo che si<br />
<strong>di</strong>parte da ogni nodo del fusto lunghi 2,5 cm; baccelli appiattiti o gonfi, lunghi 5-20 cm, larghi 1-<br />
5 cm, pubescenti o lisci, cartacei, <strong>di</strong>ritti o più raramente ricurvi, colore verde o viola; semi in<br />
numero <strong>di</strong> 3-6 per baccello, lunghi 0,6-1,3 cm, schiacciati, oblunghi con l’estremità<br />
rotondeggiante, <strong>di</strong> colore nero o bianco nelle varietà a fiore bianco; ilo e rafe prominenti;<br />
germinazione epigea. Fra i vari genotipi si possono riscontrare notevoli variazioni morfologiche,<br />
alcune delle quali sono state in<strong>di</strong>cate come caratteristiche <strong>di</strong> sottospecie. La variabilità può essere<br />
riscontrata con maggiore frequenza nella forma, <strong>di</strong>mensioni e colore dei baccelli (ver<strong>di</strong>, bianchi,<br />
viola o violetti ai margini, <strong>di</strong> consistenza fibrosa o teneri); forma, <strong>di</strong>mensioni e colore dei<br />
semi (bianchi o gialli, neri o rossastri-violetti); caratteristiche dei fiori (bianchi, rosa o viola);<br />
<strong>di</strong>mensioni della corolla ed intensità del profumo; lunghezza del peduncolo; abbondanza dei<br />
fiori; panicoli situati alla estremità <strong>di</strong> un corto peduncolo con 10-20 fiori o su un uno lungo circa<br />
30 cm e resistente provvisto, <strong>di</strong> 20-30 fiori; colore delle foglie (da ver<strong>di</strong> a viola o punteggiate <strong>di</strong><br />
viola; piante da glabre a quasi tomentose.<br />
Le varietà “Darkness” a semi neri e “Daylight” a fiori bianchi sono coltivate quasi esclusivamente<br />
come ornamentali. I genotipi “Highworth” e “Rongai” (quest’ultima a fioritura tar<strong>di</strong>va)<br />
sono impiegate come specie da foraggio soprattutto in Australia.<br />
49
50<br />
In base alla suddetta variabilità il fagiolo d’Egitto può essere classificato in tre sottospecie:<br />
1. Lablab purpureus ssp. uncinatus Verdcourt - Infiorescenze piccole, legumi gran<strong>di</strong>, lunghi<br />
circa 4 cm e larghi 1,5 cm.<br />
Sinonimi: Lablab uncinatus A. Rich., Dolichos lablab forma uncinatus Penzig,<br />
Dolichos uncinatus Schweinf., Dolichos lablab var. uncinatus (Schweinf.) Chiov.,<br />
Lablab niger var. uncinatus (A. Rich.) Cuf., Lablab niger var. crenatifructus Cuf..<br />
2. Lablab purpureus ssp. bengalensis (Jacq.) Verdcourt - Baccelli simili a quelli del fagiolo <strong>di</strong><br />
Lima (Phaseolus lunatus).<br />
Sinonimi: Dolichos bengalensis Jacq., Dolichos lablab ssp. bengalensis (Jacq.)<br />
Rivals, Lablab niger ssp. bengalensis (Jacq.) Cuf..<br />
3. Lablab purpureus var. rhomboideus (Schinz) Verdcourt - Foglie glabre, bratteole larghe e<br />
baccelli leggermente pubescenti.<br />
Sinonimi: Dolichos lablab var. rhomboideus Schinz, Dolichos pearsonii Hutch..<br />
Ecologia: Il LP viene coltivato in aree con temperature me<strong>di</strong>e variabili fra 18 e 30°C; temperature<br />
superiori non sembrano influenzare negativamente la coltura. Coltivazioni <strong>di</strong> fagiolo dall’occhio<br />
sono state riscontrate anche in aree con temperature minime annuali <strong>di</strong> 9-10°C. La<br />
coltura richiede una certa <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> acqua (meteorica o <strong>di</strong> irrigazione) durante i primi 60-<br />
90 d dalla semina. In seguito la specie tollera con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> ari<strong>di</strong>tà continuando nell’accrescimento<br />
e nella produzione <strong>di</strong> fiori per molti mesi. Questa caratteristica gli è conferita dall’apparato<br />
ra<strong>di</strong>cale particolarmente profondo ed in grado <strong>di</strong> sfruttare al massimo tutta l’umi<strong>di</strong>tà residua<br />
del terreno. La coltura non tollera le acque salmastre ed il ristagno idrico.<br />
Si possono riscontrare sia varietà a giorno corto che lungo. L’induzione a fiore nella maggior<br />
parte dei genotipi non risulta influenzata dalla temperatura.<br />
La leguminosa può essere coltivata sia in terreni sabbioso-limosi che in quelli argillosi. In<br />
In<strong>di</strong>a la coltura è <strong>di</strong>ffusa in aree aride fino ad una altitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> 1.830 m slm con una pluviometria<br />
<strong>di</strong> 600-900 mm annui. Il freddo colpisce soprattutto le foglie ma, brevi perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> basse temperature<br />
non comportano gravi effetti negativi alla coltura. Il pH ottimale è compreso fra 5,0 e 6,5.<br />
Tecnica colturale: Le tecniche <strong>di</strong> semina impiegate possono essere le più varie in relazione alla<br />
intensità colturale. Secondo la modalità utilizzata occorrono 20-70 kg ha -1 <strong>di</strong> seme. In coltura<br />
pura, intervendo <strong>di</strong> 1 o 2 zappature per controllare le infestanti, la coltura viene utilizzata come<br />
miglioratrice del terreno. Le varietà arbustive o semiarbustive sono seminate a file <strong>di</strong>stanti 90<br />
cm. Distanze <strong>di</strong> 90 x 90 cm si impiegano per semine a postarella utilizzando 6-10 semi per<br />
buchetta. In questo caso, dopo circa un mese si <strong>di</strong>rada a 4 piante le quali vengono lasciate libere<br />
<strong>di</strong> accrescersi su sostegni <strong>di</strong> vario tipo. La leguminosa produce una <strong>di</strong>screta quantità <strong>di</strong> biomassa<br />
che può essere facilmente essiccata in considerazione del basso contenuto <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà.<br />
Il LP può essere consociato con il mais in una proporzione del 10-20% e concimato con<br />
pollina ad<strong>di</strong>zionata con 10% in peso <strong>di</strong> superfosfato. Subito dopo l’emergenza il LP cresce<br />
molto lentamente in modo tale da non competere eccessivamente con il cereale. Quando il mais<br />
si approssima alla maturazione la leguminosa inizia ad arrampicarsi sui fusti ed a crescere in<br />
modo vigoroso. Dopo la raccolta del mais il fagiolo d’Egitto è in grado <strong>di</strong> coprire tutta la superficie<br />
del terreno formando uno spessore <strong>di</strong> biomassa alta 40-70 cm. La leguminosa fiorisce per<br />
molti mesi e, poiché i baccelli non sono deiscenti, la raccolta può essere eseguita al momento<br />
più conveniente. L’eccessiva umi<strong>di</strong>tà favorisce l’insorgenza <strong>di</strong> malattie e quin<strong>di</strong> si deve preve-
dere la semina del LP per far coincidere la fioritura con la stagione asciutta. Il mais consociato<br />
con il LP è in grado <strong>di</strong> fornire produzioni quasi il doppio rispetto alla coltura pura.<br />
In Africa il LP precede i cereali ma in alcune zone si trova frequentemente in rotazione<br />
dopo le colture <strong>di</strong> sorgo o <strong>di</strong> cotone. In Kenya la coltura è seminata dopo l’inizio della stagione<br />
delle piogge; i quantitativi <strong>di</strong> seme impiegati sono 20-30 kg ha -1 in file <strong>di</strong>stanti 75 x 100 cm. In<br />
In<strong>di</strong>a è comune la consociazione con il miglio perlato, o miglio a candela, (Pennisetum<br />
americanum) nelle aree semi-aride con pluviometria <strong>di</strong> 600-800 mm. In questo caso si <strong>di</strong>stribuiscono<br />
alla coltura 45 kg ha -1 <strong>di</strong> N e 20 kg ha -1 <strong>di</strong> P 2 O 5 in seguito alla prima scerbatura.<br />
Allo scopo <strong>di</strong> migliorare la fertilità del terreno, il LP può essere consociato in misura del<br />
10% con il caiano (Cajanus cajan). Dopo circa 120 d la consociazione può essere pascolata dai<br />
bovini. Il fagiolo d’Egitto inoltre, può essere consociato con il caffé o costituire un ottimo tappeto<br />
erboso (se tagliato frequentemente) nei frutteti.<br />
Raccolta: La raccolta si effettua quando i baccelli sono secchi e <strong>di</strong> colore giallastro. Secondo i<br />
genotipi e l’ambiente <strong>di</strong> coltivazione la prima maturazione può avvenire da 60 a 300 d dalla<br />
semina. Dato il portamento della pianta la raccolta è <strong>di</strong>fficile e le rese non sono generalmente<br />
elevate. I genotipi rampicanti forniscono le migliori rese quando sono coltivati in coltura pura.<br />
Le piante sono sra<strong>di</strong>cate a mano e messe ad essiccare al sole. I baccelli maturi possono<br />
essere raccolti <strong>di</strong>rettamente in campo ottenedo così un seme <strong>di</strong> migliore qualità. La trebbiatura<br />
avviene battendo le piante con bastoni <strong>di</strong> legno, utilizzando rulli o facendo calpestare le piante<br />
dai bovini (In<strong>di</strong>a). In seguito i semi vengono setacciati per eliminare i residui ed i semi delle<br />
infestanti.<br />
Il fagiolo d’Egitto ha la tendenza a comportarsi da autoriseminante, spesso in modo tale da<br />
essere considerato come una infestante (Haiti).<br />
La resa me<strong>di</strong>a del LP è <strong>di</strong> circa 0,5 t ha -1 quando coltivato in consociazione e <strong>di</strong> 1,5 t ha -1<br />
in coltura pura. In In<strong>di</strong>a le rese in baccelli freschi raggiungono 2,6-4,5 t ha -1 . Le rese in foraggio<br />
variano fra 5 e 10 t ha -1 .<br />
Avversità: Le colture <strong>di</strong> LP non sono generalmente colpite in modo grave dalle avversità. Alcune<br />
varietà sono colpite da fusariosi e da nemato<strong>di</strong>.<br />
Funghi: I funghi che interessano il dolico sono moltissimi. I principali sono: Alternaria tenuis,<br />
Ascochyta dolichi, Cercospora canescens, Corticium solani, Elsinoe dolichi, Phyllostica dolichi,<br />
Septoria sp., Uromyces appen<strong>di</strong>culatus.<br />
Batteri: Macrophomina phaseoli, Xanthomonas phaseoli.<br />
Insetti: I più comuni sono: Heliothis armigera, Exelastis atomosa e Maruca testualis. I fiori<br />
sono colpiti dai <strong>di</strong>tteri del genere Mylabris. Le piantine possono essere <strong>di</strong>strutte dalle larve <strong>di</strong><br />
Schizonycha sp.. Si ricorda inoltre attacchi alle foglie da parte della Cerotoma ruficormis e<br />
dell’afide Coptasoma eribraria.<br />
Virosi: Alcune virosi del mosaico, AMV (alfalfa mosaic virus), ACMV (alsike clover mosaic<br />
virus), BCRV (bean chlorotic ringspot virus), BTSV (Brazilian tobacco streak virus).<br />
Nemato<strong>di</strong>: Aphelenchoides becaudatus, Caconema ra<strong>di</strong>cicola, Heteronema glycines,<br />
Meloidogyne incognita acrita, M. javanica, Pratylenchus brachyurus, Rotylenchus reniformis.<br />
51
52<br />
Altre: Piante parassite del genere Striga (S. asiatica, S. gesnerioides, S. hermonthica) che possono<br />
essere controllate dal batterio Bacterium cereus var. thuringensis.<br />
Composizione: La composizione me<strong>di</strong>a dei semi secchi è la seguente: proteine 25,1%, grassi<br />
1.7%, carboidrati 68,9%, fibra 7,8%, ceneri 4%. Ulteriori dettagli sulla composizine chimica<br />
sono riportati nelle tabelle 1 e 2.
FAGIOLO DI LIMA<br />
Phaseolus lunatus L.<br />
Sinonimi: Phaseolus limensis Macf., Phaseolus inamoenus L., Phaseolus bipunctatus Jacq.<br />
Cromosomi: 2n = 22<br />
Nomi comuni: Inglese: Lima bean, Sieva bean, butter bean, Madagascar bean, sugar bean,<br />
Towe bean, Birmania bean, Rangoon bean; Francese: haricot de Lima; Spagnolo: judía de Lima.<br />
Altri nomi: akpaka, kokondo (Africa occidentale); apatrani (Ghana); awuje (Nigeria); maharage<br />
(Africa orientale); abangbang, chuku (Uganda); toaj (Sudan); lubia (Egitto); curry bean (Africa);<br />
dafal, double bean lobia, sem (In<strong>di</strong>a); hanichvela, zabache (Filippine); kachange china (Malesia);<br />
lajang koakara (Indonesia); khasu kollu (Tamil); rothud, hambala (Sri Lanka); tua rachamat<br />
(Tailan<strong>di</strong>a); avitas poroto (Perù); poroto de manteca, poroto de Lima (Argentina); frijol comba<br />
(Messico).<br />
Origine e <strong>di</strong>ffusione: Specie nativa dell’America tropicale (Messico, Guatemala, Brasile del<br />
sud, Perù e Argentina) è stata riscontrata in alcuni siti archeologici in Perù datati 6000-5000 anni<br />
A.C.. Il fagiolo <strong>di</strong> Lima a semi piccoli invece, è stato trovato in Messico in reperti archeologici<br />
datati 500-300 anni A.C.. Gli Spagnoli portarono questa leguminosa nelle Filippine e da qui in<br />
Asia da dove si <strong>di</strong>ffuse più tar<strong>di</strong> in Africa.<br />
Phaseolus lunatus L. var silvester Baudet è considerata la specie spontanea del fagiolo <strong>di</strong><br />
Lima riscontrabile in Messico meridonale e Guatemala.<br />
Attualmente il Phaseolus lunatus (PhL) è estesamente coltivato negli Stati Uniti, nel Canada<br />
meri<strong>di</strong>onale ed in tutta l’America Latina per inscatolamento, surgelazione e come prodotto<br />
fresco.<br />
Importanza ed utilizzazione: Il fagiolo <strong>di</strong> Lima viene coltivato per la produzione <strong>di</strong> semi ver<strong>di</strong><br />
(freschi) o secchi consumati in vario modo. La granella è commercializzata fresca od essiccata,<br />
inscatolata o surgelata. I baccelli ver<strong>di</strong> <strong>di</strong> alcune varietà, così come i germinelli, sono consumati<br />
come verdura.<br />
53
54<br />
Figura 13. Phaseolus lunatus: A. foglia; B. fiore; C. fiore in sezione longitu<strong>di</strong>nale; D. baccello; E.<br />
seme.
I semi maturi contengono il glucoside<br />
lutanina (o phaseololutanina). In con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
adeguata umi<strong>di</strong>tà o quando i tessuti vengono<br />
schiacciati o macinati un enzima presente nei semi<br />
provoca la liberazione <strong>di</strong> HCN. L’enzima può<br />
essere <strong>di</strong>sattivato tramite bollitura. Il limite <strong>di</strong><br />
HCN tollerato dalle leggi <strong>degli</strong> Stati Uniti è 100<br />
ppm. Contenuti <strong>di</strong> HCN <strong>di</strong> 800-900 ppm sono<br />
considerati pericolosi per la salute umana. In passato,<br />
i semi con testa colorata in rosso o nero venivano<br />
considerati ricchi in glucosi<strong>di</strong> cianogenici.<br />
Con la selezione, soprattutto negli Stati Uniti, i<br />
contenuti <strong>di</strong> tali sostanze sono stati portati a livelli<br />
<strong>di</strong> sicurezza. La supposizione che i semi bianchi<br />
non contenessero HCN si è rilevata errata non<br />
essendo stata riscontrata nessuna correlazione fra<br />
il colore dei semi ed il contenuto <strong>di</strong> sostanze tossiche.<br />
Ai semi vengono attribuite proprietà<br />
astringenti e sono in<strong>di</strong>cati nella <strong>di</strong>eta <strong>di</strong> persone<br />
febbricitanti. Il decotto <strong>di</strong> baccelli ver<strong>di</strong>, semi e<br />
steli è considerato efficace contro il morbo <strong>di</strong><br />
Bright (nefrite cronica), il <strong>di</strong>abete, l’anasarca e<br />
l’eclampsia. A Java, i semi sono utilizzati come<br />
cataplasma sull’addome per i dolori <strong>di</strong> stomaco.<br />
Caratteristiche botaniche e morfologiche: Pianta<br />
erbacea annuale o perenne. Le forme arbustive<br />
raggiungono un’altezza <strong>di</strong> circa 60 cm mentre,<br />
quelle rampicanti arrivano fino a 4 m. Foglie <strong>di</strong><br />
forma molto variabile, trifogliate, generalmente<br />
pelose; picciolo lungo 8-17 cm; stipole piccole,<br />
triangolari; foglioline da ovate a lanceolate,<br />
acuminate, provviste <strong>di</strong> corti peli sulla pagina inferiore,<br />
lunghe 5-13 cm, larghe 3-9 cm, foglioline<br />
laterali poste obliquamente rispetto a quella<br />
centrale; infiorescenza portata da racemi ascellari<br />
lunghi fino a 15 cm, provvista <strong>di</strong> molti fiori (in<br />
numero <strong>di</strong> 2-4 per ogni nodo); calice campanulato<br />
con denti molto corti; corolla larga 0,7-1,0 cm,<br />
In alto: semi maturi del tipo “Java Beans”<br />
caratterizzati dall’elevato contenuto in HCN.<br />
Sotto: baccelli ver<strong>di</strong> del tipo “Java Beans”.<br />
vessillo verde chiaro, qualche volta violetto, bianco-giallastro o rosato-viola; ali bianche, quando<br />
il vessillo è colorato anche le ali, generalmente lo sono; carena molto allungata in avanti fino<br />
a formare una spirale completa; stami in numero <strong>di</strong> 10, stilo spiralato; baccelli appiattiti, lunghi<br />
5-12 cm larghi fino a 2,5 cm, oblunghi, generalmente incurvati contenenti 2-4 semi, talvolta<br />
deiscenti; semi variabili in forma colore e <strong>di</strong>mensioni, lunghi 1-3 cm, possono essere appiattiti o<br />
rigonfi, <strong>di</strong> colore bianco, crema, marrone, rosso, viola o nero, <strong>di</strong> colore uniforme o screziato (es.<br />
bianco con venature violacee); ilo bianco con linee traslucide che si <strong>di</strong>ramano da questo al bordo<br />
della testa. Peso <strong>di</strong> 100 semi 45-200 g.<br />
55
56<br />
Semi del tipo “Lima beans”, <strong>di</strong><br />
colore bianco e privi <strong>di</strong> HCN.<br />
Chiamati commercialmente “butter<br />
beans”, sono impiegati<br />
dall’industria conserviera per la<br />
preparazione <strong>di</strong> cibi precotti.<br />
Si ritiene che la forma spontanea <strong>di</strong> PhL, Phaseolus lunatus var silvester, sia stata soggetta<br />
a tre linee <strong>di</strong> espansione le quali hanno originato tre sottogruppi o “cultigroup” (cvgr):<br />
1. Cvgr “Potato” o CARIB, corrispondente al Phaseolus bipunctatus Jacq., linea<br />
<strong>di</strong> espansione verso le In<strong>di</strong>e occidentali; caratterizzata da semi più o meno sferici ed<br />
una elevata concentrazione <strong>di</strong> HCN (fino a 900-1000 ppm);<br />
2. Cvgr “Big Lima “o INCA, corrispondente al Phaseolus inamoenus L., linea <strong>di</strong><br />
espansione verso Sud; semi gran<strong>di</strong> ed appiattiti, basso contenuto <strong>di</strong> HCN (25-55<br />
ppm).<br />
3. Cvgr “Sieva” o HOPI, corrispondente al Phaseolus lunatus L. sensu stricto,<br />
linea <strong>di</strong> espansione Nord, contenuto interme<strong>di</strong>o <strong>di</strong> HCN rispetto alle precedenti Cvgr.;<br />
Il Phaseolus ritensis M.E. Jones può essre incrociato con il PhL per migliorare alcune<br />
caratteristiche agronomiche e conferire tolleranza ad alcune avversità. I genotipi <strong>di</strong> PhL si possono<br />
<strong>di</strong>stinguere anche per molte altre caratteristiche tipiche <strong>di</strong> alcune aree <strong>di</strong> <strong>di</strong>versificazione.<br />
Per esempio, i genotipi provenienti dalla Colombia o dalla Bolivia sono caratterizzati da un<br />
elevato contenuto <strong>di</strong> carotene superiore <strong>di</strong> 14-18 volte a quello riscontrabile nelle altre varietà.<br />
Le varietà <strong>di</strong> PhL si possono classificare in tipi eretti o rampicanti. Commercialmente,<br />
sulla base della morfologia, colore e contenuto <strong>di</strong> HCN del seme, si <strong>di</strong>stinguono 4 gruppi:<br />
1. “Java beans”-Semi <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni me<strong>di</strong>e, qualche volta <strong>di</strong> colore rosso-violaceo,<br />
contenenti elevate quantità <strong>di</strong> HCN;<br />
2. “Red Rangoon beans”-Semi piccoli, rossastri, generalmente gonfi, raramente<br />
con macchie violacee, contengono tracce <strong>di</strong> HCN;<br />
3. “White Ragoon” o “White Burma”-In<strong>di</strong>cati talvolta come “Sugar beans”, han-
no semi gonfi, somiglianti ai fagioli comuni, contenenti solo tracce <strong>di</strong> HCN ma,<br />
talvolta, secondo i genotipi i quantitativi possono essere anche leggermente superiori;<br />
4. “Lima beans” o “Butter beans”-Somiglianti a gran<strong>di</strong> fagioli comuni, spesso <strong>di</strong><br />
colore bianco, privi <strong>di</strong> HCN.<br />
Ecologia: Il fagiolo <strong>di</strong> Lima può essere coltivato nella maggior parte dei Paesi tropicali dal<br />
livello del mare fino ad una altitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> 2.400 m. Rappresenta la principale leguminosa da<br />
granella delle foreste umide Africane ed è largamente coltivata in In<strong>di</strong>a e Birmania.<br />
La temperatura ottimale per la germinazione è compresa fra 21 e 27°C; la minima deve<br />
essere superiore ai 15°C. La temperatura me<strong>di</strong>a ottimale è <strong>di</strong> 15,5-21,0°C; livelli termici inferiori<br />
a 13°C ritardano l’accrescimento e temperature notturne superiori a 21°C accellerano la<br />
maturazione ma riducono il numero e le <strong>di</strong>mensioni dei semi. Oltre i 32°C si riscontrano <strong>di</strong>fficoltà<br />
<strong>di</strong> allegagione e cascola dei baccelli.<br />
L’impollinazione è autogama ma è stata riscontrata una impollinazione incrociata fino al<br />
18%.<br />
Il terreno deve essere ben areato e drenato con pH neutro poiché la maggior parte dei<br />
genotipi non tollera l’aci<strong>di</strong>tà. Si riscontrano sia varietà a giorno corto che neutro<strong>di</strong>urne. La<br />
germinazione è epigea.<br />
Tecnica colturale: Le varietà erette possono essere seminate sia a mano che con la seminatrice.<br />
Le <strong>di</strong>stanze sulla file possono variare da 5 a 20 cm e l’interfila da 80 a 90 cm. Le varietà rampicanti<br />
si seminano a postarelle <strong>di</strong>stanti 90-120 cm ponendo 3-4 semi per buchetta. Coltivazioni<br />
intensive <strong>di</strong> PhL rampicante possono prevedere sostegni costituiti da fili metallici posti ad una<br />
altezza <strong>di</strong> circa 2 m allo scopo <strong>di</strong> sostenere sia il fagiolo <strong>di</strong> Lima che altre specie.<br />
Per la semina a file i semi vengono posti nel terreno ad una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> 2,5-5 cm in<br />
quantità variabili secondo il genotipo: per le varietà a semi grossi occorrono 130-170 kg ha -1 <strong>di</strong><br />
granella mentre, per quelle a semi piccoli 60-80 kg ha -1 . I semi secchi rimangono vitali per circa<br />
3 anni.<br />
Il fagiolo <strong>di</strong> Lima necessita <strong>di</strong> terreni fertili e ben lavorati; la sistemazione del terreno in<br />
solchi non risulta idonea alla coltivazione <strong>di</strong> questa leguminosa. Le lavorazioni del terreno devono<br />
essere frequenti al fine <strong>di</strong> controllare le infestanti almeno fino alla fioritura.<br />
Nelle aree temperate la semina viene affettuata in primavera mentre, nei tropici, all’inizio<br />
o durante il primo periodo della stagione delle pioggie.<br />
Questa specie risponde favorevolmente alle concimazioni azotate ed all’apporto <strong>di</strong> letame.<br />
La nodulazione con il Rhizobium specifico non risulta necessaria poiché il ceppo che interessa<br />
il fagiolino dall’occhio riesce a provocare la nodulazione anche in presenza del PhL. Le<br />
giovani piantine del fagiolo <strong>di</strong> Lima sono molto sensibili ai sali solubili nel terreno tanto da<br />
dover porre particolare attenzione a non <strong>di</strong>stribuire i fertilizzanti troppo vicino ai semi (almeno<br />
oltre 8 cm). Secondo la fertilità del terreno si possono <strong>di</strong>stribuire 50-90 kg ha -1 <strong>di</strong> P 2 O 5 e 15-<br />
140 kg ha -1 <strong>di</strong> K 2 O. Se il pH supera il valore <strong>di</strong> 6,5 può essere necassaria la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> 5-<br />
10 kg ha -1 <strong>di</strong> Mn.<br />
Raccolta: Le varietà precoci maturano dopo circa 100 d dalla semina. Le varietà rampicanti a<br />
seme grosso del Perù e del Madagascar necessitano <strong>di</strong> almeno 9 mesi.<br />
I baccelli freschi sono raccolti a mano non appena quest’ultimi hanno quasi raggiunto le<br />
<strong>di</strong>mensioni definitive. Per ottenere rese in semi freschi sod<strong>di</strong>sfacenti le raccolte devono essere<br />
57
58<br />
ripetute molte volte. Questo incide notevolmente sui costi tanto da limitare le coltivazioni <strong>di</strong><br />
PhL per questo tipo <strong>di</strong> produzione. Nelle coltivazioni il cui prodotto viene destinato alla trasformazione,<br />
le piante sono tagliate a macchina ed i baccelli sgranati <strong>di</strong>rettamente in campo. Per<br />
ottenere la massima resa in semi ver<strong>di</strong> le piante vengono raccolte quando soltanto il 3-5% della<br />
granella è <strong>di</strong> colore bianco. I semi ver<strong>di</strong> <strong>di</strong> questa leguminosa sono trasformati imme<strong>di</strong>atamente<br />
dopo la raccolta ma possono essere conservati per 10 d alla temperatura <strong>di</strong> 0°C. I semi bianchi<br />
non sono utilizzabili per l’inscatolamento o per la surgelazione poiché, via via che il colore vira<br />
dal verde al bianco il contenuto <strong>di</strong> amido aumenta mentre quello <strong>degli</strong> zuccheri <strong>di</strong>minuisce.<br />
Per la produzione <strong>di</strong> semi secchi, le piante vengono tagliate meccanicamente la mattina<br />
presto o la sera quando i baccelli sono umi<strong>di</strong>. Dopo aver lasciato le piante ad essiccare per circa<br />
10 d, si procede alla trebbiatura.<br />
Le rese in granella secca variano da 1,0 a 4,5 t ha -1 . In In<strong>di</strong>a, con 12-14 raccolte si possono<br />
raggiungere produzioni <strong>di</strong> 5-8 t ha -1 <strong>di</strong> baccelli ver<strong>di</strong> ma solo 0,2-0,3 t ha -1 <strong>di</strong> granella. La<br />
produzione me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> semi ver<strong>di</strong> è <strong>di</strong> circa 2,5 t ha -1 .<br />
Avversità:<br />
Funghi: Alternaria tenuis, Ascochyta boltshauseri, Diaporthe phaseolorum, Fusarium solani,<br />
Phytophtora phaseoli, Sclerotinia sclerotium, Uromyces phaseoli.<br />
Batteri: Achromobacter lipopticum, Bacillus lathyri, Corynebacterium flaccumfaciens, Erwinia<br />
carotovora, Pseudomonas coadunata, Xanthomonas phaseoli.<br />
Insetti: Gli insetti che colpiscono il fagiolo <strong>di</strong> Lima sono gli stessi del fagiolo comune. Le larve<br />
dell’insetto pantropicale Etiella zinckenella attaccano i baccelli provocando gravi danni. Un<br />
insetto che interessa frequentemente la leguminosa è l’Hylema platura che colpisce soprattutto<br />
i semi a lenta germinazione. Altri insetti sono il coleottero Epilachna varivestis e quelli che<br />
interessano la granella conservata come Callosobruchus chinensis e Acanthoscelides obtectus.<br />
Virosi: AMV (alfalfa mosaic virus), ABMV (asparagus bean mosaic virus), BCR (bean chlorotic<br />
ringspot) CMV (cucumber mosaic virus).<br />
Nemato<strong>di</strong>: Belonolaimus gracilis, Heliocotylenchus <strong>di</strong>gonicus, Meloidogyne arenaria, M. incognita,<br />
M. javanica, Paratylenchus sp., Trichodorus christie.<br />
Composizione: Semi secchi: proteine 25%, grassi 1,5%, carboidrati 73,2%, fibra 4,9%, ceneri<br />
3,4%. Ulteriori dettagli sulla composizine chimica sono riportati nelle tabelle 1 e 2.
FAGIOLO MUNGO<br />
Vigna ra<strong>di</strong>ata (L.) Wilczek<br />
Sinonimi: Azukia ra<strong>di</strong>ata (L.) Ohwi, Phaseolus aureus Roxb., Phaseolus ra<strong>di</strong>atius L., Rudua<br />
aurea (Roxb.) Maekawa, Vigna aureus (Roxb.) Hepper.<br />
Cromosomi: 2n = 22<br />
Nomi comuni: Inglese: green gram, golden gram, mungo bean, mungbean; Francese: haricot<br />
velu; Spagnolo: ju<strong>di</strong>a de Mungo.<br />
Altri nomi: chiroko, chickasano (Africa); kifudu (Uganda); kanyensi (Zambia); lubia chiroko<br />
(Africa orientale); tientsin green bean (Asia); moong, mag mash (In<strong>di</strong>a); cherupayaru (In<strong>di</strong>a,<br />
Malesia); pachapayara pasipayeru (Tamil); minetu (Sri Lanka); too-akeeo, tua-kiev (Tailan<strong>di</strong>a).<br />
Origine e <strong>di</strong>ffusione: Il fagiolo mungo è una coltura conosciuta sin dall’antichità in In<strong>di</strong>a (probabile<br />
centro <strong>di</strong> origine), da dove si è <strong>di</strong>ffusa in tutto il Sud-est asiatico. Recentemente è stata<br />
introdotta nell’Africa centro-orientale, nelle In<strong>di</strong>e occidentali e, marginalmente, negli Stati Uniti<br />
ed in Australia.<br />
I maggiori produttori sono: In<strong>di</strong>a (490.000 t), Tailan<strong>di</strong>a ( 190.00 t), Indonesia (17.000 t),<br />
Filippine (16.000 t), Bangla Desh (14.000 t), Sri Lanka (6.000 t), Taiwan (3.000 t). Estese coltivazioni<br />
<strong>di</strong> V. ra<strong>di</strong>ata (VR) si possono riscontrare in Cina, In<strong>di</strong>a, Sri Lanka e Stati Uniti.<br />
Importanza ed utilizzazione: Il fagiolo mungo è, tra<strong>di</strong>zionalmente, una coltura <strong>di</strong> secondaria<br />
importanza ed è coltivata in aree marginali per fertilità e <strong>di</strong>sponibilità idriche. Spesso segue<br />
colture più importanti ed è realizzata con una tecnica colturale ridotta al solo controllo delle<br />
malerbe senza alcuna concimazione, né irrigazione o controllo dei parassiti.<br />
In In<strong>di</strong>a costituisce una preziosa fonte alimentare. I semi secchi, altamente nutritivi, vengono<br />
utilizzati interi o spezzetati, bolliti od arrostiti. I baccelli freschi sono consumati come<br />
verdura. In Cina e negli Stati Uniti i germogli sono largamente impiegati in molte pietanze. I<br />
germogli vengono ottenuti tenendo i semi in acqua per una notte; in seguito, l’accrescimento dei<br />
germogli avviene in contenitori posti al buio ed al caldo. In queste con<strong>di</strong>zioni i germinelli sono<br />
sciacquati ogni 4-6 ore ed entro 1 settimana sono pronti per essere consumati. Da 1 kg <strong>di</strong> semi<br />
secchi si ottengono 6-8 kg <strong>di</strong> germogli.<br />
59
60<br />
Figura 14. Vigna ra<strong>di</strong>ata: A. branca fruttifera; B. fiore in sezione longitu<strong>di</strong>nale; C. baccello; D. seme.
Il fagiolo mungo viene coltivato anche per<br />
sovescio, come copertura vegetale e per foraggio.<br />
Nella me<strong>di</strong>cina popolare i semi sono<br />
utlizzati come me<strong>di</strong>camento sia per uso interno<br />
che esterno contro le paralisi, i reumatismi e per<br />
affezioni del fegato e dell’apparato respiratorio.<br />
Altra utilizzazione dei semi è quella antipiretica.<br />
Le ra<strong>di</strong>ci sono considerate narcotiche.<br />
Caratteristiche botaniche e morfologiche: La<br />
sistematica delle specie <strong>di</strong> Vigna ha sempre creato<br />
pareri <strong>di</strong>scordanti. Infatti, questo genere è ricco<br />
<strong>di</strong> piante molto simili fra <strong>di</strong> loro e con caratteristiche<br />
sia botaniche che morfologiche non sempre<br />
nette. Attualmente, nella Vigna ra<strong>di</strong>ata vengono<br />
incluse Phaseolus aureus Roxb. (mung<br />
bean, gree gram, golden gram) ed il Phaseolus<br />
mungo (L.) Hepper (black gram, urad, mash,<br />
wooly pyrol). Alcuni autori preferiscono in<strong>di</strong>care<br />
con Vigna ra<strong>di</strong>ata var. aureus (l’attuale V.<br />
ra<strong>di</strong>ata) la prima specie e V. ra<strong>di</strong>ata var. mungo<br />
la seconda. Secondo questa classificazione le due<br />
specie sono <strong>di</strong>stingubili essenzialmente per i baccelli<br />
ricurvi e provvisti <strong>di</strong> corti peli della V.r. var.<br />
aureus ed i baccelli eretti o subricurvi con peli<br />
lunghi della V.r. var. mungo.<br />
Pianta semiarbustiva eretta o semieretta,<br />
piuttosto pelosa, annuale, altezza 0,3-1,2 m, ramificata,<br />
con ra<strong>di</strong>ci profonde. Le foglie sono alternate,<br />
trifogliate, <strong>di</strong> colore verde scuro provviste<br />
<strong>di</strong> peli sparsi su entrambe le pagine e sui<br />
piccioli; foglioline ampie, lunghe 5-10 cm, ovate,<br />
intere o raramente trilobate; stipole sporgenti,<br />
Dall’altto: semi, particolare del fiore e i germogli<br />
<strong>di</strong> fagiolo mungo.<br />
61
62<br />
Pianta con baccelli in fase<br />
<strong>di</strong> maturazione.<br />
peltate; stipole lunghe circa 5-10 cm; fiori giallo chiaro riuniti in racemi ascellari o terminali in<br />
gruppi <strong>di</strong> 10-25 unità; baccelli <strong>di</strong> colore nero, grigio o marrone chiaro, lunghi 2,5-10 cm, larghi<br />
4-6 mm, ricurvi, provvisti <strong>di</strong> peli corti; semi in numero <strong>di</strong> 10-20, globosi od oblunghi, lunghi<br />
3,2-5 mm e larghi 3-3,8 mm, leggermente schiacciati, generalmente <strong>di</strong> colore verde scuro (oliva)<br />
ma si possono riscontrare genotipi con semi <strong>di</strong> colore giallo, marrone, marrone-violetto, con<br />
venature tipo marmo od a chiazze; ilo piatto, lungo 1,3-1,7 mm, largo 0,5-0,6 mm, strettamente<br />
obovato, margine appena concavo; superficie dei semi liscia o appena colorata, farinosa; peso <strong>di</strong><br />
100 semi 1,5-4 g; germinazione epigea.<br />
Ecologia: Nei tropici la VR è coltivata dal livello del mare fino a 2000 m slm generalmente in<br />
asciutto dopo il riso. E’ una specie arido-resistente, sucettibile al ristagno ed alla salinità ma si<br />
possono riscontrare varietà che hanno <strong>di</strong>mostrato <strong>di</strong> possedere un certo grado <strong>di</strong> tolleranza.<br />
Per un ottimale accrescimento della coltura è necessaria una pluviometria <strong>di</strong> 700-900 mm ben<br />
<strong>di</strong>stribuita durante il corso dell’anno. Nei tropici umi<strong>di</strong> la leguminosa viene coltivata dopo il<br />
periodo <strong>di</strong> maggiore pluviometria poiché piogge eccessive durante il periodo della fioritura<br />
comportano una scarsa allegagione.<br />
Il fagiolo mungo è coltivato in terreni limosi, in vertisuoli o alluvionali a patto che quest’ultimi<br />
siano sufficientemente profon<strong>di</strong>. Nei riguar<strong>di</strong> del fotoperiodo si riscontrano sia varietà<br />
a giorno corto che lungo. Ci sono anche genotipi fotoin<strong>di</strong>fferenti che fioriscono dopo appena 30<br />
d dalla semina. I limiti <strong>di</strong> temperatura per l’accrescimento della VR sono compresi tra 7,8 e<br />
27.8°C mentre il pH tra 4,3 e 8,1.<br />
Tecnica colturale: La VR può essere coltivata pura o consociata con specie che la superano in<br />
altezza e con ciclo colturale molto più lungo come ad esempio il sorgo. Il fagiolo mungo può<br />
essere coltivato anche per sovescio o come coltura intercalare. In rotazione può precedere o<br />
seguire il riso.<br />
Nei terreni lateritici tropicali può risultare utile una <strong>di</strong>stribuzione in pre-semina <strong>di</strong> 80 kg
ha -1 <strong>di</strong> P2O5 e <strong>di</strong> 20 kg ha -1 <strong>di</strong> N. Alcune ricerche hanno <strong>di</strong>mostrato che la dose ottimale <strong>di</strong> P 2 O 5<br />
è <strong>di</strong> circa 15-40 kg ha -1 .<br />
In In<strong>di</strong>a la semina avviene a spaglio od in solchi continui <strong>di</strong>stanti 25-50 cm. Con questa<br />
tecnica la quantità <strong>di</strong> seme occorrente è pari a circa 13-17 kg ha -1 . Nel caso <strong>di</strong> semina a buchette<br />
od a file con l’uso <strong>di</strong> seminatrici (come ad es. negli Stati Uniti) la quantità <strong>di</strong> seme occorrente<br />
scende a 6-9 kg ha -1 .<br />
La germinazione avviene dopo circa 3-5 d. Per il controllo delle infestanti sono necessari<br />
almeno due interventi manuali o meccanici dopo 20 e 35-40 d dalla semina. Nelle aree più aride<br />
può essere necessario il ricorso ad una irrigazione <strong>di</strong> soccorso.<br />
Raccolta: I baccelli freschi si possono raccogliere dopo circa 50-70 d dalla semina mentre per la<br />
granella, secondo la varietà, occorrono 60-150 d. La maggioranza dei genotipi è caratterizzato<br />
da una maturazione fortemente scalare ma, alcune varietà (es. “Pusa Baisakhi”), raggiungono il<br />
75% della loro produzione potenziale alla prima raccolta ed il rimamente nei successivi 10 d. Le<br />
piante sono sra<strong>di</strong>cate e lasciate ad essiccare al sole, trebbiate o battute con bastoni oppure calpestate<br />
da bovini. In alcune aree tutte le procedure <strong>di</strong> raccolta possono essere meccanizzate; in<br />
questo caso, la scalarità <strong>di</strong> maturazione incide fortemente sui costi colturali.<br />
Le rese me<strong>di</strong>e sono <strong>di</strong> circa 0,45-0,56 t ha -1 <strong>di</strong> semi secchi. In In<strong>di</strong>a le produzioni me<strong>di</strong>e<br />
sono <strong>di</strong> 0,1-0,2 t ha -1 e sono considerate buone quelle <strong>di</strong> 0,3-0,5 t ha -1 . In Sri Lanka e negli Stati<br />
Uniti si riportano rese <strong>di</strong> 1,0-1,2 t ha -1 . Sempre negli Stati Uniti le rese in foraggio essiccato<br />
all’aria sono <strong>di</strong> 2-7 t ha -1 mentre annualmente sono prodotte circa 15.000 t <strong>di</strong> germinelli. Una<br />
varietà che ha <strong>di</strong>motsrato una buona contemporaneità <strong>di</strong> maturazione alla prima raccolta è la<br />
filippina PHLV 18; le rese me<strong>di</strong>e fatte registrate da questo genotipo sono abbastanza stabili in<br />
<strong>di</strong>versi ambienti e raggiungono in me<strong>di</strong>a 1,5-1,8 t ha -1 .<br />
Avversità:<br />
Funghi: Le malattie fungine che possono colpire la VR sono moltissime, fra le principali si<br />
ricordano quelle della “rabbia” (Ascochyta phaseolorum, Macrophomina phaseoli) ed altri come:<br />
Botrytis cinerea, Cercospora canescens, Colletotrichum lindemuthianum, Corticium solani,<br />
Erysiphe polygoni, Fusarium solani f. sp. phaseoli, Mycosphaerella phaseoli, Phoma<br />
subcircinata, Tythium spp., Rhizoctonia solani, Sclerotinia rolfsii, S. sclerotiorum, Uromyces<br />
appen<strong>di</strong>culatus.<br />
Batteri: Corynebacterium glaucum, C. faciens, Xanthomonas phaseoli.<br />
Insetti: Il Melanagromyza phaseoli (<strong>di</strong>ttero) colpisce le foglie della VR subito dopo l’emergenza<br />
e le larve, scavando nei tessuti, raggiungono il fusto e poi il colletto dove provocano marciumi.<br />
Questo insetto risulta molto <strong>di</strong>ffuso in Sri Lanka. In Asia sud orientale costituisce la principale<br />
avversità provocando talvolta la completa <strong>di</strong>struzione della coltura.<br />
Agroti<strong>di</strong> dei generi Chrysodeixis, Mocis e Spodoptera, il ragnetto rosso Tetranychus<br />
cinnabarinus e molte specie <strong>di</strong> afi<strong>di</strong> si riscontrano frequentemente nelle colture <strong>di</strong> VR.<br />
I semi immagazzinati sono colpiti dal bruchide Callosobruchus chinensis che, talvolta<br />
però, inizia a danneggiare la granella già nei baccelli ancora in campo.<br />
Virosi: AMV (alfalfa mosaic virus), BV (Brassica virus), BTS (Brazilian tobacco streak), CYM<br />
(clover yellow mosaic)<br />
63
64<br />
Nemato<strong>di</strong>: Heterodera glycines, Hoplolaimus in<strong>di</strong>cus, Meloidogyne arenaria, M. hapla, M. incognita,<br />
M. javanica, Paratylenchus minutus.<br />
Composizione: 100 g <strong>di</strong> semi secchi contengono in me<strong>di</strong>a: acqua 10%, proteine 25,6%, grassi<br />
1,3%, carboidrati 69,2%, fibra 4,9%, ceneri 3,9%. Ulteriori dettagli sulla composizine chimica<br />
sono riportati nelle tabelle 1 e 2.
Sinonimi: Vigna sinensis (L.) Savi ex Hassk<br />
Cromosomi: 2n = 22<br />
FAGIOLO DALL’OCCHIO<br />
Vigna unguiculata spp. unguiculata (L.) Walp.<br />
Nomi comuni: Inglese: cowpea, blackeye bean, southern pea, Kaffir pea, marble pea, crowder<br />
pea,; Francese: niebe, lubia, coupé, frijóle; Spagnolo: fréjol de vaca, chicharo de vaca; Portoghese:<br />
ervihla de vaca, feijâo da China.<br />
Altri nomi: dagarti bean (Africa orientale); adanguari, nori (Etiopia); agwa, aki<strong>di</strong>ani, bean (Nigeria);<br />
amuli, boo-ngor, omugobe (Uganda); ilanda (Zambia); <strong>di</strong>nawa (Botswana); barbata, charla,<br />
Nindu pea (In<strong>di</strong>a); me-karak (Sri Lanka); paythenkai, thattapayru (Tamil); kachang bol (Malesia);<br />
karkala, kibal (Filippine); tonkin pea (Tailan<strong>di</strong>a).<br />
Origine e <strong>di</strong>ffusione: Forme selvatiche <strong>di</strong> fagiolino dall’occhio sono facilmente reperibili in<br />
<strong>di</strong>verse zone dell’Africa, dall’estremo sud del continente, allo Zimbabwe, al Natal (provincia<br />
della Repubblica Sudafricana), per cui è ragionevole supporre che questo sia il suo areale <strong>di</strong><br />
origine.<br />
L’Africa occidentale, dal Camerun al Senegal, è un centro secondario <strong>di</strong> <strong>di</strong>versificazione;<br />
come lo è anche il Sud-est asiatico dove il fagiolo dall’occhio è arrivato in tempi remotissimi.<br />
Importanza ed utilizzazione: Questa leguminosa è coltivata per utilizzarne i semi secchi o<br />
freschi, i legumi immaturi, le foglie e i germogli; è impiegata anche come pianta da foraggio<br />
(fieno, insilato o pascolo).<br />
Il fagiolino dall’occhio è largamente coltivato in tutte le zone tropicali e sub-tropicali <strong>di</strong><br />
Africa, Asia e America latina, ma trova la massima <strong>di</strong>ffusione in Africa dove rappresenta il<br />
secondo legume per importanza dopo il fagiolo e dove viene realizzato oltre il 90% della produzione<br />
mon<strong>di</strong>ale. Il paese maggiore produttore è la Nigeria (850.000 t).<br />
65
66<br />
Figura 15. Vigna unguiculata spp. unguiculata: A. stelo con foglia ed infiorescenza; B. fiore visto<br />
ventralmente; C. parti della corolla e del calice: C1 vessillo, C2 ali, C3 carena, C4 calice; D. baccello; E.<br />
seme.<br />
Da sinistra: foglie, fiori e semi della V. unguiculata ssp.<br />
unguicultata.
Figura 16. Vigna unguiculata spp. sesquipedalis: A. foglia e baccello; B. fiore in sezione longitu<strong>di</strong>nale;<br />
C. seme.<br />
Figura 17. Vigna spp. unguiculata cylindrica.<br />
67
68<br />
In alto: baccelli e semi freschi <strong>di</strong> V. unguiculata<br />
ssp. unguicultata.<br />
Sotto: i lunghi baccelli della V. u. spp.<br />
sesquipedalis (asparagus bean) pronti per la<br />
ven<strong>di</strong>ta.<br />
Caratteristiche botaniche e morfologia:<br />
Non c’è concordanza <strong>di</strong> vedute sulla<br />
tassonomia <strong>di</strong> questa pianta; secondo alcuni<br />
autori la Vigna unguiculata è da considerare<br />
sinonimo <strong>di</strong> V. sinensis e V.<br />
sesquipedalis poichè tutti e tre i tipi sono<br />
facilmente interfertili, anche se sussistono<br />
alcune <strong>di</strong>fferenze nella loro morfologia.<br />
Secondo Verdcourt (1970), invece, V.<br />
unguiculata comprende cinque sottospecie:<br />
1. V. unguiculata ssp. unguiculata<br />
(L.) (Walp) Verdc. (fagiolo dall’occhio,<br />
common cowpea) con legumi<br />
pendenti anche quando poco cresciuti,<br />
lunghi 10-30 cm, semi lunghi 6-10<br />
mm, coltivata principalmente in Africa;<br />
2. V. unguiculata ssp. cylindrica (L.)<br />
Van Eseltine (catjang, catjang<br />
cowpea) con legumi eretti lunghi 7-<br />
12 cm, semi piccoli lunghi 3-6 mm,<br />
<strong>di</strong>ffusa in Africa e Asia;<br />
3. V. unguiculata ssp. sesquipedalis<br />
(L.) Verdc. (fagiolo asparago,<br />
asparagus bean) con fusto volubile,<br />
legumi pendenti lunghi da 30 a 100<br />
cm, semi lunghi 8-12 mm; coltivata<br />
soprattutto in Estremo oriente e<br />
marginalmente in Africa.<br />
4. V. unguiculata ssp. dekindtiana (Harms) Verdc., sottospecie selvatica;<br />
5. V. unguiculata ssp. mensensis (Schweinf.) Verd., sottospecie selvatica.<br />
Il fusto ha portamento variabile (eretto, cespuglioso, volubile), alto da 20 a 200 cm (quelle<br />
con fusto più lungo sono rampicanti). Le foglie sono picciolate, trifogliate con singole foglie<br />
ovato-romboidali a margine solitamente intero. Le infiorescenze sono ascellari con pochi (2-4)<br />
fiori bianchi, giallastri o violetti, lungamente peduncolati; si aprono al mattino presto e si<br />
richiudono verso mezzogiorno. La fecondazione è prevalentemente autogama con una percentuale<br />
<strong>di</strong> allogamia variabile con l’ambiente. I legumi presentano delle strozzature tra i semi;<br />
hanno forma, lunghezza e colore molto variabili.<br />
Anche per i semi (da 8 a 20 per legume) esiste una notevole variabilità <strong>di</strong> forma, <strong>di</strong>mensioni<br />
e colore (lisci o rugosi, globulari o reniformi, bianchi, ver<strong>di</strong>, bruni o con varie screziature);<br />
presentano tutti un ilo bianco circondato da un anello scuro, da cui il nome <strong>di</strong> fagiolo dall’occhio.<br />
Il peso dei 100 semi varia da 10 a 25 g.
Ecologia: Per i fabbisogni idrici c’è una certa <strong>di</strong>versificazione fra le prime tre sottospecie coltivate:<br />
il fagiolino dall’occhio può essere coltivato anche dove piovono solo 500 mm, mentre per<br />
i tipi “catjang” e “asparago” sono necessari 1200-1500 mm.<br />
Tutte le sottospecie sono estremamente adattabili ai <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> terreno, rifuggendo solo<br />
da quelli troppo salini e da quelli con ristagni idrici.<br />
Diversi genotipi della V.u. unguiculata rispondono al fotoperiodo come piante a giorno<br />
corto, mentre quelli della V.u sesquipedalis sono fotoin<strong>di</strong>fferenti ed a giorno corto le varietà<br />
della V.u cylindrica; in tutte le spp. le alte temperature accelerano la comparsa dei fiori.<br />
La germinazione è epigea e solitamente pronta (2-3 d con 28°C) e elevata in come percentuale<br />
per la lunga vitalità dei semi. L’accrescimento e lo sviluppo delle piante è più o meno<br />
rapido.<br />
Alcune varietà fioriscono entro 30 d dall’emergenza e sono pronte per la raccolta (seme<br />
secco) dopo altri 30 d; altre, invece, impiegano oltre 100 d per fiorire e concludono il ciclo in<br />
200-240 d.<br />
La maggior parte delle varietà <strong>di</strong> Vigna presenta sviluppo indeterminato per cui anche<br />
dopo l’inizio della fioritura la pianta continua ad emettere foglie e fiori.<br />
Il simbionte della Vigna è Rhizobium phaseoli; ne esistono alcuni ceppi particolarmente resistenti<br />
agli stress da alte temperature e siccità.<br />
Tecnica colturale: Il fagiolo dall’occhio può essere coltivato in coltura pura o, più spesso,<br />
consociato con mais, sorgo, miglio, manioca, ecc. È bene evitare la coltura ripetuta per non<br />
incorrere in attacchi <strong>di</strong> Striga o in malattie.<br />
L’epoca <strong>di</strong> semina dovrebbe essere scelta in modo da non interferire con le operazioni<br />
necessarie alle colture principali e, tenendo presente la lunghezza del ciclo della varietà <strong>di</strong> Vigna,<br />
da far coincidere la maturazione dei baccelli con un periodo caldo e secco dell’anno.<br />
In coltura consociata la densità delle piante é <strong>di</strong> 1-2 m 2 . Diverse ricerche condotte per<br />
in<strong>di</strong>viduare l’investimento migliore per la coltura specializzata hanno <strong>di</strong>mostrato che i valori<br />
ottimali <strong>di</strong> densità e spaziatura variano molto con il tipo <strong>di</strong> pianta. Nel caso <strong>di</strong> varietà prostrate<br />
l’investimento non dovrebbe superare le 2,5-3 piante per m- 2, mentre con tipi semi-eretti si può<br />
arrivare a 5-8 piante e con quelli eretti a 10-14 piante per m 2 . La <strong>di</strong>stanza tra le file può variare<br />
da 75 cm per i tipi semi-eretti, indeterminati, con ramificazioni impalcate alte, a 30-40 cm per i<br />
tipi eretti, determinati, con ramificazioni basse.<br />
La concimazione azotata dovrebbe essere effettuata solo in terreni poveri <strong>di</strong> sostanza organica e/<br />
o quando sfruttati in precedenza da colture come mais e sorgo; gli apporti debbono essere, comunque,<br />
contenuti entro 30-50 kg ha -1 . Particolarmente utile la concimazione fosfatica con 30-<br />
40 kg ha -1 <strong>di</strong> P 2 O 5 , mentre il potassio sarà somministrato solo quando necessario, in terreni<br />
potassio-carenti, fino a 100 kg ha -1 .<br />
Le cure colturali sono ridotte a delle sarchiature da effettuare più volte, se necessario, fino<br />
a quando la coltura “copre” l’interfila. Nelle colture in purezza le erbe infestanti possono essere<br />
controllate manualmente o con il <strong>di</strong>serbo chimico impiegando gli stessi principi attivi utilizzati<br />
per il fagiolo comune.<br />
Raccolta: La raccolta può iniziare dopo 40 d dalla semina per i baccelli ver<strong>di</strong> e dopo 50 d per i<br />
semi immaturi; per la granella secca bisogna attendere da 70 a 90 d e anche oltre, a seconda della<br />
precocità della varietà. Particolare attenzione deve essere prestata per evitare per<strong>di</strong>te per sgranatura.<br />
In Africa le produzioni <strong>di</strong> granella secca oscillano tra 0,1 e 0,3 t ha -1 ; questi valori sono<br />
molto al <strong>di</strong>sotto del potenziale produttivo della coltura stimato intorno alle 3,0 t ha -1 , quando<br />
coltivata razionalmente curando, in particolare, la <strong>di</strong>fesa dalle avversità.<br />
69
70<br />
Avversità:<br />
Funghi: Le malattie fungine sono particolarmente dannose in climi umi<strong>di</strong> dove si verificano<br />
attacchi <strong>di</strong> antracnosi (Colletotrichum lindemutianum), ruggine (Uromyces phaseoli), fusariosi<br />
(Fusarium oxysporum), cercosporiosi (Pseudocercospora cruenta) e altre malattie meno gravi.<br />
Batteri: Cancrena (Xanthomonas vignicola).<br />
Insetti: La coltura del fagiolino dall’occhio può essere danneggiata anche da molti insetti; particolarmente<br />
dannosi Ophiomyia phaseoli, Acanthoscelides obtectus e <strong>di</strong>versi minatori dei baccelli<br />
(generi Cosmalyce, Deudorix, Maruca, Spodoptera). Notevoli per<strong>di</strong>te <strong>di</strong> prodotto si possono<br />
avere per attacchi da insetti durante la conservazione.<br />
Virosi: Tra le numerose avversità che colpiscono la Vigna le virosi si <strong>di</strong>mostrano particolarmente<br />
temibili e, a volte, possono avere effetti devastanti; gli attacchi si possono manifestare in<br />
particolari sta<strong>di</strong> o per tutto il ciclo della pianta. Sono stati in<strong>di</strong>viduati oltre 20 virus; alcuni hanno<br />
importanza locale, mentre altri sono <strong>di</strong>ffusi in molte regioni del mondo. I virus sono trasmessi<br />
prevalentemente dagli afi<strong>di</strong>.<br />
Composizione: La composizione me<strong>di</strong>a della granella secca è la seguente: acqua 11%, proteine<br />
27,1%, carboidrati 65,6%, grassi 2,4%, fibra 5,4%, ceneri 4,8%. Ulteriori dettagli sulla<br />
composizine chimica sono riportati nelle tabelle 1 e 2.
TABELLE<br />
71
72<br />
Tabella 1 - Composizione me<strong>di</strong>a della granella e <strong>di</strong> alcune parti <strong>di</strong> pianta. Valori espressi per 100 g <strong>di</strong> sostanza riportati a 0% <strong>di</strong> contenuto in acqua.<br />
Parte Carboidrati ß-carotene Acido<br />
Specie <strong>di</strong> pianta Calorie Proteine Grassi totali Fibra Ceneri Ca P Fe Na K equivalente Tiamina Riboflavina Niacina ascorbico<br />
(%) (%) (%) (%) (%) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (µg) (mg) (mg) (mg) (mg)<br />
Cajanus cajan SS 383 21.6 1.4 72.7 8.1 4.2 179 316 16.6 16 61 0.80 0.16 3.22<br />
SV 383 24.1 1.9 69.6 4.5 84 435 4.2 14 1813 467 1.29 0.80 7.73 84<br />
BV 320 24.4 1.7 68.8 10.1 5.1 202 489 5.6 40 1748 407 1.24 0.44 5.05 90<br />
Lablab<br />
purpureus BV 312 25.0 2.7 65.2 16.1 7.1 509 473 8.9 18 2545 3108 0.80 0.98 8.04 179<br />
SS 382 25.1 1.7 68.9 7.8 4.0 82 472 5.8 0.70 0.20 2.37<br />
F 284 22.0 3.7 55.9 61.4 12.8 1100 523 155.9 28839 2.57 146<br />
Phaseolus<br />
lunatus SS 388 25.0 1.5 73.2 4.9 3.4 101 269 6.3 20 330 1 0.51 0.23 1.57 0<br />
SV 377 22.2 1.6 66.6 3.2 5.1 79 377 7.0 6 2368 285 0.50 0.50 4.75 95<br />
GE 306 36.1 2.2 55.6 1.7 6.1 303 1061 22.8 83 0.47 0.38 5.56 19<br />
F 286 21.4 0.0 60.7 17.9 285 1285 82.1<br />
Psophocarpus<br />
tetragonolobus BV 324 18.1 1.0 75.2 15.2 5.7 504 457 1.9 29 19513 237 1.81 0.76 9.52 200<br />
SS 450 36.4 18.8 40.5 4.4 88 222 2.2<br />
R 370 11.4 2.4 82.6 6.1 3.7<br />
F 313 33.4 3.3 56.7 6.7 894 540 41.4 20977 1.87<br />
Vigna ra<strong>di</strong>ata SS 381 25.6 1.3 69.2 4.9 3.9 118 370 7.9 7 62 0.59 0.29 2.80 4<br />
GE 303 42.4 2.0 50.5 9.1 5.0 152 717 12.1 71 2242 202 1.11 1.01 8.08 182<br />
Vigna<br />
unguiculata SV 382 27.1 2.4 65.6 5.4 4.8 81 518 6.9 6 1628 668 1.29 0.39 4.82 87<br />
SS 384 25.7 1.8 68.9 4.7 3.6 124 432 7.3 7 777 11 0.67 0.25 2.60 1<br />
Voandzeia<br />
subterranea SS 412 17.8 6.7 72.2 3.3 94 293 4.7 0 0.20 0<br />
BV: baccelli ver<strong>di</strong>; F: foglie; GE; germinelli; R: ra<strong>di</strong>ci; SS: semi secchi; SV: semi ver<strong>di</strong>;
Tabella 2 - Composizione aminoaci<strong>di</strong>ca dei semi (g/16 g N) o delle ra<strong>di</strong>ci tuberizzate (*).<br />
Specie Lis. Met. Cis. Arg. Gli. Ist. Ile. Leu. Fen. Tir. Tre. Val. Ala. Asp. Glu. Idp. Pro. Ser.<br />
Cajanus cajan 6.8 1.2 — 5.9 3.7 3.4 3.8 7.2 10.0 3.1 3.6 4.5 4.3 9.8 20.1 0.0 4.4 4.7<br />
Lablab<br />
purpureus 6.8 0.9 — 6.6 4.6 3.2 4.4 8.5 4.9 3.6 4.2 5.2 4.5 13.0 15.7 0.6 4.3 5.4<br />
Psophocarpus (*)<br />
tetragonolobus 7.7 1.3 2.3 4.7 4.7 3.2 4.4 7.0 5.0 3.5 4.8 6.1 4.8 17.7 10.0 — 7.0 5.9<br />
Vigna ra<strong>di</strong>ata (1) 9.4 2.0 0.5 6.3 3.3 2.9 4.1 7.0 5.5 2.4 3.9 4.3 3.5 10.7 13.6 — 3.5 4.0<br />
Vigna<br />
unguiculata 6.4 1.2 — 7.3 4.1 3.2 4.0 7.2 6.0 3.4 3.6 4.7 4.4 10.6 16.9 0.5 3.4 4.5<br />
(1) Contenuto in Triptofano=1.9.<br />
73