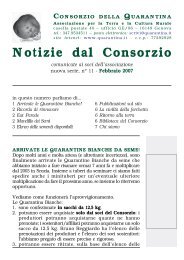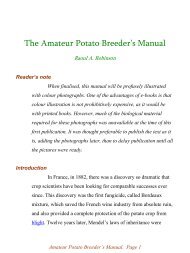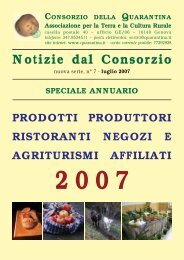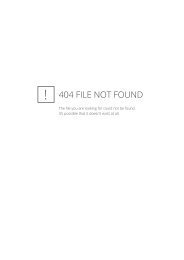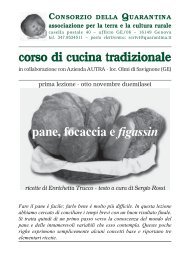Scarica PDF (1810 Kb) - Consorzio della Quarantina
Scarica PDF (1810 Kb) - Consorzio della Quarantina
Scarica PDF (1810 Kb) - Consorzio della Quarantina
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Antoine Auguste Parmentier<br />
più remota finora rinvenuta sul loro legame con<br />
la coltura <strong>della</strong> patata permette di arretrare fino<br />
al 1701, non oltre, quando un commerciante di<br />
Nordhausen portò un po’ di tuberi a una comunità<br />
stanziata nella regione del Württemberg,<br />
perché li coltivassero “per la loro sussistenza e per<br />
goderne com’erano abituati fin dal loro soggiorno<br />
nelle Valli valdesi del Piemonte” [PONS 1985,<br />
pagine 31-50].<br />
Semplificando, potremmo riassumere la storia<br />
dell’ingresso <strong>della</strong> nuova coltura in Europa attraverso<br />
due itinerari. Entrambi partono dalle Ande<br />
peruviane: il primo passa per la Spagna e Genova,<br />
da dove sono irradiate nel centro Italia e nelle<br />
valli del Piemonte occidentale, poi in Germania e<br />
quindi in Francia; il secondo passa per le colonie<br />
inglesi <strong>della</strong> Virginia e, da qui (in seguito a una<br />
spedizione di Francis Drake del 1588), conduce<br />
nelle Isole britanniche, in particolare in Irlanda<br />
[SALAMAN 1989].<br />
In Italia, benché giunte presto, le patate iniziano<br />
ad affermarsi solo nei decenni di passaggio tra<br />
Sette e Ottocento, per merito di agronomi, innovatori<br />
e parroci che, nel tubero, vedono una valida<br />
alternativa al frumento nei tempi di carestia:<br />
Alessandro Volta (1745-1827), nel Comasco;<br />
Antonio Zanon e Vincenzo Dandolo (1758-1816)<br />
nel Veneto; Filippo Re, nel Bolognese; Vincenzo<br />
Virginio (1752-1830), in Piemonte; Michele<br />
Dondero (1744-1813), nel Genovesato, per non<br />
citarne che alcuni. Ma perché è occorso tanto<br />
tempo? Certamente per superstizione e diffidenza<br />
verso una pianta ignota, sospetta, i cui fiori<br />
assomigliano a quelli <strong>della</strong> velenosa erba morella<br />
(Solanum nigrum) e di cui per molto tempo non si<br />
conoscono le parti commestibili, né si sa come<br />
cucinarle.<br />
Ma nel corso del Settecento, i motivi di resistenza<br />
sono lentamente superati dalla necessità di<br />
affrontare le ricorrenti carestie, generate non<br />
tanto dalle diminuite produzioni, quanto dal progressivo<br />
aumento <strong>della</strong> popolazione, tale da<br />
costringere a una crescente mobilità degli uomini<br />
in cerca di lavoro stagionale o di elemosina. E nes-<br />
sun prodotto sembrava, a tale scopo, più adatto<br />
<strong>della</strong> patata che rende, a parità di terreno impiegato,<br />
più del doppio del granoturco e ancora di<br />
più rispetto al frumento e ai legumi.<br />
Delle patate, a Genova, si inizia a discutere nel<br />
1779, quando il settimanale “Avvisi di Genova”<br />
pubblica la notizia di un trattato scritto dall’agronomo<br />
francese Antoine Auguste Parmentier<br />
(1737-1813) sulla Maniera di fare il pane di pomi<br />
di terra senza mescolarvi pur un poco di farina: da<br />
questo momento e ancora per molto tempo, la<br />
possibilità di panificare i “pomi di terra” diviene<br />
il modo più efficace per fare pubblicità alla nuova<br />
coltura e per incoraggiarne la diffusione [vedi le<br />
ricette a pagina 115].<br />
Dopo la pubblicazione di altri interventi sul<br />
medesimo argomento, un lettore, incuriosito,<br />
chiede notizie sulla tecnica di coltivazione. Come<br />
risposta, tra fine agosto e inizi settembre, vengono<br />
fornite alcune semplici istruzioni; pochi mesi<br />
più tardi intorno a Genova inizieranno le prime<br />
semine.<br />
L’introduzione <strong>della</strong> nuova coltura nel dominio<br />
<strong>della</strong> Repubblica era stata tentata alcuni anni<br />
prima. Se ne parla in un breve trattato intitolato<br />
De’ pomi di terra, ossia patate, stampato a<br />
Genova nel 1793 a cura <strong>della</strong> Società Patria di Arti<br />
e Manifatture, dove, dopo avere ricordato un episodio<br />
avvenuto nel 1764 (quando, intorno alla<br />
Certosa di Firenze, le patate avevano permesso di<br />
superare un momento di carestia), si afferma che<br />
successivamente a Chiavari ci fu un primo tentativo<br />
di coltivazione.<br />
Potrebbe trattarsi dell’esperimento tentato da<br />
Pietro Casaretto che nel 1774, tornato a Chiavari<br />
dall’America, fece seminare alcuni tuberi in un<br />
giardino «da lui scelto a provare la produzione di<br />
questo cibo, che dovea poi rendersi tanto utile e<br />
universalmente usato» [Biografia, manoscritto,<br />
1855, pagina 19].<br />
Dopo la propaganda fatta attraverso gli “Avvisi”,<br />
le iniziative e le pubblicazioni curate dalla Società<br />
Patria di Genova (dal 1786) e dalla Società<br />
14 15<br />
Dei Pomi di terra ne avete<br />
parlato anche troppo,<br />
facendone ora del pane,<br />
ora del cascio [formaggio];<br />
ed ora guarendone dallo<br />
scorbuto, quando l’avessimo.<br />
Non so capire<br />
per altro, per qual ragione<br />
voi, che mostrate di averli<br />
in tanto conto,<br />
e li giudicate come<br />
una produzione preziosa,<br />
non ci insegniate poi<br />
la maniera di coltivarli.<br />
“Avvisi” 1779, numero 124<br />
Un illustre intelligentissimo<br />
Amatore, persuaso<br />
dalla ragione e dal fatto<br />
dell’utilità di queste<br />
benefiche radici ne fece<br />
trapiantare una buona<br />
porzione nelle sue tenute<br />
di Chiaveri [Chiavari].<br />
Questa coltura per altro<br />
fu assai presto negletta<br />
da quei Contadini per<br />
un falso principio crudele,<br />
ch’escluder vorrebbe<br />
[…] tutto ciò,<br />
che sente di novità.<br />
De’ pomi di terra, 1793,<br />
pagina 38.