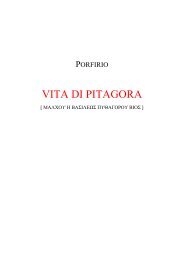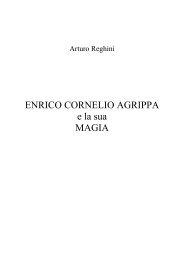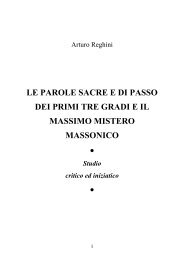DEI NUMERI PITAGORICI - La Melagrana
DEI NUMERI PITAGORICI - La Melagrana
DEI NUMERI PITAGORICI - La Melagrana
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Si ha così la diade, la dualità. Essa è determinata dalla distinzione fondamentale della monade e<br />
dell' λλος 21 .<br />
Nella vita ordinaria, umana, lo spirito accoppiato al corpo fa le spese di questo dualismo. Però<br />
come una nave ormeggiata può levare le ancore, aprire le vele e prendere il largo, così lo spirito ancorato<br />
al corpo può lasciare il porto e «metter sé per l'alto mare aperto». In greco questa operazione<br />
del levare le ancore e prendere il largo si chiamava anagoga. Metaforicamente essa è l'anagogia.<br />
Osserva il Delatte a questo proposito 22 che Giamblico fa uso di questa locuzione in senso traslato<br />
spirituale, e che Olimpiodoro (In Platonem Phedon pag. 171), parlando dell'uscita dell'anima, la paragona<br />
ad una nave che prende il largo 23 . Con questo la dualità persiste, ma si ha la possibilità di<br />
una vita anfibia; si può vivere tenendo la «piccioletta barca" alla fonda nelle tranquille acque di un<br />
porto e si può «mettersi in pelago», si può per «acquistar virtute e conoscenza» metter il «navigio<br />
per l'alto sale».<br />
Al tempo di Pitagora non difettavano gli esempi di simili casi, ed è rimasta memoria di più di<br />
uno di questi «grandi maestri della sapienza misteriosa», come li chiama il Rohde 24 , ai quali si attribuiva<br />
la facoltà di lasciare il corpo anche per lunghi anni... I più famosi furono Ermotimo di Clazomene<br />
ed Epimenide di Creta, dai quali, dice il Rohde, Platone trasse il mito di Er. Di altri due e precisamente<br />
di Abaris e di Aristea fa menzione Pindaro. I pitagorici conoscevano queste cose e si ha<br />
notizia dei loro rapporti con questi personaggi. Il Ciaceri 25 osserva che gli «stessi antichi biografi<br />
del filosofo Pitagora avevano posto in rilievo la conoscenza da parte dei pitagorici dei maravigliosi<br />
racconti che si narravano intorno ad Aristea». «Questo Aristea Proconnesio, dice ancora il Ciaceri,<br />
era un personaggio di carattere religioso e fantasticamente leggendario che sarebbe fiorito nel VI<br />
secolo, presunto autore del poema Arimaspeia, per scrivere il quale sarebbe andato sin nella terra di<br />
quei mostri da un solo occhio, verso la regione degli Iperborei». Dei rapporti di Pitagora con Aristea<br />
parlano Giamblico ed Apollonio 26 , e dei rapporti di Pitagora con l'altro iperboreo, ossia con Abaris,<br />
parla Porfirio 27 ; ed il Diels 28 dimostra che Abaris, al pari di Epimenide e di Aristea, era presentato<br />
come un precursore di Pitagora.<br />
Invece, secondo il neo-pitagorico Giamblico 29 , Epimenide di Creta era discepolo di Pitagora; e<br />
questa asserzione è accettata e riportata da Porfirio nella sua vita di Pitagora 30 . Ora pur tenendo con-<br />
21 I Theologumena Arithmetica (Cfr. A. Delatte - Études sur la litt. pyth., pag. 172) dicono che la diade ha questo<br />
nome perché tramezza ed attraversa e per prima si allontana dalla monade (∆υ ς ε ρηται παρ τ διέναι κα διαπορεύσθαι·<br />
πρ τη γ ρ χώρισεν αύτ ν κ τ ς µονάδος) e che essa si disgiunge (διαιρε σθαι) in due parti eguali. Anche<br />
Anatolio usa il termine dieresi ossia separazione ed i termini κίνησις, movimento, ed ρµή, violenza. Essa è chiamata<br />
anche τόλµα perché ha l'audacia e la temerità di separarsi ed opporsi alla monade. <strong>La</strong> diade è l'avversaria della<br />
monade nel senso etimologico, l'etimologia è la stessa di quella della parola diavolo, il «nostro avversario» come lo<br />
chiama Dante. Ed anche il concetto è lo stesso col vantaggio che la diade non si presta facilmente ad una personificazione<br />
ed identificazione col Maligno, il demonio, Lucifero, Satanasso, Mammone... e tutte le altre divinità del politeismo<br />
semitico popolare.<br />
22 A. Delatte - Études sur la litt. pythag., pag. 18.<br />
23 Ricordiamo a nostra volta che, secondo Dante, «le scritture si possono intendere e debbonsi sponere massimamente<br />
per quattro sensi» (Convito, Il, I). Dante dichiara che «lo quarto senso si chiama anagogico, cioè sovrasenso», e questo<br />
dice poche righe dopo aver detto che «lo tempo chiama e domanda la mia nave uscire di porto». Dante fa uso frequente<br />
di questo simbolismo navale in senso anagogico, per esempio in Inf. XXVI, Purg. I, Purg. II, 13; e dichiara egli<br />
stesso di nascondere la sua dottrina sotto il velame delli versi strani. Egli del resto non fa anche in questo che imitare gli<br />
antichi; Ovidio ad esempio, che in un passo, riportato dal Rostagni (Il Verbo di Pitagora – [Bocca, Torino, 1924] pag.<br />
282) in cui si occupa della metempsicosi esclama: poiché l'alto mare mi ha preso ed ho dato piene le vele ai venti...<br />
Notiamo infine che anche Filolao fa uso della parola governare in senso simbolico, tale e quale del resto come è adoperata<br />
da tutti.<br />
24 Erwin Rohde - Psiche, versione it., II, 4.<br />
25 Emanuele Ciaceri - Storia della Magna Grecia - Milano, 1928 - I, 122 ed I, 119.<br />
26 Giamblico - De vita Pythagorae, 136; ed Apollonio – Mirab., 2.<br />
27 Porfirio - Vita Pythagorae, 28 ed anche Giamblico - De vita Pythagorae, 90, 135, 275.<br />
28 Diels - Sitzungb. der Berlin. Akadem. 1891; pag. 393 e seg.<br />
29 Giamblico - De vita Pythagorae - I, 22.<br />
12