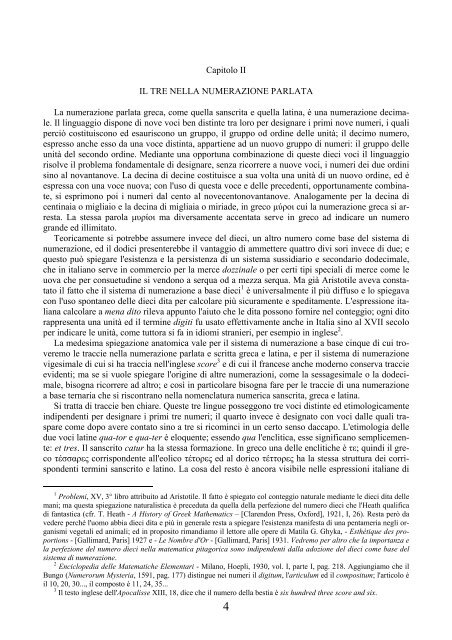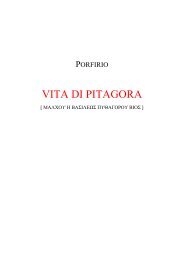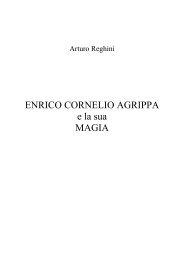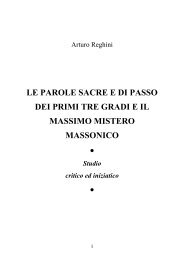DEI NUMERI PITAGORICI - La Melagrana
DEI NUMERI PITAGORICI - La Melagrana
DEI NUMERI PITAGORICI - La Melagrana
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Capitolo II<br />
IL TRE NELLA NUMERAZIONE PARLATA<br />
<strong>La</strong> numerazione parlata greca, come quella sanscrita e quella latina, è una numerazione decimale.<br />
Il linguaggio dispone di nove voci ben distinte tra loro per designare i primi nove numeri, i quali<br />
perciò costituiscono ed esauriscono un gruppo, il gruppo od ordine delle unità; il decimo numero,<br />
espresso anche esso da una voce distinta, appartiene ad un nuovo gruppo di numeri: il gruppo delle<br />
unità del secondo ordine. Mediante una opportuna combinazione di queste dieci voci il linguaggio<br />
risolve il problema fondamentale di designare, senza ricorrere a nuove voci, i numeri dei due ordini<br />
sino al novantanove. <strong>La</strong> decina di decine costituisce a sua volta una unità di un nuovo ordine, ed è<br />
espressa con una voce nuova; con l'uso di questa voce e delle precedenti, opportunamente combinate,<br />
si esprimono poi i numeri dal cento al novecentonovantanove. Analogamente per la decina di<br />
centinaia o migliaio e la decina di migliaia o miriade, in greco µύροι cui la numerazione greca si arresta.<br />
<strong>La</strong> stessa parola µυρίοι ma diversamente accentata serve in greco ad indicare un numero<br />
grande ed illimitato.<br />
Teoricamente si potrebbe assumere invece del dieci, un altro numero come base del sistema di<br />
numerazione, ed il dodici presenterebbe il vantaggio di ammettere quattro divi sori invece di due; e<br />
questo può spiegare l'esistenza e la persistenza di un sistema sussidiario e secondario dodecimale,<br />
che in italiano serve in commercio per la merce dozzinale o per certi tipi speciali di merce come le<br />
uova che per consuetudine si vendono a serqua od a mezza serqua. Ma già Aristotile aveva constatato<br />
il fatto che il sistema di numerazione a base dieci 1 è universalmente il più diffuso e lo spiegava<br />
con l'uso spontaneo delle dieci dita per calcolare più sicuramente e speditamente. L'espressione italiana<br />
calcolare a mena dito rileva appunto l'aiuto che le dita possono fornire nel conteggio; ogni dito<br />
rappresenta una unità ed il termine digiti fu usato effettivamente anche in Italia sino al XVII secolo<br />
per indicare le unità, come tuttora si fa in idiomi stranieri, per esempio in inglese 2 .<br />
<strong>La</strong> medesima spiegazione anatomica vale per il sistema di numerazione a base cinque di cui troveremo<br />
le traccie nella numerazione parlata e scritta greca e latina, e per il sistema di numerazione<br />
vigesimale di cui si ha traccia nell'inglese score 3 e di cui il francese anche moderno conserva traccie<br />
evidenti; ma se si vuole spiegare l'origine di altre numerazioni, come la sessagesimale o la dodecimale,<br />
bisogna ricorrere ad altro; e così in particolare bisogna fare per le traccie di una numerazione<br />
a base ternaria che si riscontrano nella nomenclatura numerica sanscrita, greca e latina.<br />
Si tratta di traccie ben chiare. Queste tre lingue posseggono tre voci distinte ed etimologicamente<br />
indipendenti per designare i primi tre numeri; il quarto invece è designato con voci dalle quali traspare<br />
come dopo avere contato sino a tre si ricominci in un certo senso daccapo. L'etimologia delle<br />
due voci latine qua-tor e qua-ter è eloquente; essendo qua l'enclitica, esse significano semplicemente:<br />
et tres. Il sanscrito catur ha la stessa formazione. In greco una delle enclitiche è τε; quindi il greco<br />
τέσσαρες corrispondente all'eolico τέτορες ed al dorico τέττορες ha la stessa struttura dei corrispondenti<br />
termini sanscrito e latino. <strong>La</strong> cosa del resto è ancora visibile nelle espressioni italiane di<br />
1 Problemi, XV, 3° libro attribuito ad Aristotile. Il fatto è spiegato col conteggio naturale mediante le dieci dita delle<br />
mani; ma questa spiegazione naturalistica è preceduta da quella della perfezione del numero dieci che l'Heath qualifica<br />
di fantastica (cfr. T. Heath - A History of Greek Mathematics – [Clarendon Press, Oxford], 1921, I, 26). Resta però da<br />
vedere perché l'uomo abbia dieci dita e più in generale resta a spiegare l'esistenza manifesta di una pentameria negli organismi<br />
vegetali ed animali; ed in proposito rimandiamo il lettore alle opere di Matila G. Ghyka, - Esthétique des proportions<br />
- [Gallimard, Paris] 1927 e - Le Nombre d'Or - [Gallimard, Paris] 1931. Vedremo per altro che la importanza e<br />
la perfezione del numero dieci nella matematica pitagorica sono indipendenti dalla adozione del dieci come base del<br />
sistema di numerazione.<br />
2 Enciclopedia delle Matematiche Elementari - Milano, Hoepli, 1930, vol. I, parte I, pag. 218. Aggiungiamo che il<br />
Bungo (Numerorum Mysteria, 1591, pag. 177) distingue nei numeri il digitum, l'articulum ed il compositum; l'articolo è<br />
il 10, 20, 30..., il composto è 11, 24, 35...<br />
3 Il testo inglese dell'Apocalisse XIII, 18, dice che il numero della bestia è six hundred three score and six.<br />
4