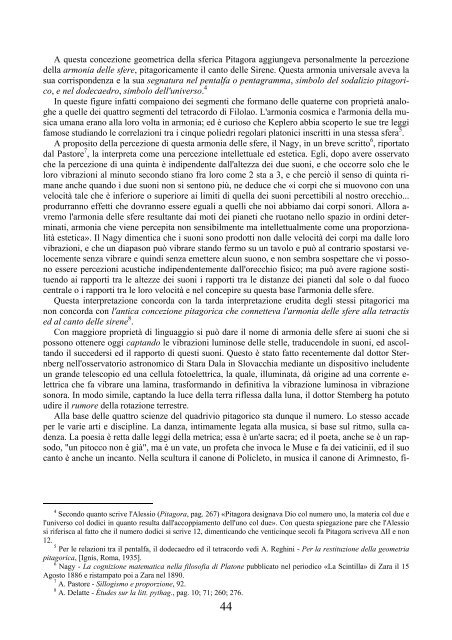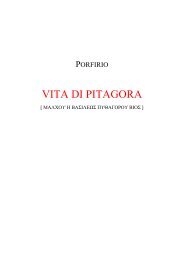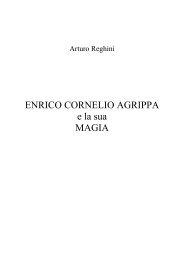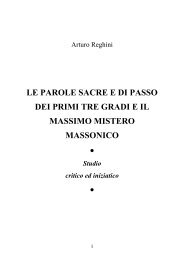DEI NUMERI PITAGORICI - La Melagrana
DEI NUMERI PITAGORICI - La Melagrana
DEI NUMERI PITAGORICI - La Melagrana
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
A questa concezione geometrica della sferica Pitagora aggiungeva personalmente la percezione<br />
della armonia delle sfere, pitagoricamente il canto delle Sirene. Questa armonia universale aveva la<br />
sua corrispondenza e la sua segnatura nel pentalfa o pentagramma, simbolo del sodalizio pitagorico,<br />
e nel dodecaedro, simbolo dell'universo. 4<br />
In queste figure infatti compaiono dei segmenti che formano delle quaterne con proprietà analoghe<br />
a quelle dei quattro segmenti del tetracordo di Filolao. L'armonia cosmica e l'armonia della musica<br />
umana erano alla loro volta in armonia; ed è curioso che Keplero abbia scoperto le sue tre leggi<br />
famose studiando le correlazioni tra i cinque poliedri regolari platonici inscritti in una stessa sfera 5 .<br />
A proposito della percezione di questa armonia delle sfere, il Nagy, in un breve scritto 6 , riportato<br />
dal Pastore 7 , la interpreta come una percezione intellettuale ed estetica. Egli, dopo avere osservato<br />
che la percezione di una quinta è indipendente dall'altezza dei due suoni, e che occorre solo che le<br />
loro vibrazioni al minuto secondo stiano fra loro come 2 sta a 3, e che perciò il senso di quinta rimane<br />
anche quando i due suoni non si sentono più, ne deduce che «i corpi che si muovono con una<br />
velocità tale che è inferiore o superiore ai limiti di quella dei suoni percettibili al nostro orecchio...<br />
produrranno effetti che dovranno essere eguali a quelli che noi abbiamo dai corpi sonori. Allora avremo<br />
l'armonia delle sfere resultante dai moti dei pianeti che ruotano nello spazio in ordini determinati,<br />
armonia che viene percepita non sensibilmente ma intellettualmente come una proporzionalità<br />
estetica». Il Nagy dimentica che i suoni sono prodotti non dalle velocità dei corpi ma dalle loro<br />
vibrazioni, e che un diapason può vibrare stando fermo su un tavolo e può al contrario spostarsi velocemente<br />
senza vibrare e quindi senza emettere alcun suono, e non sembra sospettare che vi possono<br />
essere percezioni acustiche indipendentemente dall'orecchio fisico; ma può avere ragione sostituendo<br />
ai rapporti tra le altezze dei suoni i rapporti tra le distanze dei pianeti dal sole o dal fuoco<br />
centrale o i rapporti tra le loro velocità e nel concepire su questa base l'armonia delle sfere.<br />
Questa interpretazione concorda con la tarda interpretazione erudita degli stessi pitagorici ma<br />
non concorda con l'antica concezione pitagorica che connetteva l'armonia delle sfere alla tetractis<br />
ed al canto delle sirene 8 .<br />
Con maggiore proprietà di linguaggio si può dare il nome di armonia delle sfere ai suoni che si<br />
possono ottenere oggi captando le vibrazioni luminose delle stelle, traducendole in suoni, ed ascoltando<br />
il succedersi ed il rapporto di questi suoni. Questo è stato fatto recentemente dal dottor Sternberg<br />
nell'osservatorio astronomico di Stara Dala in Slovacchia mediante un dispositivo includente<br />
un grande telescopio ed una cellula fotoelettrica, la quale, illuminata, dà origine ad una corrente elettrica<br />
che fa vibrare una lamina, trasformando in definitiva la vibrazione luminosa in vibrazione<br />
sonora. In modo simile, captando la luce della terra riflessa dalla luna, il dottor Stemberg ha potuto<br />
udire il rumore della rotazione terrestre.<br />
Alla base delle quattro scienze del quadrivio pitagorico sta dunque il numero. Lo stesso accade<br />
per le varie arti e discipline. <strong>La</strong> danza, intimamente legata alla musica, si base sul ritmo, sulla cadenza.<br />
<strong>La</strong> poesia è retta dalle leggi della metrica; essa è un'arte sacra; ed il poeta, anche se è un rapsodo,<br />
"un pitocco non è già", ma è un vate, un profeta che invoca le Muse e fa dei vaticinii, ed il suo<br />
canto è anche un incanto. Nella scultura il canone di Policleto, in musica il canone di Arimnesto, fi-<br />
4<br />
Secondo quanto scrive l'Alessio (Pitagora, pag. 267) «Pitagora designava Dio col numero uno, la materia col due e<br />
l'universo col dodici in quanto resulta dall'accoppiamento dell'uno col due». Con questa spiegazione pare che l'Alessio<br />
si riferisca al fatto che il numero dodici si scrive 12, dimenticando che venticinque secoli fa Pitagora scriveva ∆ΙΙ e non<br />
12.<br />
5<br />
Per le relazioni tra il pentalfa, il dodecaedro ed il tetracordo vedi A. Reghini - Per la restituzione della geometria<br />
pitagorica, [Ignis, Roma, 1935].<br />
6<br />
Nagy - <strong>La</strong> cognizione matematica nella filosofia di Platone pubblicato nel periodico «<strong>La</strong> Scintilla» di Zara il 15<br />
Agosto 1886 e ristampato poi a Zara nel 1890.<br />
7<br />
A. Pastore - Sillogismo e proporzione, 92.<br />
8<br />
A. Delatte - Études sur la litt. pythag., pag. 10; 71; 260; 276.<br />
44