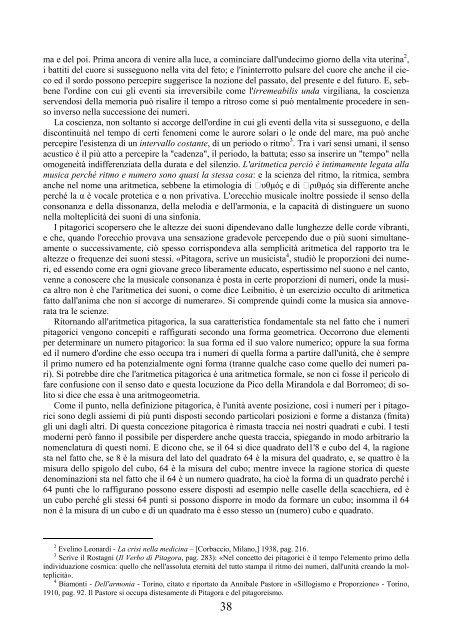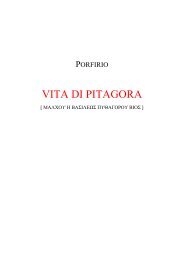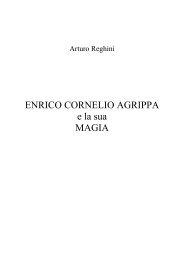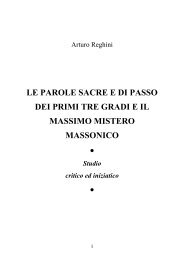DEI NUMERI PITAGORICI - La Melagrana
DEI NUMERI PITAGORICI - La Melagrana
DEI NUMERI PITAGORICI - La Melagrana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ma e del poi. Prima ancora di venire alla luce, a cominciare dall'undecimo giorno della vita uterina 2 ,<br />
i battiti del cuore si susseguono nella vita del feto; e l'ininterrotto pulsare del cuore che anche il cieco<br />
ed il sordo possono percepire suggerisce la nozione del passato, del presente e del futuro. E, sebbene<br />
l'ordine con cui gli eventi sia irreversibile come l'irremeabilis unda virgiliana, la coscienza<br />
servendosi della memoria può risalire il tempo a ritroso come si può mentalmente procedere in senso<br />
inverso nella successione dei numeri.<br />
<strong>La</strong> coscienza, non soltanto si accorge dell'ordine in cui gli eventi della vita si susseguono, e della<br />
discontinuità nel tempo di certi fenomeni come le aurore solari o le onde del mare, ma può anche<br />
percepire l'esistenza di un intervallo costante, di un periodo o ritmo 3 . Tra i vari sensi umani, il senso<br />
acustico è il più atto a percepire la "cadenza", il periodo, la battuta; esso sa inserire un "tempo" nella<br />
omogeneità indifferenziata della durata e del silenzio. L'aritmetica perciò è intimamente legata alla<br />
musica perché ritmo e numero sono quasi la stessa cosa: e la scienza del ritmo, la ritmica, sembra<br />
anche nel nome una aritmetica, sebbene la etimologia di υθµός e di ριθµός sia differente anche<br />
perché la α è vocale protetica e α non privativa. L'orecchio musicale inoltre possiede il senso della<br />
consonanza e della dissonanza, della melodia e dell'armonia, e la capacità di distinguere un suono<br />
nella molteplicità dei suoni di una sinfonia.<br />
I pitagorici scopersero che le altezze dei suoni dipendevano dalle lunghezze delle corde vibranti,<br />
e che, quando l'orecchio provava una sensazione gradevole percependo due o più suoni simultaneamente<br />
o successivamente, ciò spesso corrispondeva alla semplicità aritmetica del rapporto tra le<br />
altezze o frequenze dei suoni stessi. «Pitagora, scrive un musicista 4 , studiò le proporzioni dei numeri,<br />
ed essendo come era ogni giovane greco liberamente educato, espertissimo nel suono e nel canto,<br />
venne a conoscere che la musicale consonanza è posta in certe proporzioni di numeri, onde la musica<br />
altro non è che l'aritmetica dei suoni, o come dice Leibnitio, è un esercizio occulto di aritmetica<br />
fatto dall'anima che non si accorge di numerare». Si comprende quindi come la musica sia annoverata<br />
tra le scienze.<br />
Ritornando all'aritmetica pitagorica, la sua caratteristica fondamentale sta nel fatto che i numeri<br />
pitagorici vengono concepiti e raffigurati secondo una forma geometrica. Occorrono due elementi<br />
per determinare un numero pitagorico: la sua forma ed il suo valore numerico; oppure la sua forma<br />
ed il numero d'ordine che esso occupa tra i numeri di quella forma a partire dall'unità, che è sempre<br />
il primo numero ed ha potenzialmente ogni forma (tranne qualche caso come quello dei numeri pari).<br />
Si potrebbe dire che l'aritmetica pitagorica è una aritmetica formale, se non ci fosse il pericolo di<br />
fare confusione con il senso dato e questa locuzione da Pico della Mirandola e dal Borromeo; di solito<br />
si dice che essa è una aritmogeometria.<br />
Come il punto, nella definizione pitagorica, è l'unità avente posizione, così i numeri per i pitagorici<br />
sono degli assiemi di più punti disposti secondo particolari posizioni e forme a distanza (fmita)<br />
gli uni dagli altri. Di questa concezione pitagorica è rimasta traccia nei nostri quadrati e cubi. I testi<br />
moderni però fanno il possibile per disperdere anche questa traccia, spiegando in modo arbitrario la<br />
nomenclatura di questi nomi. E dicono che, se il 64 si dice quadrato del1'8 e cubo del 4, la ragione<br />
sta nel fatto che, se 8 è la misura del lato del quadrato 64 è la misura del quadrato, e, se quattro è la<br />
misura dello spigolo del cubo, 64 è la misura del cubo; mentre invece la ragione storica di queste<br />
denominazioni sta nel fatto che il 64 è un numero quadrato, ha cioè la forma di un quadrato perché i<br />
64 punti che lo raffigurano possono essere disposti ad esempio nelle caselle della scacchiera, ed è<br />
un cubo perché gli stessi 64 punti si possono disporre in modo da formare un cubo; insomma il 64<br />
non è la misura di un cubo e di un quadrato ma è esso stesso un (numero) cubo e quadrato.<br />
2 Evelino Leonardi - <strong>La</strong> crisi nella medicina – [Corbaccio, Milano,] 1938, pag. 216.<br />
3 Scrive il Rostagni (Il Verbo di Pitagora, pag. 283): «Nel concetto dei pitagorici è il tempo l'elemento primo della<br />
individuazione cosmica: quello che nell'assoluta eternità del tutto stampa il ritmo dei numeri, dall'unità creando la molteplicità».<br />
4 Biamonti - Dell'armonia - Torino, citato e riportato da Annibale Pastore in «Sillogismo e Proporzione» - Torino,<br />
1910, pag. 92. Il Pastore si occupa distesamente di Pitagora e del pitagoreismo.<br />
38