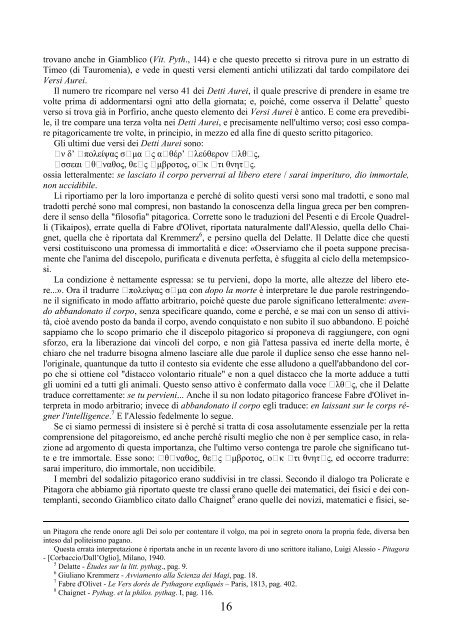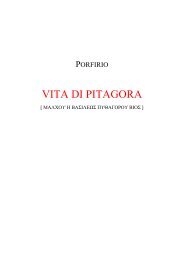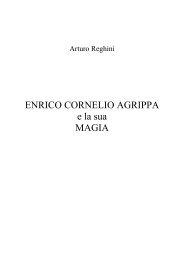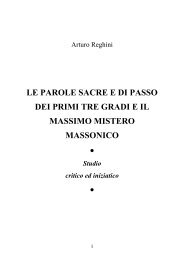DEI NUMERI PITAGORICI - La Melagrana
DEI NUMERI PITAGORICI - La Melagrana
DEI NUMERI PITAGORICI - La Melagrana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
trovano anche in Giamblico (Vit. Pyth., 144) e che questo precetto si ritrova pure in un estratto di<br />
Timeo (di Tauromenia), e vede in questi versi elementi antichi utilizzati dal tardo compilatore dei<br />
Versi Aurei.<br />
Il numero tre ricompare nel verso 41 dei Detti Aurei, il quale prescrive di prendere in esame tre<br />
volte prima di addormentarsi ogni atto della giornata; e, poiché, come osserva il Delatte 5 questo<br />
verso si trova già in Porfirio, anche questo elemento dei Versi Aurei è antico. E come era prevedibile,<br />
il tre compare una terza volta nei Detti Aurei, e precisamente nell'ultimo verso; così esso compare<br />
pitagoricamente tre volte, in principio, in mezzo ed alla fine di questo scritto pitagorico.<br />
Gli ultimi due versi dei Detti Aurei sono:<br />
ν δ’ πολείψας σ µα ς α θέρ’ λεύθερον λθ ς,<br />
σσεαι θ ναθος, θε ς µβροτος, ο κ τι θνητ ς.<br />
ossia letteralmente: se lasciato il corpo perverrai al libero etere / sarai imperituro, dio immortale,<br />
non uccidibile.<br />
Li riportiamo per la loro importanza e perché di solito questi versi sono mal tradotti, e sono mal<br />
tradotti perché sono mal compresi, non bastando la conoscenza della lingua greca per ben comprendere<br />
il senso della "filosofia" pitagorica. Corrette sono le traduzioni del Pesenti e di Ercole Quadrelli<br />
(Tikaipos), errate quella di Fabre d'Olivet, riportata naturalmente dall'Alessio, quella dello Chaignet,<br />
quella che è riportata dal Kremmerz 6 , e persino quella del Delatte. Il Delatte dice che questi<br />
versi costituiscono una promessa di immortalità e dice: «Osserviamo che il poeta suppone precisamente<br />
che l'anima del discepolo, purificata e divenuta perfetta, è sfuggita al ciclo della metempsicosi.<br />
<strong>La</strong> condizione è nettamente espressa: se tu pervieni, dopo la morte, alle altezze del libero etere...».<br />
Ora il tradurre πολείψας σ µα con dopo la morte è interpretare le due parole restringendone<br />
il significato in modo affatto arbitrario, poiché queste due parole significano letteralmente: avendo<br />
abbandonato il corpo, senza specificare quando, come e perché, e se mai con un senso di attività,<br />
cioè avendo posto da banda il corpo, avendo conquistato e non subìto il suo abbandono. E poiché<br />
sappiamo che lo scopo primario che il discepolo pitagorico si proponeva di raggiungere, con ogni<br />
sforzo, era la liberazione dai vincoli del corpo, e non già l'attesa passiva ed inerte della morte, è<br />
chiaro che nel tradurre bisogna almeno lasciare alle due parole il duplice senso che esse hanno nell'originale,<br />
quantunque da tutto il contesto sia evidente che esse alludono a quell'abbandono del corpo<br />
che si ottiene col "distacco volontario rituale" e non a quel distacco che la morte adduce a tutti<br />
gli uomini ed a tutti gli animali. Questo senso attivo è confermato dalla voce λθ ς, che il Delatte<br />
traduce correttamente: se tu pervieni... Anche il su non lodato pitagorico francese Fabre d'Olivet interpreta<br />
in modo arbitrario; invece di abbandonato il corpo egli traduce: en laissant sur le corps régner<br />
l'intelligence. 7 E l'Alessio fedelmente lo segue.<br />
Se ci siamo permessi di insistere si è perché si tratta di cosa assolutamente essenziale per la retta<br />
comprensione del pitagoreismo, ed anche perché risulti meglio che non è per semplice caso, in relazione<br />
ad argomento di questa importanza, che l'ultimo verso contenga tre parole che significano tutte<br />
e tre immortale. Esse sono: θ ναθος, θε ς µβροτος, ο κ τι θνητ ς, ed occorre tradurre:<br />
sarai imperituro, dio immortale, non uccidibile.<br />
I membri del sodalizio pitagorico erano suddivisi in tre classi. Secondo il dialogo tra Policrate e<br />
Pitagora che abbiamo già riportato queste tre classi erano quelle dei matematici, dei fisici e dei contemplanti,<br />
secondo Giamblico citato dallo Chaignet 8 erano quelle dei novizi, matematici e fisici, se-<br />
un Pitagora che rende onore agli Dei solo per contentare il volgo, ma poi in segreto onora la propria fede, diversa ben<br />
inteso dal politeismo pagano.<br />
Questa errata interpretazione è riportata anche in un recente lavoro di uno scrittore italiano, Luigi Alessio - Pitagora<br />
- [Corbaccio/Dall’Oglio], Milano, 1940.<br />
5 Delatte - Études sur la litt. pythag., pag. 9.<br />
6 Giuliano Kremmerz - Avviamento alla Scienza dei Magi, pag. 18.<br />
7 Fabre d'Olivet - Le Vers dorés de Pythagore expliqués – Paris, 1813, pag. 402.<br />
8 Chaignet - Pythag. et la philos. pythag. I, pag. 116.<br />
16