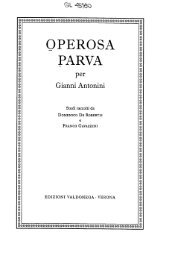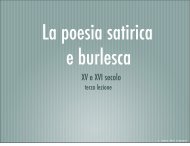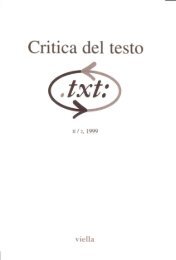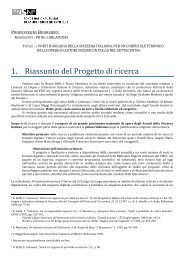Sonetti contro l'Ariosto, giudice de' Savi in Ferrara - Carla Rossi ...
Sonetti contro l'Ariosto, giudice de' Savi in Ferrara - Carla Rossi ...
Sonetti contro l'Ariosto, giudice de' Savi in Ferrara - Carla Rossi ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Studi e Ricerche<br />
51
In copert<strong>in</strong>a: Francesco Bonsignori, Ritratto del Pistoia (?), tempera su tavola (32 x<br />
28 cm), collezione G. G. Poldi Pezzoli, Milano.
Antonio Cammelli<br />
(il Pistoia)<br />
<strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto,<br />
<strong>giudice</strong> de’ <strong>Savi</strong> <strong>in</strong> <strong>Ferrara</strong><br />
Edizione critica a cura di<br />
<strong>Carla</strong> <strong>Rossi</strong><br />
Edizioni dell’Orso<br />
Alessandria
© 2006<br />
Copyright by Edizioni dell’Orso s.r.l.<br />
via Rattazzi, 47 15100 Alessandria<br />
tel. 0131.252349 fax 0131.257567<br />
e-mail: edizionidellorso@libero.it<br />
http://www.ediorso.it<br />
Impag<strong>in</strong>azione a cura di Isabella M. Grasso<br />
È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata,<br />
compresa la fotocopia, anche a uso <strong>in</strong>terno e didattico. L’illecito sarà penalmente<br />
perseguibile a norma dell’art. 171 della Legge n. 633 del 22.04.41<br />
ISBN 88-7694-000-0
Erostrato: “Pasifilo, entra <strong>in</strong> casa, e va’ ne la<br />
cuc<strong>in</strong>a, e fa’ cuocere e disporre quelle vivande<br />
a tuo arbitrio!”<br />
Pasifilo: “Se mi avessi fatto Iudice de’ <strong>Savi</strong>,<br />
non mi davi uffizio che più secondo il mio<br />
appetito fussi! Io vi vo di botto”.<br />
Ludovico Ariosto, I Suppositi, Atto V, Scena II
Tavola delle abbreviazioni<br />
Nel testo vengono utilizzate queste sigle e citate <strong>in</strong> forma abbreviata le seguenti<br />
opere:<br />
BCA Biblioteca Comunale Ariostea, <strong>Ferrara</strong><br />
BNF Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze<br />
BORSETTI F. BORSETTI, Serie dei giudici dei <strong>Savi</strong> e dei <strong>Savi</strong> del Maestrato<br />
della città di <strong>Ferrara</strong> dall’anno 1321 s<strong>in</strong>o al corrente 1760,<br />
<strong>Ferrara</strong>, Biblioteca Comunale Ariostea, Ms Classe I, 492.<br />
CALEFFINI U. CALEFFINI, Croniche, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms.<br />
Vat. Lat. 9263 (già I, 1, 4, della Chigiana).<br />
CF Rime edite ed <strong>in</strong>edite di Antonio Cammelli detto il Pistoia, a c.<br />
di A. CAPPELLI e S. FERRARI, Livorno, Vigo, 1884.<br />
Diario ferrarese B. ZAMBOTTI, Diario ferrarese dall’anno 1476 s<strong>in</strong>o al 1504, a<br />
c. di G. PARDI, appendice al Diario Ferrarese, <strong>in</strong> RIS 2 , XXIV/7<br />
(1928)<br />
FANFANI P. FANFANI, Vocabolario della L<strong>in</strong>gua Italiana, Firenze, 1905.<br />
HONDEDIO Hondedio di Vitale, Cronaca, <strong>Ferrara</strong>, BCA, Coll. Antonelli, Ms<br />
257.<br />
LD Archivio di Stato di Modena, Cancelleria ducale, Leggi e decreti.<br />
Rettori Archivio di Stato di Modena, Cancelleria ducale, Carteggi dei<br />
rettori dello Stato.<br />
RIS 1 Rerum Italicarum Scriptores, a c. di L. A. MURATORI, Milano,<br />
Società Palat<strong>in</strong>a, 1723-51.<br />
RIS 2 Rerum Italicarum Scriptores, a c. di G. CARDUCCI e V. FIORINI,<br />
Bologna, Zanichelli, 1900-…<br />
SACCHETTI Franco SACCHETTI, Il Libro delle Rime, a c. di A. CHIARI, Bari,<br />
Laterza, 1936.<br />
Statuta Ferrariae Statuta Ferrariae. Anno MCCLXXXVII, a c. di W. MONTORSI,<br />
Cassa di Risparmio, <strong>Ferrara</strong> 1955.<br />
TIRABOSCHI G. TIRABOSCHI, Dizionario topografico-storico degli Stati Estensi,<br />
Tip. Camerale, Modena 1824-25.<br />
Vacchette Archivio Storico Comunale di Modena, Camera segreta.<br />
Villani, Cronica Giovanni Villani, Nuova cronica, a c. di G. PORTA, 3 voll., Parma,<br />
Fondazione Pietro Bembo, Milano, Guanda, 1990-1991.
2 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
Voc. Crusca Il Vocabolario degli Accademici della Crusca, Venezia 1612.<br />
Edizione elettronica, Accademia della Crusca - Scuola Normale<br />
Superiore CRIBeCu, 2001.
Premessa<br />
Nel 1865, Antonio Cappelli pubblicava a Bologna, presso Romagnoli, la<br />
pr<strong>in</strong>ceps dei <strong>Sonetti</strong> giocosi di Antonio da Pistoia, costituita da venti componimenti<br />
tratti <strong>in</strong> parte dal codice a. H. 6. I della Biblioteca Estense di Modena, e <strong>in</strong><br />
parte dal ms. D. 313 della Forteguerriana di Pistoia, cui aggiungeva, <strong>in</strong> appendice,<br />
ventitré sonetti adespoti <strong>contro</strong> Niccolò Ariosto, il quale, dal 28 gennaio del<br />
1486 s<strong>in</strong>o alla f<strong>in</strong>e di dicembre del 1488, aveva ricoperto la carica di Giudice dei<br />
Dodici <strong>Savi</strong> di <strong>Ferrara</strong> e che è passato alla storia più per essere il padre di Ludovico<br />
che per particolari meriti personali.<br />
La s<strong>in</strong>golare collana di sonetti caudati <strong>contro</strong> l’Ariosto è tràdita da un solo<br />
codice miscellaneo lat<strong>in</strong>o e italiano di prose e versi di vari autori: il Lat. 228 = a.<br />
W. 2. 11 della Biblioteca Estense Universitaria di Modena, che la contiene alle<br />
cc. 179r-188v. Il manoscritto è stato esemplato quasi <strong>in</strong>teramente dal patrizio e<br />
letterato ferrarese Gaspare Sardi (1480-1559) 1 , sebbene i <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
appaiano di altra mano.<br />
In quella sede, il Cappelli avanzò per primo, ancorché senza argomentazioni<br />
conv<strong>in</strong>centi 2 , l’ipotesi che l’autore dei componimenti satirici <strong>contro</strong> il conte<br />
Ariosto fosse Antonio Cammelli, detto il Pistoia (1436-1502), uno dei maggiori<br />
poeti burleschi del nostro Quattrocento, acclamato e celebrato <strong>in</strong> vita e ancor più<br />
nel C<strong>in</strong>quecento 3 , pur tuttavia generalmente negletto dalla critica contemporanea.<br />
A favore dell’attribuzione si espresse <strong>in</strong> seguito Giosuè Carducci, nel Saggio<br />
sulle poesie lat<strong>in</strong>e di Lodovico Ariosto 4 e Giulio Bertoni, nel 1910, scriveva<br />
che gli argomenti del Cappelli «non raggiungono, per comune consenso, il valo-<br />
1 Autore, tra l’altro, del Libro delle historie ferraresi, edito per la prima volta a <strong>Ferrara</strong>,<br />
presso Francesco <strong>Rossi</strong> da Valenza, 1556.<br />
2 A. CAPPELLI, <strong>Sonetti</strong> giocosi di Antonio da Pistoia e sonetti satirici senza nome<br />
d’autore, Bologna, Romagnoli, 1865, p. 16.<br />
3 Dal Castiglione nel Cortegiano, II 67; dal Berni (che possedette il prezioso “codice<br />
Giann<strong>in</strong>ello”); dal Bandello <strong>in</strong> una delle sue Novelle, I XXXIV; da Niccolò Franco nelle<br />
Rime <strong>contro</strong> l’Aret<strong>in</strong>o; dall’Aret<strong>in</strong>o stesso nel Ragionamento delle Corti e ancora dall’Ariosto<br />
nelle Satire (VI: «Ma se degli altri io vuo’ scoprir gli altari, /tu dirai che rubato e<br />
del Pistoia /e di Petro Aret<strong>in</strong>o abbia gli armari»), dal Manfredi e dal Casio.<br />
4 G. CARDUCCI, Saggio sulle poesie lat<strong>in</strong>e di Lodovico Ariosto, Zanichelli, Bologna,<br />
1876, p. 31.
4 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
re d’una dimostrazione, ma hanno più d’una presunzione di coglier nel vero» 5 ;<br />
mentre nel 1953, Antonio Piromalli notava: «come ebbe a riconoscere ampiamente<br />
Vittorio Cian, il Pistoia che fu costretto a vivere presso le corti non si<br />
confonde con la turba dei verseggiatori prezzolati […] fu poeta anticortigiano e<br />
antiestense perché il sistema di vita che derivava dalla corte estense venne da lui<br />
satireggiato con amarezza: la corruzione dei funzionari, la vanità dei letterati, la<br />
crudeltà dei magistrati e capitani di giustizia hanno nel Pistoia un coraggioso denunciatore<br />
e per tale motivo non ci meraviglieremmo se si accertasse la sua paternità<br />
dei sonetti <strong>contro</strong> Niccolò Ariosto» 6 .<br />
La produzione del Pistoia, che comprende un poemetto giovanile <strong>in</strong> ottava rima,<br />
l’Istoria di Patroclo e d’Insidoria 7 , più di c<strong>in</strong>quecento sonetti satirici e politici,<br />
una tragedia, Pamphila (considerata dagli storici della letteratura la prima<br />
opera teatrale italiana che si discosti dalla forma delle rappresentazioni popolari<br />
e si avvic<strong>in</strong>i alla classica), una commedia, De Amicitia, purtroppo oggi perduta,<br />
una frottola, Madonna mia illustrissima ed un capitolo, ascrivibile al genere della<br />
“disperata”, è stata f<strong>in</strong>ora raccolta ed edita disord<strong>in</strong>atamente (soprattutto per<br />
quel che riguarda i problemi ectodici legati alla tradizione manoscritta), senza i<br />
necessari collegamenti fra i s<strong>in</strong>goli testi e, soprattutto, senza una contestualizzazione<br />
storico-culturale.<br />
Studiato con moderato <strong>in</strong>teresse verso la f<strong>in</strong>e dell’Ottocento, come attestano<br />
anche alcune stampe, pubblicate soprattutto <strong>in</strong> occasione di nozze, riscoperto e<br />
edito da Erasmo Pèrcopo agli <strong>in</strong>izi del Novecento, il pistoiese è stato, tuttavia,<br />
trascurato dalla critica contemporanea, che gli ha negato s<strong>in</strong>ora un’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e organica,<br />
tanto che la pubblicazione più importante sul suo conto, <strong>in</strong> epoca relativamente<br />
recente, resta la sola voce curata da Domenico De Robertis per il DBI 8 .<br />
Grazie ad una sovvenzione del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca<br />
Scientifica, ho perciò <strong>in</strong>trapreso il vasto progetto di edizione dell’<strong>in</strong>tero corpus<br />
lirico del Pistoia, <strong>in</strong>iziando dalla pubblicazione di uno dei più s<strong>in</strong>golari componimenti<br />
del poeta toscano: la Disperata 9 , capitolo <strong>in</strong> terza rima posto a mo’ di<br />
epilogo del suo canzoniere burlesco; per proseguire poi con il presente studio dei<br />
<strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto (ripubblicati qui nel maggiore rispetto del codice unico<br />
5 G. BERTONI, Intorno a un sonetto dialettale attribuito al Pistoia, <strong>in</strong> «Giornale storico<br />
della letteratura italiana», vol. LV, Tor<strong>in</strong>o, Loescher, 1910, pp. 455-457.<br />
6 Cfr. A. PIROMALLI, La cultura a <strong>Ferrara</strong> al tempo di Ludovico Ariosto, Firenze, La<br />
Nuova Italia, 1953, p. 149.<br />
7 Tràdito anonimo dal solo codice BNF Palat<strong>in</strong>o 219, ma, come spero di dimostrare<br />
nella mia monografia dedicata al Pistoia di prossima pubblicazione, senz’altro attribuibile<br />
al Cammelli.<br />
8 D. DE ROBERTIS, Cammelli Antonio, <strong>in</strong> DBI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,<br />
1960-, XVII, ad vocem, pp. 277-86.<br />
9 C. ROSSI, La “Disperata”, capitolo conclusivo dei “<strong>Sonetti</strong> faceti” del Pistoia, <strong>in</strong><br />
«LIA», 6 (2005), pp. 43-61.
Premessa<br />
che li contiene) 10 , e term<strong>in</strong>are <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e con una monografia, corredata dall’edizione<br />
critica dei più importanti sonetti politici, lubrici e satirici del pistoiese e da alcune<br />
opere tràdite anonime, che vanno <strong>in</strong>discutibilmente restituite al Cammelli.<br />
Dopo aver sottoposto la collana dei sonetti <strong>contro</strong> il Giudice de’ <strong>Savi</strong> ad<br />
un’accurata analisi critica, stilistica e l<strong>in</strong>guistica, sono giunta alla conclusione<br />
che dei 23 sonetti polemici volti a colpire l’avidità del conte Niccolò, personaggio<br />
pubblico tristemente noto ai sudditi del ducato estense, 21 sono certamente<br />
usciti dalla plume, avvelenatissima, del Pistoia, mentre altri due sono di un secondo<br />
autore (con ogni verosimiglianza Lelio Manfredi) 11 , il quale <strong>in</strong>tervenne<br />
apertamente a dar man forte al Nostro.<br />
Ho approntato quest’edizione commentata con l’obiettivo di rilanciare, <strong>in</strong> una<br />
prospettiva ermeneutica consona, l’opera lirica del poeta satirico toscano. A tale<br />
scopo l’Introduzione colloca i <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto nel contesto storico-politico<br />
nel quale essi vennero elaborati; si passa poi all’esegesi della s<strong>in</strong>golare collana,<br />
segnalando, a piè di pag<strong>in</strong>a, le poche correzioni apportate al manoscritto e le<br />
molte <strong>in</strong>esattezze della stampa del 1865 (riedita nel 1884 a cura di Cappelli e<br />
Ferrari) 12 ; <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, la parafrasi di ogni componimento e il commento ai s<strong>in</strong>goli sonetti<br />
tenteranno di penetrarne la particolare veste l<strong>in</strong>guistica.<br />
Com’è noto, nel Quattrocento, dalla poesia del Burchiello prese corpo una<br />
produzione burlesca e satirica che <strong>in</strong>teressò una messe di autori dissem<strong>in</strong>ati <strong>in</strong><br />
tutta Italia e che trovò sfogo nel l<strong>in</strong>guaggio allusivo e a doppio senso dei canti<br />
carnascialeschi. Una produzione che cont<strong>in</strong>uò nel C<strong>in</strong>quecento col Folengo, col<br />
Berni e con i burleschi che fecero capo alla romana Accademia dei Vignaioli o<br />
con i toscani dell’Accademia degli Umidi, cui aderirono, tra gli altri, il poeta-pittore<br />
Agnolo di Cosimo, detto il Bronz<strong>in</strong>o 13 , Anton Francesco Grazz<strong>in</strong>i, detto il<br />
Lasca 14 e, tra i m<strong>in</strong>ori, l’Amelonghi e il Seraf<strong>in</strong>i (autori di argute rime giocose<br />
10 Riproduco i sonetti quali si leggono nel citato codice estense, perché più facilmente<br />
si rilev<strong>in</strong>o e correggano le molte <strong>in</strong>esattezze della stampa del Cappelli, pubblicata, tra<br />
l’altro, senza l’ausilio di un adeguato commento. Il mio obiettivo è quello di offrire un<br />
contributo per un’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e filologicamente, letterariamente e storicamente più approfondita<br />
attorno all’opera del Pistoia.<br />
11 Traduttore del Tirant lo Blanc di Joanot Martorell negli anni Dieci del C<strong>in</strong>quecento.<br />
Sul Manfredi, cfr. C. ZILLI, Notizia di Lelio Manfredi, letterato di corte, <strong>in</strong> «Studi e<br />
problemi di critica testuale», XXII (1983), pp. 39-54.<br />
12 A. Cappelli ripubblicò, <strong>in</strong>fatti, <strong>in</strong>sieme con S. Ferrari (Cfr. CF), nel 1884, i ventitré<br />
sonetti <strong>in</strong> Rime edite e <strong>in</strong>edite di Antonio Cammelli detto il Pistoia, Livorno, Vigo, pp.<br />
250-277.<br />
13 Poeta burlesco di notevole raff<strong>in</strong>atezza, autore, tra l’altro, di una collana di sonetti<br />
<strong>contro</strong> il Castelvetro dal titolo I Salterelli dell’Abbrucia sopra i Mattacc<strong>in</strong>i di ser Fedocco,<br />
a c. di C. ROSSI, Roma, Salerno Editrice, 1998.<br />
14 Anton Francesco Grazz<strong>in</strong>i, Le rime burlesche edite e <strong>in</strong>edite, a c. di C. VERZONE,<br />
Firenze, Sansoni, 1882.<br />
5
6 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
d’occasione), esponenti d’una lirica che scelse le vie della mimesi burlesca, del<br />
rifacimento parodico, dell’<strong>in</strong>vettiva e della satira e che non disdegnò il lat<strong>in</strong>o<br />
macaronico, il gergo ionadattico, il dialetto (usati, s’<strong>in</strong>tende, con estrema consapevolezza<br />
e perizia stilistica).<br />
Se si vuole tracciare una mappa aggiornata della poesia burlesca quattro-c<strong>in</strong>quecentesca<br />
e seguire, <strong>in</strong> tutte le sue ramificazioni, l’accidentato percorso che<br />
dal Burchiello conduce al Berni, non si può non passare per il Pistoia, come ha<br />
sottol<strong>in</strong>eato Adriana Mauriello 15 , e non si può non dedicare a questo poeta l’attenzione<br />
che merita, anche per comprendere le ragioni di una diaspora che il mecenatismo<br />
di Lorenzo il Magnifico non volle e non potè fermare ed il s<strong>in</strong>golare<br />
<strong>in</strong>treccio di culture diverse prodottosi nelle corti settentrionali, dove si giunse<br />
addirittura a favorire una sorta di colonizzazione da parte dei letterati toscani.<br />
15 Cfr. A. MAURIELLO, L’edizione dei “<strong>Sonetti</strong> faceti” di Antonio Cammelli, <strong>in</strong><br />
«Esperienze letterarie» (1999), pp. 51-67.
1. Il “Giudice de’ <strong>Savi</strong>” di <strong>Ferrara</strong><br />
I<br />
Introduzione<br />
Il 28 gennaio del 1486, il ferrarese Niccolò Ariosto, <strong>in</strong>vestito alcuni anni prima<br />
del mero titolo di conte (senza feudo) dall’Imperatore Federico III, già capitano<br />
della cittadella di Reggio dal 1472 al 1480, capitano <strong>in</strong> Poles<strong>in</strong>e durante la<br />
guerra <strong>contro</strong> i veneziani (1481-82) e tesoriere generale delle milizie estensi,<br />
venne nom<strong>in</strong>ato dal proprio protettore, il duca Ercole I d’Este, “Giudice de’ XII<br />
<strong>Savi</strong>”, ossia capo dell’amm<strong>in</strong>istrazione comunale di <strong>Ferrara</strong> 16 .<br />
Michele Catalano, nella sua biografia di Ludovico Ariosto 17 , si domanda come<br />
avesse fatto il padre del poeta ad ottenere una carica tanto prestigiosa e avanza<br />
l’ipotesi che l’avesse comprata, come avveniva allora per molti impieghi di<br />
corte e del comune. La verità storica è, se possibile, anche peggiore: sappiamo<br />
difatti che il duca aveva un debito aperto con il neo-conte il quale, nel 1471, aveva<br />
partecipato al complotto, ordito a Modena, per uccidere il legittimo duca di<br />
<strong>Ferrara</strong>, Niccolò di Lionello d’Este. La nom<strong>in</strong>a dell’Ariosto a Giudice dei <strong>Savi</strong><br />
serviva, verosimilmente, all’estense per disobbligarsi e al conte per trarne facili<br />
guadagni ed un certo potere. Nel Quattrocento, <strong>in</strong>fatti, il pr<strong>in</strong>cipale organo del<br />
comune di <strong>Ferrara</strong> era il consiglio dei <strong>Savi</strong> (derivante dal m<strong>in</strong>or consiglio medievale),<br />
i cui membri venivano nom<strong>in</strong>ati direttamente dal duca, al pari del Giudice<br />
che li presiedeva e di ogni altro ufficiale e magistrato cittad<strong>in</strong>o, compreso il massaro<br />
che gestiva le entrate del comune.<br />
Quella di Giudice dei <strong>Savi</strong>, def<strong>in</strong>ito «pater moderatorque patriae et praefectus<br />
universitatis» 18 , sebbene fosse una carica di grande prestigio all’<strong>in</strong>terno del consiglio,<br />
comportava mansioni <strong>in</strong> realtà piuttosto circoscritte che si limitavano, per<br />
lo più, a compiti di rappresentanza: immissione nell’officio del podestà 19 , posi-<br />
16 La carica equivaleva a quella di Gonfaloniere <strong>in</strong> altre città.<br />
17 M. CATALANO, Vita di Ludovico Ariosto, G<strong>in</strong>evra, Olschki, 1931, I, p. 61.<br />
18 Cfr. Statuta Ferrariae, Anno MCCLXXXVII, cc. 1r-v.<br />
19 Le cronache ferraresi ricordano, ad esempio, l’immissione <strong>in</strong> ufficio da parte dell’Ariosto<br />
del podestà Jacomo Baiardo, gentiluomo di Parma, nel gennaio del 1487:<br />
«acompagnato a cavallo da li zentilhom<strong>in</strong>i con le trombe e coi stendardi. Al quale el Magnifico<br />
Zudexe di XII <strong>Savi</strong>i, messer Niccolò di Ariosti, ge dette la bacheta al tribunale,<br />
<strong>in</strong> presentia di XII Sapienti» (Diario ferrarese, p. 177).
8 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
zioni d’onore nelle cerimonie e nelle processioni cittad<strong>in</strong>e, ord<strong>in</strong>aria amm<strong>in</strong>istrazione<br />
<strong>in</strong> materia di rifornimento annonario, fiscalità, igiene e istruzione pubblica.<br />
Fu proprio dal <strong>contro</strong>llo diretto del fisco che molti <strong>Savi</strong> trassero i loro maggiori<br />
guadagni, sovente senza che il duca fosse al corrente dei loro traffici.<br />
«Di fatto l’unica sfera <strong>in</strong> cui i <strong>Savi</strong> si muovevano con una certa autonomia<br />
era la redazione degli estimi civili e rurali e delle altre forme di rilevamento della<br />
popolazione, <strong>in</strong> base a cui oltre alle “colte” stabilite dal comune venivano ripartite<br />
anche alcune imposte e gravezze straord<strong>in</strong>arie istituite dal Signore» 20 . Le<br />
l<strong>in</strong>ee guida erano sempre stabilite dal duca e dai suoi collaboratori, di cui i <strong>Savi</strong><br />
si limitavano a eseguire le decisioni con scarsi marg<strong>in</strong>i di <strong>in</strong>iziativa. Presso l’Archivio<br />
Storico di <strong>Ferrara</strong> sono conservati i registri contenenti le Deliberazioni<br />
dei <strong>Savi</strong> 21 ; è assai <strong>in</strong>dicativo il fatto che il consiglio, solo sporadicamente menzionato<br />
negli statuti quattro e c<strong>in</strong>quecenteschi, non avesse neppure una sede propria<br />
e si riunisse <strong>in</strong> alcune sale del priorato di San Romano (antico monastero già<br />
semiabbandonato nel Quattrocento), da dove nel 1474 si trasferì, <strong>in</strong> affitto, <strong>in</strong><br />
una camera del palazzo di corte, accanto ai locali del Consiglio segreto.<br />
Lo scarso peso politico del consiglio si rifletteva sulla sua composizione: se è<br />
vero che per tutto il Quattrocento le famiglie che contavano il più alto numero di<br />
<strong>Savi</strong> fra i propri membri appartenevano tutte a quelle che un cronista ferrarese<br />
come il Caleff<strong>in</strong>i def<strong>in</strong>iva genericamente «case di zentilhom<strong>in</strong>i», va però sottol<strong>in</strong>eato<br />
come numerose casate fra le più antiche, potenti e prestigiose se ne mantennero<br />
sempre lontane, proprio perché la carica comportava un’implicazione<br />
personale nel <strong>contro</strong>llo di tasse, denari, mercati e nel rapporto diretto con i cittad<strong>in</strong>i.<br />
Come ha sottol<strong>in</strong>eato Marco Fol<strong>in</strong>: «delle 244 famiglie che entrarono <strong>in</strong><br />
consiglio fra il 1420 e il 1505, solo 38 (15%) sono def<strong>in</strong>ibili <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di ‘gentilizie’:<br />
esse occuparono complessivamente 337 (25%) dei 1347 seggi disponibili;<br />
particolarmente presenti furono i Sacrati (11 membri della famiglia occuparono<br />
59 seggi), gli Ariosto (9 consiglieri, 37 seggi), i Costabili (10 consiglieri, 29 seggi),<br />
i Perondoli (7 consiglieri, 27 seggi), i Trotti (7 consiglieri, 24 seggi)» 22 .<br />
Complessivamente, nell’arco del secolo i gentiluom<strong>in</strong>i non occuparono più di un<br />
quarto dei seggi consiliari; viceversa si segnalavano per l’assidua presenza diverse<br />
famiglie borghesi: soprattutto giureconsulti, grandi mercanti e banchieri,<br />
ma anche molti notai, medici, speziali, probabilmente <strong>in</strong> ossequio all’antica consuetud<strong>in</strong>e<br />
che parte del consiglio fosse scelto a rappresentare le contrade.<br />
Si ha dunque l’impressione che il seggio di <strong>Savi</strong>o, oltre che come forma di<br />
gratificazione <strong>in</strong>dividuale, fosse concesso dal duca ottemperando ai desideri delle<br />
famiglie più co<strong>in</strong>volte nei traffici cittad<strong>in</strong>i, e dunque maggiormente <strong>in</strong>teressate<br />
a gestirne anche gli aspetti economici più m<strong>in</strong>uti.<br />
20 Cfr. M. FOLIN, R<strong>in</strong>ascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico Stato<br />
italiano, Bari, Laterza, 2004, p. 76.<br />
21 Regg. 65 (1393-1796).<br />
22 FOLIN, R<strong>in</strong>ascimento estense, cit., ibid.
Introduzione<br />
L’Ariosto succedeva, nella carica, al ricco e rispettabile Bonifacio Bevilacqua,<br />
il quale aveva operato con correttezza ed era stimato dalla popolazione; al<br />
contrario del suo predecessore, il conte Niccolò era un uomo avido e senza scrupoli<br />
e, come giustamente notava Giuseppe Pardi, «il duca potrebbe aver pensato<br />
che egli fosse capace di ricavare le maggiori somme possibili dalle imposte comunali.<br />
L’esonero di Bonifacio Bevilacqua non può essere accaduto perché egli<br />
avesse fatto guadagni illeciti, ma perché forse non era abbastanza energico nell’imporre<br />
il pagamento delle tasse e non faceva rendere abbastanza all’erario comunale<br />
e ducale» 23 .<br />
Così, già il primo gennaio del 1488, <strong>in</strong> occasione dell’<strong>in</strong>sediamento di un<br />
nuovo e giovane podestà a <strong>Ferrara</strong>, i <strong>Savi</strong>, nel corso della seduta pubblica, manifestarono<br />
il loro risentimento nei confronti dell’Ariosto, il cui operato illecito era<br />
talmente palese da imbarazzare i colleghi 24 ; tanto che, alla f<strong>in</strong>e del 1488, il conte<br />
Ariosto, a neppure tre anni dalla sua prestigiosa nom<strong>in</strong>a, venne sollevato, repent<strong>in</strong>amente,<br />
dal redditizio <strong>in</strong>carico dal duca che, declassandolo, nel marzo dello<br />
stesso anno, lo <strong>in</strong>viò come capitano a Modena. Le cosiddette “vacchette” del comune<br />
di Modena, custodite presso l’Archivio Storico Comunale, registrano il<br />
suo <strong>in</strong>gresso <strong>in</strong> città fra una gran turba di cittad<strong>in</strong>i:<br />
Nicolaus de Areostis comes <strong>in</strong>travit honorifice pro Capitaneo huius alme civitatis<br />
Mut<strong>in</strong>e magna civium comitante caterva 1489 die XXVIII febr.<br />
A dar credito ad un anonimo poeta dell’epoca, i modenesi avevano ben poche<br />
ragioni di festeggiare l’<strong>in</strong>gresso del nuovo capitano <strong>in</strong> città: Modena si lamenta e<br />
dice Oimè / io mi sento doler forte la testa, / perché <strong>Ferrara</strong> giubila e fa festa, /<br />
della sua febbre che venir mi dè // Misera agnella mè, che mal per me, / dal gran<br />
suo lupo <strong>in</strong> preda son richiesta, / ché se ’l Pastor mio aduito non mi presta, /<br />
scannata ho già la pelle per mia fé. (son. XXI). Il motivo dell’allontanamento<br />
del conte Ariosto dalla capitale del ducato estense risiedeva giustappunto nel fatto<br />
che, nei quasi tre anni trascorsi a capo dell’amm<strong>in</strong>istrazione comunale, egli si<br />
era manifestamente arricchito a spese dei suoi concittad<strong>in</strong>i ed era divenuto celeberrimo<br />
per le sue <strong>in</strong>sistenti e cont<strong>in</strong>ue estorsioni, ruberie e violenze.<br />
Che il padre di Ludovico fosse un uomo violento e iracondo è cosa risaputa<br />
presso i biografi del poeta e Girolamo Baruffaldi, nella Vita di Lodovico Ariosto<br />
25 riferisce di una lettera, conservata presso l’Archivio estense, a firma di Niccolò<br />
<strong>in</strong> cui il conte, da Modena, si vantava col duca di esser riuscito ad estorcere<br />
con la tortura ad un povero <strong>in</strong>nocente una dettagliata confessione.<br />
Il 5 aprile del 1487, il duca Ercole I convocò i <strong>Savi</strong>, per annunciare loro la<br />
23 Cfr. Diario ferrarese, p. 172.<br />
24 Cfr. CATALANO, Vita di Ludovico Ariosto, cit., I, p. 61.<br />
25 Cfr. G. BARUFFALDI, Vita di Lodovico Ariosto, <strong>Ferrara</strong>, 1807, p. 23.<br />
9
10 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
sua decisione di partire <strong>in</strong> pellegr<strong>in</strong>aggio, alla volta di Santiago de Compostela:<br />
«Lo illustrissimo et excellentissimo duca nostro, messer Hercule, fece chiamare<br />
<strong>in</strong> la camera soa lo magnifico zudexe di XII <strong>Savi</strong>i, messer Nicolò di Ariosti, con<br />
tuti li XII <strong>Savi</strong>i e molti altri z<strong>in</strong>tilhom<strong>in</strong>i. A li quali parlò <strong>in</strong> presentia de lo ambasatore<br />
del duca de Milano […]: “Carissimi e nobilissimi mei cittad<strong>in</strong>i e z<strong>in</strong>tilhom<strong>in</strong>i.<br />
Domane de mat<strong>in</strong>a io son per dirizare il cam<strong>in</strong>o mio verso Sancto Jacobo<br />
de Gallicia […]. Da posa il magnifico zudexe di XII <strong>Savi</strong>i, messer Nicolò di<br />
Ariosti, subiunse con bono animo e audacemente le seguente parole: “Illustrissimo<br />
Signore, avenga che la presentia de la Celsitud<strong>in</strong>e vostra sia a nuy tuti più<br />
grata che il desiderio de quella <strong>in</strong> soa absentia, niente de meno, habiando deliberata<br />
de adimpire il vodo facto, ne è forza stare contenti de la volentade vostra,<br />
perché cusì è sta’ sempre uxanza de questo populo vostro fidelissimo, de stare<br />
obediente a la volentade de li soi Signori, e cusì io <strong>in</strong> nome de questo populo<br />
rengratio la segnoria vostra, quella se habia dignata de domandare licentia de tale<br />
partita, la quale è <strong>in</strong> potestà vostra. Per il che nuy comprehenderemo quella<br />
havere uxato uno grandissimo segno de benivolentia e maxime per averne arecomandato<br />
il Stato e li fioli, molgie e fratelli: li quali sempre ne sono e seràno al<br />
cuore per lo caratere de la benivolentia porteremo a vostra Excellentia, la quale<br />
pregamo divotamente ne volgia aricomandare tuti a le soe segnorie, e nuy pregaremo<br />
lo omnipotente Dio ve faci andare e retornare felici e con sanitade» 26 .<br />
Approfittando dell’assenza del duca, partito per Santiago de Compostela, ma<br />
costretto poi a trattenersi a Roma, presso il Papa s<strong>in</strong>o al 24 giugno, avvenne che,<br />
a <strong>Ferrara</strong>, nel corso di un’<strong>in</strong>tera settimana, dal 9 al 15 di giugno del 1487, una<br />
sorta di Pasqu<strong>in</strong>o ante litteram della corte estense, che fece di tutto per mantenere<br />
l’anonimato (sonetto IX: O tu che saper brami chi sia quello / che sì di Niccolò<br />
predica e dice, / perdonami ché qui dir non mi lice / il nome mio, ma t’amo<br />
qual fratello), compose una collana di sonetti, divulgati <strong>in</strong> piazza e presso la corte,<br />
per denunciare le rap<strong>in</strong>e e le malefatte del conte Ariosto. Palad<strong>in</strong>o dei poveri,<br />
il “Detrattore” (come quest’anonimo poeta si def<strong>in</strong>isce nel XII sonetto della sua<br />
collana) prese a denunciare i furti commessi dal Giudice ai danni della gente del<br />
contado e dei cittad<strong>in</strong>i ferraresi, dando l’esempio e <strong>in</strong>coraggiando altri poeti a<br />
seguirlo nel diffamare pubblicamente <strong>in</strong> versi l’Ariosto.<br />
Nelle sue Croniche, Ugo Caleff<strong>in</strong>i ricorda: «Fu adì dicto [9 di giugno] ritrovato<br />
essere stato atacato cum colla suso ambedue le porte del palatio del duca<br />
per mezo il Vescoato e s. Domenico e soto le banche di Calegari e <strong>in</strong> multi altri<br />
tribi, bischizi e <strong>in</strong> grandissima vergogna e obrobrio de Niccolò di Areosti, Iudice<br />
di XII <strong>Savi</strong>j de <strong>Ferrara</strong>, <strong>in</strong> rima e non se potè <strong>in</strong>tendere lo auctore e scriptore» 27 .<br />
D’altronde, l’Ariosto non perse mai il vizio di considerare una cosa sola la<br />
cassa personale e quella dello Stato estense: nel 1496 il duca fu costretto a to-<br />
26 Diario ferrarese, p. 182.<br />
27 Cfr. Vat. Lat. 9263, c. 256: Vergogna del Judice di XII Savj.
Introduzione<br />
gliergli anche l’ultimo <strong>in</strong>carico affidatogli, dopo averlo più volte casso e declassato<br />
da quelli precedenti e dopo avergli chiesto di consegnargli tutte le tasse che<br />
gli erano dovute (che l’Ariosto aveva fatto abilmente sparire): «A dì 24 dicto<br />
[nov. 1496] Niccolò di Ariosti da <strong>Ferrara</strong>, che era commissario <strong>in</strong> Romagna, a<br />
Lugo, per il duca Ercole, a furia fu casso de l’offitio suo e condennato <strong>in</strong> c<strong>in</strong>quecento<br />
ducati d’oro et a non dovere mai più avere offizio dal Signore» 28 .<br />
A <strong>Ferrara</strong>, l’Ariosto tentò più volte di conv<strong>in</strong>cere sia la duchessa Eleonora<br />
d’Aragona d’Este, moglie di Ercole I, sia il duca stesso, a prender provvedimenti<br />
<strong>contro</strong> il suo agguerrito Detrattore (Io sento dir che tu preghi Madama, / che faccia<br />
fare una grida patente, / per ritrovar colui ch’è sì veemente / <strong>in</strong> pubblicar la<br />
tua perversa fama), ma senza successo.<br />
Come accennato nella Premessa, nel 1865, il Cappelli volle dare un nome a<br />
questo mordace rimatore, che con tanta veemenza, quattro secoli prima, si era<br />
scagliato <strong>contro</strong> l’operato dell’avido Ariosto ed avanzò perciò l’ipotesi che si<br />
trattasse d’un toscano di nascita e di temperamento, attivo da tempo alla corte<br />
ferrarese: Antonio Cammelli, detto il Pistoia.<br />
La proposta di Cappelli merita più attente verifiche, soprattutto dopo che l’unico<br />
editore moderno di una parte del corpus delle liriche del Pistoia, Erasmo<br />
Pèrcopo 29 , agli <strong>in</strong>izi del secolo scorso si pronunciò <strong>contro</strong> quest’attribuzione,<br />
senza addurre valide e conv<strong>in</strong>centi giustificazioni al suo dissenso.<br />
Riprendiamo qu<strong>in</strong>di la vexata quæstio e tentiamo di capire se l’ipotesi timidamente<br />
avanzata dal Cappelli possa avere un qualche fondamento. Scriveva il<br />
Cappelli, riguardo alla sua già citata edizionc<strong>in</strong>a di alcuni sonetti del Pistoia, nel<br />
1865: «La mia raccolta ho divisa <strong>in</strong> due parti […]. La parte seconda si compone<br />
di una serie di XXIII sonetti satirici e anonimi <strong>contro</strong> il Giudice de’ <strong>Savi</strong> Niccolò<br />
Ariosto, i quali per più riscontri si direbbero appartenere ad Antonio da Pistoia,<br />
se non mostrassero natural propensione al dialetto lombardo […] e non si mostrassero<br />
dettati <strong>in</strong> <strong>Ferrara</strong>, quando il nostro poeta n’era lontano». Quasi vent’anni<br />
dopo, lo stesso Cappelli, nell’edizione delle Rime del Pistoia curata <strong>in</strong>sieme<br />
con S. Ferrari, corresse il tiro, scrivendo, <strong>in</strong> merito alla paternità di questi sonetti:<br />
«ne acquisto maggior persuasione coll’essermi accorto che il codice miscellaneo<br />
estense ha dove <strong>in</strong>com<strong>in</strong>ciano i sonetti <strong>contro</strong> Niccolò Ariosto una striscia di<br />
carta piegata a guisa di segno, nel cui <strong>in</strong>terno si legge di vecchio carattere Antonius<br />
ex familia Cameli oriunda Pistorio, floruit XV et XVI sec.» 30 .<br />
Affrontiamo brevemente, qui di seguito, i s<strong>in</strong>goli argomenti del Cappelli, partendo<br />
<strong>in</strong>nanzitutto dalla data di composizione dei sonetti, per passare poi al discorso<br />
sulla loro veste l<strong>in</strong>guistica.<br />
28 Diario ferrarese, pp. 191-2.<br />
29 E. PÈRCOPO, I <strong>Sonetti</strong> faceti di Antonio Cammelli, Napoli, Jovene, 1908.<br />
30 CF xxxij.<br />
11
12 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
2. La data di composizione dei Bischizi<br />
Come già anticipato, Ugo Caleff<strong>in</strong>i segnalò che durante un’<strong>in</strong>tera settimana<br />
di giugno del 1487, dal 9 al 15, feroci bischizi 31 vennero affissi un po’ ovunque a<br />
<strong>Ferrara</strong>: «Domenica adì 10 dicto ne fue etiam ritrovati de altra manera pure contra<br />
el dicto Niccolò Areosto. Luni similiter ne fu retrovati de altra sorte. Marti similiter<br />
ne fu retrovato de altra sorte. Vegneri adì 15 ne fu retrovato multo più vituperosi<br />
contra el dicto e contra Zoanne Jeronimo Marchese, fiolo che fu de<br />
Zoanne Ludovico Marchese da <strong>Ferrara</strong>» 32 .<br />
Si confonde dunque il Cappelli nell’ascrivere i ventitré sonetti <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
al 1497, di conseguenza sbaglia nel dire che, se di mano del Pistoia, essi furono<br />
causa dell’allontanamento del poeta dal posto di Capitano della porta Santa<br />
Croce a Reggio Emilia, quello stesso anno 33 : la composizione dei sonetti <strong>in</strong>iziali<br />
della corona <strong>contro</strong> il Giudice dei <strong>Savi</strong>, <strong>in</strong>fatti, è da ascrivere certamente a dieci<br />
anni prima e dovette proseguire s<strong>in</strong>o al 1489.<br />
È lecito però chiedersi se i componimenti cui allude il Caleff<strong>in</strong>i fossero solo i<br />
ventitré della collana tràdita dal ms. Lat. 228 = a. W. 2. 11 della Biblioteca<br />
Estense Universitaria di Modena, o se tra i feroci bischizi non ve ne fossero anche<br />
altri, di diversi autori.<br />
I sonetti <strong>contro</strong> Zoanne Jeronimo Marchese sono, come vedremo tra breve,<br />
certamente tra quelli <strong>in</strong>clusi nella collana del codice estense.<br />
Mi pare tuttavia che, tra i <strong>Sonetti</strong> ferraresi del ’400 <strong>in</strong> una raccolta di poeti<br />
cortigiani 34 , tratti da un codice esemplato da Ermete Bentivoglio, negli anni Novanta<br />
del Quattrocento, ve ne siano di quelli che furono affissi a <strong>Ferrara</strong> nei fatidici<br />
giorni <strong>in</strong> cui più di un rimatore (che maneggiava il verso con perizia e vigoria<br />
di stile non certo improvvisate) <strong>in</strong>veì <strong>contro</strong> l’Ariosto.<br />
«Fronda, opposizione, circolazione clandest<strong>in</strong>a di versi e libelli satirici fatta<br />
da nobili, <strong>in</strong>tellettuali e ricchi borghesi: <strong>in</strong> questo ambiente vengono composti i<br />
sonetti. È letteratura di opposizione e gli autori, assumono qui la voce dei contad<strong>in</strong>i<br />
denunciando giudici, sbirri, malgoverno e signori» 35 .<br />
Si legga, ad esempio il sonetto XXIX (Scene contad<strong>in</strong>esche) 36 , <strong>in</strong> cui un contad<strong>in</strong>o<br />
si appella alla giustizia per avere del grano e si ritrova <strong>in</strong>vece <strong>in</strong> prigione<br />
per aver offeso il Giudice:<br />
31 ‘Bisticci’, ossia ‘giochi di parole’.<br />
32 Cfr. ms. Vat. Lat. 9263, cit., ibidem.<br />
33 Ibid., p. xxxi.<br />
34 Raccolti e trascritti da Ermete Bentivoglio, cavaliere di Ercole I, duca di <strong>Ferrara</strong>, il<br />
10 maggio 1494. A c. di M. MILANI, «Giornale Storico della Letteratura Italiana», 1973,<br />
pp. 292-322.<br />
35 Ibid., p. 302.<br />
36 Ibid., p. 297.
Introduzione<br />
- Mesier lo zuise, fai me dar del gram.<br />
- El non s’<strong>in</strong> pole avere. Anda, medì!<br />
- O Diè el volesse ch’el fusse abonì,<br />
ch’arà mo fatto tre forna de pam!<br />
Ne cri che v’abaresse <strong>in</strong> sta domam.<br />
- Horsù, livra-la ancuò, che dighi a mi?<br />
- Potta de l’ango, misser, sta-vu qui<br />
per far iostisia o per menar le mam?<br />
- Te me dì vilania, vilam poltrom?<br />
- Non fo zà mi, messer, muora ch’il fu<br />
e tutti quei che non volen far rasom.<br />
- E così sia, se te ’l comporto più.<br />
- Fatte <strong>in</strong> zà, Bagatim, e ti, Squarzom!<br />
Tolli una corda e ligàme costù.<br />
- Miser, granmarzé a vu.<br />
E cognosso bem mo che sì cortese<br />
zà che avì voia de farme le spese.<br />
Questo Giudice, aiutato da sbirri tristemente noti ai ferraresi, non può essere<br />
altri che l’Ariosto il quale, tra i suoi scagnozzi, annoverava personaggi dai nomi<br />
parlanti quali Squarzone e Magagn<strong>in</strong>o (tristi figuri che compaiono anche nella<br />
collana di sonetti <strong>contro</strong> l’Ariosto).<br />
Nella trentesima Scena contad<strong>in</strong>esca, <strong>in</strong>clusa nella raccolta di poeti cortigiani<br />
del Bentivoglio, ritroviamo proprio siffatto Magagn<strong>in</strong>o 37 , <strong>in</strong> compagnia di Pol da<br />
Lend<strong>in</strong>ara, protagonista, tra l’altro, anche del sonetto 141 del codice Ambrosiano<br />
H 223 P. <strong>in</strong>f., contenente la maggiore silloge delle rime del Pistoia:<br />
Orsù, brigà, che ’l se vol far d<strong>in</strong> donper allegrezza e strusiar del v<strong>in</strong>,<br />
può che l’è casso el nostro Magagn<strong>in</strong><br />
e Pol da Lendenara quel gioton!<br />
Oh quante volte m’han dà passïon,<br />
ch’a’ m’arecordo per un bologn<strong>in</strong> 5<br />
i me destenne e, se ’l n’era Bel<strong>in</strong>,<br />
i me cazava <strong>in</strong> la marza preson!<br />
Ma questo fu nïente. I vennen può<br />
a casa mia, da lì a qualche un mese,<br />
e sì me volsen tuor el carro e i buò. 10<br />
Ben sai ch’a’ me butiè su le defese<br />
e sì ghe dissi: O Pol, requia s’tu vo,<br />
non me voler cazar del Ferarese!<br />
Magagn<strong>in</strong> se la prese<br />
e sì zurò de meterme <strong>in</strong> gatara 15<br />
se ’l me poseva coiere a Ferara;<br />
37 <strong>Sonetti</strong> ferraresi del ’400, cit., p. 314.<br />
13
14 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
ma Pol da Lendenara<br />
seppe sì ben menar el barboncello<br />
che ’l me convene donarghe un agnello.<br />
I disen può: Fraello, 20<br />
tiente ben cara la nostra amistà,<br />
che la te pò zovar <strong>in</strong> cose’ asà.<br />
Il feroce Magagn<strong>in</strong> tornerà, come vedremo tra breve, nei sonetti XII e XVIII<br />
<strong>contro</strong> l’Ariosto: evidentemente il soprannome è giocato sul term<strong>in</strong>e magagna,<br />
associato all’etimo dal lat<strong>in</strong>o medioevale magnanus ‘fabbro’. Ma uno sbirro dal<br />
nome Magagn<strong>in</strong>o appare anche nella Lena di Ludovico Ariosto (atto IV, scena V<br />
e VII), ambientata proprio a <strong>Ferrara</strong>. Non stupirà dunque scoprire che, all’epoca<br />
di Ercole I, uno dei segretari ducali che assistevano anche il Giudice de’ <strong>Savi</strong>,<br />
fosse un certo Girolamo Magnan<strong>in</strong>o, il cui cognome ben si presta alla storpiatura<br />
burlesca.<br />
M. Milani ricorda che: «a <strong>Ferrara</strong> le poesie satiriche dovevano avere un loro<br />
pubblico ristretto, che solo eccezionalmente diventava quello dell’<strong>in</strong>tera città<br />
quando, al risveglio, i ferraresi trovavano bischizi affissi nei punti più disparati e<br />
maggiormente frequentati di <strong>Ferrara</strong>» 38 .<br />
3. I <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto e la tradizione del vituperium<br />
Se recenti pubblicazioni hanno consentito di acquisire importanti materiali<br />
critici sulle cosiddette pasqu<strong>in</strong>ate romane e sul rapporto Aret<strong>in</strong>o-Pasqu<strong>in</strong>o 39 , non<br />
si è ancora neppure <strong>in</strong>iziato a lavorare attorno ai precursori dei cosiddetti “pasqu<strong>in</strong>anti”;<br />
mentre al Gobbo di Rialto di Venezia, al Porcell<strong>in</strong>o di Firenze o al<br />
“Gegante ’e palazzo” di Napoli sono stati dedicati s<strong>in</strong>o ad oggi pochissimi studi<br />
critici 40 .<br />
38 Ibid., p. 299.<br />
39 Mi riferisco <strong>in</strong> particolare a tre importanti pubblicazioni della Salerno Editrice: Pasqu<strong>in</strong>ate<br />
romane del C<strong>in</strong>quecento, a cura di V. MARUCCI, A. MARZO e A. ROMANO, Presentazione<br />
di G. AQUILECCHIA, Roma, Salerno Editrice («Testi e documenti di letteratura<br />
e di l<strong>in</strong>gua», VII), 1983, 2 voll.; Pasqu<strong>in</strong>ate del C<strong>in</strong>que e Seicento, a cura di V.<br />
MARUCCI, ivi («Omikron», 32), 1988; Pasqu<strong>in</strong>o e d<strong>in</strong>torni. Testi pasqu<strong>in</strong>eschi del C<strong>in</strong>quecento,<br />
a cura di A. MARZO, ivi («Omikron», 35), 1990. Di qualche utilità può risultare<br />
anche C. RENDINA, Pasqu<strong>in</strong>o statua parlante. Quattro secoli di pasqu<strong>in</strong>ate, Roma,<br />
Newton Compton Editori («Quest’Italia», 160), 1991, di carattere più che altro divulgativo.<br />
Purtroppo resta scoperto <strong>in</strong> gran parte il Pasqu<strong>in</strong>o lat<strong>in</strong>o, d’importanza essenziale <strong>in</strong><br />
una cultura radicalmente bil<strong>in</strong>gue qual era quella pontificia.<br />
40 A. MOSCHETTI, Il Gobbo di Rialto e le sue relazioni con Pasqu<strong>in</strong>o, <strong>in</strong> «Nuovo Archivio<br />
Veneto», vol. V (1893), pp. 5-85; oltre agli <strong>in</strong>terventi di V. ROSSI, nella «Rassegna<br />
bibliografica della Lett. It.», I, 184 e nel GSLI, XXII, pag. 295.
Introduzione<br />
Né si può sostenere che i versi <strong>contro</strong> il Giudice dei <strong>Savi</strong> siano genericamente<br />
ascrivibili al genere comico-giocoso, def<strong>in</strong>izione che mal circoscrive fenomeni<br />
stilistici diversi: i bischizi affissi a <strong>Ferrara</strong> non valgono solo come documenti<br />
storico-politici, ma anche come esibizioni retoriche coram populo di vituperium<br />
e di parodia.<br />
Notava a giusto titolo Franco Suitner, nel 1983: «Mario Marti, l’ultimo studioso<br />
che ha dedicato ampie ed amorose cure a questa poesia, ha difeso efficacemente<br />
la qualifica di poesia “giocosa” sulle altre possibili. Le sue argomentazioni<br />
sono assai conv<strong>in</strong>centi e certamente “poesia giocosa” è una etichetta che più<br />
facilmente copre le varie manifestazioni solitamente avvic<strong>in</strong>ate dalla tradizione<br />
storiografica. E tuttavia almeno una pr<strong>in</strong>cipalissima ne resta parzialmente fuori:<br />
il vituperium, la poesia di attacco personale» 41 .<br />
Tanto nel caso dei <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto, quanto per molti sonetti del Pistoia,<br />
sarà dunque più corretto parlare di vituperatio, piuttosto che, approssimativamente,<br />
di poesia giocosa, <strong>in</strong>serendo <strong>in</strong> tal mondo la nostra s<strong>in</strong>golare corona di<br />
sonetti nel solco di quella tradizione di cui, <strong>in</strong> ambito italiano, il fiorent<strong>in</strong>o Rustico<br />
Filippi fu uno degli <strong>in</strong>iziatori 42 .<br />
Le tecniche della vituperatio erano specificatamente contemplate nei trattati<br />
medievali di ars versificandi: la reprehensio veniva messa <strong>in</strong> relazione con la<br />
descriptio personae e rispecchiava il pr<strong>in</strong>cipio del conveniens, ossia della<br />
conformità tra forma e contenuto. Perfettamente <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea con la tradizione è dunque<br />
l’espressione di stupore dell’autore dei <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto, laddove egli<br />
nota che non vi è consonanza tra la dignità della carica ricoperta da Niccolò<br />
Ariosto e il suo operato (come nel secondo componimento della raccolta, vv. 1-<br />
4):<br />
Quand’io ben penso a tua strana natura,<br />
rimango preso <strong>in</strong> gran confusïone:<br />
tu magni ’l legno, il marmore, il sabbione,<br />
il ferro e se gli è cosa ancor più dura.<br />
Nelle artes si rispecchiavano dei precisi ord<strong>in</strong>es personarum: supreme, <strong>in</strong>fime,<br />
mediocres (superiores, equales, <strong>in</strong>feriores): solitamente a una bruttezza fisi-<br />
41 F. SUITNER, La poesia satirica e giocosa nell’età dei Comuni, Antenore, Padova,<br />
1983, p. 3.<br />
42 Per Rustico di Filippo, cfr. la pr<strong>in</strong>ceps, Le rime di Rustico di Filippo, a c. di V. FE-<br />
DERICI, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1899; <strong>in</strong>oltre <strong>Sonetti</strong> di Rustico Filippo,<br />
a c. di V. MENGALDO, Tor<strong>in</strong>o, E<strong>in</strong>audi, 1971; Rustico di Filippo, <strong>Sonetti</strong> satirici e<br />
giocosi, a c. di S. BUZZETTI GALLARATI, Roma, Carocci, 2005 e ancora I trenta sonetti<br />
realistici di Rustico Filippi, nuove congetture testuali e <strong>in</strong>terpretazioni a c. di M. STAN-<br />
GHELLINI, Siena, Accademia dei Rozzi, 2004. Per un testo vituperoso di Rustico si pensi<br />
a Fastel, messer fastidio de la cazza, <strong>contro</strong> tale Messer Iacopo, ghibell<strong>in</strong>o.<br />
15
16 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
ca corrispondeva una bruttezza morale, come avviene anche per i nostri sonetti,<br />
si legga ad esempio l’ottavo (vv. 5-8):<br />
Perché di questo mostro aspro ed orribile<br />
la istoria te dirò, ch’io son dottissimo<br />
de’ furti soi, ed ho un libro plenissimo,<br />
ove cose udirai quasi <strong>in</strong>credibile.<br />
Suitner 43 , chiedendosi da dove giunga <strong>in</strong> Italia questo tipo di poesia, di quali<br />
l<strong>in</strong>fe culturali si nutra il nostro casal<strong>in</strong>go vituperium, nota che non è nella poesia<br />
goliardica, pur importante per altri versanti della rimeria giocosa, che si possono<br />
cercare i diretti modelli dei componimenti caricaturali e vituperosi dei nostri rimatori:<br />
«Una posizione di primaria importanza va <strong>in</strong>vece attribuita alla lirica<br />
provenzale, particolarmente a quella che si sviluppa su suolo italiano. Nelle attuali<br />
trattazioni sulla poesia comico-realistica toscana questo <strong>in</strong>flusso è decisamente<br />
non valutato <strong>in</strong> misura adeguata. […] Per quel che riguarda il vituperium<br />
<strong>in</strong>famante, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione soprattutto al sirventese» 44 .<br />
Se, d’un canto, è <strong>in</strong>negabile che gli immediati precursori dei bozzetti toscani<br />
caricaturali e vituperosi vadano ravvisati nelle derizorias provenzali (la componente<br />
vituperosa di molta lirica provenzale, nella tradizione lat<strong>in</strong>a dei cantica <strong>in</strong><br />
blasphemiam alterius, è stata più volte evidenziata ed illustrata dalla critica romanza)<br />
45 ed anche nelle cantigas d’escarnho della penisola iberica, nel Medioevo,<br />
<strong>in</strong> Italia e specie <strong>in</strong> Toscana, la satira burlesca personale, sovente comb<strong>in</strong>ata<br />
con la satira politica, avrà un suo sviluppo particolare, trovando humus <strong>in</strong> ambiente<br />
comunale, spesso angusto e fazioso e per questo tanto più l<strong>in</strong>guacciuto.<br />
R. Davidsohn, ricostruendo proprio l’ambiente fiorent<strong>in</strong>o ai tempi di Dante,<br />
notava che: «da molto tempo a Firenze era abituale la satira a parole rimate o no,<br />
tanto che i fiorent<strong>in</strong>i erano chiamati buffoni satirici» 46 , e pers<strong>in</strong>o le scritte sui<br />
muri delle case avevano spesso un carattere politico tale da eccitare il popolo.<br />
«Un Antonio Cammelli è veramente l’<strong>in</strong>terprete di quella corrente di vita che<br />
gli storici alla Bacchelli fanno sfumare nel bel gesto di rivolta isolata o nell’oleografia<br />
di un tumulto di piazza e gli storici della letteratura disperdono <strong>in</strong> generi<br />
letterari, <strong>in</strong> espressioni astratte di comicità, satira, umorismo» 47 .<br />
È un dato <strong>in</strong><strong>contro</strong>vertibile, però, che il Cammelli, al pari dell’anonimo autore<br />
dei <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto, nei suoi testi <strong>contro</strong> i magistrati ferraresi e <strong>contro</strong><br />
lo stesso Giudice de’ <strong>Savi</strong>, non fu certo l’esponente d’una rivolta isolata, tant’è<br />
43 SUITNER, La poesia satirica e giocosa, cit.<br />
44 Ibidem, p. 33.<br />
45 Cfr., ad esempio, D. RIEGER, Gattungen und Gattungsbezeichnungen der Trobadorlyrik,<br />
Tub<strong>in</strong>ga, Niemeyer, 1976, pp. 56-62 e 147-165.<br />
46 R. DAVIDSOHN, Firenze ai tempi di Dante, Firenze, Bemporad, 1929, pp. 387-388.<br />
47 Cfr. PIROMALLI, La cultura a <strong>Ferrara</strong>, cit., p. 152.
Introduzione<br />
che sfidò le severissime pene riservate a quei poeti sovversivi, veri e propri pasqu<strong>in</strong>anti<br />
ferraresi ante-litteram, rappresentanti d’una classe che faticava a trovare<br />
il proprio posto all’<strong>in</strong>terno del grande circo che gravitava <strong>in</strong>torno alla famiglia<br />
ducale: taglio della mano e <strong>in</strong>sproccamento (ossia escissione) della l<strong>in</strong>gua,<br />
s<strong>in</strong>o alla morte, erano le esemplari punizioni per chi osava oltraggiare, pubblicamente<br />
<strong>in</strong> rima, gli esponenti del potere estense. Decreti come quelli ferraresi<br />
(che si <strong>in</strong>seriscono <strong>in</strong> una lunga tradizione di leggi come quella del 20 dicembre<br />
del 1269 del Consiglio di Perugia che decretava la pena del taglio della l<strong>in</strong>gua<br />
per chi componesse o recitasse canzoni <strong>contro</strong> Carlo d’Angiò o si mostrasse fautore<br />
di Corrad<strong>in</strong>o di Svevia) attestano della forza propagandistica riconosciuta<br />
alla poesia vituperosa e il ruolo d’<strong>in</strong>centivo a moti popolari che essa poteva<br />
assumere.<br />
4. Antonio Cammelli da Pistoia<br />
Sappiamo che il Pistoia scrisse sonetti satirici <strong>contro</strong> più persone (dal Bell<strong>in</strong>cioni<br />
allo Zampante, da Pol da Lend<strong>in</strong>ara al C<strong>in</strong>zio). Sono certamente suoi i ventitré<br />
sonetti <strong>contro</strong> il poeta Niccolò Lelio della Comare, detto il Cosmico, reo di<br />
sodomia. Proprio questi sonetti term<strong>in</strong>ano così: Se più troverai versi alla colonna,<br />
/ non seran miei, ché non serò più stolto, a conferma del fatto che il poeta<br />
non disdegnava certe “pasqu<strong>in</strong>ate”.<br />
Il Pistoia, come il fiorent<strong>in</strong>o Bernardo Bell<strong>in</strong>cioni, fu tra i protagonisti di un<br />
particolare momento della vita culturale tardo-quattrocentesca, che sp<strong>in</strong>se numerosi<br />
<strong>in</strong>tellettuali toscani a convergere verso le corti di <strong>Ferrara</strong>, Mantova e Milano.<br />
Nato nella città di C<strong>in</strong>o, nel 1436 da famiglia orig<strong>in</strong>aria di San Pietro <strong>in</strong> V<strong>in</strong>cio,<br />
contrada e parrocchia fuori porta Lucchese, lasciato il borgo toscano <strong>in</strong> cerca<br />
di miglior fortuna <strong>in</strong>torno al 1478, a quarantadue anni, il Cammelli trovò il<br />
suo primo approdo sicuro presso la corte ferrarese di Niccolò da Correggio, cug<strong>in</strong>o<br />
di Ercole I d’Este e colto, ma assai povero mecenate, cui fu legato da una<br />
profonda e fraterna amicizia testimoniata da un fitto scambio epistolare e di sonetti.<br />
Ebbe <strong>in</strong>izio, poi, la sudditanza presso la famiglia ducale: risulta che il poeta<br />
fosse attivo presso la corte estense, a <strong>Ferrara</strong>, già prima dell’<strong>in</strong>vasione veneziana<br />
durante la guerra del 1482-84. Nel 1485, egli accettò un compito poco gratificante,<br />
quale esattore della gabella. Dal Libro autentico della Masseria della<br />
città di Reggio, appare che egli fu mandato «Capitano alla porta di Santa Croce<br />
<strong>in</strong> Reggio dell’Emilia, colla paga mensile di lire 16 reggiane, oltre l’alloggio, il<br />
privilegio della pesca nelle fosse presso la detta porta e il godimento di alcuni<br />
orti entro la città. Pare tuttavia ch’egli non avesse cagione di chiamarsi molto<br />
contento del nuovo ufficio ottenuto dalla liberalità del duca, al quale scriveva lagnandosi<br />
dello stipendio che stentava a comparire» 48 . Poco dopo, <strong>in</strong>fatti, nel<br />
48 CF, xxix.<br />
17
18 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
1487, egli era nuovamente a <strong>Ferrara</strong> dove rimase f<strong>in</strong>o al 1490, quando partì alla<br />
volta di Roma per un breve soggiorno (ricordato dall’Aret<strong>in</strong>o nel suo Ragionamento);<br />
di nuovo a Reggio dopo la sosta romana, tornò <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e nell’amata <strong>Ferrara</strong>,<br />
dove rimase s<strong>in</strong>o alla morte. Nonostante i tentativi di approccio con Ludovico il<br />
Moro, non è attestato un suo soggiorno a Milano, mentre i legami del poeta con<br />
la corte mantovana sono da attribuire al rapporto che egli ebbe con Isabella d’Este,<br />
figlia di Ercole I e sposa del marchese Francesco Gonzaga, signore di Mantova,<br />
che gli permise di ottenere piccole occupazioni redditizie.<br />
La vita del Pistoia, una volta lasciata la Toscana, si svolse dunque prevalentemente<br />
<strong>in</strong> Emilia e fu caratterizzata da frequenti peregr<strong>in</strong>azioni da una città all’altra,<br />
con un progressivo decl<strong>in</strong>o di fortuna, di fama e soprattutto di salute, che lo<br />
portò alla morte, per sifilide, a <strong>Ferrara</strong> appunto, nel 1502.<br />
Il poeta, nonostante l’amicizia e la stima che lo legarono al Correggio, dedicò<br />
alla marchesa di Mantova, Isabella d’Este, il suo canzoniere giunto a noi, verosimilmente<br />
nella veste voluta dallo stesso autore, attraverso il codice Ambrosiano<br />
H. 223 P. I <strong>in</strong>f.: una raccolta di 533 sonetti caudati, preceduti da un Dialogo (i<br />
cui <strong>in</strong>terlocutori sono lo Spirito del Pistoia, Caronte, Archidrommo e Plutone) e<br />
seguiti da un componimento <strong>in</strong>titolato Disperata.<br />
Il 18 di giugno del 1499, il poeta <strong>in</strong>viava a Isabella la sua tragedia Pamphila,<br />
promettendo alla «illustrissima et eccellentissima marchesana di Mantua e madonna<br />
sua colendissima», allora villeggiante nella tenuta di Sacchetta di Sust<strong>in</strong>ente,<br />
che di lì a poco le avrebbe fatto avere anche un’<strong>in</strong>tera raccolta di sonetti 49 .<br />
Trascorsero, da allora, altri tre anni, durante i quali la Marchesa non ricevette<br />
nulla; il 29 aprile del 1502 il Pistoia moriva, senza essere riuscito ancora a far<br />
avere alla propria benefattrice il volume promessole e a lei dedicato.<br />
Nel 1893, un catalogo della Biblioteca Ambrosiana di Milano rivelò allo studioso<br />
napoletano Erasmo Pèrcopo l’esistenza di un manoscritto di rime del Pistoia:<br />
il codice H. 223 P. I <strong>in</strong>f. Il Pèrcopo, esam<strong>in</strong>ando il contenuto del codice e<br />
confrontandolo con gli altri testimoni s<strong>in</strong>o ad allora noti, giunse alla conclusione<br />
che non solo si trattava di un autografo del Pistoia, ma che il volume andava<br />
identificato proprio con la raccolta promessa dal poeta alla Marchesa di Mantova<br />
nella lettera del 1499. Lo studioso decise di pubblicarlo <strong>in</strong>teramente, salvo il capitolo<br />
della Disperata che, nel manoscritto, come appena accennato, si trova alla<br />
f<strong>in</strong>e dei sonetti, alle carte 283v-288r, e che il Pèrcopo (a causa del tema tragico<br />
trattato nel componimento che, a suo dire, strideva con il tono brioso dell’<strong>in</strong>tera<br />
raccolta) decise di dare alle stampe separatamente 50 .<br />
Se l’attribuzione al Pistoia del codice Ambrosiano non è <strong>in</strong> discussione, non è<br />
chiaro, tuttavia, per quali vie il Pèrcopo abbia accertato l’autografia del volume.<br />
49 Cfr. E. PÈRCOPO, I <strong>Sonetti</strong> faceti, cit., Prefazione X, XI.<br />
50 Idem, Una disperata famosa <strong>in</strong> «Raccolta di Studi Critici dedicata ad Alessandro<br />
D’Ancona», Firenze, Barbera, 1901, p. 702 sgg.
Introduzione<br />
A tal f<strong>in</strong>e, <strong>in</strong>fatti, il critico non utilizzò documenti di mano del poeta. Per di più,<br />
egli stesso espresse profondo rammarico per non aver potuto visionare direttamente<br />
il manoscritto e confessò, con molta onestà, di non averne ottenuta neppure<br />
una copia <strong>in</strong>tegrale.<br />
Nessuna precisazione è fornita, poi, dall’editore <strong>in</strong> merito ai criteri di trascrizione<br />
del manoscritto. Nel Codice autografo dei sonetti, prefazione all’edizione<br />
dei componimenti, egli scrive:<br />
«Ritrovai questo codice <strong>in</strong> una rapida visita, dell’aprile 1893, all’Ambrosiana, nel<br />
cui catalogo, sotto la lettera V, era notato V<strong>in</strong>ci Antonio da Pistoia, Rime; ma io,<br />
credendo si trattasse di qualche sonetto disperso, non mi curai di esam<strong>in</strong>are il manoscritto,<br />
che poi non ho potuto più vedere. Chiesto poi ed ottenuto dall’amico<br />
Emidio Mart<strong>in</strong>i, allora bibliotecario della Braidense, un <strong>in</strong>dice del codice, ne riconobbi,<br />
quand’ero troppo lontano, tutta l’importanza; e dovetti contentarmi di<br />
avere, colla descrizione del manoscritto, una copia dei soli sonetti <strong>in</strong>editi ed una<br />
collazione degli editi sui testi a stampa, fatiche tutte del dottor Virgilio Mazzelli,<br />
allora sottobibliotecario della Braidense. Un’accuratissima revisione sulle bozze<br />
di stampa debbo alla cortesia degli amici Proff. Domenico Bassi e Bernardo Sansiventi,<br />
che qui r<strong>in</strong>grazio pubblicamente» 51 .<br />
Punto impresc<strong>in</strong>dibile per chi <strong>in</strong>tenda conoscere la lirica del Pistoia, l’edizione<br />
percopiana, pregevole e meritevole sotto più aspetti, necessitava, a un secolo<br />
dalla sua pubblicazione, di essere sottoposta a una m<strong>in</strong>uziosa <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e analitica;<br />
operazione che ho tentato di compiere nella già annunciata monografia dedicata<br />
al pistoiese, attualmente <strong>in</strong> corso di revisione per la stampa per questa stessa casa<br />
editrice.<br />
In s<strong>in</strong>tesi, dopo l’<strong>in</strong>dispensabile accertamento dell’autografia del codice Ambrosiano<br />
H 223 <strong>in</strong>f., sono giunta alla conclusione che, tra il 1499 e il 1501 il Pistoia,<br />
oppresso dai gravi problemi di salute, causati dalla sifilide (tra i quali una<br />
quasi totale cecità), sentendo approssimarsi la propria f<strong>in</strong>e, commissionò al figlio<br />
Marc’Antonio, anch’egli poeta, la trascrizione dei suoi sonetti all’<strong>in</strong>terno di<br />
quello che oggi è il codice Ambrosiano che, dunque, è un codice d’autore, ma<br />
non autografo del poeta.<br />
Molte scelte editoriali del Pèrcopo si rivelano, oggi, assai discutibili: prima<br />
tra tutte quella di elim<strong>in</strong>are dall’edizione dei <strong>Sonetti</strong> faceti la Disperata che fu, ai<br />
suoi tempi, celeberrima.<br />
Come ho dimostrato di recente 52 , la Disperata del Pistoia rappresenta l’epilogo<br />
del suo canzoniere (ed è <strong>in</strong> stretta relazione con quella corona di componimenti<br />
del Tebaldeo, <strong>in</strong>titolata al comune amico Timoteo Bendedei, che tratta il<br />
51<br />
PÈRCOPO, I <strong>Sonetti</strong> faceti, cit., p. XVI, n. 1.<br />
52 Cfr. C. ROSSI, La “Disperata”, capitolo conclusivo dei <strong>Sonetti</strong> faceti del Pistoia,<br />
cit.<br />
19
20 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
tema della monacazione della donna amata): un epilogo sarcastico per un canzoniere<br />
di sonetti faceti, osceni, pungenti e anticlericali. Posta a conclusione dell’<strong>in</strong>tera<br />
raccolta, la Disperata, pur rispondendo perfettamente ai canoni del genere,<br />
presenta una peculiarità rispetto a tutte le altre Disperate del R<strong>in</strong>ascimento.<br />
Essa è venata d’una amara ironia, <strong>in</strong>sita nel messaggio stesso del componimento:<br />
“altra via di salir al ciel ci resta che non i conventi”. Monacandosi, la donna<br />
amata ha privato il poeta non solo di sè medesima, ma anche della possibilità di<br />
salvezza attraverso l’amore.<br />
Erasmo Pèrcopo considerò, <strong>in</strong>vece, il componimento un epicedio per la<br />
scomparsa di Beatrice d’Este, la giovane moglie di Ludovico il Moro, morta il 3<br />
gennaio del 1497 di parto, all’età di ventidue anni (l’<strong>in</strong>terpretazione si basa, più<br />
che sull’esegesi testuale, su una lettera 53 , priva di data, con cui il Pistoia dedica a<br />
un anonimo dest<strong>in</strong>atario la raccolta di componimenti parzialmente tramandata<br />
dal cod. Bolognese 2618, un manoscritto mutilo, <strong>in</strong> cui però non figura il testo<br />
della Disperata). Per lo studioso napoletano, il tono e l’argomento del componimento<br />
risultano talmente <strong>in</strong> dissonanza con l’<strong>in</strong>sieme della raccolta dei sonetti<br />
del Pistoia, da <strong>in</strong>durlo a mutilare il codice Ambrosiano H. 223.<br />
Allo stesso modo, appaiono piuttosto discutibili i motivi che <strong>in</strong>dussero il Pèrcopo<br />
a resp<strong>in</strong>gere la proposta del Cappelli, che voleva attribuire al Pistoia i <strong>Sonetti</strong><br />
<strong>contro</strong> l’Ariosto; egli <strong>in</strong>fatti, non trovandoli nel codice Ambrosiano, scrive:<br />
«non vi compariscono affatto quegli arguti e virulenti sonetti <strong>contro</strong> il Cosmico,<br />
come non vi compariscono quegli altri, non men belli e terribili, <strong>contro</strong> Niccolò<br />
Ariosti, che lo stesso Cappelli volle, senza alcun solido fondamento, pure affibbiare<br />
al nostro. Se veramente del Cammelli, l’una e l’altra di queste serie avrebber<br />
trovato <strong>in</strong>dubbiamente il loro posto accanto a quelle consimili <strong>contro</strong> il Bell<strong>in</strong>cioni,<br />
il Sasso, il Ciampante ed altri mal capitati rimatori e pubblici ufficiali» 54 .<br />
5. La l<strong>in</strong>gua dei <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> Niccolò Ariosto<br />
Come accennato al punto 1 di questa Introduzione, il Cappelli ebbe fondamentalmente<br />
due dubbi riguardo all’attribuzione al Pistoia della corona di sonetti<br />
satirici <strong>contro</strong> l’Ariosto: il primo, come s’è visto, concerneva la presenza del<br />
Pistoia a <strong>Ferrara</strong> negli anni <strong>in</strong> cui venne redatta la corona (ma, come ci aiuta a<br />
chiarire il Caleff<strong>in</strong>i, attraverso la testimonianza delle sue Croniche, il Cappelli<br />
posticipò erroneamente la composizione di almeno dieci anni). Il fatto che il Pistoia,<br />
all’epoca della redazione dei sonetti <strong>contro</strong> l’Ariosto (dal giugno del 1487<br />
al gennaio 1489) non fosse più a <strong>Ferrara</strong>, come paventò Cappelli, è dunque assolutamente<br />
<strong>in</strong>esatto: <strong>in</strong>fatti, è evidente che i sonetti tràditi dal codice Ambrosiano<br />
53 Pubblicata da R. RENIER <strong>in</strong> I sonetti del Pistoia giusta l’apografo Trivulziano, Tor<strong>in</strong>o,<br />
Loescher, 1888.<br />
54<br />
PÈRCOPO, I <strong>Sonetti</strong> faceti, cit., p. XXVI.
Introduzione<br />
H 223 <strong>in</strong>f. seguono non solo un’organizzazione tematica, ma anche cronologica.<br />
Nel 1487, il Pistoia scrisse una corona di sonetti <strong>contro</strong> il poeta toscano Bernardo<br />
Bell<strong>in</strong>cioni, che nell’Ambrosiano vanno sotto i numeri dal 111 al 130. I sonetti<br />
che, nel codice, vengono immediatamente dopo questa corona, si riferiscono<br />
a fatti, come il vestirsi alla franciucula e personaggi ferraresi come il Signor<br />
Pietro De Benvenuti dagli Ord<strong>in</strong>i, che compare nel sonetto 131 (personaggio che<br />
Pèrcopo non riuscì a identificare 55 , ma che risulta essere l’architetto ducale,<br />
quando venne istituito l’officio alle Fabbriche e Munizioni, un organo deputato<br />
specificamente alla cura degli edifici del duca).<br />
Così i sonetti 142-143 sono scritti <strong>contro</strong> Gregorio Zampante, nativo di Lucca<br />
e podestà a <strong>Ferrara</strong> proprio nel 1489 56 , che il Diario ferrarese def<strong>in</strong>isce<br />
«grandissimo ribaldo, ma il maggior huomo <strong>in</strong> autorità appresso Ercole I» 57 .<br />
Che il Pistoia calunni personaggi attivi a <strong>Ferrara</strong> sul f<strong>in</strong>ire degli anni Ottanta<br />
del Quattrocento, mi pare una prova <strong>in</strong>confutabile del fatto che egli si trovasse<br />
nella capitale estense <strong>in</strong> quegli anni; tra l’altro, da alcuni documenti superstiti,<br />
citati dallo stesso Pèrcopo 58 , risulta che nel 1489, a ricoprire la carica del Pistoia<br />
di capitano di porta Santa Croce a Reggio, non vi era più il poeta, ma un suo nipote,<br />
tale Andrea.<br />
L’anno successivo, per l’esattezza il 30 giugno del 1490, la presenza del poeta<br />
a <strong>Ferrara</strong> è attestata dai sonetti 210 e 211, <strong>in</strong> cui il poeta commenta una ridicola<br />
giostra fatta sulla piazza pr<strong>in</strong>cipale, fra un cavaliere spagnolo e uno francese.<br />
Il secondo dubbio del Cappelli riguardava la l<strong>in</strong>gua dei sonetti. Eppure, la<br />
presunta natural propensione al dialetto lombardo, o meglio, al dialetto emiliano,<br />
cui egli faceva cenno 59 si riduce a pochi, scherzosi vezzi l<strong>in</strong>guistici, di cui<br />
non v’è traccia alcuna nei primi c<strong>in</strong>que componimenti.<br />
La l<strong>in</strong>gua dei <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto è <strong>in</strong>negabilmente il toscano letterario,<br />
con qualche settentrionalismo assolutamente <strong>in</strong>tenzionale (come d’altronde anche<br />
nei sonetti autografi del Pistoia), lì dove i locutori sono personaggi ferraresi,<br />
oppure, come nel ventiduesimo sonetto, dove a parlare sono il conte Ariosto e<br />
sua moglie, la reggiana Daria Malaguzzi Valeri. Si tenga conto, <strong>in</strong>oltre, che alcune<br />
grafie settentrionali sono certamente da attribuire al copista e non all’autore<br />
(si veda ad esempio il primo sonetto, dove la rubrica riporta il term<strong>in</strong>e Judice, da<br />
attribuire all’autore, mentre nell’ultimo verso appare zudese). Che l’autore sia un<br />
toscano è confermato anche dalla presenza di numerose parole (quali foco,<br />
gioco, loco) <strong>in</strong> cui si registra il mancato dittongamento di -o- tonica. Dalla mia<br />
55 Ibid., p. 169.<br />
56 Cfr. L. N. CITTADELLA, Notizie relative a <strong>Ferrara</strong> per la maggior parte <strong>in</strong>edite,<br />
<strong>Ferrara</strong>, 1864, p. 367.<br />
57 Cfr. Diario ferrarese, p. 330.<br />
58 E. PÈRCOPO, Antonio Cammelli e i suoi sonetti faceti, <strong>in</strong> «Studi di Letteratura italiana»,<br />
vol. VI, Napoli 1904, p. 312, nota 1.<br />
59<br />
CAPPELLI, <strong>Sonetti</strong> giocosi di Antonio da Pistoia, cit., p. 252.<br />
21
22 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
trascrizione del codice modenese, che riproduco qui, risultano molto più evidenti<br />
i toscanismi del poeta, rispetto a quanto non traspaia sia dalla prima, che dalla<br />
seconda edizione a stampa di Cappelli e Ferrari i quali, purtroppo, hanno la tendenza<br />
a correggere e ammodernare troppi lemmi. Sicuramente attribuibile all’autore,<br />
ad esempio, è la forma, sempre corretta da Cappelli e Ferrari ‘gi’, ‘ge’<br />
per ‘ci’, ‘ce’: <strong>in</strong>fatti nel vernacolo pistoiese risulta particolarmente sp<strong>in</strong>ta la sonorizzazione<br />
della velare <strong>in</strong>iziale (d’altronde ‘gi’ e ‘ge’ compaiono talmente tante<br />
volte nei sonetti del Pistoia che una lista delle occorrenze si tramuterebbe <strong>in</strong><br />
un noiosissimo e sterile elenco). Nel sesto sonetto della corona, vi sono solo due<br />
settentrionalismi, <strong>in</strong> rima: tò (v. 5), per tuo e bò (v. 8), per bue, usati evidentemente<br />
per schernire il Giudice. Nel settimo sonetto, lì dove il locutore si rivolge<br />
ai ferraresi usa il term<strong>in</strong>e dialettale cà (v. 15) per casa. Nel ventesimo sonetto, il<br />
popolo grida “Al spurco, al lordo!” (v. 13). Sono troppo <strong>in</strong>sufficienti le occorrenze<br />
di espressioni o lemmi dialettali settentrionali per poter affermare che questi<br />
sonetti propendono al dialetto lombardo. Tra l’altro, bisogna ricordare che la<br />
città di Pistoia «disponendo di una via naturale che la metteva <strong>in</strong> contatto diretto<br />
con Bologna e la Val Padana, si era potuta aprire a quegli <strong>in</strong>flussi determ<strong>in</strong>anti<br />
per la varietà toscana che def<strong>in</strong>iamo ‘occidentale’. Alcuni di questi tratti del l<strong>in</strong>guaggio<br />
pistoiese appaiono molto antichi, altri appaiono <strong>in</strong>vece come la conseguenza<br />
di <strong>in</strong>flussi che si manifestarono nella seconda metà del duecento» 60 , ne<br />
deriva che il lessico del Pistoia presenta naturalmente alcune peculiarità emiliane.<br />
Un dato <strong>in</strong>confutabile, comunque, a testimonianza che l’autore dei sonetti<br />
<strong>contro</strong> l’Ariosto fu un toscano, e meglio ancora, un pistoiese, è l’uso del term<strong>in</strong>e<br />
broldo, che appare nel secondo sonetto della corona, v. 18:<br />
In questo mezzo un broldo<br />
s’apparecchia, per farti un bel cappello,<br />
acciò che ’l sol non ti secchi il cervello. 20<br />
Si noti che broldo è la forma s<strong>in</strong>copata di beroldo o biroldo, che nulla ha a<br />
che vedere con brolo (giard<strong>in</strong>o), come <strong>in</strong>vece credette il Cappelli. Biroldo è un<br />
term<strong>in</strong>e dialettale toscano (e più precisamente pistoiese) per ‘sangu<strong>in</strong>accio’, ovvero<br />
«budello o di vitella o di majale ripieno di sangue acconciato con varj <strong>in</strong>gredienti<br />
e cotto nel pajuolo» (Fanfani). A Pistoia è nota la ricetta del beroldo<br />
con busicchioni (budelli), salame piccante, pecor<strong>in</strong>o e brodo di rigaglie. Quel<br />
che è certo è che nessun poeta ferrarese del Quattrocento avrebbe mai usato un<br />
simile term<strong>in</strong>e tanto caratteristico della cuc<strong>in</strong>a di una certa area della Toscana,<br />
term<strong>in</strong>e che (il dato è ancor più importante), compare <strong>in</strong> altri due sonetti del Pistoia<br />
(il 158 e il 161 61 ), fra l’altro <strong>in</strong> rima, come nel secondo sonetto della raccolta<br />
<strong>contro</strong> l’Ariosto, proprio con manigoldo e soldo.<br />
60 *Storia di Pistoia, vol. II, Firenze, Le Monnier, 1998, p. 328.<br />
61 I numeri si riferiscono all’ord<strong>in</strong>e <strong>in</strong> cui compaiono i sonetti nell’edizione percopiana<br />
del codice Ambrosiano H 223 <strong>in</strong>f. (cfr. PÉRCOPO, I sonetti faceti, cit.)
Introduzione<br />
A ciò si aggiunga, ancora, che anche nel sonetto 158 del Pistoia, i beroldi servono<br />
a costruire un copricapo, <strong>in</strong> questo caso per <strong>in</strong>coronare due poeti:<br />
Dunque Apollo ve <strong>in</strong>vita 15<br />
a coronar questi dui manigoldi,<br />
l’un de vesiche e l’altro de beroldi.<br />
Harrà il beccar di soldi,<br />
pel malifitio, il pugno e ’l grembo pieno,<br />
l’altro con l’oro del comune <strong>in</strong> seno.<br />
Si noti, <strong>in</strong>oltre, nei sonetti <strong>contro</strong> l’Ariosto, l’uso del term<strong>in</strong>e ventroni (che<br />
appare nel ventesimo sonetto della corona, al verso 15):<br />
E con levi e ventroni, 15<br />
per dignità acquistata nell’offizio,<br />
sia <strong>in</strong> salutarlo a gara ogn’uom propizio.<br />
Levi e ventroni stanno qui per ‘polmoni’ e ‘ventricoli’ di animali. Se è abbastanza<br />
chiaro il doppio senso di levi, che nel gergo furbesco sta per ‘cose rubate’,<br />
per cui il ladro è detto levant<strong>in</strong>o (e la merce rubata quel che vien di Levante, come<br />
nel sonetto 151 v. 5 dell’Ambrosiano H 223), non altrettanto chiaro è il senso<br />
di ventroni, che sfuggirebbe completamente se non se ne conoscesse l’uso fattone<br />
dal Pistoia, <strong>in</strong> special modo nei sonetti <strong>contro</strong> il C<strong>in</strong>zio, ovvero <strong>contro</strong> il verseggiatore<br />
anconetano Francesco C<strong>in</strong>zio Ben<strong>in</strong>casa. Si legga ad esempio il sonetto<br />
150 (v. 9 sgg.):<br />
Correte qua che C<strong>in</strong>thio fa sonetti,<br />
lardarolli, carnifici, fornari,<br />
con ovi, con ventroni e pan boffetti.<br />
Battuti, tosto Christo sugli altari,<br />
chiamate il boia che ’l suo C<strong>in</strong>thio aspetti<br />
[…]<br />
Il Pistoia chiama a raccolta pizzicagnoli, macellai e fornai, che con uova,<br />
ventroni e pane marcio accorrano a salutare il C<strong>in</strong>thio, mentre i battuti (i monaci<br />
della “compagnia della morte”) pregano per l’anima sua e il boia lo attende sul<br />
patibolo.<br />
Era costume, <strong>in</strong>fatti, che il condannato al capestro venisse messo alla berl<strong>in</strong>a<br />
e che <strong>contro</strong> di lui la popolazione scagliasse frutta marcia, ciarpame, uova e<br />
quant’altro.<br />
Anche nel ventesimo sonetto della collana <strong>contro</strong> l’Ariosto, il poeta <strong>in</strong>cita il<br />
popolo ferrarese a lanciare <strong>contro</strong> l’Ariosto frattaglie d’animali: giacché il Giudice<br />
ha levato (rubato) e s’è riempito il ventre durante il periodo <strong>in</strong> cui era <strong>in</strong> carica.<br />
Per dignità acquistata nell’offizio (v. 16), le frattaglie che il poeta suggerisce<br />
di tirargli addosso non possono essere altro che levi e ventroni.<br />
Ciò che conta maggiormente, però, è che sia al Pèrcopo, sia al Cappelli e al<br />
23
24 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
Bertoni, sono totalmente sfuggiti alcuni sonetti, <strong>in</strong>clusi anch’essi nel codice Ambrosiano<br />
sotto i numeri 156-57, <strong>in</strong> cui il Pistoia riprende esplicitamente la polemica<br />
<strong>contro</strong> Niccolò Ariosto esattemente nei term<strong>in</strong>i <strong>in</strong> cui essa è trattata nei sonetti<br />
anonimi <strong>contro</strong> il Giudice de’ <strong>Savi</strong>.<br />
In questa corona, il conte Ariosto viene soprannom<strong>in</strong>ato sarcasticamente Magnaferro,<br />
per la sua abitud<strong>in</strong>e a divorare qualsiasi cosa, anche la più <strong>in</strong>digesta, al<br />
pari degli struzzi, che divorano pers<strong>in</strong>o i sassi.<br />
Il codice modenese riporta, <strong>in</strong> calce al ventesimo sonetto della corona, una<br />
data precisa: 1489, adì primo de zanaro la mat<strong>in</strong>a fu casso il dicto Magnaferro e<br />
<strong>in</strong> suo luogo successe il spettabile Galiazzo Trotto. Si noti, ora, come il sonetto<br />
156 del codice Ambrosiano sia <strong>in</strong> stretta relazione con questo ventesimo sonetto.<br />
Codice Ambrosiano H. 223 P. I <strong>in</strong>f.,<br />
autografo del Pistoia<br />
CLVI.<br />
“Refrenative, l<strong>in</strong>gue, or ch’io son casso,<br />
non fate più per me circolo <strong>in</strong> piazza,<br />
ché lo struzzo crudel di mala razza<br />
non mangiarà tra voi più ferro o sasso.<br />
Dui sol tesori al mio partir vi lasso: 5<br />
la bella <strong>in</strong>famia e la mia vita pazza.<br />
Vo <strong>in</strong> mar tranquillo, <strong>in</strong> quella galeazza<br />
ch’e’ m’ha col trotto suo cangiato il passo.<br />
Dove io ne vo, si sa senza ch’i ’l dica,<br />
per volontà del iusto Ercule nostro, 10<br />
che vuol ch’io provi una sua gran fatica.<br />
La morte aspetto <strong>in</strong> man di qualche<br />
mostro;<br />
figli pietosi di mia patria antica,<br />
deh, per l’anima mia, un pater nostro!<br />
Quel ben sì sarà vostro, 15<br />
ch’io aspetto al mio fallir quella iustizia,<br />
la qual sempre negai per l’avaritia”.<br />
Collana anonima <strong>contro</strong> il Giudice de’ <strong>Savi</strong><br />
XX.<br />
Gloria <strong>in</strong> excelsis Deo, e <strong>in</strong> terra pace.<br />
Giubila, pesta patria, ridi e canta:<br />
la cassia è data, medic<strong>in</strong>a santa,<br />
al Magnafer, ladron publico e audace.<br />
Inclito Duca, a cui il vizio spiace, 5<br />
ben ti r<strong>in</strong>grazio di clemenza tanta;<br />
ma più se <strong>in</strong> piazza una forca si pianta,<br />
per far giustizia del lupo rapace.<br />
O buoni patrizi eletti, io vi ricordo,<br />
che il corvo non condice <strong>in</strong> fra i pavoni, 10<br />
però scacciate questo aspide sordo.<br />
E voi, plebei, suonate i tamburloni,<br />
sgridandol per le strade: “Al sporco, al lordo!”<br />
corona s<strong>in</strong>golar di poltronzoni.<br />
E con levi e ventroni, 15<br />
per dignità acquistate nell’offizio,<br />
sia <strong>in</strong> salutarlo a gara ogn’uom propizio.<br />
Nel sonetto 156 del manoscritto Ambrosiano, il Pistoia lascia che a parlare<br />
sia direttamente il protagonista: un personaggio pubblico che è casso, vale a dire<br />
destituito dal Duca. Costui si rivolge a coloro i quali si riunivano <strong>in</strong> piazza per<br />
sparlare di lui. I vv. 3-4 specificano che lo struzzo crudel di mala razza/non<br />
mangiarà tra voi più ferro o sasso. Mi pare, questo, un <strong>in</strong>equivocabile riferimento<br />
all’Ariosto che, nel sesto sonetto della collana anonima, viene def<strong>in</strong>ito proprio
Introduzione<br />
uccel struzzo. Ancor più espliciti sono i vv. 7-8, col riferimento alla galeazza e a<br />
un personaggio che m’ha col trotto suo cangiato il passo. Infatti, come palesato<br />
anche dal ventesimo sonetto della collana qui riprodotto, il nome del successore<br />
dell’Ariosto era Galeazzo Trotti. Sono stati proprio questi versi a trarre <strong>in</strong> <strong>in</strong>ganno<br />
Pèrcopo che, <strong>in</strong> Correzioni e giunte <strong>in</strong> appendice alla sua citata edizione dei<br />
sonetti del Pistoia, scrive che questo componimento è: «diretto, come il seguente<br />
sonetto (CLVII) <strong>contro</strong> Galeazzo de’ Trotti che, dal 1489 al 91, fu <strong>giudice</strong> de’ savi<br />
<strong>in</strong> <strong>Ferrara</strong>. Difatti <strong>in</strong> questo sonetto è detto di lui che, partendo da <strong>Ferrara</strong>, va<br />
<strong>in</strong> mar tranquillo, <strong>in</strong> quella galeazza […] ov’è chiara l’allusione al duca di Milano<br />
Gian Galeazzo Sforza» 62 .<br />
Un dato sostanziale che <strong>in</strong>valida la tesi di Pèrcopo è che Galeazzo Trotti non<br />
venne mai casso dal suo officio, ma morì dopo due anni dall’elezione a Giudice<br />
dei <strong>Savi</strong>, mentre era ancora <strong>in</strong> carica (non ebbe dunque il tempo, ammesso che lo<br />
abbia mai pensato, di recarsi a Milano presso lo Sforza). Certo, neppure il Trotti<br />
fu uno st<strong>in</strong>co di santo e non fece che perpetrare le malefatte dell’Ariosto, tanto<br />
che quando morì, così scrisse il cronista Hondedio, al suo spettacolare funerale<br />
assistette una gran turba di ferraresi «perché non credeano che ’l fusse morto et<br />
se davano a credere che ’l dovesse resuscitare et essergli acagnato a’ fianchi per<br />
devorargli quel altro pocho che gli era restato» 63 ; Galeazzo fu sepolto nel duomo<br />
di <strong>Ferrara</strong>, sebbene «passò de questa vita senza confessione e senza alcuno segno<br />
de contritione di suoi pechati, ma più presto afeccionato pure a fare dele facende,<br />
dandose ad <strong>in</strong>tendere che la morte li fusse lontana» 64 .<br />
Il Pèrcopo pare non accorgersi, poi, che nell’ottavo verso del sonetto 156 il<br />
Pistoia scrive che ei ha cambiato il passo del locutore col suo trotto: il Trotti,<br />
fuor di metafora, ha dato il cambio all’Ariosto. Nei versi successivi vien detto<br />
che il luogo dove questo personaggio casso sta per andare, è noto a tutti. Ora, il<br />
gioco di parole del Pistoia sul term<strong>in</strong>e galeazza è doppio: <strong>in</strong>fatti, la galeazza<br />
(chiara allusione al nome del Trotti, Galeazzo, e non certo al nome dello Sforza,<br />
Gian Galeazzo, che nulla ha a che vedere con la vicenda), è un bastimento a vela<br />
e a remi; ma una delle ville dell’Ariosto, fatta costruire su un terreno di proprietà<br />
del fratello Francesco, si chiamava proprio Barchetta. Non è escluso che il Pistoia<br />
alluda qui al fatto che l’Ariosto, destituito dal duca, lasciata <strong>Ferrara</strong> (dove<br />
abitava <strong>in</strong> una casa <strong>in</strong> via Gioco del Pallone), potesse andare a vivere <strong>in</strong> mar<br />
tranquillo, <strong>in</strong> quella Galeazza. A ciò si aggiunga che il locutore del sonetto dice<br />
che egli se ne va per volontà del Duca Ercole I (v. 10), il quale lo vuole punire,<br />
facendogli sperimentare una delle sue leggendarie fatiche (gli scrittori cortigiani<br />
estensi, <strong>in</strong>fatti, come ricorda lo stesso Pèrcopo 65 , attribuivano al duca Ercole I le<br />
62<br />
PÈRCOPO, I <strong>Sonetti</strong> faceti, cit., p. 658.<br />
63<br />
HONDEDIO, c. 23v.<br />
64 Ibid.<br />
65 Ibid., p. 193.<br />
25
26 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
stesse virtù dell’eroe mitologico, tanto che Pietro Andrea de’ Bassi, nel 1475<br />
aveva pubblicato, a <strong>Ferrara</strong>, un <strong>in</strong>tero poema dal titolo Le fatiche d’Ercole).<br />
Appare chiaro che il locutore del sonetto 156 del Pistoia è Niccolò Ariosto,<br />
casso e <strong>in</strong>viato poco dopo da Ercole I a Modena. Se il componimento del Pistoia<br />
si conclude con l’Ariosto che chiede ai suoi concittad<strong>in</strong>i un pater nostro per la<br />
sua anima, il ventesimo della raccolta si apre con un Gloria <strong>in</strong> excelsis Deo, pronunciato<br />
dall’Autore e con un r<strong>in</strong>graziamento al duca Ercole I per aver scacciato<br />
il Magnaferro.<br />
Si noti poi come, se nel sonetto del ms. Ambrosiano, il Pistoia parli della<br />
piazza come luogo di ritrovo di coloro che si lamentavano delle malefatte dell’Ariosto;<br />
nel ventesimo della corona, quella stessa piazza viene <strong>in</strong>vocata come<br />
pubblico luogo di supplizio (sempre nella medesima piazza le cronache ferraresi<br />
ci dicono che vennero affissi i sonetti di scherno <strong>contro</strong> il Giudice de’ <strong>Savi</strong>).<br />
Altrettanto <strong>in</strong>teressante per comprendere il risentimento del Pistoia nei confronti<br />
dell’Ariosto è il sonetto 157 del codice Ambrosiano che così recita:<br />
“Attolite le porte” – “Chi è quello?”<br />
“Il <strong>giudice</strong> de’ <strong>Savi</strong>y, tuo creato”.<br />
“Hai tu denar pel passo?” – “Io fui chiamato<br />
sì presto ch’io non poti’ tuor bursello.<br />
Non è qua il secretario, mio fratello, 5<br />
sì ch’io ci son senza denari a lato”.<br />
“O dov’è il tuo tesoro?” – “Io l’ho lasciato<br />
a’ miei figlioli, e la robba e ’l mantello”.<br />
“Ch’è de lo avanzo delle tue far<strong>in</strong>e,<br />
quando genaro <strong>in</strong> Po mise il presame, 10<br />
che tu tosavi i sacchi alle mol<strong>in</strong>e?<br />
Quanti ne festi allor morir di fame<br />
per tenir grasse, <strong>in</strong> casa, le gall<strong>in</strong>e!<br />
Chi non sa scorticar, guasta il coiame.<br />
O Ciampante o Beltrame, 15<br />
fatte che questi dui sian cotti tosto,<br />
il più giovane lesso e ’l vecchio arosto.<br />
Vien qua tu, Ciuffalmosto,<br />
mangia questi dui spiriti cattivi:<br />
mangiati che tu gli ha, cacagli vivi. 20<br />
Nella f<strong>in</strong>zione poetica, il <strong>giudice</strong> de’ <strong>Savi</strong> è morto (Niccolò Ariosto morì nel<br />
1500), f<strong>in</strong>isce agli Inferi e, giunto all’entrata dell’Inferno, grida: “Aprite le porte”<br />
– “Chi è?” gli viene risposto – “Il Giudice de’ <strong>Savi</strong>, tuo protetto” – “Hai denari<br />
per il passaggio della tua anima?” – “Io sono stato chiamato così <strong>in</strong> fretta<br />
che non ho potuto prendere il borsello. E siccome non c’è il segretario, mio fratello,<br />
son venuto senza denari”. – “Dov’è il tuo tesoro?” – “L’ho lasciato ai miei<br />
figli, con tutti gli averi e il mantello”. – “E cosa ne è del resto delle tue far<strong>in</strong>e,<br />
quando a gennaio si gelò il Po, e tu tagliavi i sacchi ai mul<strong>in</strong>i? Quanti ne hai fatti<br />
morire di fame, allora, per <strong>in</strong>grassare, a casa tua, le tue gall<strong>in</strong>e? Chi non sa scor-
Introduzione<br />
ticare, rov<strong>in</strong>a il cuoio. Ciampante, Beltrame, fate che questi due siano subito cotti,<br />
il più giovane lesso, il più vecchio arrosto. Vieni qua, tu, Ciuffalmosto, mangia<br />
questi due spiriti cattivi e non appena li hai mangiati, cacali vivi!”.<br />
Il sonetto, che s’<strong>in</strong>izia con un solo protagonista, il Giudice de’ <strong>Savi</strong> (v. 2), si<br />
chiude con due anime da cuocere all’Inferno, probabilmente quelle di due fratelli.<br />
Come per il sonetto precedente, Pèrcopo pensò che il <strong>giudice</strong> qui schernito sia<br />
Galeazzo Trotti, ma il mancato dittongamento di arosto del v. 17, mi pare <strong>in</strong>tenzionale<br />
da parte del Pistoia e mi pare lecito ritenere che il poeta alluda ai due<br />
Ariosto: Niccolò e il fratello Francesco, che fu consigliere di Stato a <strong>Ferrara</strong> e<br />
segretario del duca Ercole I (v. 5 il secretario).<br />
Per quanto riguarda, <strong>in</strong>vece, l’<strong>in</strong>vocazione ai due diavoli Ciampante e Beltrame<br />
(v. 15), noteremo come fra i giusdicenti estensi dell’epoca, un gruppo fortemente<br />
caratterizzato era quello degli ufficiali forestieri, come nel caso di Gregorio<br />
Zampante (di cui già abbiamo <strong>in</strong> parte detto per il sonetto 156, e che qui appare<br />
al v. 15), lucchese, che nel corso del suo operato a <strong>Ferrara</strong> si era macchiato<br />
di atroci nefandezze, tanto che morì assass<strong>in</strong>ato fra il giubilo popolare 66 ; mentre<br />
Beltram<strong>in</strong>o Cusatro (Beltrame) era mantovano e fu un commissario della corte<br />
estense dispotico e mal voluto dal popolo. Se la nom<strong>in</strong>a di forestieri ai posti di<br />
podestà costituiva un segno di rispetto per le consuetud<strong>in</strong>i municipali, il loro impiego<br />
<strong>in</strong> <strong>in</strong>carichi sv<strong>in</strong>colati dall’osservanza degli statuti rappresentava <strong>in</strong>vece<br />
un atto di forza <strong>contro</strong> l’autonomia dei sudditi, che come tale lo recepivano riversando<br />
il proprio astio sui ‘commissari’.<br />
6. La struttura della corona<br />
Alla pari di altre collane di sonetti di scherno e vituperio 67 , anche quella <strong>contro</strong><br />
l’Ariosto segue un ord<strong>in</strong>e per sequenze argomentative, volte a colpire il Giudice<br />
de’ <strong>Savi</strong>. Prendendo spunto da dati della realtà storica, fissati nella struttura<br />
chiusa della corona, questi sonetti si trasformano pertanto <strong>in</strong> veri e propri paradigmi.<br />
Il primo componimento funge da proemio: il sonetto d’esordio, per quanto<br />
sferzante, è comunque tra i più contenuti; il locutore si rivolge, come nei c<strong>in</strong>que<br />
che seguono, direttamente all’Ariosto, apostrofandolo sarcasticamente come<br />
Giudice de’ Matti. Gli fa notare come, attraverso le sue ruberie, di cui ormai parlano<br />
tutti, perpetrate sfruttando la sua carica politica, stia <strong>in</strong>grassando sempre<br />
più, mentre i ferraresi patiscono la miseria. La città è ormai dissanguata dalle<br />
cont<strong>in</strong>ue richieste <strong>in</strong> denaro del Giudice che non si vergogna, ma va perpetrando<br />
66 Cfr. Diario ferrarese, cit., pp. 182-83.<br />
67 Penso <strong>in</strong> modo particolare alla corona di sonetti caudati del Bronz<strong>in</strong>o <strong>contro</strong> il Castelvetro,<br />
per cui cfr. ROSSI, I Salterelli, cit., p. 62.<br />
27
28 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
le sue estorsioni come un serpente velenoso, aggressivo e crudele, come un lupo<br />
predatore. Si mostra clemente solo con chi gli offre di più, ma se non cambierà<br />
stile e modo di fare, lo ammonisce il Poeta, il popolo gli griderà “A morte!” (come<br />
fecero i siciliani <strong>contro</strong> gli oppressori francesi a Palermo) e lo esorta a ravvedersi.<br />
In uno stile icastico e ricorrendo a un lessico brioso, l’auctor chiama l’Ariosto<br />
pestifero, mordace, crudel angue, lupo rapace, ladrone pubblico, mostro<br />
<strong>in</strong>iquo e strano. Il legame tra i sonetti è accentuato dalla ripresa del tema anticipato<br />
nel componimento che precede; così nel secondo sonetto, l’Autore <strong>in</strong>siste<br />
sulla strana natura dell’Ariosto, che al pari di uno struzzo, mangia legno, marmo,<br />
sabbione e ferro: da cui l’epiteto di Magnaferro. Il quarto sonetto dà un’idea<br />
del momento storico <strong>in</strong> cui la corona venne composta, giacché risulta che il duca<br />
Ercole I non è a <strong>Ferrara</strong> (è <strong>in</strong>fatti partito per un pellegr<strong>in</strong>aggio a Santiago) e all’Ariosto<br />
non rimane che pregare Madama, vale a dire Eleonora d’Aragona che<br />
faccia fare una grida patente (v. 2) <strong>contro</strong> questo Pasqu<strong>in</strong>o ferrarese (il “Detrattore”)<br />
che faceva circolare i propri sonetti malevoli <strong>in</strong> piazza. L’abitud<strong>in</strong>e di apporre<br />
sonetti di scherno <strong>in</strong> luoghi pubblici è attestata <strong>in</strong> varie città italiane ben<br />
prima della comparsa, a Roma, nel 1501, di Pasqu<strong>in</strong>o. Nella stessa Roma era la<br />
consuetud<strong>in</strong>e lasciare versi di scherno attaccati alle colonne di Palazzo Apostolico,<br />
<strong>in</strong> Campo di Fiori, a ponte Sant’Angelo, sui sepolcri medesimi dei pontefici<br />
e dei card<strong>in</strong>ali.<br />
Lo stesso Ugo Caleff<strong>in</strong>i parlò di alcuni sonetti di scherno <strong>contro</strong> più Signori<br />
italiani, ritrovati a Venezia «atachati a le colonne del palatio del pr<strong>in</strong>cipe, sive<br />
doxe, <strong>in</strong> Venetia […]» 68 : ebbene proprio uno di quei sonetti, quello che diede avvio<br />
ad una serie di risposte per le rime, uscì dalla penna del Pistoia, trattandosi di<br />
quel componimento giunto una matt<strong>in</strong>a di dicembre del 1492 69 appositamente da<br />
<strong>Ferrara</strong>, <strong>in</strong> cui il Pistoia scherniva i veneziani, parlando <strong>in</strong> versi dell’avvio dei lavori<br />
per la cosiddetta “Addizione Erculea”, che avrebbe gravemente nuociuto a<br />
Venezia.<br />
I sonetti VIII e IX della collana sono particolari, perché mettono <strong>in</strong> scena una<br />
sorta di dialogo tra due poeti: nell’VIII sonetto un altro anonimo rimatore (stilisticamente<br />
diverso dal Pistoia) si dice pronto a unire le proprie forze a quelle del<br />
Detrattore e gli dà appuntamento <strong>in</strong> piazza per l’<strong>in</strong>domani: perché di questo mostro<br />
aspro ed orribile / la istoria ti dirò, ch’io son dottissimo / de’ furti suoi, ed<br />
ho un libro pienissimo, / ove cose udirai quasi <strong>in</strong>credibile.<br />
Questa è una prova tangibile (e non si tratta di un mero espediente letterario)<br />
che gli autori impegnati <strong>contro</strong> l’Ariosto erano vari e, come nota M. Milani, non<br />
è improbabile che l’opposizione al Giudice fosse «ristretta a una cerchia di <strong>in</strong>tel-<br />
68 Dal cod. Vat. Lat. 9263, cc. 301-302v.<br />
69 Il sonetto di scherno, che diede avvio alla polemica, è il 393 della raccolta ambrosiana<br />
del Pistoia, O il Duca nostro fa i gran cavamenti, cui ben dieci poeti risposero per<br />
le rime.
Introduzione<br />
lettuali illum<strong>in</strong>ati, forse anche nobili che mal vedevano accrescersi la potenza<br />
della bassa e debile casetta degli Ariosti. […] Non capricci e scherzi dei soliti<br />
poeti di corte, personaggi a volte un po’ bizzarri, ben capaci di satire e <strong>in</strong>vettive,<br />
ma sempre pronti a seguire il vento del potere. Da questi sonetti sembra <strong>in</strong>vece<br />
trasparire qualcosa di più serio» 70 . Si manifesta, <strong>in</strong>vero, un’opposizione feroce<br />
da parte di chi non ha remore ad istigare il popolo all’<strong>in</strong>surrezione (sonetto VII),<br />
come difatti avverrà pochi anni dopo, con l’uccisione dello Zampante (<strong>contro</strong> il<br />
quale più volte si era scagliato il Pistoia nei suoi sonetti). Non mi pare dunque<br />
fuori luogo avanzare un nome per l’autore dell’ottavo sonetto: un poeta che il Pistoia,<br />
nel suo testamento letterario, def<strong>in</strong>ì, proprio come fa l’anonimo autore della<br />
corona <strong>contro</strong> l’Ariosto, fratello, ossia Lelio Manfredi (si rilegga la coda dell’ultimo<br />
sonetto del codice Ambrosiano):<br />
7. Cronologia<br />
Ecco la Morte: i miei sonetti al foco!<br />
Gli altri versi d’amor sian posti <strong>in</strong> sale;<br />
pur, se gli è alcun faceto e alcun morale,<br />
stiano, per fugir otio, fermi <strong>in</strong> gioco.<br />
Perché del viver mio resta ancor poco, 5<br />
d’ogni opra mia si faccia un carnevale:<br />
ché, quando un pezzo l’omo ha fatto male,<br />
è pur bon ravedersi a tempo e a loco.<br />
Lascio il Correggio mio, ch’è la mia musa,<br />
per quei che <strong>in</strong> tumul mi daran libello: 10<br />
ottimo ostacul <strong>contro</strong> a chi m’accusa.<br />
E lascio Gian Francesco Giann<strong>in</strong>ello,<br />
Ieronimo da Casi a far mia scusa,<br />
e, a Mantua, Paris col dir raro e bello.<br />
A Correggio un fratello: 15<br />
Lelio Manfredi, <strong>contro</strong> a questi cani,<br />
che la farà con versi e con le mani.<br />
1471-1505 Governo di Ercole d’Este (nato nel 1435).<br />
1471 Niccolò Ariosto va a Modena per uccidere Niccolò di Lionello d’Este (uno<br />
dei concorrenti di Ercole).<br />
1471 Niccolò Ariosto è nom<strong>in</strong>ato maggiordomo del Duca.<br />
1474 Nasce il primo dei dieci figli dell’Ariosto, Ludovico.<br />
1481 L’Ariosto è nom<strong>in</strong>ato Capitano della guarnigione di Rovigo.<br />
1482-84 Guerra <strong>contro</strong> Venezia.<br />
70 <strong>Sonetti</strong> ferraresi, cit., p. 301.<br />
29
30 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
1483 Peste a <strong>Ferrara</strong>. Il Pistoia è a <strong>Ferrara</strong>, al servizio degli Estensi.<br />
1484 L’Ariosto rientra a <strong>Ferrara</strong>, dove viene nom<strong>in</strong>ato collaterale dei soldati. Dimora<br />
con la famiglia <strong>in</strong> una casa <strong>in</strong> via Gioco del Pallone.<br />
1485 Il Pistoia è capitano alla porta Santa Croce a Reggio Emilia.<br />
1486 Niccolò Ariosto è nom<strong>in</strong>ato Giudice de’ XII <strong>Savi</strong>.<br />
1487 - 5 Aprile: il duca convoca presso di sé i dodici <strong>Savi</strong>, per prendere congedo<br />
da loro, prima della partenza per Santiago de Compostela; l’Ariosto<br />
manifesta pubblicamente il proprio rammarico per la partenza del duca.<br />
Il Pistoia è a <strong>Ferrara</strong>, dove, dal 9 al 15 giugno compone sonetti diffamatori <strong>contro</strong><br />
l’Ariosto.<br />
1489 Niccolò Ariosto è deposto dal duca e <strong>in</strong>viato come capitano a Modena. Il<br />
Pistoia esulta, <strong>in</strong> versi, per la cacciata dell’Ariosto da <strong>Ferrara</strong>.<br />
1490 Il Pistoia parte da <strong>Ferrara</strong> per un breve soggiorno a Roma.<br />
1500 Morte di Niccolò Ariosto.<br />
1502 Morte del Pistoia, a <strong>Ferrara</strong>, per sifilide.
II<br />
I Testi<br />
Criteri editoriali<br />
Si sono sciolte le abbreviazioni, adattati all’uso odierno le maiuscole e le gem<strong>in</strong>ate,<br />
<strong>in</strong>troducendo <strong>in</strong>oltre accenti ed apostrofi (questi ultimi impiegati anche<br />
per segnalare l’apocope e l’aferesi, quando la vocale <strong>in</strong>iziale caduta è seguita da<br />
nasale). Si è dist<strong>in</strong>ta u da v. La nota tironiana si è risolta <strong>in</strong> e; si è reso il nesso ph<br />
con f, ti con z e si è elim<strong>in</strong>ata l’h etimologica e paraetimologica.
32 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
SONETTI CONTRO NICCOLÒ ARIOSTO<br />
GIUDICE DE’SAVI IN FERRARA 1<br />
**************<br />
Data a Niccolò Ariosto, Giudice di’ Matti<br />
I.<br />
Ser Niccolò, del ferrarese sangue<br />
te vai facendo grasso a poco a poco;<br />
del tuo robar si parla <strong>in</strong> ogni loco:<br />
già ciascun cittad<strong>in</strong> afflitto langue.<br />
E tu che vedi la città esangue, 5<br />
non te vergogni e pur segui il tuo gioco,<br />
giugnendo sempre legne sopra ’l foco;<br />
pestifero, mordace e crudel angue.<br />
Lupo rapace, pubblico ladrone,<br />
<strong>in</strong>saziabile mostro <strong>in</strong>iquo e strano, 10<br />
nemico di giustizia e di ragione!<br />
Achi offerisce più, te mostri umano;<br />
ma se non muti stilo e op<strong>in</strong>ïone,<br />
te fia cantato un vespro siciliano.<br />
So che non parlo <strong>in</strong>vano: 15<br />
però estima ben questi toi fatti,<br />
magnifico mio Giudice dei Matti!<br />
CF:<br />
2. Ti vai; faciendo. 5. cittade 6. ti vergogni 7. giungendo; legna 11. giustizia 12. ti<br />
mostri 13. stile e op<strong>in</strong>ione 14. ti fia 16. questi tuoi<br />
Ms.:<br />
2. faciendo; pocho 4. afflicto 9. Luppo; publico 10. <strong>in</strong>saciabil; humano 13. stillo e<br />
opp<strong>in</strong>ione 14. scicialiano 17. Zudese.<br />
[Ser Niccolò, stai <strong>in</strong>grassando sempre di più, nutrendoti del sangue dei ferraresi.<br />
Ovunque si parla delle tue ruberie e già ogni cittad<strong>in</strong>o, <strong>in</strong>debolito, si <strong>in</strong>fiacchisce./<br />
E tu che vedi la città di <strong>Ferrara</strong> dissanguata, non ti vergogni e seguiti la<br />
1 Per altre <strong>in</strong>dicazioni sull’operato dell’Ariosto quale Giudice de’ <strong>Savi</strong>, oltre a quelle<br />
da me fornite nell’Introduzione, cfr. BORSETTI.
I Testi 33<br />
tua opera, aggiungendo nuove richieste alle vecchie. Sei un serpente velenoso,<br />
aggressivo e crudele./ Sei un lupo <strong>in</strong>gordo, un grassatore pubblico, un mostro <strong>in</strong>saziabile,<br />
disonesto e orrendo, nemico della giustizia e della rettitud<strong>in</strong>e./ Ti mostri<br />
clemente solo con chi ti offre di più, ma se non cambi stile e giudizio, f<strong>in</strong>iranno<br />
col cantarti un vespro siciliano./ So che non parlo <strong>in</strong>utilmente, perciò, considera<br />
bene questi tuoi comportamenti, magnifico mio Giudice dei Matti!]
34 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
Data a Magnaferro<br />
II.<br />
Quand’io ben penso a tua strana natura,<br />
rimango preso <strong>in</strong> gran confusïone:<br />
tu magni ’l legno, il marmore, il sabbione,<br />
il ferro e se gli è cosa ancor più dura.<br />
Se ’l tuo divorar gran tempo dura, 5<br />
di <strong>Ferrara</strong> serai distruzïone.<br />
Aspese del Comune la possessione<br />
comprasti e questa non è cosa oscura.<br />
E la tua bassa e debole casetta,<br />
levasti <strong>in</strong> alto, ser Niccolò mio. 10<br />
Questa è la legge ch’hai sotto la bretta.<br />
Tu credi che tal cosa piaccia a Dio.<br />
expecta pur la pena, expecta, expecta:<br />
giusto è ’l ciel, credi quel che te dic’io.<br />
O ladro, falso e rio. 15<br />
Sper vederti <strong>in</strong> man del manegoldo,<br />
Che ti darà la sp<strong>in</strong>ta per un soldo.<br />
In questo mezzo un broldo<br />
s’apparecchia per farti un bel cappello,<br />
acciò che ’l sol non te secchi ’l cervello. 20<br />
CF:<br />
3. tu mangi 4. ancora 6. sarai 7. Comun 9. debile 11. berretta 13. aspetta 14. ti dic’io<br />
16 spero; manigoldo<br />
Ms.:<br />
2. confussione 4. anchor 6. destructione 12. piaza (settentrionalismo attribuibile al<br />
copista) 17. mezo<br />
[Quando penso alla tua natura <strong>in</strong>solita, vengo assalito da una gran confusione:<br />
tu mangi il legno, il marmo, la rena, il ferro e anche cose più dure, se ve ne sono./<br />
Se questo tuo mangiare avidamente cont<strong>in</strong>uerà ancora, f<strong>in</strong>irai con l’essere la distruzione<br />
di <strong>Ferrara</strong>. Comprasti a spese del Comune la tua proprietà e questo non<br />
è certo un mistero./ E così <strong>in</strong>nalzasti la tua umile e mesch<strong>in</strong>a casetta, ser Niccolò<br />
mio. Questa è la legge che hai nella testa./ Tu credi che questo piaccia a Dio. Ma<br />
attendi pure la pena che il Signore ti riserva: il cielo è giusto, credi a me./ O ladro,<br />
falso e scellerato, spero di vederti <strong>in</strong> mano al boia che, per un soldo, sul patibolo<br />
ti darà la sp<strong>in</strong>ta per impiccarti./ Nel frattempo si prepara un sangu<strong>in</strong>accio per farti<br />
un bel cappello, perché il sole non ti faccia essiccare il cervello].
I Testi<br />
III.<br />
Data a Niccolò Ariosto più matto che mattissimo<br />
Io t’ammonii per dui sonetti mei,<br />
che lassasti il rubar, Niccolò mio;<br />
ma a quel ch’io sento, cresce il tuo desio:<br />
di novo se lamentan li giudei.<br />
Ma forse tu fai strazio de li ebrei, 5<br />
per vendicar il stento acerbo e rio.<br />
che ferno sopportar al sommo Iddio:<br />
<strong>in</strong> questo, Niccolò, pietoso sei.<br />
Ma i poveri villan, che con tormenti,<br />
s’affatican pel ben della cittade, 10<br />
che han fatto contra Dio, ché tu li stenti?<br />
Dimme, te par che questa sia pietade?<br />
Che fai misero te, ché non te penti?<br />
Pentite ormai di tal scelleritade.<br />
Odi tutte le strade. 15<br />
che te cridano dietro a gran furore:<br />
“Al ladro, al manigoldo, al malfattore!”.<br />
Perch’io bramo il tuo onore,<br />
te scrivo questo, <strong>giudice</strong> mio bello:<br />
già sei dep<strong>in</strong>to per ciascun bordello. 20<br />
CF:<br />
1. due sonetti miei 4. di nuovo si 6. lo stento 11. <strong>contro</strong> 12. Dimmi ti par 13. ti penti<br />
14. pentiti 16. ti gridano 20. dip<strong>in</strong>to<br />
Ms.:<br />
17. malfactore 18. honore 19. zudese<br />
[Ti misi <strong>in</strong> guardia attraverso due miei sonetti, aff<strong>in</strong>ché smettessi di rubare,<br />
Niccolò mio; ma da quel che sento, crescono le tue bramosie: gli ebrei si lamentano<br />
nuovamente./ Ma forse tu strazi gli ebrei, per vendicare le orrende e crudeli<br />
sofferenze che essi fecero sopportare al sommo Iddio: <strong>in</strong> questo, Niccolò, sei<br />
pio./ Ma i poveri contad<strong>in</strong>i che con grandi affanni si affaticano per il bene della<br />
città, cosa hanno fatto loro <strong>contro</strong> Dio perché tu li strazi?/ Dimmi, ti sembra che<br />
questa sia pietà? Cosa fai, misero te, perché non ti penti? Pentiti orsù di questa<br />
scelleratezza./ Ascolta la gente che da ogni strada ti grida dietro a gran voce: “Al<br />
ladro, al manigoldo, al malfattore!”/ Giacché io tengo al tuo onore, ti scrivo questo,<br />
<strong>giudice</strong> mio bello: tu già sei dip<strong>in</strong>to <strong>in</strong> ogni bordello].<br />
35
36 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
Data al gran ladrone<br />
IV.<br />
Io sento dire che tu preghi Madama,<br />
che faccia fare una crida patente,<br />
per ritrovar colui ch’è sì veemente<br />
<strong>in</strong> pubblicar la tua perversa fama.<br />
Niccolò, tu fai mal, ché colui t’ama; 5<br />
e per ritrar tua diabolica mente<br />
dai latroc<strong>in</strong>i noti <strong>in</strong> fra la gente<br />
te scrive, come quel ch’el tuo onor brama.<br />
Tu credi assass<strong>in</strong>are e quello e questo<br />
e che i toi furti debbian star celati? 10<br />
Il tuo robare è troppo manifesto.<br />
Ame ne venne alli giorni passati<br />
di Corbola il contado afflitto e mesto,<br />
e disse che gli avevi addimandati<br />
ben ducento ducati; 15<br />
ma volle Iddio che il furto se sentì,<br />
e <strong>in</strong> fumo il tuo pensier se convertì.<br />
El non mancò per ti,<br />
lupo rapace, maledetto e fello,<br />
che <strong>in</strong> sulle spalle avevi già l’agnello! 20<br />
Te par, Messer mio bello,<br />
che questa cosa non se debìa scrivere?<br />
Se voi ch’io taccia, emenda il tuo mal vivere!<br />
CF:<br />
2. grida 8. ti scrive 10. tuoi furti 11. rubare 16. se sentì 17. se convertì 18. Ei 21. ti<br />
par 22. debba<br />
Ms.:<br />
1. pregi 3. vehemente 5. te ama 7. latrosc<strong>in</strong>ij 8. honor 19. luppo<br />
[Io sento dire che tu preghi la Marchesa, che emani un bando per trovare<br />
quello che è così violento nel render pubblica la tua fama perversa./ Niccolò, tu<br />
fai male, perché costui ti ama e per distrarre la tua mente dai latroc<strong>in</strong>i noti tra la<br />
gente, ti scrive, come uno che ha a cuore il tuo onore./ Tu credi di poter uccidere<br />
questo e quello e che le tue nefandezze possano rimanere celate? Le tue ruberie<br />
sono troppo evidenti./ Vennero da me nei giorni passati, i cittad<strong>in</strong>i di Corbola,<br />
afflitti e addolorati, dicendo che avevi domandato loro ben duecento ducati; ma<br />
grazie a Dio si seppe della tua ruberia e il tuo <strong>in</strong>tento andò <strong>in</strong> fumo./ Il furto non<br />
fallì per causa tua, avido lupo, maledetto e <strong>in</strong>fame, che già avevi rapito l’agnello./<br />
Ti sembra, Messer mio bello, che questa cosa non si debba scrivere? Se vuoi<br />
che io taccia, correggi la tua vita scellerata!]
I Testi 37<br />
Data al conte di gnic-gnac<br />
V.<br />
Ciascun me dice ch’io segua il scrivere<br />
di te, Giudice mio, per castigarte;<br />
ma e’ ge vorria altro che penne e carte<br />
a far che tu lassasti il tuo mal vivere!<br />
Buon seria un ramo di c<strong>in</strong>quanta livere 5<br />
che ti spezzasse il capo <strong>in</strong> mille parti,<br />
o un duro laccio avesse a strangularti:<br />
questo a me parerebbe un bel descrivere.<br />
In te non è sc<strong>in</strong>tilla di vergogna;<br />
tu mostri non udire e alla rap<strong>in</strong>a 10<br />
<strong>in</strong>tento stai col becco di cicogna.<br />
Né guardi a nobil sangue, né a dottr<strong>in</strong>a,<br />
e a questo popol gratti sì la rogna,<br />
che non gie val <strong>in</strong>guento o medec<strong>in</strong>a.<br />
E per più gran ru<strong>in</strong>a, 15<br />
de’ ferraresi allevi un ghiottoncello,<br />
che resti dopo te nostro flagello.<br />
Ma presto al gran bordello,<br />
andrai col tuo Jeronimo Marchese,<br />
e mendicare ve vedrò le spese! 20<br />
CF:<br />
4. ci vorria; lassiasti 6. parte 7. strangolarti 14. gli val unguento o medic<strong>in</strong>a 20 vi<br />
vedrò<br />
Ms.:<br />
Rubrica: gnich gnach. 12. doctr<strong>in</strong>a 16. giottoncello 17. doppo<br />
[Ognuno mi dice che devo cont<strong>in</strong>uare a scrivere di te, Giudice mio, per castigarti,<br />
ma ci vorrebbe ben altro che le denunce scritte, perché tu cambiassi vita./<br />
Sarebbe necessario un ramo da c<strong>in</strong>quanta libbre, che ti rompesse la testa <strong>in</strong> mille<br />
pezzi, o un laccio robusto per strangolarti: questo mi sembrerebbe qualcosa di<br />
bello da descrivere./ In te non vi è un m<strong>in</strong>imo di vergogna, tu sembri non darmi<br />
ascolto e sei pronto a derubare col becco di cicogna la gente./ Né ti fermi di fronte<br />
ai nobili o alle persone colte e a questo popolo gratti f<strong>in</strong>anco la rogna, che non<br />
basta unguento o medic<strong>in</strong>a./ E per maggior rov<strong>in</strong>a dei ferraresi, tu allevi un piccolo<br />
furfante, che dopo di te sia il nostro flagello./ Ma andrai presto <strong>in</strong> malora<br />
col tuo Geronimo Marchese e vi vedrò mendicare il cibo!]
38 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
Data all’uccello struzzo<br />
VI.<br />
Da pria io ti chiamai ser Niccolò,<br />
non avendo di te ben cognoscenza;<br />
or ti darò della magnificenza<br />
poi che tua condizione e’l stato io so.<br />
Io prego che tu facci ch’io sia tò: 5<br />
tu sai pur ch’io son fatto a tua obbedienza,<br />
io t’amo, onoro e porto riverenza,<br />
non altramente che faria a un bò.<br />
E se me avvisi quando tu esci fuora<br />
di casa, <strong>in</strong>sieme anch’io con la tua setta 10<br />
ti farò coda, pur ch’io sappia l’ora.<br />
E son disposto non sol la bretta<br />
a te cavarme, ma le braghe ancora,<br />
da poi che ’l fumo tanto te diletta.<br />
Presto s’andrà a Zoetta, 15<br />
t’ammaestro però a poco a poco,<br />
acciò che meglio sappi usare il gioco.<br />
CF:<br />
2. conoscenza 8. altrimenti 14. ti diletta 15. Gioetta<br />
Ms.:<br />
2. havendo 3. magnificentia 4. condictione; scio 13. brage<br />
[Non conoscendoti bene, all’<strong>in</strong>izio ti chiamai ser Niccolò, ora ti darò del Magnifico,<br />
giacché conosco il tuo stato e la tua condizione./ Prego che tu faccia sì<br />
che io divenga tuo: sai che sono al mondo per ubbidirti, io ti amo, ti onoro e ti<br />
porto rispetto, non diversamente da come farei con un bue./ Se mi avvisi quando<br />
esci fuori di casa, ti seguirò anch’io, con la tua schiera, purché conosca l’ora./ E<br />
sono disposto a togliermi d<strong>in</strong>nanzi a te non solo il berretto, ma anche le braghe,<br />
giacché la puzza ti piace tanto./ Presto andremo a Gioetta, ma ti istruisco a poco<br />
a poco, aff<strong>in</strong>ché tu sappia giocare sempre meglio].
I Testi<br />
Data al pater patrie<br />
VII.<br />
Populo non dormir più, levate su<br />
prendi ormai l’arme <strong>contro</strong> questo can<br />
del Giudice crudele, aspro e villan,<br />
che te consuma e strazia ogni die più.<br />
Ite alla casa e sbattetela giù: 5<br />
oggi è da far senza expectare diman.<br />
Costui vi tien oppresso il v<strong>in</strong>o e el pan;<br />
per disfarve s’è dato a Belzebù.<br />
Clamate oramai: “Mora il gran ladron!<br />
Mora, mora il ladron che ne disfà, 10<br />
degno è d’ogni martir, d’ogni passion.<br />
Se ancora un mese <strong>in</strong> quest’offizio sta,<br />
mandarà nui <strong>in</strong> tal decl<strong>in</strong>azion,<br />
che mai più alcun de nui risorgerà”.<br />
Tiratelo di cà, 15<br />
e strasc<strong>in</strong>ato sia con gran supplizio,<br />
che a Dio fia grato simil sacrifizio.<br />
CF:<br />
1 Popol; levati 4. ti consuma … ogni dì 6. aspettare 7. ti tiene 8. disfarvi 9. Sclamate<br />
12. officio 13. manderà noi 14. di noi<br />
Ms.:<br />
3. Zudese<br />
[Popolo, non dormire più, alzati e prendi le armi <strong>contro</strong> questo cane del Giudice<br />
crudele, duro e villano, che ti logora e strazia ogni giorno di più./ Andate a<br />
casa sua e abbattetela: bisogna farlo oggi, senza attendere domani. Costui vi sottrae<br />
il v<strong>in</strong>o e il pane e per annientarvi si è dato al diavolo./ Gridate, f<strong>in</strong>almente:<br />
“Muoia il gran ladrone, muoia, muoia il gran ladrone che ci distrugge: egli è degno<br />
di ogni martirio, di ogni sofferenza./ Se rimane ancora un mese <strong>in</strong> carica, ci<br />
manderà <strong>in</strong> tale rov<strong>in</strong>a, che non risorgerà più nessuno./ Tiratelo fuori di casa e che<br />
sia trasc<strong>in</strong>ato con gran supplizio, poiché a Dio sarà gradito questo sacrificio].<br />
39
40 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
VIII.<br />
Data al divoratore della città di <strong>Ferrara</strong><br />
Oh tu che mosso sei tanto terribile<br />
<strong>in</strong> dir de Niccolò ladro espertissimo,<br />
parlar con teco me saria gratissimo:<br />
fa ch’io conosca te, se gli è possibile.<br />
Perché di questo mostro aspro ed orribile 5<br />
la istoria te dirò, ch’io son dottissimo<br />
de’ furti soi, ed ho un libro plenissimo,<br />
ove cose udirai quasi <strong>in</strong>credibile.<br />
Messo non ge hai che a trenta bologn<strong>in</strong>i<br />
torre el frumento marzo ai fornar fa, 10<br />
onde ne portan danno i cittad<strong>in</strong>i.<br />
Ed hai taciuto quando ai Masi ei va,<br />
che se fa far le spese ai contad<strong>in</strong>i,<br />
dicendo che improvviso egli è arrivà.<br />
Ed altre cose assà; 15<br />
ma forse cussì amplo e gran soggetto,<br />
ti fa mancar le rime e l’<strong>in</strong>telletto.<br />
Però diman t’aspetto,<br />
<strong>in</strong> su la piazza per parlar con teco,<br />
ch’io so ch’util te fia conferir meco. 20<br />
CF:<br />
2. di Niccolò 3. mi saria 4. s’egli è 9. non v’hai 10. marcio 13. si fa 20. ti fia<br />
Ms.:<br />
16. subjecto 18. t’expecto<br />
[Tu che sei tanto ardimentoso nel dare del ladro a Niccolò, mi sarebbe assai<br />
gradito parlare con te. Fa’ che io ti conosca, se possibile./ Perché ti dirò la storia<br />
di questo mostro aspro e orribile, poiché io conosco molto bene tutti i suoi furti<br />
ed ho un libro pieno di cose <strong>in</strong>credibili su di lui./ Tu non hai detto che egli fa<br />
comprare il frumento marcio ai fornai per trenta bologn<strong>in</strong>i, per cui ci rimettono i<br />
cittad<strong>in</strong>i./ E non hai detto che quando va ai Masi, si fa dare ogni ben di Dio dai<br />
contad<strong>in</strong>i, dicendo che è arrivato all’improvviso/ e hai tralasciato di dire altre cose<br />
ancora./ Ma forse un argomento così vasto ti fa mancare le rime e l’<strong>in</strong>telletto./<br />
Perciò ti aspetto domani sulla piazza per discutere con te, perché so che ti sarà<br />
utile parlare con me.]
Introduzione<br />
IX.<br />
Data a Niccolò degli Ariosti matto delli XII <strong>Savi</strong><br />
Oh tu che saper brami chi sia quello<br />
che sì di Niccolò predica e dice,<br />
perdoname ché qui dir non me lice<br />
il nome mio, ma io t’amo qual fratello.<br />
Ch’esser tu mostri al dir uom di cervello, 5<br />
e ché Caliope te sia fautrice;<br />
e certo io me terrò sempre felice,<br />
se veder posso quel tuo gran libello.<br />
Perch’io apparecchio un bischizo longissimo<br />
ov’io voglio per ord<strong>in</strong>e distendere, 10<br />
il viver suo scorretto e bestialissimo.<br />
E acciò che meglio ciascun possa <strong>in</strong>tendere,<br />
i furti di quest’uom scelleratissimo,<br />
lo farò a stampa <strong>in</strong> su le piazze vendere.<br />
Però ti piaccia prendere 15<br />
la penna <strong>in</strong> man, la carta con l’<strong>in</strong>chiostro,<br />
<strong>in</strong> darme aiuto a divulgar tal mostro.<br />
CF:<br />
3. perdonami … mi 4. ma t’amo 6. Calliopè ti sia 7. mi terrò 17. per darmi<br />
[Tu che desideri ardentemente sapere chi sia quello che predica e dice tanto<br />
male di Niccolò, perdonami, ma qui non mi è consentito dire il mio nome, eppure<br />
sappi che ti amo come un fratello./ Giacché attraverso i tuoi scritti, mostri di<br />
essere un uomo di cervello, ti auguro che la musa della poesia epica e dell’eloquenza<br />
ti assista, e mi riterrò felice, se potrò vedere quel tuo gran libello./ Dato<br />
che sto preparando una composizione satirica lunghissima, nella quale voglio<br />
trattare per ord<strong>in</strong>e del suo vivere scorretto e folle./ E perché ciascuno possa conoscere<br />
meglio le malefatte di quest’uomo scellerato, la farò stampare e vendere<br />
<strong>in</strong> piazza./ Dunque ti piaccia prendere la penna <strong>in</strong> mano, la carta e l’<strong>in</strong>chiostro,<br />
ed aiutarmi a divulgare le cattive azioni di questo mostro.]<br />
41
42 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
Data al gran sberettiero<br />
X.<br />
Di te tacere avea deliberato,<br />
ma Stefano Furlan buon contad<strong>in</strong>o,<br />
venuto è a me dolente e assai mesch<strong>in</strong>o,<br />
dicendo: “Scrivi un furto <strong>in</strong>usitato”.<br />
Il tuo <strong>giudice</strong> degno m’ha robato, 5<br />
s’io ho voluto farme cittad<strong>in</strong>o,<br />
un gran pezzo di terra, e ancor Zann<strong>in</strong>o<br />
del Fabbro tel dirà ch’ei fu arrogato.<br />
E tanti prieghi il poverel mi fe,<br />
che di nuovo la penna ho presa <strong>in</strong> mano: 10<br />
ladron non ha coscienza e non ha fè.<br />
Ma se ciascuno il prezzo del Furlano,<br />
per farsi cittad<strong>in</strong>o pagar dè,<br />
ognun più presto voglia esser villano.<br />
Ma sento che, piano piano, 15<br />
tu vai dicendo che al Signor de noi,<br />
come tornato sia, doler ti vuoi.<br />
Deh taci, ché se i toi<br />
furti presenti <strong>in</strong>tende e i preteriti,<br />
impiccar te farà come tu meriti. 20<br />
CF:<br />
5. rubato 7. Giann<strong>in</strong>o 13. offrir ti dè (assolutamente di fantasia questa lettura di Cappelli)<br />
18. se i tuoi 19. l’<strong>in</strong>tende (si tratta di lettura errata dell’h- <strong>in</strong>iziale presente nel ms.)<br />
Ms.:<br />
5. zudese 7. Zan<strong>in</strong>o 12. pretio 19. h<strong>in</strong>tende<br />
[Avevo deciso di non scrivere più di te, ma Stefano Furlano, buon contad<strong>in</strong>o,<br />
è venuto da me triste e afflitto, dicendomi: “Scrivi di un fatto <strong>in</strong>usitato. Il tuo degno<br />
<strong>giudice</strong>, quando ho voluto diventare cittad<strong>in</strong>o, mi ha rubato un gran pezzo di<br />
terra; anche Giann<strong>in</strong>o del Fabbro te lo dirà, perché lui ha curato il rogito”./ E il<br />
poverello tanto mi ha pregato, che ho preso di nuovo la penna <strong>in</strong> mano: il ladrone<br />
non ha coscienza e non ha fede./ Ma se tutti quelli che vogliono diventare cittad<strong>in</strong>i,<br />
devono pagarti il prezzo che t’ha pagato il Furlano, desidereranno tutti rimanere<br />
contad<strong>in</strong>i./ Sento dire che hai <strong>in</strong>tenzione di lagnarti di noi con il Duca,<br />
quando ritornerà./ Suvvia, taci, perché se viene a sapere dei tuoi furti presenti e<br />
di quelli passati, ti farà impiccare come meriti.]
I Testi<br />
Dato al volto <strong>in</strong>vedrià, ladro <strong>in</strong>saziabile<br />
XI.<br />
Misera patria, piena di disgrazia,<br />
quando uscirai di tanta amaritud<strong>in</strong>e?<br />
Contempla con che gran sollecitud<strong>in</strong>e<br />
Niccolò ti consuma, afflige e strazia.<br />
Questo arrabbiato lupo mai si sazia; 5<br />
<strong>in</strong> lui non è pietà, né mansuetud<strong>in</strong>e:<br />
spelonca è di rap<strong>in</strong>e e <strong>in</strong>gratitud<strong>in</strong>e,<br />
vuoto d’ogni vergogna e pien d’audazia.<br />
Non venne il spirto suo dal ciel stellifero:<br />
Satana il generò sol per tuo eccidio, 10<br />
e nel corpo dapoi gli entrò Lucifero.<br />
Non basteria Lucan, Persio né Ovidio,<br />
a scriver di quest’uomo sporco e pestifero;<br />
ma spero presto al ciel verrà <strong>in</strong> fastidio.<br />
E per suo buon sussidio 15<br />
manderà Giove una saetta <strong>in</strong> furia,<br />
che vendetta farà di tanta <strong>in</strong>giuria.<br />
CF:<br />
Rubrica: <strong>in</strong>vetriato 11. nel corpo di lui gli entrò<br />
Ms.:<br />
17. <strong>in</strong>juria<br />
[Misera patria, piena di sventura, quando verrai fuori da tanta amarezza?<br />
Guarda con che diligenza Niccolò ti consuma, tormenta e affigge./ Questo lupo<br />
arrabbiato non si sazia mai, <strong>in</strong> lui non vi è pietà, né docilità. Egli è ricettacolo di<br />
rap<strong>in</strong>e e <strong>in</strong>gratitud<strong>in</strong>e, privo di qualsiasi vergogna e pieno d’audacia./ Il suo spirito<br />
non scese dal cielo stellato, ma lo generò Satana solo per distruggerti e nel<br />
suo corpo entrò poi Lucifero./ Non basterebbero Lucano, Aulo Persio, né Ovidio<br />
per scrivere di quest’uomo sordido e pestilenziale, ma spero che presto verrà <strong>in</strong><br />
odio a Dio./ E che Giove, per aiutarci con la sua bontà, mandi una saetta, che<br />
vendicherà tanta <strong>in</strong>solenza].<br />
43
44 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
XII.<br />
Sonetto comm<strong>in</strong>atorio, compilato per Niccolò,<br />
padre della patria e conte palat<strong>in</strong>o <strong>contro</strong> il Detrattore<br />
La poesia per certo è troppo ardita<br />
troppo s’estende <strong>in</strong> detrarre il mio onore:<br />
io son pur della patria protettore,<br />
anzi, quel padre che gli dà la vita.<br />
Ma chi ha la sua l<strong>in</strong>gua nel mal dir forbita, 5<br />
d’<strong>in</strong>vidia è segno e non d’alcuno amore:<br />
io farò m’<strong>in</strong>tendere a Madama e al Signore,<br />
con l’eloquenza mia ornata e fiorita.<br />
Scio ben che Sue Eccellenze avran per male<br />
che sia stimata mia persona magna 10<br />
a <strong>Ferrara</strong> una zucca senza sale.<br />
All’India, al Catai, Marocco e Spagna,<br />
se ben volasse il Detrattor con l’ale,<br />
già gli ho per carpir lui tesa una ragna.<br />
E perch’ei non guadagna 15<br />
di questa sua <strong>in</strong> grosso mercanzia,<br />
sempre contemplo con la fantasia.<br />
Su, Magagn<strong>in</strong>, va’ via,<br />
e porta sto sonetto <strong>in</strong> fra la gente,<br />
acciò che paia ch’io non tema niente. 20<br />
CF:<br />
7. farò m’<strong>in</strong>tenda Madama e ’l Signore 8. con l’ornata eloquenza mia fiorita 9. So<br />
ben 14. or gli ho per carpir lui tesa una ragna<br />
Ms.:<br />
2. extende 4. anci 12. Da <strong>in</strong> India, dal Cathaio<br />
[La poesia è certamente troppo ardita e troppo si dilunga a vituperare il mio<br />
onore: io sono protettore della patria, anzi sono quel padre che le dà la vita./ Ma<br />
chi ha la l<strong>in</strong>gua ammaestrata nel dir male è <strong>in</strong>vidioso e privo d’amore: farò <strong>in</strong><br />
modo che mi ascolt<strong>in</strong>o la duchessa e il duca, parlerò con la mia eloquenza forbita./<br />
So bene che le Eccellenze si dispiaceranno molto del fatto che la mia pregevole<br />
persona sia considerata, a <strong>Ferrara</strong>, una zucca senza sale./ Seppure il mio detrattore<br />
volasse <strong>in</strong> India, <strong>in</strong> Catai, <strong>in</strong> Marocco o <strong>in</strong> Spagna, gli ho teso una trappola<br />
per acciuffarlo./ E, dato che egli non ci guadagna nulla con questa mercanzia<br />
all’<strong>in</strong>grosso, io sogno sempre di catturarlo./ Su, Magagn<strong>in</strong>o, va’ via e porta<br />
questo sonetto tra la gente, perché si capisca che io non temo niente].
I Testi<br />
XIII.<br />
Sonetto compilato per Niccolò Ariosto,<br />
All’illustriss. Madama Duchessa di <strong>Ferrara</strong>.<br />
Illustrissima mia cara Madama,<br />
ogni bel ballo a lungo andar r<strong>in</strong>cresce:<br />
parmi oramai ch’io sia un nuovo pesce,<br />
o quella ch’ogni occel sul palmon chiama.<br />
Vostra Eccellenza poco il mio onor ama, 5<br />
e ogni dì <strong>in</strong> men favor la mi riesce;<br />
però materia di mal scriver cresce,<br />
al detrattor della mia chiara fama.<br />
Deh, fate fare, s’el vi piace, una grida<br />
comm<strong>in</strong>atoria, ov’io gli sia nomato 10<br />
con prem<strong>in</strong>enza di persona fida.<br />
Ch’io sia Fabrizio o l’Uticense Cato,<br />
e che per niente alcun non mi derida,<br />
nel mio governo e viver costumato.<br />
Se non, ch’ei sia impiccato; 15<br />
ed io farò l’offizio senza soldo,<br />
per spesa al Comun tuor del manigoldo.<br />
CF:<br />
6. ch’ogni dì 10. ov’io vi sia nomato 16. l’ufficio 17. tor<br />
[Illustrissima mia cara Duchessa, a lungo andare anche il più bel ballo viene<br />
a noia: mi sento un avannotto facile da pescare o la pania che cattura gli uccelli<br />
sul palmone. /Vostra Eccellenza ha poco a cuore il mio onore, perchè ogni giorno<br />
vedo che perdo i Vostri favori e perciò il mio detrattore ha sempre più materia<br />
per scrivere male della mia chiara fama./ Orsù, fate fare, per favore, una grida<br />
comm<strong>in</strong>atoria, dove io appaia nom<strong>in</strong>ato come persona di fiducia./ In modo che<br />
io vi appaia come un Fabrizio o un Catone, e perché nessuno mi prenda <strong>in</strong> giro<br />
per il mio governo e il mio modo di vivere./ Se così non sarà, allora ch’egli venga<br />
impiccato, ed io farò l’ufficio senza esser pagato, a spese del Comune].<br />
45
46 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
XIV.<br />
Dolce e amorevole Raccoglienza fatta all’Illustr. Signor nostro<br />
nel suo ritorno, per Niccolò Ariosto<br />
Signor mio caro, vui siati il ben venuto<br />
per mille volte e anche il ben trovato:<br />
vui sete sempre sano e salvo stato,<br />
poi ch’io non v’ho, a quel ch’io <strong>in</strong>tendo, veduto?<br />
Piacemi assai! Così Giove <strong>in</strong> aiuto 5<br />
mi sia cont<strong>in</strong>uo avante apparecchiato,<br />
ma perché ho sol ben retto il Vostro Stato,<br />
son, Signor mio, da ognuno <strong>in</strong> odio avuto.<br />
E udite poi che giunta ho io da un ghiotto:<br />
che a’ preghi altrui sì il capo mi rasenza 10<br />
e <strong>in</strong> rima egli ha il mio onor fornito e cotto.<br />
Io dirò ben alla Vostra Eccellenza,<br />
più a destro il tutto, perché forse un grotto<br />
sarei tenuto qua <strong>in</strong> Vostra presenza.<br />
Dalla magnificenza 15<br />
di questi baron chiari e cavalieri,<br />
che scio che me caleffan volentieri.<br />
CF:<br />
1. mio caro, siate 2. tornato 3. siete voi sempre 4. come <strong>in</strong>tendo 6. vi sia 17. che so<br />
che mi<br />
[Mio caro Signore siate mille volte il benvenuto e il ben tornato. Siete sempre<br />
stato bene, dato che non vi ho visto?/ Mi fa molto piacere, che Dio mi assista<br />
sempre: solo perché ho retto bene il Vostro Stato, sono venuto <strong>in</strong> odio a tutti./ E<br />
ascoltate poi quale cattiveria supplementare mi viene da un disgraziato, il quale<br />
mi fà lavate di capo e con le sue rime ha diffamato il mio onore./ Io dirò all’Eccellenza<br />
vostra il tutto <strong>in</strong> privato, più comodamente, perché se lo facessi ora sarei<br />
ritenuto un uomo mesch<strong>in</strong>o/ da questi stimabili baroni e cavalieri che so mi<br />
prendono <strong>in</strong> giro volentieri.]
I Testi<br />
XV.<br />
Umana e graziosa risposta fatta al detto Niccolò<br />
per lo prelibato Illustriss. Signor nostro.<br />
Noi vi abbiam, Niccolò, ben cognosciuto<br />
sempre prudente, savio e accostumato:<br />
il mondo Vi dà quel che ’l ciel gli ha dato,<br />
che niente <strong>in</strong>fonde di grazia compiuto.<br />
A nui r<strong>in</strong>cresce e molto è dispiaciuto 5<br />
sapere che siati sì poco estimato:<br />
ma almen che sia, ne avete un buon mercato,<br />
poiché pur peggio non V’è <strong>in</strong>travenuto.<br />
Copriteve la testa col zuccotto,<br />
ché tira vento, e Vui con dispiacenza 10<br />
nostra dal freddo sareste corrotto.<br />
Volemo a ogni modo abiati pacienza,<br />
per nostro amor, e che facciati un scotto<br />
a chi scrivendo Vi dà penitenza.<br />
Ché gli è somma prudenza 15<br />
saper temporeggiar coi cervellieri,<br />
che sanno a mente tutti li mestieri.<br />
CF:<br />
1. conosciuto 2. costumato 3. vi ha dato 5. noi 6. sciapere; che siete 12. vogliamo<br />
abbiate ogni modo pazienza 13. facciate<br />
Ms.:<br />
16. sciapere 17. sciano … gli mestieri<br />
[Niccolò, noi Vi sappiamo un uomo prudente, savio e di bei modi: il mondo<br />
vi rende ciò che il cielo, che certo non regala grazia ed eccellenza di costumi, gli<br />
ha dato./ A noi r<strong>in</strong>cresce e ci è dispiaciuto molto sapere che siete così poco stimato:<br />
ma dato che è così, ritenetevi fortunato, perché non vi è capitato di peggio./<br />
Copritevi la testa con lo zuccotto, poiché tira vento e Voi con nostro dispiacere<br />
sareste colpito dal mal tempo./ Vogliamo che comunque abbiate pazienza,<br />
per amor nostro, e che paghiate lo scotto a chi scrivendo vi dà pena./ Poiché è assai<br />
prudente saper temporeggiare con gli uom<strong>in</strong>i di bell’umore, che ben conoscono<br />
ogni mestiere.]<br />
47
48 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
Al gran flagello<br />
XVI.<br />
Credi forse ch’io abbia a starmi <strong>in</strong> stroppa<br />
con dir “il gatto è gionto <strong>in</strong> la dispensa,<br />
e ’l topo ch’era sì acconcio alla mensa<br />
sta guatto, ascoso dentro a qualche toppa?”<br />
Gnaffe, bon pro! Tu voi che di Gioan Stoppa 5<br />
di scriver resti a tua vergogna immensa?<br />
Ma gli è ’na robaria, chi ben la pensa,<br />
d’una mannaia darte <strong>in</strong> su la coppa.<br />
Il poverello avea sangue sudato,<br />
ben mille volte, restaurando i ponti, 10<br />
tanto che col Comun avea avanzato<br />
ducati ottanta; e poi, fatt’i suoi conti,<br />
di qual, se lui ne volse esser pagato,<br />
convenne a parte far teco dui monti.<br />
Lassa: ch’a suoi orizzonti 15<br />
t’aspetta ’l gran Pluton, poi ch’un capestro,<br />
t’avrà d’andare, a lui concesso il destro!<br />
CF:<br />
Rubrica: flagellato (altro esempio di lettura errata e fuorviante di Cappelli) 7. ruberia<br />
13. quel 14. due<br />
[Credi forse che io debba avere soggezione nel dire: “il gatto è arrivato alla<br />
dispensa e il topo che era così avvezzo alla mensa sta nascosto dentro a qualche<br />
buco?” In fede, buon pro ti faccia! Vuoi che quel che hai fatto con Gioan Stoppa<br />
resti scritto a tua imperitura vergogna? Ma questa è una ruberia, e chi ci riflette<br />
bene, ti darebbe una mannaia sul collo. Il poverello aveva sudato sangue mille<br />
volte restaurando i ponti, tanto che era <strong>in</strong> credito col Comune di ottanta ducati e<br />
poi, fatti i suoi conti, quando volle esser pagato, di quegli ottanta ducati dovette<br />
far con te, <strong>in</strong> disparte, due mucchietti.<br />
Aspetta, perché dopo la tua impiccagione, ti attende all’Inferno il grande Plutone,<br />
al quale dovrai fare atto di sottomissione.]
I Testi<br />
Data al magnaterra.<br />
XVII.<br />
Mille saluti con commendazione<br />
Al Magnifico, per parte del Furlano,<br />
ch’el creò cittad<strong>in</strong>, ch’era villano,<br />
ricco d’un pezzo bel di possessione.<br />
Questo lupo rapace, anzi leone 5<br />
famelico del pover sangue umano,<br />
avaro, al bel terren, furioso e <strong>in</strong>sano,<br />
se slanciò e divorollo <strong>in</strong> un boccone.<br />
L’agresto villanzon, morbido e grasso,<br />
di roba più ch’esperto d’addiettivi, 10<br />
nel dimacrar diè <strong>in</strong> terra un gran fracasso.<br />
El Magnaferro, co’ suoi superlativi,<br />
calvo, con gli occhi saettando a spasso,<br />
com<strong>in</strong>ciò a lat<strong>in</strong>ar per i passivi.<br />
Dicendo: “Scrivi, scrivi, 15<br />
Giann<strong>in</strong> del Fabbro, un publico istrumento,<br />
come il manzo, d’accordo el, sta contento”.<br />
CF:<br />
2. da parte 11. dimagrir 12. Il Magnafer 17. ei<br />
[Mille saluti, con rispetto, al Magnifico Giudice da parte del Furlano, che da<br />
ricco contad<strong>in</strong>o il Giudice fece diventare cittad<strong>in</strong>o ferrarese./ Questo lupo <strong>in</strong>gordo,<br />
anzi leone avido del povero sangue umano, avaro, ghiotto e dissennato, si<br />
lanciò sul bel terreno e lo divorò <strong>in</strong> un sol boccone./ Il contad<strong>in</strong>o, morbido e<br />
grasso, più esperto di cose concrete che di aggettivi, nel dimagrire cadde <strong>in</strong> terra<br />
con grande fracasso./ Il Magnaferro, con i suoi superlativi, calvo, saettando con<br />
gli occhi, <strong>in</strong>iziò a parlare difficile, dicendo “Scrivi, scrivi, Giann<strong>in</strong> del Fabbro,<br />
un rogito pubblico su come lo sciocco contad<strong>in</strong>o è tutto contento dell’accordo”.]<br />
49
50 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
XVIII.<br />
Data al pelador di gatti salvadegi, el magnaferro.<br />
(Dialogo fra un Villano, Niccolò e Squarzone)<br />
Villano: “Tòcche!” Niccolò: “Squarzon!” Squarzone: “Messer”<br />
N.: “Guarda chi è quello”.<br />
S.: “Chi batte all’uscio?” V.: “Io dimando il Messere”.<br />
N.: “Chi èllo?” S.: “È uno il qual mi pare avere<br />
sopra le spalle un buon e grasso agnello”.<br />
N.: “Menal su. Ben ne venga il mio Bertello”. 5<br />
V.: “Io son venuto per farvi sapere<br />
che ’l Vostro Magagn<strong>in</strong>o, oltre il dovere,<br />
l’altrier mi tolse una coltre e un mantello<br />
perch’io non sono andato al lavoriero:<br />
Messere a questo non sono obbligato!” 10<br />
N.: “Gli ha fatto mal, ma non ti dar pensiero!<br />
Gran mercé dell’agnel che m’hai donato…<br />
senza quel t’avrei visto volentiero”.<br />
V.: “Ma non l’ho qui, Messer, per Voi portato:<br />
io lo porto al mercato 15<br />
per venderlo e comprarmi pane e v<strong>in</strong>,<br />
ch’io ho la moglie e c<strong>in</strong>que fantes<strong>in</strong>.”<br />
N.: “Su, presto, Magagn<strong>in</strong>,<br />
e tu, Squarzon, menatelo <strong>in</strong> prigione!”<br />
V.: “Messer, e’ non vuol questo la ragione…” 20<br />
N.: “Oh, brutto villanzone!”<br />
V.: “Ecco l’agnello, e lassatemi andare!”<br />
N.: “Lassal; ma mai di questo non parlare!”<br />
CF:<br />
Rubrica: pelator de’ gatti selvatici, magnafer<br />
Villano: “Toc, toc!” Niccolò: “Squarzone!” Squarzone: “Signore?” N.: “Guarda<br />
chi è” S.: “Chi bussa alla porta?” V.: “Io chiedo del Signore” N.: “Chi è costui?”<br />
S.: “È uno che mi pare abbia sulle spalle grasso e buon agnello”. N.: “Fallo<br />
salire. Ben ne venga il mio Bertello”. V.: “Io sono venuto per farvi sapere che<br />
il Vostro Magagn<strong>in</strong>o, oltre il dovuto, l’altro giorno mi tolse una coperta e un mantello<br />
perché io non sono andato a pesca: Signore a questo non sono obbligato!”.<br />
N.: “Magagn<strong>in</strong>o ha fatto male, ma non darti pena! Grazie per l’agnello che mi hai<br />
regalato, ma anche senza questo ti avrei rivisto volentieri!”. V.: “Ma Signore, non<br />
l’ho portato qui per Voi: lo porto al mercato per venderlo e comprarmi pane e v<strong>in</strong>o,<br />
perché ho moglie e c<strong>in</strong>que bamb<strong>in</strong>i”. N.: “Su, presto, Magagn<strong>in</strong>o, e tu, Squarzone,<br />
portatelo <strong>in</strong> prigione!”. V.: “Messere, non è questo un motivo…” N.: “Oh,<br />
brutto screanzato!”. V.: “Ecco l’agnello, e lasciatemi andare!” N.: “Lascialo; ma<br />
non parlare mai di quanto è avvenuto!”
I Testi<br />
XIX.<br />
Dalida, mogliere del Magnaferro, lo ammonisce.<br />
Magnifico marito mio dolcissimo,<br />
io non ardisco più di casa uscire,<br />
perch’io mi sento dietro a ciascun dire:<br />
“Ecco la moglie del ladro atrocissimo!”<br />
Io so che tu se’ accorto e sapientissimo, 5<br />
però, se brami pur tanto il rapire,<br />
sforzati i furti toi sempre coprire,<br />
per acquietare questo rumore altissimo.<br />
Niccolò, ditto Magnaferro, gli risponde:<br />
Or, non usar con me simil parole!<br />
Io robo e roberò, ché <strong>in</strong> fra la gente, 10<br />
chi è senza roba matto dir si sole.<br />
Da prima ne fuggìan tutt’ i parenti,<br />
or ne fan festa: o Dalida, el se vole,<br />
mentre si può, mangiar con tutti i denti.<br />
Quando biasmar li senti, 15<br />
serra l’orecchie, e non stare a contendere:<br />
come io fo, che mostro non <strong>in</strong>tendere.<br />
CF:<br />
Rubrica: Daria, moglie del magnaferro, lo ammonisce 7. tuoi 8. acquetar Intestazione:<br />
detto Magnaferro le risponde 9. Eh non usar 11. si suole 13. Daria, egli si vuole<br />
[Daria, moglie del magnaferro, lo ammonisce.<br />
Magnifico marito mio dolcissimo, non oso più uscire di casa, perchè sento<br />
dietro alle mie spalle la gente dire: “Ecco la moglie del ladro orrendo!”. Io so<br />
che tu sei prudente e sapientissimo, perciò, se ti piace tanto rubare, cerca almeno<br />
di tener celati i tuoi furti, per attenuare queste chiacchiere.<br />
Niccolò, detto Magnaferro, le risponde:<br />
Tu, non usare simili parole con me! Io rubo e ruberò, perché la gente considera<br />
matto chi è senza roba. Prima tutti i parenti fuggivano, adesso fanno festa: Daria,<br />
bisogna mangiare con tutti i denti f<strong>in</strong>ché si può. Quando senti la gente biasimarti,<br />
chiuditi le orecchie e non stare a litigare: come faccio io, che f<strong>in</strong>go di non<br />
sentire.]<br />
51
52 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
XX.<br />
Gloria <strong>in</strong> excelsis Deo, <strong>in</strong> terra pace.<br />
Giubila, mesta patria, ridi e canta:<br />
la cassia è data, medec<strong>in</strong>a santa,<br />
al Magnafer, ladron publico e audace.<br />
Inclito Duca, a cui il vizio dispiace, 5<br />
ben te r<strong>in</strong>grazio di clemenzia tanta;<br />
ma più s’<strong>in</strong> piazza una forca se pianta,<br />
per far giustizia del lupo rapace.<br />
O boni patrizi eletti, io vi ricordo,<br />
che ’l corvo non condice <strong>in</strong> fra i pavoni, 10<br />
però scacciate questo aspide sordo.<br />
E voi, plebei, suonate i tamburloni,<br />
sgridandol per le strade: “Al spurco e lordo!”<br />
corona s<strong>in</strong>gular di poltronzoni.<br />
E con levi e ventroni, 15<br />
per dignità acquistate nell’offizio,<br />
sia <strong>in</strong> salutarlo a gara ogn’uom propizio.<br />
CF:<br />
3. medic<strong>in</strong>a 5. spiace 6. ti … clemenza 7. se <strong>in</strong> … si pianta 13. Al sporco, al lordo 14.<br />
s<strong>in</strong>golar<br />
Ms.:<br />
17. garra<br />
[Gloria <strong>in</strong> excelsis Deo, e <strong>in</strong> terra pace./ Gioisci, povera patria, ridi e canta:/<br />
la senna è data, medic<strong>in</strong>a santa,/ al Magnaferro, ladro pubblico e audace./ Nobile<br />
duca, a cui non piace il vizio,/ ti r<strong>in</strong>grazio di tanta benevolenza,/ ma ti r<strong>in</strong>grazierò<br />
ancor più se si pianta una forca <strong>in</strong> piazza,/ per far giustizia del lupo vorace./<br />
Buoni padrizi eletti, vi ricordo/ che il corvo non sta bene tra i pavoni,/ dunque<br />
scacciate questa serpe sordida./ E voi, gente, suonati i tamburoni,/ gridando<br />
per le strade: “Al sporco, al lordo!”,/ massa di <strong>in</strong>dolenti. E, per la dignità che egli<br />
ha acquistato nell’ufficio,/ sia ogni uomo ben disposto a salutarlo con levi e ventroni].
I Testi<br />
XXI.<br />
Modena se lamenta e dice oimè<br />
io mi sento doler forte la testa,<br />
perché <strong>Ferrara</strong> giubila e fa festa,<br />
della sua febbre che venir me dè.<br />
Misera agnella me, che mal per me, 5<br />
dal gran suo lupo <strong>in</strong> preda son richiesta,<br />
ché se ’l Pastor mio aduito non mi presta,<br />
scannata ho già la pelle per mia fé.<br />
Misericordia, alturio: adiuta, adiuta,<br />
San Gem<strong>in</strong>ian, s’<strong>in</strong> ciel col sommo Giove, 10<br />
Mai per te cosa alcuna si è potuta.<br />
Vedi la mala bestia che se move,<br />
ver me, tanto rabbiosa divenuta,<br />
ch’el par che mai la non mangiasse altrove.<br />
E io so per mille prove, 15<br />
del suo gran divorar: ma ell’è sì ria,<br />
che dopo il pasto ha più fame che pria.<br />
Però se <strong>in</strong> agonia<br />
son constituta, tu sai la cagione,<br />
sì ch’io ti chiamo <strong>in</strong> mia defensïone.<br />
CF:<br />
5. omé 7. aiuto 9. aiuto: aiuta, aiuta 10. se <strong>in</strong> ciel 14. che par<br />
Ms.<br />
10. San Zimignan<br />
[Modena si lamenta e dice ahimé,/ sento che mi fa male la testa,/ perché <strong>Ferrara</strong><br />
gioisce e fa festa/ per la sua febbre che mi deve venire./ Misera agnella, che<br />
sono richiesta come preda dal suo gran lupo,/ mal per me, perché se il pastore<br />
non mi presta aiuto,/ ho già la pelle scannata, <strong>in</strong> fede mia!/ Misericordia, soccorretemi:<br />
aiutami, aiutami,/ San Gimignano, <strong>in</strong> cielo con il sommo Iddio,/ se mai<br />
hai potuto far qualcosa./ Vedi la malefica bestia che si muove verso di me,/ divenuta<br />
tanto rabbiosa,/ che sembra che non abbia mai mangiato altrove./ Io so per<br />
mille testimonianze/ del suo grande divorare:/ ma la bestia è così cattiva/ che dopo<br />
aver mangiato ha più fame di prima./ Perciò se sono dest<strong>in</strong>ata all’agonia,/ tu<br />
ne conosci la ragione,/ così che ti chiamo <strong>in</strong> mia difesa].<br />
53
54 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
Dialogus<br />
(Niccolò e Daria)<br />
XXII.<br />
Niccolò: “Daria, sorella, il fia’ mi viem a men,<br />
Lo è adesso un mese io non divora’,<br />
e ho padito tutto il stragualzà,<br />
fer, marmor, sabbion, legn, paglia e fen.<br />
Mill’anni il dì mi par, sì tardo vien 5<br />
il tempo, ch’io sia a Modena arrivà;<br />
ché, se ’l desegno mio non va fallà,<br />
là tanto sluviaren che s’empiren!”.<br />
Daria: “Caro marito, affrena il dente tò:<br />
hai troppo pien il v<strong>in</strong>tre, e per mia fè, 10<br />
chi tutto volse, di rabbia crepò.<br />
Tu il sciai: di tanta <strong>in</strong>famia il viver n’è,<br />
che niun di nui di casa uscir non pò<br />
perché ogn’uon dietro adì ne fa “ve’, ve’,<br />
ai ladri, uz, te te”, 15<br />
che par ch’abbiàn crocifisso Jesù,<br />
però sii savio e non robar mai più!”<br />
Niccolò: “Il to dicto bon non fu:<br />
io ho tanta fame ch’a Modena ancora<br />
slovezarò la preda arengadora”. 20<br />
[Niccolò: “Daria, sorella, mi manca il fiato. È un mese che non divoro e ho<br />
digerito tutto ciò che ho trangugiato: ferro, marmo, sabbione, legno, paglia e fieno./<br />
Mi pare che il giorno <strong>in</strong> cui andrò a Modena sia lontano mille anni, e poi, se<br />
il mio progetto non fallirà, là ci <strong>in</strong>gozzeremo e ci riempiremo.<br />
Daria: caro marito, frena i tuoi denti, hai il ventre troppo pieno, <strong>in</strong> fede mia,<br />
chi tutto volle, crepò di rabbia. Tu lo sai, siamo tanto <strong>in</strong>famati che nessuno di noi<br />
può uscire di casa perché sentiamo gridarci dietro “ve’, ve’, ai ladri, uz, té, té” e<br />
pare che abbiamo crocefisso Gesù, dunque sii savio e non rubare mai più.<br />
Niccolò: “La tua predica non serve a niente: ho tanta fame che anche a Modena<br />
<strong>in</strong>gollerò anche la pietra arr<strong>in</strong>gadora!”]
I Testi<br />
Ad Jo. Jeronimum Marchionem.<br />
XXIII.<br />
Il gran calculator dell’alfabecco,<br />
che volea scorrer tutto il mare magno<br />
con la sua nave, è sommerso <strong>in</strong> un stagno,<br />
ch’ha le sue rive e tutto il fondo secco.<br />
Ma cusì va: chi è una semplic’Ecco, 5<br />
e fa gran tele essendo tristo aragno,<br />
ch’<strong>in</strong>f<strong>in</strong> li perde l’onor ed il guadagno;<br />
Dio mel perdona, se <strong>in</strong> sta parte io pecco.<br />
Ch’io parlo, per dir ver, d’un ladroncello,<br />
ch’essendo sue virtù ben tutte <strong>in</strong>tese, 10<br />
sarian vizi nefandi <strong>in</strong> un bordello.<br />
Questo è il nostro Gioan Gironimo Marchese,<br />
qual volendo stracciar l’altrui mantello<br />
n’ha perso uno novo, ed a tutte le sue spese.<br />
Per sue arroganti imprese, 15<br />
sarà presto il suo cul quel de la simia,<br />
e faccia pur, se il scia, ben far di scrimia.<br />
CF:<br />
1. calcolator 7. <strong>in</strong>f<strong>in</strong> vi perde 8. perdoni 9. a dire il ver 12. Gli è … Gian Gerolamo<br />
14 a sue spese 16. d’una scimia<br />
[Il grande calcolatore dell’alfabeto, che voleva percorrere tutto il mare magno<br />
con la sua nave, è annegato <strong>in</strong> uno stagno che ha le rive e il fondo asciutti./ Ma<br />
capita così a chi è una semplice Eco e tesse grandi trame essendo un semplice ragnetto<br />
e <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e perde l’onore e il guadagno. Dio mi perdoni se <strong>in</strong> ciò io pecco./<br />
Perché io parlo, a dire il vero, di un ladroncello che le sue virtù fossero elencate<br />
tutte, sarebbero considerate vizi nefandi pers<strong>in</strong>o <strong>in</strong> un bordello./ Egli è il nostro<br />
Gian Girolamo Marchese, che volendo rubare il mantello altrui, ne ha perso uno<br />
nuovo e a sue spese./ Per le sue arroganti imprese, il suo culo somiglierà presto a<br />
quello di una scimmia e allora che faccia pure, se ne è capace, far di scherma].<br />
55
56 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
Note<br />
**************<br />
I.<br />
Il metro dei componimenti è quello tipico dei sonetti caudati (<strong>in</strong> cauda venenum!)<br />
con coda composta da settenari e distico di endecasillabi eventualmente iterabile, forma<br />
consacrata dal Burchiello. Il numero di versi varia da 17 a 20, massimo 23; tutti i componimenti<br />
presentano lo stesso schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD DEE.<br />
Il sonetto d’esordio, per quanto sferzante, è tra i più contenuti e meno mordaci della<br />
collana.<br />
Il locutore si rivolge direttamente all’Ariosto, apostrofandolo sarcasticamente come<br />
Giudice de’ Matti. Gli fa notare come, attraverso le sue ruberie (di cui ormai parlano tutti),<br />
perpetrate sfruttando la sua carica politica, stia <strong>in</strong>grassando sempre più, mentre i ferraresi<br />
patiscono la miseria. La città è ormai dissanguata dalle cont<strong>in</strong>ue richieste <strong>in</strong> denaro<br />
del Giudice che non si vergogna, ma va perpetrando le sue estorsioni come un serpente<br />
velenoso, aggressivo e crudele, come un lupo predatore. Egli si mostra clemente solo<br />
con chi gli offre di più, ma se non cambierà stile e modo di fare, lo ammonisce il Poeta,<br />
il popolo gli griderà “A morte!” (come fecero i siciliani <strong>contro</strong> gli oppressori francesi a<br />
Palermo) e lo esorta a ravvedersi.<br />
Nell’<strong>in</strong>testazione di molti sonetti del Pistoia si legge, come qui, Data.<br />
1. Ser Nicolò: si noti il crescendo: <strong>in</strong>izialmente l’Autore usa per l’Ariosto il titolo di<br />
sere, che nella forma apocopata <strong>in</strong>dica deferenza; nel son. III della collana lo chiama, più<br />
confidenzialmente, Nicolò mio (v. 2); e nel son. VI, precisa: io ti chiamai ser Nicolò/ non<br />
avendo di te ben conoscenza/ or ti darò della magnificenza.<br />
Per le parole <strong>in</strong> rima poco, loco, gioco, foco cfr. Pistoia, <strong>Sonetti</strong>, 12 e il primo dei sonetti<br />
<strong>contro</strong> il Cosmico.<br />
ferrarese sangue: ‘sangue dei ferraresi’.<br />
4. langue: < LANGUESCERE, LANGUERE, ‘svenire’, ‘mancar di forze’, ‘perdere il vigore’,<br />
‘divenire afflitto’ (Voc. Crusca).<br />
7. giungendo sempre legna sopra il foco: locuzione dal lat. ignem igni <strong>in</strong>ducere.<br />
8. angue: < ANGUIS, ‘serpente’.<br />
10. <strong>in</strong>iquo: < INIQUUS, ‘<strong>in</strong>giusto’.<br />
12. offerisce: ‘offre’, ‘paga’.<br />
13. vespro siciliano: «diciamo <strong>in</strong> proverbio Cantare il vespro a uno, fargli una gagliarda<br />
riprensione, o dirgli liberamente l’animo suo» (Voc. Crusca), ma qui l’Autore si<br />
riferisce alla nota sommossa popolare, che fu <strong>in</strong>iziata a Palermo il 30 marzo 1282, al grido<br />
di «Mora, mora!», lanciato da una donna <strong>contro</strong> gli odiati oppressori francesi.
I Testi<br />
II.<br />
Questo sonetto, il primo della collana <strong>in</strong> cui l’Ariosto viene apostrofato con l’appellativo<br />
di Magnaferro, è <strong>in</strong> stretta relazione con il son. 156 del codice Ambrosiano H 223<br />
<strong>in</strong>f., contenente la maggiore silloge delle rime del Pistoia, di cui si è già parlato nell’Introduzione.<br />
Nei vv. 7-8 l’Autore ricorda che l’Ariosto ha acquistato un ricco podere, con<br />
annessa villa, a spese del comune: si tratta dell’attuale villa Pavanelli. Nella seconda<br />
metà del ’400, esisteva <strong>in</strong> suo luogo uno splendido Castello con un’ampia tenuta, che fu<br />
venduto nel 1475 alla famiglia Trotti. I fratelli Ariosto, Nicolò e Francesco, riuscirono ad<br />
entrarne <strong>in</strong> possesso dopo la cacciata dei Trotti da <strong>Ferrara</strong> nel 1482, a spese del comune<br />
di <strong>Ferrara</strong>, come appunto precisa il sonetto. L’Autore augura poi all’Ariosto che, per le<br />
sue malefatte, possa f<strong>in</strong>ire nelle mani del boia (v. 16), che lo impiccherà per la modica<br />
somma di un soldo. Nel frattempo, si prepara un beroldo, vale a dire un <strong>in</strong>saccato di sangu<strong>in</strong>accio<br />
a forma di pagnotta, per fargli un bel cappello, aff<strong>in</strong>ché il sole non gli faccia<br />
essiccare il cervello.<br />
3. sabbione: ‘terra arenosa’, Cfr. Pistoia, <strong>Sonetti</strong>, 34, v. 14: «che sia stracco a sedere<br />
<strong>in</strong> sul sabbione»; e Villani 7. 29. 3: «E non sofferse il Re, che fossono seppelliti <strong>in</strong> luogo<br />
sacro, ma <strong>in</strong> sul sabbion del mercato». Si noti che all’epoca, a <strong>Ferrara</strong>, un’<strong>in</strong>tera zona era<br />
detta “dei sabbioni” per essere stata “spianata de sablone”, come ricorda Ricobaldo, il<br />
più antico storico di <strong>Ferrara</strong>, e segnava il limite nord della città, la quale a sud f<strong>in</strong>iva sulla<br />
riva del Po.<br />
7. possessione: < POSSESSIO, ‘villa e poderi che si posseggono’. Cfr. Decameron VIII<br />
2: «Di grandissime posessioni, e di danari, di gran lunga trapassava la ricchezza d’ogni<br />
altro ricchissimo Cittad<strong>in</strong>o».<br />
11. bretta: forma s<strong>in</strong>copata dialettale per ‘berretta’, cfr. Pistoia, <strong>Sonetti</strong>, 12, 299, 313.<br />
16. manegoldo: cfr. Pistoia, <strong>Sonetti</strong>, 158, <strong>in</strong> rima con soldo e beroldo.<br />
18. broldo: ‘beroldo’ o ‘biroldo’, voce dialettale pistoiese per ‘sangu<strong>in</strong>accio’. Derivante,<br />
forse per metatesi dal lat. BIRÒTULUS, d’onde birotilo, birotolo, birolto, biroldo,<br />
formato da bi(s) + ròtulus. Il Cappelli 2 , volle correggere il term<strong>in</strong>e con brolo, spiegandolo<br />
con ‘corona di fiori’, ma <strong>in</strong> realtà il verso è molto più truculento. Con beroldo, <strong>in</strong>fatti,<br />
<strong>in</strong> Toscana si <strong>in</strong>tende un <strong>in</strong>saccato di media pezzatura (diametro di 5-7 cm), di forma<br />
tondeggiante e schiacciata, legato alle due estremità, il cui ripieno è amalgamato col sangue<br />
di maiale. Il Pistoia usa il lemma <strong>in</strong> due altri suoi sonetti, <strong>in</strong>clusi nella raccolta del<br />
codice Ambrosiano: il 158 e il 161.<br />
2<br />
57
58 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
III.<br />
Nella f<strong>in</strong>zione letteraria, il Poeta, notando che i suoi due precedenti sonetti non sono<br />
bastati ad ammonire l’Ariosto, aff<strong>in</strong>ché smetta di derubare i poveri ferraresi, si vede costretto<br />
a scriverne un altro, giacché sente gli ebrei lamentarsi di nuovo (v. 4).<br />
Una folta comunità ebraica era confluita, <strong>in</strong>fatti, <strong>in</strong> quegli anni a <strong>Ferrara</strong>, attratta dalla<br />
politica liberale degli estensi. All’epoca, gli ebrei abitavano nel cuore della città medioevale,<br />
nel triangolo tra via Sabbioni, via San Romano e via Gattamarcia ed erano<br />
molti tra costoro quelli che esercitavano il mestiere di banchiere: i loro banchi erano sede<br />
di operazioni di cambio e di prestito e per svolgere quest’attività pagavano una tassa<br />
alla Camera Ducale, che variava a seconda del volume degli affari. Evidentemente l’Ariosto<br />
trasse illeciti guadagni da questa tassa.<br />
Il Poeta, cont<strong>in</strong>ua, poi, a deridere il Giudice dicendogli che il suo accanimento <strong>contro</strong><br />
gli ebrei è certamente frutto della sua pietà cristiana (nel mondo cristiano, il marchio<br />
d’<strong>in</strong>famia che accompagnava gli ebrei era l’accusa di deicidio); ma gli chiede cosa mai<br />
abbiano fatto di male <strong>contro</strong> Dio i poveri contad<strong>in</strong>i del ferrarese, ridotti ormai agli stenti<br />
a causa della sua avidità. Ancora una volta il Poeta, con una tenacia degna d’un Savonarola,<br />
esorta l’Ariosto a pentirsi e ravvedersi: già da ogni canto, <strong>in</strong>fatti, gli si grida dietro:<br />
“Al ladro, al manigoldo, al malfattore!”.<br />
1. due sonetti miei: sono i due precedenti sonetti della corona.<br />
8. pietoso: ironicamente, nel senso di ‘pio’, ‘buon cristiano’.<br />
18. bramo il tuo onore: cfr. sonetto IV, v. 8.<br />
20. sei dip<strong>in</strong>to per ciascun bordello: cfr. Pistoia, <strong>Sonetti</strong>, 137, v. 17: «miracol da dip<strong>in</strong>gerlo<br />
<strong>in</strong> bordello». L’abitud<strong>in</strong>e di dip<strong>in</strong>gere scene di naturali mostruosità nei bordelli<br />
è antichissima, basti pensare agli affreschi ritrovati nelle case di piacere a Pompei o <strong>in</strong><br />
quelli <strong>in</strong> prossimità dello stadio Domiziano a Roma.
I Testi<br />
IV.<br />
Il duca fu assente da <strong>Ferrara</strong> dal 5 aprile al 24 giugno del 1487, quando partito per<br />
Santiago de Compostela, fu improvvisamente convocato dal papa e dunque fu costretto a<br />
recarsi a Roma, a conferire col pontefice. In assenza di Ercole I, l’Ariosto prega la duchessa,<br />
aff<strong>in</strong>ché emani un bando, per trovare quel poeta che lo diffama pubblicamente<br />
con tanta veemenza. Il locutore ironizza sull’acrimonia dell’Ariosto nei confronti di questo<br />
anonimo scrittore. Come può mai l’Ariosto, si chiede il Poeta, credere di poter assass<strong>in</strong>are<br />
e quello e questo (v. 9) rimanendo impunito: qui il Poeta si riferisce sì all’abitud<strong>in</strong>e<br />
del Giudice di far morire di stenti coloro che tassava e derubava, ma anche al fatto<br />
che l’Ariosto assass<strong>in</strong>o lo era realmente, avendo partecipato alla congiura <strong>contro</strong> Nicolò<br />
d’Este, aspirante a succedere, nel ducato, a Borso, <strong>in</strong>vece del fratello di questi, Ercole I.<br />
Come può egli, <strong>in</strong>oltre, si chiede ancora, pretendere che i suoi latroc<strong>in</strong>i, esercitati alla luce<br />
del sole, rest<strong>in</strong>o celati? Qualche giorno addietro, cont<strong>in</strong>ua, gli si sono presentati i contad<strong>in</strong>i<br />
di Corbola, per narrargli che l’Ariosto pretendeva da loro ben duecento ducati, ma<br />
fortunatamente la notizia del furto si diffuse rapidamente e così l’<strong>in</strong>tento dell’Ariosto<br />
andò <strong>in</strong> fumo. Eppure la cattiva impresa non fallì perché l’Ariosto si era ricreduto: lui<br />
già aveva sulle spalle l’agnello per portarlo via e divorarlo (v. 19), come fanno «<strong>in</strong> vesta<br />
di pastor lupi rapaci» (Dante, Paradiso XXVII 55). Nuovamente il Poeta lo esorta a pentirsi,<br />
se vuole che egli taccia delle sue malefatte (v. 23).<br />
1. Madama: Eleonora d’Aragona, moglie di Ercole d’Este<br />
crida patente: ‘grida’, disposizione con valore coercitivo, accompagnata cioè da una<br />
sanzione e utilizzata per articolare e adattare la legislazione formale ad un caso particolare.<br />
Per un’idea sulle grida emesse dalla giustizia estense, cfr. Gridario.<br />
13. Corbola: nella laguna Adriana. Il suo nome sembra dim<strong>in</strong>utivo di corbis (corbulla,<br />
corbula, corbicola) – ‘corba’ o ‘cesta’ – che fu misura di grano, ed anche misura di<br />
terra necessaria per sem<strong>in</strong>arvi una corba di grano. Dalla misura corba, poté qu<strong>in</strong>di nom<strong>in</strong>arsi<br />
un dato territorio, sul quale sorgevano villaggi o territori che avrebbero preso il nome<br />
di Corbola. Corbola, allorché si staccò dal territorio adriese (circa nel 1140) fu posta<br />
a far parte del ducato di <strong>Ferrara</strong>.<br />
14. contado: ‘campagna <strong>in</strong>torno alla città, nel quale si contengono i villaggi, e le posessioni’<br />
(Voc. Crusca); per estensione ‘gli abitanti che vivono nel contado’ o ‘contad<strong>in</strong>i’.<br />
Cfr. Sacchetti, Rime, 224 8, pag. 267: «Era Fetonte ne la somma gloria / con carri<br />
carchi di gente lunatica / fra’ nove cieli, dove facean pratica / quelli de la città bisbigliatoria;<br />
/ e vegendo ciascun fuor di memoria, / subito corse a la terra sismatica / e <strong>in</strong>segnò<br />
a’ fanciulli la gramatica, / onde ne fa ’l contado ancor baldoria».<br />
18. mancò: fallì.<br />
59
60 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
V.<br />
Il Poeta ironizza sul recente titolo di conte ottenuto dai fratelli Ariosto direttamente<br />
dall’Imperatore Federico III, il quale, però, non ha assegnato loro alcun feudo. Ci vorrebbe<br />
ben altro, nota il Pistoia, che una corona di sonetti per far sì che l’Ariosto abbandoni<br />
i suoi latroc<strong>in</strong>i; potrebbe servire, <strong>in</strong>vece, un bel tronco da c<strong>in</strong>quanta libbre sulla testa<br />
dell’avido <strong>giudice</strong>, o un duro laccio che lo strangoli. Nell’Ariosto non v’è traccia alcuna<br />
di vergogna per le proprie malefatte, egli si lancia anzi alla rap<strong>in</strong>a col becco da cicogna<br />
(v. 11). Né si ferma d<strong>in</strong>nanzi a persone nobili o colte (v. 12), ma ruba tutto, pers<strong>in</strong>o<br />
la rogna al popolo al quale, per curarsi, non è sufficiente unguento o medic<strong>in</strong>a. E per<br />
la rov<strong>in</strong>a ancora maggiore dei ferraresi, egli alleva un giovane di mal affare, che ne raccolga<br />
l’eredità, per perpetrare i suoi furti. Ma presto, lo ammonisce il Poeta, l’Ariosto<br />
andrà <strong>in</strong> malora, <strong>in</strong>sieme col suo segretario Gian Girolamo Marchese e tutti e due andranno<br />
<strong>in</strong> giro a chiedere l’elemos<strong>in</strong>a.<br />
Rubrica. gnic gnac: voce onomatopeica che sta qui a <strong>in</strong>dicare che la contea mancava<br />
e si riduceva solo a un vano titolo.<br />
3. ge vorria: ‘ci vorrebbe’, particolarmente sp<strong>in</strong>ta nel pistoiese risulta la sonorizzazione<br />
della velare <strong>in</strong>iziale. Cfr. G. BERTONI, Italia dialettale, Milano, repr<strong>in</strong>t Hoepli,<br />
1986, p. 129.<br />
13. gratti sì la rogna: cfr. Pistoia, <strong>Sonetti</strong>, 152, vv. 7-8.<br />
14. <strong>in</strong>guento: esempio di traccia ligure nei dialetti altorenani, nel bolognese e nel vernacolo<br />
pistoiese.<br />
16. ghiottoncello: dim. di ‘ghiotto’, per ‘uomo di male affare’. Decameron VIII 5:<br />
«Messer non gli credete, ch’egli è un ghiottoncello».<br />
18. al gran bordello: ‘<strong>in</strong> malora’.<br />
19: Jeronimo Marchese: figlio del ferrarese Gian Ludovico Marchese, tesoriere e segretario<br />
personale dell’Ariosto.<br />
20. spese: al plurale nel senso di ‘alimenti’, ‘cibo’: cfr. Decameron IX 4: «E senza alcun<br />
salario sopra le spese».
I Testi<br />
VI.<br />
All’<strong>in</strong>izio, afferma il Pistoia, ha chiamato rispettosamente il Giudice de’ <strong>Savi</strong> ser Nicolò,<br />
non conoscendolo bene, adesso gli darà mordacemente della Magnificenza (nelle<br />
cronache ferraresi il Giudice de’ <strong>Savi</strong> è sempre detto ‘Magnifico’), giacché ne conosce lo<br />
stato e la condizione (di gran ladro). Aggiunge che se l’Ariosto gli farà l’onore di avvisarlo<br />
quando sta per uscire di casa, egli si accoderà alla schiera della sua corte e sarà disposto<br />
ad ossequiarlo togliendosi non solo il berretto al suo passaggio, ma anche le braghe,<br />
giacché il Giudice pare gradire il fetore (<strong>in</strong>teso come lezzo di traffici illeciti). Presto,<br />
lo ammonisce il Poeta, si andrà a Gioetta (v. 15), luogo di festa e svaghi, perciò sarà<br />
bene che l’Ariosto raff<strong>in</strong>i il suo gioco.<br />
3. magnificenza: «Magnificenza si è una virtù, che s’ adopera nelle ricchezze, e solamente<br />
nelle grandi spese» (Voc. Crusca). Poco più avanti, <strong>in</strong>fatti, gli darà del Magnifico<br />
(Sonetto XVII).<br />
10. setta: ‘schiera’.<br />
12. bretta: cfr. Sonetto II, v. 11.<br />
14. Zoetta: vale per ‘Zueca’ ovvero ‘Giovecca’. Il nome fa la sua apparizione <strong>in</strong> un<br />
documento ferrarese del 1401, <strong>in</strong> cui si accenna a certo Ioannes T<strong>in</strong>tus pelachanus (conciatore<br />
di pelli), de Zueca. Ed appare pure nel 1438 <strong>in</strong> una bolla di Papa Eugenio IV <strong>in</strong><br />
cui si accenna ad una “Zudecha Turres<strong>in</strong>oru”. A <strong>Ferrara</strong> la denom<strong>in</strong>azione di Zueca o<br />
Zudecha <strong>in</strong>dicava una località posta nei pressi dell’attuale Giovecca nel suo ultimo tratto<br />
verso Levante. Luigi Napoleone Cittadella, che toccò tutti i tasti della storia ferrarese,<br />
nel suo Notizie relative a <strong>Ferrara</strong>, edito nel 1564, ipotizzò che Giovecca potesse derivare<br />
dalla parola provenzale “Iuec” gioco, <strong>in</strong>dicante un luogo adibito a giuochi, a divertimenti,<br />
ad assembramenti festaioli e che non avesse nulla a che vedere con “Zudeca”,<br />
cioè Giudecca, che a <strong>Ferrara</strong>, come <strong>in</strong> altre città (si pensi a Venezia), <strong>in</strong>dicava il luogo<br />
degli ebrei. Il lemma, <strong>in</strong>fatti, <strong>in</strong> questo sonetto, sta senz’altro per ‘luogo adibito a giochi’<br />
(cfr. v. 17).<br />
61
62 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
VII.<br />
Da questo sonetto si comprende più che dagli altri quanto l’opposizione nei confronti<br />
dell’Ariosto, nel giugno del 1487, fosse ormai giunta all’apice: traspare <strong>in</strong>fatti una fronda<br />
violenta che non si trattiene dall’istigare la popolazione ferrarese all’<strong>in</strong>surrezione.<br />
Che non si tratti di vana retorica e di semplice poesia burlesca, ma di una mossa politicamente<br />
responsabile lo provano le rivolte popolari di Massafiscaglia (dove nel luglio del<br />
1488 venne ucciso a furor di popolo il podestà) e di Argenta (dove l’anno successivo, il<br />
26 ottobre 1489, venne assass<strong>in</strong>ato crudelmente Apollonio M<strong>in</strong>otto, camerlengo ducale).<br />
Rubrica: come accennato nell’Introduzione, il Giudice de’ <strong>Savi</strong> era def<strong>in</strong>ito, negli<br />
Statuti di <strong>Ferrara</strong>, pater moderatorque patriae.<br />
9. clamate: < EXCLAMARE, ‘chiamare a gran voce’, ‘gridare’.<br />
15. ca’: ‘casa’ <strong>in</strong> vari dialetti dell’alto Reno e della Toscana (oltre che <strong>in</strong> lombardo);<br />
cfr. Dizionario Toponomastico del Comune di Sambuca Pistoiese, Società Pistoiese di<br />
Storia Patria, Pistoia, 1993 e G. GIACOMELLI, Vocabolario Pistoiese, Società Pistoiese di<br />
Storia Patria, Pistoia, 2000.<br />
16. strasc<strong>in</strong>ato: ‘Tirare una cosa per terra, senza sollevarla’ (Vocabolario degli Accademici<br />
della Crusca). Cfr. Villani 7 113 1. «Il fece strasc<strong>in</strong>ar per la terra, e poi impiccar<br />
per la gola».
I Testi<br />
VIII.<br />
Sonetto di altro poeta, probabilmente il ferrarese Lelio Manfredi, il quale afferma di<br />
avere un libro pieno di appunti (v. 7) su tutti i furti e le malefatte dell’Ariosto. Questo<br />
poeta anonimo, sostiene che il Pistoia non ha detto, nei suoi sonetti (messo non v’hai, v.<br />
9), che il Giudice fa comprare ai fornai il frumento marcio a 30 bologn<strong>in</strong>i, per cui ne soffrono<br />
i cittad<strong>in</strong>i. Effettivamente, nelle cronache ferraresi, l’<strong>in</strong>verno del 1487 è ricordato<br />
come uno dei più rigidi, tanto che nel febbraio di quell’anno la popolazione prese d’assalto<br />
parecchi magazz<strong>in</strong>i per rubare le provviste. In marzo il frumento era cresciuto di<br />
prezzo <strong>in</strong> maniera spropositata. Aggiunge ancora il Poeta che quando l’Ariosto va nelle<br />
sue possessioni, ai Masi (v. 12) pretende <strong>in</strong> omaggio dai suoi contad<strong>in</strong>i ogni ben di Dio.<br />
Questo secondo poeta anonimo si dice <strong>in</strong>teressato a conoscere l’identità del Detrattore<br />
dell’Ariosto e afferma di essere pronto a unire le proprie forze poetiche alle sue, dandogli<br />
<strong>in</strong>f<strong>in</strong>e appuntamenento sulla piazza pr<strong>in</strong>cipale per l’<strong>in</strong>domani.<br />
9. bologn<strong>in</strong>i: altro nome per ‘soldo’, che si divideva <strong>in</strong> dodici denari. Era la moneta<br />
più <strong>in</strong> uso <strong>in</strong> Emilia e a <strong>Ferrara</strong>, specie il Grosso bologn<strong>in</strong>o, con la dicitura «Bonona mater<br />
studiorum», coniato nel XIV, che ebbe grande fortuna e fu imitato da quasi tutte le<br />
più importanti zecche italiane.<br />
10. torre: sta per ‘torre <strong>in</strong> compera’, ‘comprare’.<br />
12. Masi: si trovavano nel distretto di <strong>Ferrara</strong>, vic<strong>in</strong>o a Portomaggiore. Queste terre,<br />
per la loro fertilità, oltre che di molti monasteri ferraresi, erano proprietà di importanti<br />
famiglie ferraresi, come appunto quelle degli Ariosto che possedevano i fondi denom<strong>in</strong>ati<br />
“Teste del Vescovo” e “Trebbo”.<br />
14. improvviso: ‘<strong>in</strong>aspettatamente’.<br />
63
64 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
Risposta del Pistoia al sonetto precedente; qui egli afferma di amare l’autore di quel<br />
componimento come un fratello e di ammirarlo per la sua <strong>in</strong>telligenza e per il suo <strong>in</strong>gegno<br />
poetico (vv. 5-6), ma di non poter rivelare apertamente la propria identità. Si dice<br />
però <strong>in</strong>teressato a vedere quel gran libello (v. 8), ovvero il libro pienissimo di annotazioni<br />
sulle malefatte dell’Ariosto, cui l’autore del sonetto VIII allude al v. 7. Afferma <strong>in</strong>oltre<br />
di voler far stampare e vendere <strong>in</strong> piazza (v. 14) un suo lunghissimo bischizzo, <strong>in</strong> cui<br />
svergogna il Giudice de’ <strong>Savi</strong>; chiede <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e all’amico poeta, di prendere la penna <strong>in</strong> mano,<br />
per aiutarlo a far conoscere a tutti le malefatte di tal mostro (v. 17).<br />
1. Oh tu: <strong>in</strong>cipit, con <strong>in</strong>teriezione, identico a quello del sonetto precedente, di cui<br />
questo è la risposta.<br />
IX.<br />
6. Calliopè: Musa della poesia epica e dell’eloquenza.<br />
9. bischizzo: dal Ted. beschiss ‘frode’, per analogia con ‘schizzo’ è nato questo term<strong>in</strong>e,<br />
che sta per ‘componimento satirico’ ed è usato, tra l’altro, anche dal Caleff<strong>in</strong>i per designare<br />
proprio i sonetti diffamatori <strong>contro</strong> l’Ariosto, <strong>in</strong>collati sulla pubblica piazza a<br />
<strong>Ferrara</strong> tra il 9 e il 15 giugno 1487.
I Testi<br />
X.<br />
Il Pistoia, palad<strong>in</strong>o dei poveri villani taglieggiati dall’Ariosto, racconta di come un<br />
contad<strong>in</strong>o, Stefano Furlan, il quale aveva voluto divenire cittad<strong>in</strong>o ferrarese, era stato derubato<br />
del proprio podere dal Giudice, che gli aveva sottratto la terra con un atto notarile.<br />
Dà <strong>in</strong>oltre all’Ariosto dello sberrettiero, vale a dire del ruffiano: il Giudice va dicendo <strong>in</strong><br />
giro che, quando il Duca rientrerà a <strong>Ferrara</strong>, egli si lamenterà con lui di tutti coloro che<br />
lo hanno pubblicamente <strong>in</strong>famato. Dai versi 14-16 pare di capire che i poeti, autori delle<br />
rime di scherno affisse un po’ ovunque a <strong>Ferrara</strong> <strong>in</strong> quei giorni di giugno, siano personaggi<br />
della corte estense. Ma il Pistoia ammonisce il Giudice, ricordandogli che sarà meglio<br />
che egli taccia col duca, se non vuole essere impiccato per i suoi furti.<br />
Rubrica: sberrettiero: ‘colui che si sberretta’, ‘adulatore’.<br />
6. farmi cittad<strong>in</strong>o: chiedere alle autorità di potersi trasferire dalla campagna nel centro<br />
urbano: grazie alla felice collocazione geografica, <strong>Ferrara</strong> era decisamente la città più<br />
popolosa del dom<strong>in</strong>io estense, e con i suoi circa 35.000 abitanti poteva annoverarsi fra le<br />
prime metropoli italiane per numero di abitanti.<br />
8. arrogato: ‘rogato’; «term<strong>in</strong>e legale, e dicesi del distendere, e sottoscrivere, che<br />
fanno i notai de’ contratti, come persone pubbliche, per l’autorità conceduta loro» (Vocabolario<br />
degli Accademici della Crusca). È tipico del pistoiese lo sviluppo di vocali anaptittiche:<br />
sotto <strong>in</strong>flussi provenienti dal nord la vocale di appoggio ‘a’ si è <strong>in</strong>trodotta anche<br />
nelle zone settentrionali della Toscana come nel lucchese e pistoiese “arricordare”, “arriposare”,<br />
“arrispondere” (Cfr. G. ROHLFS, Grammatica storica della L<strong>in</strong>gua Italiana e<br />
dei Suoi dialetti, pp. 472-473).<br />
65
66 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
XI.<br />
Anche questo sonetto pare, stilisticamente, dello stesso autore dell’ottavo della collana:<br />
costui chiama <strong>in</strong>fatti <strong>Ferrara</strong> “misera patria” e nota che non basterebbero i più grandi<br />
autori lat<strong>in</strong>i come Marco Anneo Lucano, Persio Flacco, oppure Ovidio a scrivere delle<br />
malefatte dell’Ariosto, il quale è spelonca di rap<strong>in</strong>e (v. 7), vuoto d’ogni vergogna, ma<br />
pien d’audacia (v. 8). Dal punto di vista l<strong>in</strong>guistico, il sonetto presenta maggiori tratti<br />
settentrionali attribuibili all’Autore (volto <strong>in</strong>vedrià della Rubrica; audazia <strong>in</strong> rima, v. 8).<br />
Rubrica. <strong>in</strong>vedrià: ‘<strong>in</strong>vetriato’, ‘che ha l’aspetto e la consistenza del vetro’, oggi diremmo<br />
‘faccia di bronzo’.<br />
16. vendetta farà: cfr. Pistoia, <strong>Sonetti</strong>, 72, v. 5.
I Testi<br />
XII.<br />
Nella f<strong>in</strong>zione letteraria, è adesso lo stesso Ariosto a discolparsi e a parlare <strong>contro</strong> il<br />
proprio detrattore. Egli giudica la poesia del suo diffamatore troppo ardita e si schermisce<br />
affermando che le maldicenze sul suo conto sono un chiaro segno d’<strong>in</strong>vidia.<br />
Seppure l’anonimo poeta avesse le ali per volare s<strong>in</strong>o <strong>in</strong> India o <strong>in</strong> Catai, l’Ariosto gli<br />
ha teso una trappola per catturarlo e farlo condannare a morte per diffamazione e comunque,<br />
perché appaia che egli non ha nulla da temere, chiede al proprio sbirro, Magagn<strong>in</strong>o,<br />
di diffondere tra la gente questa sua risposta <strong>in</strong> rima.<br />
Rubrica. comm<strong>in</strong>atorio: ‘m<strong>in</strong>atorio’, ‘<strong>in</strong>timidatorio’.<br />
per: come il fr. par, ‘da’.<br />
8. con l’ornata eloquenza: più volte <strong>in</strong> questa corona all’Ariosto è riconosciuto il<br />
pregio di saper di parlare <strong>in</strong> maniera forbita e lat<strong>in</strong>ar per i passivi, per raggirare le proprie<br />
vittime ignoranti (sonetto XVII), ma qui ad esser circuiti dall’arte retorica del Giudice<br />
saranno le Sue Eccellenze, il duca e la duchessa.<br />
14. ragna: ‘rete, con la quale si catturavano gli uccelli’, per estens. ‘agguato’, ‘<strong>in</strong>sidia’;<br />
cfr. Paradiso 9, 51: «Che già, per lui carpir, si fa la ragna».<br />
18. Magagn<strong>in</strong>: Girolamo Magnan<strong>in</strong>o, collaboratore del Giudice de’ <strong>Savi</strong>, con funzioni<br />
di sbirro (come esattore delle tasse). Si conservano alcune sue lettere; cfr. Rettori, Modena,<br />
B. 2d, lettera di Amato Cusatro a Girolamo Magnan<strong>in</strong>o del 15, del 17 e del 21 febbraio,<br />
del 9 marzo, del 19 e 23 aprile 1507.<br />
67
68 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
XIII.<br />
È ancora l’Ariosto a parlare, rivolgendosi, come anticipato nel sonetto precedente, alla<br />
duchessa, per chiederle di divulgare una grida per acciuffare il detrattore, grida <strong>in</strong> cui<br />
egli stesso sia presentato come persona di fiducia e probo al pari di Gaio Fabrizio o di Catone<br />
l’Uticense, perché non sopporta più di essere deriso. Farà sì che il detrattore venga<br />
impiccato e sarà egli stesso a fare il lavoro del boia. Che non si tratta di una banale <strong>in</strong>timidazione,<br />
è confermato dal Diario ferrarese 3 , che, nel maggio del 1495, riporta questa<br />
agghiacciante notizia: «A dì quattro de Magio, de luni, fu condennato per messer Gregoro<br />
Zampante, capitaneo de iustitia <strong>in</strong> <strong>Ferrara</strong>, Francesco, fiolo de Bernard<strong>in</strong>o de Philippo<br />
Cestarello da <strong>Ferrara</strong>, ad essere taiata la testa, per cagione che confessò havere scritti certi<br />
bullett<strong>in</strong>i <strong>in</strong> vilipendio del duca, del Judice de’ <strong>Savi</strong>i da <strong>Ferrara</strong> et di altri officiali; la<br />
quale testa pagando mille ducati se potesse scuotere». Il povero giovane poeta condannato<br />
a morte per aver reiterato la tradizione di scrivere bullett<strong>in</strong>i di scherno nei confronti di<br />
personaggi pubblici, era Francesco Cestarelli, nipote del mercante e abile amm<strong>in</strong>istratore<br />
estense Filippo Cestarelli, casso, alla pari dell’Ariosto, dal duca Ercole I, dalla carica di<br />
Giudice de’ <strong>Savi</strong> il primo gennaio del 1495 e sostituito dal conte Uberto del Sacrato, <strong>contro</strong><br />
il quale Francesco scrisse i sonetti diffamatori che lo portarono alla morte. Nessuno rimaneva<br />
a lungo nell’ufficio di Giudice dei dodici <strong>Savi</strong> o perché chi n’era <strong>in</strong>vestito diveniva<br />
presto impopolare per l’eccessiva fiscalità cui lo costr<strong>in</strong>gevano i bisogni del duca o perché<br />
effettivamente non riusciva a rispondere alle cont<strong>in</strong>ue richieste di denaro di Ercole I.<br />
3. nuovo pesce: ‘<strong>in</strong>genuo’, «che agevolmente lasci <strong>in</strong>gannarsi, tratta la metafora dal<br />
pesce, che noi chiamiamo avanotto, quasi uguannotto, cioè nati dell’anno, ch’e’ si pigliano,<br />
che sono pesciol<strong>in</strong>i, e agevoli a esser presi» (Voc. Crusca).<br />
4. palmon: ‘trappola’. «Queste verghe piccole impaniate si ficch<strong>in</strong>o lievemente nelle<br />
verghe de’ palmoni, che son pertiche grandi di rami d’arbori verdi, massimamente di<br />
quercia, aventi nel capo superiore, quattro, o c<strong>in</strong>que verghe un poco elevate, nelle quali si<br />
ficcano le verghe sottilissime impaniate. E quando quel palmone sarà, ec. gli uccelli si<br />
pongono sopra ’l detto palmone impaniato» (Voc. Crusca).<br />
12. Fabrizio: Dionisio di Alicarnasso racconta che durante la guerra tra Roma e Taranto,<br />
i Romani <strong>in</strong>viarono un’ambasceria a Pirro, re dell’Epiro e alleato dei Tarant<strong>in</strong>i, per<br />
riscattare i prigionieri romani. Faceva parte della legazione il console Gaio Fabrizio Lusc<strong>in</strong>o<br />
che Pirro cercò di corrompere perché persuadesse il Senato alla pace. Ma Fabrizio<br />
rispose che, anche se era povero, possedeva come tutti i cittad<strong>in</strong>i romani il bene massimo:<br />
la libertà; se si fosse venduto a Pirro non sarebbe stato che lo schiavo di un tiranno.<br />
Ammirato dalla nobiltà d’animo del console, il re dell’Epiro liberò tutti i prigionieri senza<br />
riscatto. Da quella volta Fabrizio divenne simbolo di onestà e <strong>in</strong>tegrità morale.<br />
l’Uticense Cato: Catone l’Uticense, simbolo per antonomasia di probità e rettitud<strong>in</strong>e,<br />
fu uomo di profonda cultura, molto severo nei costumi e nemico di ogni azione disonesta.<br />
3 Cit., p. 150.
I Testi<br />
XIV.<br />
Il 24 giugno del 1487 Ercole I rientrò da Roma a <strong>Ferrara</strong>, passando per porta San<br />
Giorgio, accolto con grandi festeggiamenti dalla popolazione. In questo sonetto l’Ariosto<br />
è presentato tra i cortigiani che gli diedero il benvenuto; il Giudice, con fare lezioso da<br />
vero sberrettiero, racconta al duca di un ghiotto (v. 9), il quale, <strong>in</strong>citato da molti, scrive<br />
sonetti di scherno <strong>contro</strong> di lui.<br />
9. ghiotto: ‘uomo di mal affare’, cfr. il ghiottoncello del sonetto VI, v. 16.<br />
10. rasenza: propriamente ‘rade’.<br />
11. fornito e cotto: imbandito per vivanda aff<strong>in</strong>ché ognuno se ne sazi a piacere.<br />
13. più a destro: ‘più comodamente’, ‘da solo a solo’.<br />
grotto: ‘gretto’, ‘mesch<strong>in</strong>o’.<br />
16. caleffan: ‘si burlano di me’, cfr. Sacchetti, Trecentonovelle, 213, pag. 553.37:<br />
«Dice Cecco: - In fé di Dio, e’ mi pare strano che ciò possa essere, io credea che tu caleffassi.<br />
- Dice Giann<strong>in</strong>o: - Io non ho da caleffare, ché mi pare mill’anni che io sappia da<br />
qualche medico se ’l colpo è cassale o no».<br />
69
70 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
XV.<br />
La risposta data dal duca a Niccolò è degna d’un gran signore. Ercole manifesta la<br />
propria stima per il conte e ammette che gli r<strong>in</strong>cresce molto sapere che il Giudice è stato<br />
messo alla berl<strong>in</strong>a, lo <strong>in</strong>vita anche ad essere magnanimo e a perdonare chi lo deride, ma<br />
contemporaneamente lo mette <strong>in</strong> guardia, suggerendogli di coprirsi il capo, poiché tira<br />
vento (v. 10; vale a dire Niccolò è m<strong>in</strong>acciato) e sarebbe corrotto dal freddo (v. 11; ovvero<br />
dalle freddure di coloro che lo caleffano volentieri).<br />
Rubrica. Umana: ‘benigna’<br />
4. compiuto: «per dotato d’ogni eccellenza di costumi, e di virtù». (Voc. Crusca). Cfr.<br />
Decameron II 9: «Se, di spezial grazia da Dio avere una donna per moglie, la più compiuta<br />
di tutte quelle virtù».<br />
13. scotto: ‘prezzo da pagare all’osteria o alla locanda’ (dal franco skot, ‘tassa’), fig.<br />
‘<strong>contro</strong>partita’, ‘pagare il fio’; qui sta più <strong>in</strong> generale per ‘perdonare’.<br />
15. Gli è: «Talora par, che gli abbia forza di neutro, ed <strong>in</strong> un certo modo è particella<br />
riempitiva, proprietà di questo l<strong>in</strong>guaggio». (Voc. Crusca).
I Testi<br />
XVI.<br />
Il poeta ricorda all’Ariosto che, sebbene il Signore sia rientrato a <strong>Ferrara</strong> (v. 2), egli<br />
non ha paura di cont<strong>in</strong>uare a denunciare pubblicamente i suoi furti: come quello perpetrato<br />
ai danni del povero Giovanni Stoppa, che aveva riparato i ponti così tante volte, e<br />
avanzava dal Comune ottanta ducati, ma quando poi volle essere pagato, dovette dividere<br />
il suo <strong>in</strong>troito con l’Ariosto (v. 14). Ancora una volta il Pistoia augura al Giudice di f<strong>in</strong>ire<br />
sul patibolo e, poi, all’<strong>in</strong>ferno!<br />
1. stroppa: dal gergo mar<strong>in</strong>aresco sta a <strong>in</strong>dicare un pezzo di corda, piegata ad anello,<br />
con cui si avvolge un oggetto mobile <strong>in</strong> modo da unirlo a un punto fisso senza <strong>in</strong>tralciarne<br />
i movimenti. Starmi <strong>in</strong> stroppa con dir sta qui per ‘trattenermi dal dire’.<br />
4. guatto: ‘quatto’.<br />
8. coppa: «con l’o stretto, la parte di dietro del capo» (Voc. Crusca).<br />
14. dui monti: ‘due cumuli’ (dovette cioè dividere gli ottanta ducati con l’Ariosto).<br />
16. capestro: propriamente il cánapo con cui venivano impiccati i condannati alla<br />
forca.<br />
71
72 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
XVII.<br />
Torna <strong>in</strong> questo sonetto un personaggio già <strong>in</strong>contrato nel decimo della corona: Stefano<br />
Furlano, quel contad<strong>in</strong>o che aveva voluto <strong>in</strong>urbarsi ed era stato truffato dall’Ariosto,<br />
il quale gli aveva rubato il suo terreno (v. 4). Nel componimento viene nuovamente<br />
ricordato il furto e l’Ariosto è apostrofato come Magnaterra. Questa ripetizione che<br />
avrebbe poco senso nell’economia della raccolta, sp<strong>in</strong>ge a credere che il sonetto (cronologicamente<br />
posteriore al decimo) sia stato scritto e affisso <strong>in</strong> qualche pubblico luogo,<br />
dopo il ritorno del duca a <strong>Ferrara</strong>, aff<strong>in</strong>ché ad Ercole I giungesse notizia delle appropriazioni<br />
<strong>in</strong>debite del Giudice dei <strong>Savi</strong>.<br />
10. di roba più ch’esperto d’addiettivi: ricco di roba, ma ignorante e dunque facile<br />
preda di chi sa usare i superlativi (v. 12).<br />
14. com<strong>in</strong>ciò a lat<strong>in</strong>ar per i passivi: ‘parlare difficile’, ma qui ironicamente anche<br />
‘mandar <strong>in</strong> rov<strong>in</strong>a (<strong>in</strong> passivo) l’attivo del Furlan’, facendo scrivere al notaio un pubblico<br />
strumento (v. 16) sull’accordo con il manzo (lo stolto contad<strong>in</strong>o).<br />
17. manzo: ‘sciocco’.
I Testi<br />
XVIII.<br />
Sonetto sul genere dei dialoghi dialettali e delle Scene contad<strong>in</strong>esche dei <strong>Sonetti</strong> ferraresi<br />
del Quattrocento (per cui cfr. Introduzione). Vi sono rappresentati un contad<strong>in</strong>o,<br />
l’Ariosto e i due sbirri Magagn<strong>in</strong>o e Squarzone, i quali derubano un villano di un agnello.<br />
Rubrica. pelador… salvadegi: così apostrofato perché strappa via pers<strong>in</strong>o la pelle<br />
(deruba) ai gatti selvatici (i poveri contad<strong>in</strong>i). Si noti, dal punto di vista l<strong>in</strong>guistico, che<br />
nella quasi totalità della prov<strong>in</strong>cia di Pistoia il fenomeno dell’aspirazione consonantica è<br />
limitato alla sola “k”, mentre risulta sconosciuta l’aspirazione di “p” e “t” (cfr. G.<br />
ROHLFS, cit., p. 162), che così si sonorizzano.<br />
5. Bertello: nome convenzionale dei villani anche nei <strong>Sonetti</strong> ferraresi del Quattrocento.<br />
9. lavoriero: impianto da pesca tipico delle valli e degli stagni, costituito da graticci e<br />
pali disposti a formare un angolo con il vertice rivolto al mare, per la cattura dei pesci<br />
durante la migrazione. Il lemma appare anche nelle Scene contad<strong>in</strong>esche, XIV, v. 9.<br />
17. fantes<strong>in</strong>: ‘bamb<strong>in</strong>i’, da ‘piccolo fante’, ‘<strong>in</strong>fante’.<br />
73
74 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
XIX.<br />
Altro dialogo, stavolta tra Niccolò Ariosto e sua moglie, la reggiana Daria Malaguzzi<br />
Valeri, la quale con grande tatto nei confronti dell’amato marito, si lamenta con lui di come<br />
la gente, per strada, sparli di lei, apostrofandola come “moglie del ladro atrocissimo”<br />
(v. 4); ma l’Ariosto, con fare gretto, le consiglia di f<strong>in</strong>gere di non udire le accuse, perché<br />
tanto lui, f<strong>in</strong>ché gliene sarà concessa la possibilità, cont<strong>in</strong>uerà a rubare, dato che “chi è<br />
senza roba, viene considerato pazzo” (v. 9).<br />
Rubrica. mogliere: lat<strong>in</strong>ismo. Il lemma è usato anche <strong>in</strong> Toscana e non solo nei dialetti<br />
del Sud; cfr. Decameron II 8: «Perotto, Giachetto, che è qui, ha tua sorella per mogliere».
I Testi<br />
XX.<br />
Nel manoscritto il sonetto non è rubricato, nonostante ciò, nell’edizione Cappelli-<br />
Ferrari appare preceduto da questa nota: Quando adì 1. gennaio 1489 fu casso il Magnaferro,<br />
ed <strong>in</strong> suo luogo successe lo spettabile Galeazzo Trotti. In realtà, nel codice, alla<br />
carta 187v, <strong>in</strong> calce al sonetto si legge: 1489, adì primo de zanaro la mat<strong>in</strong>a fu casso il<br />
dicto Magnaferro e <strong>in</strong> suo luogo successe il spettabile Galiazzo Trotto.<br />
Per un commento più dettagliato, cfr. Introduzione.<br />
3. cassia: ‘erba cassìa’, ‘senna’ ovvero ‘lassativo’; qui l’ironia è giocata sul term<strong>in</strong>e<br />
‘cassare’, ‘destituire’.<br />
10. condice: < CONDICERE, ‘convenire’.<br />
12. tamburloni: ‘tamburlani’, ‘tamborlani’, cioè ‘arnesi metallici per distillare’ e anche<br />
‘cil<strong>in</strong>dri metallici con coperchi’; qui <strong>in</strong> generale ‘arnesi che fanno fracasso’.<br />
14. poltronzoni: ‘uom<strong>in</strong>i dappoco’, ‘vili’.<br />
15. levi e ventroni: frattaglie d’animali da lanciare, per umiliarlo, <strong>contro</strong> il Giudice<br />
che nel corso del suo ufficio ha rubato e si è riempito il ventre. Levi nel gergo furbesco<br />
sta per ‘cose rubate’, ventroni ‘ventricoli’, qui sta ironicamente per ‘cose di cui l’Ariosto<br />
si è riempito il ventre’.<br />
75
76 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
XXI.<br />
Anche il sonetto seguente, nel codice, appare senza rubrica, ma nell’edizione Cappelli-Ferrari<br />
è preceduto dalla seguente nota: Per la nom<strong>in</strong>a di Niccolò a governatore di<br />
Modena.<br />
7. pastor: il duca.<br />
9. alturio: < ADIUTORIUM, ‘soccorso’, ‘aiuto’.<br />
10. San Gem<strong>in</strong>ian: San Gimignano, vescovo e protettore di Modena.
I Testi<br />
XXII.<br />
Le <strong>in</strong>esattezze della stampa di Cappelli-Ferrari, per questo sonetto, sono talmente numerose<br />
che preferiamo commentarle qui di seguito, piuttosto che riportarne un semplice<br />
elenco <strong>in</strong> calce al componimento che, altrimenti, sarebbe di difficile comprensione se venisse<br />
letto come fecero Cappelli e Ferrari. Il primo verso è ammodernato <strong>in</strong> il fiato mi<br />
vien men, al v. 2 viene corretto ch’io non ho divorà l’orig<strong>in</strong>ale ch’i’ ho non divorà, che<br />
testimonia un tratto assai importante della negazione che accomuna il vernacolo pistoiese<br />
al bolognese. A tale proposito, bisogna notare che la compresenza di una forma ridondante<br />
anche nella parte meridionale dell’Alto Reno e nel pistoiese è di estremo <strong>in</strong>teresse<br />
perché accomuna tutto questo territorio a un’area dell’Europa centrale francofona e germanofona<br />
dove la negazione è sempre del tipo ridondante o postverbale (es: il tedesco<br />
“Morgen muss ich nicht arbeiten”); come è noto la negazione ridondante può semplificarsi<br />
<strong>in</strong> negazione postverbale. Tutto il territorio <strong>in</strong> cui appare la negazione postverbale e<br />
la negazione ridondante appartiene alla cosiddetta “Area Carlo Magno”, ovvero ai territori<br />
del germanico “Sacro Romano Impero”; i territori che presentano la negazione postverbale<br />
e/o la negazione ridondante sono quelli che maggiormente hanno ospitato popolazioni<br />
germaniche. Ancora, Cappelli e Ferrari leggono perduto (v. 3) dove <strong>in</strong>vece il manoscritto<br />
ha padito, che è voce dialettale emiliana per digerito (qui è evidente l’ironia del<br />
poeta, che mette <strong>in</strong> bocca all’Ariosto term<strong>in</strong>i tipici del suo lessico di gran divoratore, tutto<br />
<strong>in</strong>centrato sul mangiare, digerire, <strong>in</strong>gurgitare) e sempre al v. 3 strangualzare per stragualzare.<br />
Cappelli-Ferrari trascrivono ancora s’empirem per s’impirem (v. 8); un <strong>in</strong>comprensibile<br />
dento per dente (v. 9); pieno e ventre per pien e v<strong>in</strong>tre (v. 10); udir ne fa per<br />
adì ne fa (cioè aldire), sluvazzerò per slovezarò (v. 20).<br />
3. stragualzà: voce emiliana per ‘mangiare avidamente’, ‘divorare’. In un testo emiliano<br />
di poco posteriore, il Processo e confessione del squaquarante Carnevael, viene<br />
prescritto di «sbevazare, papare, sgolazare, trachanare, <strong>in</strong>gultire, lecare, stragualzare»<br />
(cfr. G.C. Croce, La solenne e trionfante entrata dello squaquaratissimo et sloffeggiantissimo<br />
Signor Carnevale <strong>in</strong> questa città, Bologna, B. Cochi, s.a., <strong>in</strong> Affanni e canzoni<br />
del padre di Bertoldo, a c. di M. DURSI, Bologna, Alfa ed., 1966, p. 119).<br />
20. slovezarò: ha identico significato di stragualzare (v. 3), cioè ‘<strong>in</strong>gollare con avidità’.<br />
preda arr<strong>in</strong>gadora: <strong>in</strong> modenese ‘pedra r<strong>in</strong>gadora’, <strong>in</strong> piazza grande; ovvero la pietra<br />
dell’arr<strong>in</strong>go, dove si saliva per parlare <strong>in</strong> pubblico e dove venivano esposti i condannati<br />
alla berl<strong>in</strong>a; cfr. Pistoia, <strong>Sonetti</strong> 77 v. 9. Per lo sviluppo di vocali anaptittiche cfr. nota al<br />
Sonetto X, v. 8.<br />
77
78 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
XXIII.<br />
L’ultimo sonetto della corona è diretto (come ricorda anche Caleff<strong>in</strong>i, nelle sue Croniche)<br />
al ghiottoncello allevato dall’Ariosto: Gian Gerolamo Marchese, segretario del<br />
Giudice de’ <strong>Savi</strong>. Il giovane credeva di poter rubare anch’egli, percorrendo tutto il mare<br />
magno (perpetrando un’<strong>in</strong>f<strong>in</strong>ità di furti), grazie al paterno aiuto del conte Ariosto, ma ora<br />
che il suo protettore è casso e scacciato da <strong>Ferrara</strong>, Gian Gerolamo si trova sommerso <strong>in</strong><br />
uno stagno (v. 3). Per voler rubare il mantello altrui, dice il Poeta, il giovane ladruncolo<br />
ne ha perso uno nuovo (nel senso che avrebbe potuto fare una brillante carriera e <strong>in</strong>vece<br />
si trova <strong>in</strong>famato, a tutte sue spese, v. 14). La velenosa cauda del sonetto è degna d’un<br />
vero poeta satirico quale fu il Pistoia: presto il giovane verrà tanto bastonato per le sue<br />
malefatte che si troverà il deretano rosso come quello d’una scimmia, e allora per difendersi,<br />
faccia pure, se ne è all’altezza, di scherma (cioè, sfidi pure a duello chi lo sta <strong>in</strong>famando<br />
adesso).<br />
2. mare: chiara allusione al mare di roba rubata.<br />
magno: term<strong>in</strong>e furbesco che sott<strong>in</strong>tende il ‘magnare a ufo’.<br />
5. Ecco: Eco, la n<strong>in</strong>fa ridotta a pura voce, qui sta per ‘gregario’.<br />
17. scrimia: dal Ted. schirm, schirmian > poi scrima, scrimia, schermo ed <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e<br />
scherma.
Nota bibliografica<br />
La necessità di focalizzare l’attenzione sul Cammelli nasce dall’<strong>in</strong>spiegabile<br />
carenza di studi critici riguardanti il rimatore toscano. La sua bibliografia, soprattutto<br />
nell’ultimo secolo, è assai scarsa.<br />
Il primo studioso del Pistoia fu, nel 1865, Antonio Cappelli (1817-1887), che<br />
pubblicò la pr<strong>in</strong>ceps dei <strong>Sonetti</strong> giocosi di Antonio da Pistoia, costituita da 20<br />
sonetti provenienti da E, <strong>in</strong> parte da P, cui aggiunse 23 sonetti adespoti <strong>contro</strong><br />
Niccolò Ariosto, tratti da un altro codice estense, siglato W. 2. II.<br />
Ad <strong>in</strong>teressarsi dell’opera del poeta toscano fu poi Ottaviano Targioni-Tozzetti<br />
(1833-1899), il quale, tra il 1869 e il 1883, <strong>in</strong> alcune pubblicazioni “per<br />
nozze”, fece conoscere soprattutto i sonetti politici del codice della Biblioteca<br />
Comunale Ariostea, segnato 408, N., D. 3., cc. 5r-33r; 251v, 273 r, <strong>in</strong>dicatogli<br />
dall’allora bibliotecario della Comunale di <strong>Ferrara</strong>: «tutti notevolissimi e spesso<br />
veramente belli […] massime quelli che si riferiscono al periodo della discesa di<br />
Carlo VIII» 1 .<br />
Risale al 1884 la pubblicazione, a Livorno, delle Rime edite e <strong>in</strong>edite di Antonio<br />
Cammelli detto il Pistoia, a c. di A. Cappelli e S. Ferrari: i componimenti sono<br />
tratti da due codici della Nazionale di Firenze (II. ii. 109 e il Magliab. VII.<br />
25), dal citato codice P, dai due mss. estensi di Modena e dal cod. I 408 della<br />
Comunale di <strong>Ferrara</strong>.<br />
Tra coloro che accolsero con <strong>in</strong>teresse l’edizione di Cappelli e Ferrari vi fu<br />
Rodolfo Renier (1857-1915), che la recensì nella «Rivista storica mantovana» 2 .<br />
Così, sempre nel 1884, Renier notò, nel catalogo dei manoscritti della celebre biblioteca<br />
privata dei Trivulzio di Milano 3 , stilato dal Porro, un codice contenente<br />
la più ampia silloge di rime del Cammelli f<strong>in</strong>o ad allora conosciuta.<br />
1 <strong>Sonetti</strong> politici e burleschi <strong>in</strong>editi di Antonio Cammelli, detto il Pistoia, Livorno,<br />
Vigo, 1869, p. 3; per le altre pubblicazioni dello stesso autore cfr. il cap. Stampe antiche,<br />
qui di seguito. Si tratta di una pubblicazione per nozze, di soli 55 esemplari, preceduta<br />
da un’<strong>in</strong>teressante Avvertenza, <strong>in</strong> cui Targioni Tozzetti accenna alla necessità di una storia<br />
della poesia giocosa e contraddice il «troppo cattivo giudizio che sembra prevalere<br />
<strong>contro</strong> tutti i rimatori burleschi». I diciotto sonetti riprodotti sono ben illustrati da note<br />
storiche, quasi tutte riprodotte <strong>in</strong> seguito da CF, per concessione dell’autore.<br />
2 Del Pistoia, <strong>in</strong> «Rivista Storica Mantovana», I (1885), p. 72 sgg.<br />
3 G. PORRO, Trivulziana. Catalogo dei cod. manoscritti, Tor<strong>in</strong>o, Stamperia Reale Paravia<br />
e Comp., 1884.
80 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
Quattro anni più tardi, nel 1888, fu lo stesso Renier a pubblicare <strong>in</strong>tegralmente<br />
il manoscritto Trivulziano 979 presso Loescher di Tor<strong>in</strong>o, con il titolo I <strong>Sonetti</strong><br />
del Pistoia giusta l’apografo Trivulziano (il lavoro di Renier venne s<strong>in</strong> troppo<br />
severamente criticato dal Pèrcopo: «il testo di quest’edizione, allestito troppo <strong>in</strong><br />
fretta, riuscì assai scorretto e, per questo riguardo può ben formare il paio con<br />
quello non meno errato delle Novelle <strong>in</strong>edite del Sercambi, messe fuori […] dallo<br />
stesso editore») 4 .<br />
Ma l’edizione, per quanto imprecisa <strong>in</strong> più punti e priva di un serio commento,<br />
ebbe il merito di far conoscere il Pistoia anche all’estero; così, nel 1901, Philippe<br />
Monnier (1864-1911), nel volume Le Quattrocento 5 parlò, non senza enfasi,<br />
di un «pauvre domestique, Antonio Cammelli, relégué avec les estafiers et les<br />
esclaves à l’office, où il mange sur une nappe trouée du pa<strong>in</strong> qui a des poils et de<br />
la vache qui semble du cuir […]. Seul le Pistoia, qui imite Burchiello, le ferait il<br />
oublier et annoncerait il le Berni» 6 . Lo studioso olandese Willem Bijvanck<br />
(1895-1921), tracciò un profilo piuttosto bizzarro del poeta <strong>in</strong> un articolo dest<strong>in</strong>ato<br />
al grande pubblico, ma assai impreciso e superficiale, <strong>in</strong> cui il poeta è presentato<br />
come una sorta di buffone di corte, dal titolo Pistoja een italiaansch humorist<br />
van de 15 e eeuw 7 . Maggiore precisione dimostrò Edmund Garratt Gardner<br />
(1869-1935), <strong>in</strong> Dukes & poets <strong>in</strong> <strong>Ferrara</strong>; a study <strong>in</strong> the poetry, religion, and<br />
politics of the fifteenth and early sixteenth centuries 8 , <strong>in</strong> cui si occupò pr<strong>in</strong>cipalmente<br />
dei sonetti politici del Nostro, fornendone anche una traduzione <strong>in</strong>glese.<br />
Risale al 1904 il corposo studio di Erasmo Pèrcopo (1860-1928), Antonio<br />
Cammelli e i suoi sonetti faceti 9 . Il mosaico delle pubblicazioni delle liriche del<br />
Pistoia si completò <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e nel 1908, con l’<strong>in</strong>serimento della tessera di più vaste<br />
dimensioni: l’edizione dei <strong>Sonetti</strong> faceti di Antonio Cammelli secondo l’autografo<br />
Ambrosiano, curata sempre dal Pèrcopo 10 .<br />
Gli studi sul Pistoia vennero rilanciati dall’edizione percopiana, cui seguirono<br />
recensioni e brevi segnalazioni, edite soprattutto nel «Giornale Storico della<br />
Letteratura Italiana», dal 1885 s<strong>in</strong>o al 1910.<br />
Nel 1929, Domenico Clarizia, giovane studioso napoletano, diede alle stampe<br />
4 2 Perc , p. 882.<br />
5 Ph. MONNIER, Le Quattrocento, Paris, Perr<strong>in</strong>, 1901.<br />
6 Cit., p. 355.<br />
7 e W. G. C. BIJVANCK, Pistoja een italiaansch humorist van de 15 eeuw, <strong>in</strong> «De<br />
Gids», 3 (1902), pp. 339-357.<br />
8 E. GARRATT GARDNER, Dukes & poets <strong>in</strong> <strong>Ferrara</strong>. A study <strong>in</strong> the poetry, religion,<br />
and politics of the fifteenth and early sixteenth centuries, London, Constable & Co,<br />
1904, pp. 475-485.<br />
9 In «Studi di Letteratura italiana», 6 (1904-1906), pp. 299-920.<br />
10 E. PÈRCOPO, <strong>Sonetti</strong> faceti di Antonio Cammelli secondo l’autografo Ambrosiano,<br />
Napoli, Jovene, 1908.
Nota bibliografica 81<br />
la propria tesi di laurea, <strong>in</strong>teramente dedicata al Cammelli, dal titolo Un poeta<br />
giocoso del R<strong>in</strong>ascimento: il Pistoia, Salerno, Beraglia Editore.<br />
La pubblicazione più importante sul pistoiese, <strong>in</strong> epoca recente, rimane la voce<br />
sul Cammelli, curata da D. De Robertis, nel DBI 11 .<br />
Purtroppo <strong>in</strong>utilizzabile, sia perché scritto <strong>in</strong> un italiano piuttosto approssimativo,<br />
sia perché essenzialmente un impreciso sunto dello studio del Pèrcopo<br />
del 1904, è il libro Anticlericalismo e <strong>in</strong>giustizie sociali nell’Italia del ’400: l’opera<br />
poetica e satirica di Antonio Cammelli detto il Pistoia, firmato da Rocco<br />
Pallone, docente presso la Fordham University - Rose Hill City di New York 12 .<br />
Nel 1983 Antonia Tissoni Benvenuti e Maria Pia Muss<strong>in</strong>i Sacchi pubblicano la<br />
Panfila, nel volume edito dalla UTET, Teatro del Quattrocento: le corti padane.<br />
Nel 1996 viene organizzata a Napoli una giornata di studi sull’Attività di Erasmo<br />
Pèrcopo tra storiografia letteraria e pratica filologica, cui Adriana Mauriello<br />
partecipa con un breve <strong>in</strong>tervento sull’Edizione dei <strong>Sonetti</strong> faceti di Antonio<br />
Cammelli, edito tre anni più tardi <strong>in</strong> «Esperienze Letterarie» 13 .<br />
Nell’ottobre del 2003 l’associazione culturale pistoiese “Un Club per l’Europa”<br />
dedica uno dei suoi <strong>in</strong>contri alla rievocazione della figura del Pistoia, <strong>in</strong> occasione<br />
della quale la Biblioteca Forteguerriana predispone una mostra, piccola<br />
ma ben documentata, <strong>in</strong> cui vengono esposti il codice Tonti, le edizioni ottocentesche<br />
delle rime del poeta e la corrispondenza autografa degli studiosi che se ne<br />
erano occupati.<br />
Nel 2004 esce, per cura di chi scrive, l’articolo La Disperata, capitolo conclusivo<br />
dei <strong>Sonetti</strong> faceti del Pistoia, <strong>in</strong> «LIA», 6 (2004), pp. 43-61.<br />
Nel 2005, Paolo Orvieto, avvertendo la necessità di presentare nuovamente al<br />
pubblico l’opera del Pistoia, cura la ristampa anastatica dell’edizione percopiana<br />
(divenuta ormai praticamente <strong>in</strong>trovabile), preceduta da una documentata <strong>in</strong>troduzione.<br />
11 Cit., cfr. n. 4 della Premessa.<br />
12 R. PALLONE, Anticlericalismo e <strong>in</strong>giustizie sociali nell’Italia del ’400: l’opera poetica<br />
e satirica di Antonio Cammelli detto il Pistoia, Roma, Trevi editore, 1975.<br />
13 Cfr. nota 19 della Premessa.
Sigle<br />
Bibliografia<br />
BCC = Bologna, Biblioteca di Casa Carducci<br />
Bibl. Marc. = Venezia, Biblioteca Marciana<br />
Bibl. Triv. = Milano, Archivio Storico Civico e Bibl. Trivulziana<br />
BNBr. = Milano, Biblioteca Nazionale Braidense<br />
BNC = Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale<br />
BNF = Paris, Bibliothèque Nationale de France<br />
GSLI = «Giornale Storico della Letteratura Italiana», period. trim., Tor<strong>in</strong>o,<br />
Loescher, 1883-<br />
SFI = «Studi di Filologia Italiana», period. annuale, Firenze, Accademia della<br />
Crusca, 1928-<br />
SR =«Studi Romanzi», period. dal 1903 al 1947<br />
RLI = «La Rassegna della Letteratura Italiana», period. quadr., Firenze, Sansoni, poi<br />
Le Lettere, n.s. 1953-<br />
Testi comici delle orig<strong>in</strong>i / edizioni e antologie<br />
[In caso di testi rari, <strong>in</strong>dico, per utilità degli studiosi <strong>in</strong>teressati, almeno una<br />
biblioteca italiana o straniera che ne possiede una copia e, ove possibile, dopo la<br />
sigla della biblioteca, la collocazione attuale]<br />
1661<br />
ALLACCI Mons. Leone, Poeti antichi raccolti dai Codici manoscritti della Biblioteca<br />
Vaticana e Barber<strong>in</strong>a (a c. di), Napoli, 1661 poi Firenze, Piovar<strong>in</strong>i, 1847,<br />
79 pp. (Bibl. Triv., Triv.L.978).<br />
1817<br />
VILLAROSA Carlo Antonio (De Rosa, marchese di), Raccolta di rime antiche toscane,<br />
Palermo, G. Assenzio (Bibl. Triv., Triv.D.600.2).
84 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
1847<br />
Trucchi Francesco, Poesie italiane <strong>in</strong>edite di dugento autori dall’orig<strong>in</strong>e della<br />
l<strong>in</strong>gua <strong>in</strong>f<strong>in</strong>o al secolo XVII (raccolte ed illustrate da), 2 vol., Prato, Ranieri Guasti,<br />
1846-1847 (BNC, Buon. 296).<br />
1867<br />
VIANI Prospero, Rime di B<strong>in</strong>do Bonichi da Siena (a c. di), Bologna, Romagnoli<br />
(BCC, 3. o. 343 /1).<br />
1868<br />
CAPPELLI Antonio, Cecco Angiolieri, Sonetto a Dante Alighieri, <strong>in</strong> Otto sonetti<br />
del secolo XIV, Modena, Tip. Cappelli (Bibl. Marc., Miscell. C. 1714).<br />
1874<br />
DEL PRETE Leone, Rime di Ser P. Dei Fayt<strong>in</strong>elli detto il Mugnone, poeta lucchese<br />
del secolo XIV (con <strong>in</strong>tr. e note di), Bologna, Romagnoli (BNC, TORDI 885).<br />
1875<br />
D’ANCONA, Alessandro; COMPARETTI Domenico; CASINI Tommaso, Le antiche<br />
rime volgari secondo la lezione del Codice Vaticano 3793 (pubbl. a c. di), Bologna,<br />
Romagnoli, Vol. I (BNF, Z32314(42), BNC, C.2.11.8 e Bibl. Marc., Cont. 302 41).<br />
1878<br />
MOLTENI Enrico; MONACI Ernesto, Il canzoniere chigiano L VIII 305 (a c. di),<br />
Bologna, Fava e Garagnani (BCC, 3. a. 40).<br />
1880<br />
NAVONE Giulio, Le rime di Folgore da San Gimignano e di Cenne dalla Chitarra<br />
di Arezzo (a c. di), Bologna, Romagnoli (Bibl. Marc., 57A- 293 e BNBr., Coll. Ital.<br />
52.176).
Nota bibliografica 85<br />
1881<br />
BARTOLI Adolfo; CASINI Tommaso, Il canzoniere Palat<strong>in</strong>o 418 della Biblioteca<br />
Nazionale di Firenze (a c. di), Bologna, Romagnoli-Dall’Acqua (BNC, Testi ital.<br />
5/2).<br />
1885<br />
MORPURGO Salomone, Le rime di Pieraccio Tedaldi (a c. di), Firenze, Libreria<br />
Dante (BNBr., Coll. Ital. 23.11).<br />
1887<br />
MAZZONI Guido, Il Bisbidis di Manoello giudeo secondo il Cod. Casanatense<br />
d.V.5 (a c. di), Roma, Metastasio (BCC, 4. d. 10 /6).<br />
1888<br />
NAVONE Giulio, <strong>Sonetti</strong> <strong>in</strong>editi di Niccolò de’ <strong>Rossi</strong>, Roma, Forzani.<br />
1891<br />
SANESI Ireneo, B<strong>in</strong>do Bonichi da Siena e le sue rime, <strong>in</strong> GSLI, XVIII, 1891, pp.<br />
1-75, Tor<strong>in</strong>o, Loescher.<br />
1893<br />
TONDELLI Vittorio, Sei sonetti di Cecco Angiolieri e barzelletta della città di Siena,<br />
<strong>in</strong> occasione delle nozze Guidi-Incontri, Bologna, Zanichelli, 20 pp. (BNC, Misc.<br />
Morpurgo 8191.24).<br />
TENNERONI Annibale, <strong>Sonetti</strong> <strong>in</strong>editi di Ser Mar<strong>in</strong>o Ceccoli, Roma, Eugenio Tenneroni<br />
(BNC, Misc. Morpurgo 8192.5).<br />
1894<br />
PATRIZI Ugo, Moscoli Neri, Rime (pubbl. da), Città di Castello, Tip. S. Lapi<br />
(BNC, Misc. Morpurgo 8193.11).
86 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
1895<br />
PELAEZ Mario, Rime antiche italiane secondo la lezione del Codice Vaticano<br />
3214 e del Codice Casanatense d. V. 5. (a c. di), Bologna, Romagnoli dall’Acqua<br />
(BNC, Testi ital. 5/5).<br />
1897<br />
BACCI Orazio, Un nuovo testo dei “<strong>Sonetti</strong> dei mesi” di Folgore da San Gimignano,<br />
<strong>in</strong> «Miscellanea Storica della Valdelsa», a. V, fasc. 2, pp. 123-128, Castelfiorent<strong>in</strong>o,<br />
Tip. Giovanelli e Carpitelli (BNF, 8°K6238, BNC, V.Ri.133).<br />
TOMMASINI-MATTIUCCI (Pietro), Nero Moscoli da Città di Castello: antico rimatore<br />
sconosciuto, Perugia, Unione Tipografica cooperativa (BNBr., L.N.I 232).<br />
1899<br />
FEDERICI V<strong>in</strong>cenzo, Le Rime di Rustico di Filippo (raccolte ed illustrate da), Bergamo,<br />
Istituto Italiano d’arti grafiche (Bibl. Marc., Cont. 768.4 e BNC, C.5.94).<br />
1904<br />
DE BENEDETTI Santorre, I sonetti volgari di Immanuel Romano, Tor<strong>in</strong>o, Paravia,<br />
16 pp. (BNC, 6584.36).<br />
MASSERA Aldo Francesco, I sonetti di Cecco Angiolieri contenuti nel Cod. Chigiano<br />
LVIII 305, <strong>in</strong> SR II, pp. 41-61.<br />
SATTA Salvatore; EGIDI Francesco, Il libro di varie romanze volgari Cod. Vat.<br />
3793 (a c. di) (BNC, Testi Ital. 8/4).<br />
1905<br />
MONACI Ernesto, Dai poeti antichi perug<strong>in</strong>i, Roma, Loescher (Bibl. Marc.,<br />
53a128).<br />
1913<br />
TOZZI Federigo, Antologia d’antichi scrittori senesi, Siena, Giunt<strong>in</strong>i-Bentivoglio.<br />
1914<br />
GIULIOTTI Domenico, Le rime di Cecco Angiolieri, Siena, Giunt<strong>in</strong>i-Bentivoglio.
Nota bibliografica<br />
NERI (Ferd<strong>in</strong>ando), I sonetti di Folgore da San Gimignano (a c. di), Città di Castello,<br />
S. Lapi, 118 pp., nuova ed., Coll. Classici italiani, Tor<strong>in</strong>o, UTET.<br />
1917<br />
MASSERA Aldo Francesco, Nuovi sonetti di Cecco Angiolieri, <strong>in</strong> SR XIII, pp. 77-<br />
97, Roma, Soc. filologica romana.<br />
1920<br />
MASSERA Aldo Francesco, <strong>Sonetti</strong> burleschi e realistici dei primi due secoli (a c.<br />
di), Bari, Laterza, Coll. Scrittori d’Italia n. 53, 2 Vol., Vol. 1, 247 pp. e Vol. 2, 204<br />
pp. nuova ed. a c. di L. RUSSO, Bari, Laterza.<br />
1925<br />
STEINER Carlo, Cecco Angiolieri, Il Canzoniere (Introduzione e commento di),<br />
Tor<strong>in</strong>o, UTET, nuova ed. 1928.<br />
1926<br />
DE BARTHOLOMEIS V<strong>in</strong>cenzo, Rime giullaresche e popolari d’Italia (a c. di), Bologna,<br />
Zanichelli.<br />
1941<br />
CABONI Adriana, Antiche rime italiane tratte dai Memoriali bolognesi, Modena,<br />
Soc. Tip. Modenese (BNC Firenze, C.8.413.23).<br />
1946<br />
BLANCATO Sebastiano, Cecco Angiolieri, Il Canzoniere (a c. di), Milano, Casa<br />
ed. Il Ruscello (BNC, C.4.672.1).<br />
1952<br />
BIANCHI Gabriele, Quattro sonetti estratti dai “<strong>Sonetti</strong> dei mesi”, <strong>in</strong> Sogni e stagioni,<br />
Bergamo (BNC, Th.4x.397).<br />
87
88 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
FOLGORE DA SAN GIMIGNANO, Corona dei mesi con 12 tavole dei mesi marciani,<br />
Milano, All’<strong>in</strong>segna del paese d’oro (BNC, C.11.816.41).<br />
SAPEGNO (Natal<strong>in</strong>o), Poeti m<strong>in</strong>ori del Trecento (a c. di), Milano-Napoli, Ricciardi.<br />
1956<br />
MARTI Mario, Poeti giocosi del tempo di Dante (a c. di), Milano, Rizzoli.<br />
VITALE Maurizio, Rimatori comico-realistici del 200 e 300 (a c. di), Tor<strong>in</strong>o,<br />
UTET, nuova ed., 3 voll.<br />
1959<br />
CAVALLI Gigi, Cecco Angiolieri, Rime (a c. di), Milano, Rizzoli (BNBr., Coll.<br />
Ital. T8 481).<br />
1960<br />
CARAVAGGI Giovanni, Folgore da San Gimignano, <strong>Sonetti</strong> (a c. di), Tor<strong>in</strong>o, E<strong>in</strong>audi,<br />
nuova ed. 1965 e 1969.<br />
CONTINI (Gianfranco), Poeti del Duecento (a c. di), Tomo II, Milano-Napoli,<br />
Ricciardi, VIII-1002 pp.<br />
1961<br />
SECCHI Marco, Folgore da San Gimignano, Tutti i sonetti (Prefazione e note di),<br />
Poggibonsi, Coltell<strong>in</strong>i (BNC, 14608.17).<br />
1968<br />
NAVONE Giulio, Le rime di Folgore da San Gemignano e di Cenne da la Chitarra<br />
d’Arezzo (nuovamente pubbl. da), Bologna, Commissione per i testi di l<strong>in</strong>gua,<br />
nuova ed. (BNC, C.8.1695.172).<br />
1969<br />
CORSI Giuseppe, Rimatori del Trecento (a c. di), Tor<strong>in</strong>o, UTET, nuova ed.
Nota bibliografica<br />
1971<br />
MENGALDO Pier V<strong>in</strong>cenzo, Rustico Filippi, <strong>Sonetti</strong> (a c. di), Tor<strong>in</strong>o, E<strong>in</strong>audi.<br />
1972<br />
FOLGORE DA SAN GIMIGNANO, <strong>Sonetti</strong> dei mesi (con tre acqueforti di Ernesto<br />
Treccani), Ancona, Giovagnoli.<br />
1974<br />
BRUNI BETTARINI Anna, Le rime di Meo dei Tolomei e di Muscia da Siena (a c.<br />
di), <strong>in</strong> SFI XXXII, pp. 31-98, Firenze, Sansoni.<br />
BRUGNOLO Furio, Il canzoniere di Nicolo’ de’ <strong>Rossi</strong>, 2 Vol., Padova, Antenore.<br />
ZANETTI Umberto, <strong>Sonetti</strong> giocosi <strong>in</strong> dialetto bergamasco, Bergamo, Il Convent<strong>in</strong>o.<br />
1977<br />
CATENAZZI Flavio, Poeti fiorent<strong>in</strong>i del Duecento (a c. di), Brescia, Morcelliana.<br />
1984<br />
BEC Pierre, Burlesque e obscénité chez les troubadours, Paris, Stock.<br />
SUITNER Franco, La poesia satirica e giocosa nell’età dei comuni, Antenore, Padova,<br />
cap. 3: Orig<strong>in</strong>i e carattere del «vituperium» <strong>in</strong> volgare.<br />
1990<br />
LANZA Antonio, Cecco Angiolieri, Le rime (a c. di), Roma, Archivio Guido Izzi.<br />
1992<br />
ARVEDA Antonia, Contrasti amorosi nella poesia italiana antica (a c. di), Roma,<br />
Salerno.<br />
SANSONE Giuseppe E., I trovatori licenziosi (a c. di), Milano, ES, “Biblioteca<br />
dell’Eros”.<br />
89
90 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
1995<br />
CASTAGNOLA Raffaela, Cecco Angiolieri, Le Rime (a c. di), Milano, Mursia.<br />
Studi sulla poesia comica e burlesca pre-r<strong>in</strong>ascimentale<br />
1730<br />
CRESCIMBENI Giovan Mario, Istoria della Volgar Poesia e Dei Commentari <strong>in</strong>torno<br />
alla sua istoria della volgar poesia (a c. di), vol. I-VI, Roma, A. De’ <strong>Rossi</strong>, (Ia<br />
ed. 1698 ridotta), 1710-1711, edizione ampliata Venezia, Basegio, 1730-31, Vol. II,<br />
parte I e Vol. III, libri I e II (Bibl. Marc., 89C, 30-38).<br />
1741<br />
QUADRIO Francesco Saverio, Della storia e della ragione d’ogni poesia, vol. II,<br />
Bologna, Agnelli, 1741, 171p. (Biblioteca dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana<br />
Treccani, Roma, FE A I I).<br />
1753<br />
MAZZUCCHELLI Giammaria, Gli Scrittori d’Italia, cioè notizie storiche e critiche<br />
<strong>in</strong>torno alla vita e agli scritti dei letterati italiani, 2 Vol., Brescia, Giambattista Boss<strong>in</strong>i,<br />
1753-1763.<br />
1874<br />
D’ANCONA Alessandro, Cecco Angiolieri da Siena, poeta umorista del secolo<br />
decimoterzo, <strong>in</strong> «La Nuova Antologia», gennaio 1874, <strong>in</strong> seguito <strong>in</strong> Studi di critica e<br />
storia letteraria, Bologna, Zanichelli, 1880, nuova ed. 1912, pp. 163-275 <strong>in</strong>-12°).<br />
1880<br />
GERUNZI Egisto, P. Dei Fayt<strong>in</strong>elli detto Mugnone e il moto d’Uguccione della<br />
Faggiuola <strong>in</strong> Toscana, <strong>in</strong> «Il Propugnatore», a. XVII, n. 2 (BNC, Misc. S. Morpurgo<br />
8203.23).
Nota bibliografica<br />
1890<br />
CASINI Tommaso, Un poeta umorista del secolo XIII, <strong>in</strong> «La Nuova Antologia»,<br />
XXV, Firenze, Le Monnier, poi <strong>in</strong> Scritti danteschi, Città di Castello, 1913.<br />
1899<br />
DEL LUNGO Isidoro, Un realista fiorent<strong>in</strong>o dei tempi di Dante, <strong>in</strong> «Rivista d’Italia»,<br />
ottobre 1899, pp. 193-212 e novembre 1899, pp. 425-440 (Accademia delle<br />
Scienze di Tor<strong>in</strong>o, Misc.B.671(28) e BNF, 8°Z14986).<br />
1901<br />
MASSERA Aldo Francesco, La patria e la vita di Cecco Angiolieri, <strong>in</strong> «Bullett<strong>in</strong>o<br />
senese di storia patria», a. VIII, fasc. 1, pp. 435-452, Siena, Lazzeri.<br />
1906<br />
MOMIGLIANO Attilio, L’anima e l’arte di Cecco Angiolieri, <strong>in</strong> «Italia moderna»,<br />
IV, aprile 1906, pp. 678-684.<br />
PIRANDELLO Luigi, Un preteso poeta umorista del secolo XIII e L’anima e l’arte<br />
di Cecco Angiolieri, nuova ed. <strong>in</strong> Saggi, poesie e scritti vari, Milano, Mondadori,<br />
1960, pp. 247-304.<br />
1911<br />
MANZELLA FRONTINI Gesualdo, Villon e Cecco Angiolieri, <strong>in</strong> «Le cronache letterarie»,<br />
a. II, n. 40, 22 gennaio 1911, p. 3, colonne 2-4 (BNC, Ga.II.177).<br />
1923<br />
FATTOVICH N<strong>in</strong>o, La poesia amorosa di Cecco Angiolieri, Annuario del Liceog<strong>in</strong>nasio<br />
Dante Alighieri di Fiume, Fiume (Biblioteca civica di Trieste, Misc 4 1251).<br />
POMPEATI (Arturo), I debiti poetici di Cecco Angiolieri, <strong>in</strong> “Marzocco”, a. XX-<br />
VIII, n. 45, 11 XI 1923, pp. 1-2, Firenze (BNC, GE.III.940).<br />
1924<br />
CAPPUCCIO Carmelo, Folgore da San Gimignano e Cenne dalla Chitarra, Siracusa,<br />
Santoro (BNC, 16957.8).<br />
91
92 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
SUDANO Raimondo, Cecco Angiolieri, Modica, Tip. E. Sarta, 1924.<br />
1926<br />
RUSSO Luigi, Cecco Angiolieri e la critica, <strong>in</strong> «Leonardo», a. II, n. 1, pp. 303-<br />
305, An. Romana ed. (BNC, I.Re.303), nuova ed. col titolo La critica moderna e gli<br />
antichi, <strong>in</strong> «Problemi di metodo critico», Bari, Laterza, 1950, pp. 271-281.<br />
1928<br />
COMUNALE Italo, Rustico di Filippo, esame esegetico-estetico dei suoi sonetti<br />
giocosi e satirici, Salerna, P. Beraglia (BNC, 10995.9).<br />
D’ANCONA Alessandro, Cecco Angiolieri, <strong>in</strong> Le pag<strong>in</strong>e della letteratura italiana,<br />
Gli scrittori e i critici a c. di L. Lippar<strong>in</strong>i, Milano, Signorelli, 1928, pp. 239-263.<br />
1929<br />
NANNETTI Elvira, Cecco Angiolieri, la sua patria, i suoi tempi e la sua poesia,<br />
Siena, Libreria editrice senese (Bibl. com. degli <strong>in</strong>tronati di Siena, BCI Bargagli Petrucci,<br />
739).<br />
SAPEGNO Natal<strong>in</strong>o, La l<strong>in</strong>gua e l’arte di Cecco Angiolieri, <strong>in</strong> «Convivium», a. I,<br />
n. 3, maggio-giugno, 1929, pp. 371-382, Tor<strong>in</strong>o, Soc. ed. Internazionale.<br />
1930<br />
MARCAZZAN Mario, La poesia d’amore di Cecco Angiolieri, <strong>in</strong> Didimo Chierico<br />
ed altri saggi, Milano, ed. degli Omenoni, 1930, pp. 123-194 (BNBr., NSP 1013).<br />
1931<br />
BIADENE Galeazzo, Cecco Angiolieri, Studio, Venezia, Tip. del Gazzett<strong>in</strong>o illustrato<br />
(BNC, 17318.22).<br />
RHO Edmondo, Cecco Angiolieri, <strong>in</strong> «Civiltà moderna», III, 3, giugno 1931, pp.<br />
499-512, Milano, Omenoni (BNC, I. Ri. 336).<br />
SAPEGNO Natal<strong>in</strong>o, Ancora su Cecco Angiolieri, <strong>in</strong> «La Nuova Italia», IX, marzo<br />
1931, pp. 114-116.
Nota bibliografica<br />
1932<br />
ASINELLI Piero, Il “bon begolardo” a Dante Alighieri, Bobbio, Tip. Bellocchio<br />
(BNC, 13159.6).<br />
IDEM, Il riso di Cecco Angiolieri e l’amore, l’odio, il dolore nel canzoniere di<br />
Cecco Angiolieri, Bobbio, Bellocchio (Biblioteca comunale di Piacenza, 3111 40).<br />
IDEM, Natura e posizione della poesia di Cecco Angiolieri, Bobbio, Tip. Bellocchio<br />
(BNC, 14259.3).<br />
MARLETTA Francesco, Folgore da San Gimignano, <strong>in</strong> «Rassegna di studi francesi»,<br />
a. 10, n. 1, pp. 14-21, Bari, T. Accolti-Til.<br />
MUSCO Livia, Cecco Angiolieri nella critica moderna, Napoli, Istituto della<br />
Stampa.<br />
1933<br />
MASCIA Francesco S., La poesia di Cecco Angiolieri, Milano, Soc. ed. Dante<br />
Alighieri (BNC, 13201.8).<br />
MONTAGNA Gianni, La poesia di Cecco Angiolieri, Pavia, Istituto di arti grafiche<br />
(Bibl. univ. di Pavia, 86.L.40).<br />
SAPEGNO Natal<strong>in</strong>o, La corrente realistica nelle orig<strong>in</strong>i della nostra letteratura,<br />
<strong>in</strong> «La Nuova Italia» IV, 1933, pp. 39-47 e Il Trecento, Milano, Vallardi, 1934, nuova<br />
ed. 1960.<br />
TODARO Adele, Il caribetto “a nulla guisa” di Meo di Simone dei Tolomei, <strong>in</strong><br />
«Bullett<strong>in</strong>o senese di storia patria», n. s., IV, fasc. II., 1933, pp. 147-163, Siena, Lazzeri.<br />
1934<br />
GUERRI Domenico, Cecco Angiolieri, Revisione delle rime del “Beffardo”, <strong>in</strong><br />
«Rivista di s<strong>in</strong>tesi letteraria», a. I, n. 3, luglio-sett. 1934, pp. 419-436, Ud<strong>in</strong>e, Lib.<br />
ed. “Aquileia” (BNC, VII Ri 132).<br />
TODARO Adele, Sull’autenticità dei sonetti attribuiti a Cecco Angiolieri, Palermo,<br />
Boccone del Povero (BNC, C.7.i.1615).<br />
1936<br />
GROSSI Teresio, Cecco Angiolieri e i burleschi del Duecento e Trecento, Tor<strong>in</strong>o,<br />
Paravia (BNC, C.6.217.L19).<br />
93
94 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
1938<br />
ROEDEL Reto, Cecco Angiolieri “begolardo”, <strong>in</strong> Dieci scrittori, Bell<strong>in</strong>zona, Ist.<br />
ed. tic<strong>in</strong>ese, pp. 205-215 (BNBr., NSN 2675).<br />
1939<br />
PREVITERA Carmelo, La poesia giocosa e l’umorismo, Milano, Vallardi.<br />
1941<br />
LI GOTTI Ettore, Cecco e Folgore, <strong>in</strong> Id. Saggi, Firenze, La Nuova Italia, 1941,<br />
pp. 19-35 (BNC, 7.i.2330).<br />
RONCAGLIA (Aurelio), Per due sonetti di Cecco Angiolieri e uno di Jacopo da<br />
Lèona, <strong>in</strong> GSLI CXVIII, Tor<strong>in</strong>o, Loescher, pp. 81-92.<br />
1945<br />
MARTI Mario, Cecco Angiolieri e i poeti autobiografici tra il ’200 e il ’300, Lecce,<br />
Galat<strong>in</strong>a.<br />
1946<br />
MAIER Bruno, Cecco Angiolieri, motivi per un profilo critico, Trieste, Smolars<br />
(Biblioteca civica di Trieste, R.P.MISC. 2-1683).<br />
RUSSO Luigi, La letteratura “comico-realistica” nella Toscana del Duecento, <strong>in</strong><br />
«Belfagor», pp. 141-161 e pp. 558-576, Firenze, ed. G. D’Anna (BNC, VII. Re.84),<br />
nuova ed. <strong>in</strong> Ritratti e disegni storici, Studi sul Due e Trecento, Bari, Laterza, 1951,<br />
pp. 151-207.<br />
1947<br />
MAIER Bruno, L’ultimo “canzoniere” di Cecco Angiolieri, <strong>in</strong> «Ausonia», II,<br />
1947, pp. 14-15.<br />
IDEM, La personalità e la poesia di Cecco Angiolieri, Studio critico, Bologna,<br />
Cappelli.<br />
MATTALIA Daniele, Voce “Canzoniere di Cecco Angiolieri”, <strong>in</strong> Dizionario letterario<br />
delle opere e dei personaggi di tutti i tempi e di tutte le letterature, Vol. II, p.<br />
93, Milano, Bompiani, 1947-1950.
Nota bibliografica<br />
RONCAGLIA Aurelio, Correzioni al testo di Rustico di Filippo, <strong>in</strong> «Annali della<br />
Scuola Normale Superiore di Pisa», serie II, XV, 1947, pp. 201-205, Pisa-Roma,<br />
Valler<strong>in</strong>i.<br />
1950<br />
FIGURELLI Fernando, La musa bizzarra di Cecco Angiolieri, Napoli, Pironti.<br />
IDEM, La poesia comico-giocosa nei due primi secoli, Napoli, Pironti.<br />
MARTI Mario, Per una nuova edizione dei sonetti di Cecco Angiolieri, <strong>in</strong> «Convivium»,<br />
n. 3, 1950, pp. 441-454, Tor<strong>in</strong>o, Soc. ed. Internazionale.<br />
IDEM, Sui sonetti attribuiti a Cecco Angiolieri, <strong>in</strong> GSLI, CXXVII, 1950, pp. 253-<br />
275.<br />
1951<br />
RHEINFELDER Hans, Umorismo di Cecco Angiolieri, <strong>in</strong> Dai trovatori arabo-siculi<br />
alla poesia d’oggi. Atti del congresso <strong>in</strong>ternazionale di poesia e di filologia, Palermo,<br />
pp. 125-131.<br />
TRAVI Ernesto, L’<strong>in</strong>telligenza fiorent<strong>in</strong>a della f<strong>in</strong>e del ’200, Rustico Filippi, <strong>in</strong><br />
«Aevum», pp. 248-266.<br />
VUOLO Emilio, Per alcuni versi di Cecco Angiolieri <strong>in</strong> Siciliano, <strong>in</strong> «Cultura<br />
neolat<strong>in</strong>a», XI, pp. 255-272.<br />
1952<br />
MARTI Mario, Revisione ed <strong>in</strong>terpretazione di due sonetti di Rustico di Filippo,<br />
<strong>in</strong> GSLI, CXXIX, pp. 26-30.<br />
1953<br />
MAIER Bruno, La poesia di Cecco Angiolieri e i suoi problemi, <strong>in</strong> «Ausonia»,<br />
VIII, pp. 28-37.<br />
MARTI Mario, Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante, Pisa, Nistri-<br />
Lischi.<br />
1954<br />
BAZZINI Anna, Intorno all’autenticità delle rime ascritte a Cecco Angiolieri, <strong>in</strong><br />
«Filologia romanza», I, 1954, pp. 30-38, Napoli, Loffredo (BN Paris, <strong>in</strong>-8°<br />
X.22812).<br />
95
96 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
1955<br />
MARTI Mario, Per un’edizione dei giocosi e di alcune questioni di metrica antica,<br />
<strong>in</strong> RLI, ser. VII, n. I, pp. 41-47.<br />
1996<br />
PASQUINI Emilio, Letteratura popolareggiante, comica e giocosa, lirica m<strong>in</strong>ore e<br />
narrativa <strong>in</strong> volgare del Quattrocento, <strong>in</strong> Storia della letteratura italiana, diretta da<br />
E. Malato, III, Roma, Salerno ed., pp. 803-911.<br />
Bibliografia generale<br />
1867<br />
D’ANCONA Alessandro, La politica nella poesia nel secolo XIII e XIV, Firenze,<br />
Le Monnier.<br />
1868<br />
DE SANCTIS Francesco, Storia della Letteratura Italiana, Napoli, Morano, 1868,<br />
nuova edizione a c. di N. GALLO, Tor<strong>in</strong>o, E<strong>in</strong>audi, 1958, 2 Vol.<br />
1874<br />
D’ANCONA Alessandro, La poesia popolare <strong>in</strong> Italia, Livorno, Vigo.<br />
1876<br />
BARTOLI (Adolfo), I precursori del Boccaccio e alcune delle sue fonti, Firenze,<br />
Sansoni, 1876, 86p. (Bièvre, 3088).<br />
CARDUCCI (Giosuè), Intorno ad alcune rime del secolo XIII e XIV ritrovate nei<br />
Memoriali dell’Archivio notarile di Bologna, Imola, Galeati, 1876.<br />
1879<br />
BARTOLI (Adolfo), Storia della letteratura italiana, 7 Vol., Vol. 2, Firenze, Sansoni,<br />
1879 (BNC Roma).
Nota bibliografica<br />
1880<br />
BARTOLI (Adolfo), Letteratura dialettale dell’Italia di mezzo, <strong>in</strong> I primi due secoli<br />
della letteratura italiana, Vol. 1, Cap. V, pp. 148-172, Milano, Vallardi, 1880, 609p.<br />
(Sorbonne, HMi 61(24) <strong>in</strong>-4°).<br />
1891<br />
NOVATI (Francesco), Le serie alfabetiche proverbiali e gli alfabeti disposti nella<br />
letteratura italiana de’ primi tre secoli, <strong>in</strong> “Giornale storico della letteratura italiana”,<br />
XVIII, 1891, pp. 105-147, Tor<strong>in</strong>o, Loescher (Sorbonne, P231 <strong>in</strong>-8°).<br />
1894<br />
MERLINI (Domenico), Saggio di ricerche sulla satira <strong>contro</strong> il villano, Tor<strong>in</strong>o,<br />
Loescher, 1894, 229p. (BNC Firenze, R<strong>in</strong>asc. Op. Gen. 243).<br />
1900<br />
CIAN (Vittorio), I contatti letterari italo provenzali e la prima rivoluzione poetica<br />
della letteratura italiana, Mess<strong>in</strong>a, 1900 (Sorbonne, A.33863, LH C.919(31) <strong>in</strong> -8°).<br />
1902<br />
TORRACA (Francesco), Studi su la lirica italiana del ’200, Bologna, Zanichelli,<br />
1902, 468p. (Sorbonne, Leip 268 <strong>in</strong>-12°).<br />
1920<br />
MASSERA (Aldo Francesco), Per la storia letteraria del Dugento, <strong>in</strong> “Giornale<br />
Storico della Letteratura Italiana”, LXXV, 1920, pp. 209-233, Tor<strong>in</strong>o, Loescher<br />
(Sorbonne, P231 <strong>in</strong>-8° et Bièvre, R155).<br />
1921<br />
MASSERA (Aldo Francesco), Feste e grandezze senesi del bel tempo antico, Castelfiorent<strong>in</strong>o,<br />
Giovannelli e Carpitelli, 1921, 17p. (BNC Firenze, 16890.20).<br />
1923<br />
CIAN (Vittorio), Storia dei generi letterari italiani, La satira, Vol. I, Dal Medioevo<br />
al Pontano, Milano, Vallardi, 1923 (Sorbonne, LH 1824 (6,1-2) <strong>in</strong>-8°).<br />
1925<br />
GUERRIERI-CROCETTI, La lirica predantesca, Firenze, Vallecchi, 1925, pp. 57-59<br />
(BU Bordeaux).<br />
97
98 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
1928<br />
SANTANGELO (Salvatore), Le tenzoni poetiche nella le tteratura italiana delle orig<strong>in</strong>i,<br />
G<strong>in</strong>evra, 1928 (Sorbonne, Lpv.428 (I,9) <strong>in</strong>-8°).<br />
1933<br />
CROCE (Benedetto), Poesia popolare e poesia d’arte, Bari, Laterza, 1933, 523p.<br />
(BNC Firenze, O.4.305).<br />
1934<br />
APOLLONIO (Mario), Uom<strong>in</strong>i e forme nella cultura italiana delle orig<strong>in</strong>i, Saggio<br />
di storiografia letteraria, Firenze, Sansoni, 1934, 371p. (BNC Firenze, 7.0.2510).<br />
1937<br />
RHO (Edmondo), Primitivi e romantici, Firenze, Sansoni, 1937, 136p. (Bièvre,<br />
L2936).<br />
1942<br />
NATALI (Giulio), Realtà e realismo nella poesia italiana del Duecento, <strong>in</strong> “Dal<br />
Gu<strong>in</strong>izelli al D’Annunzio”, Roma, Tosi, 1942, pp. 9-36 (BNC Firenze, C.7.794.3).<br />
1946<br />
AUERBACH (Erich), Mimesis, 1946, ed. ital., Tor<strong>in</strong>o, E<strong>in</strong>audi, 1956, éd. Fra.,<br />
1968, 563p. (Sorbonne, L29.821 <strong>in</strong>-8°).<br />
BAKHTINE (Mikhaïl), L’oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au<br />
Moyen Age et sous la Renaissance, Paris, Gallimard, 1946.<br />
FUBINI (Mario), Critica e poesia, Roma, Bonacci, 1946, rééd. en 1956 et 1966,<br />
VII-524p. (Sorbonne, Z470 (513) <strong>in</strong>-8°, pour l’édition de 1956).<br />
1947<br />
CASTELLANI (Arrigo), Il “vocabolario senese” del fondo boscioniano della Biblioteca<br />
nazionale di Firenze, <strong>in</strong> “L<strong>in</strong>gua nostra”, Vol. VII, fasc. 3-4, 1947, p. 65, Firenze,<br />
Sansoni (Sorbonne, P1044 <strong>in</strong>-4°).<br />
1950<br />
SCHIAFFINI (Alfredo), A proposito dello stile comico di Dante, <strong>in</strong> “Momenti di<br />
storia della Letteratura italiana”, Bari, ed. Leonardo da V<strong>in</strong>ci, 1950, pp. 43-56 (BNC<br />
Firenze, 7.0.3987).
Nota bibliografica<br />
1954<br />
MONTEVERDI (Angelo), Poesia politica e poesia amorosa nel Duecento, <strong>in</strong> “Studi<br />
e saggi sulla letteratura italiana dei primi secoli”, Milano-Napoli, Ricciardi, 1954,<br />
VIII-320p. (BNC Firenze, 7.i.3571).<br />
1956<br />
CURTIUS (Ernst Robert), Scherz und Ernst im mittelalterliche Dichtung, <strong>in</strong> “Romanische<br />
Forschungen”, t. 53, 1939, repris dans Littérature européenne et Moyen<br />
Age lat<strong>in</strong>, Paris, PUF, 1956.<br />
DAVIDSOHN (Robert), Storia di Firenze, Firenze, Sansoni, 1956-77, 6 vol. (Bièvre,<br />
H1076 (1-6)).<br />
1958<br />
FARAL (Edmond), Les arts poétiques aux XIIème et XIIIème siècles, Paris,<br />
Champion, 1958, XVI-384p. (Grans Palais).<br />
1959<br />
VISCARDI (Antonio), Le orig<strong>in</strong>i della tradizione letteraria italiana, Roma, Studium,<br />
1959 (BNU Strasbourg, A.501 890, 64).<br />
1960<br />
AUERBACH (Erich), L<strong>in</strong>gua letteraria e pubblico nella tarda antichità e nel medioevo,<br />
Milano, Feltr<strong>in</strong>elli, 1960, 312p.<br />
CONTINI (Gianfranco), Esperienze di un antologista del ’200 poetico italiano, <strong>in</strong><br />
“Studi e Problemi di critica testuale”, Bologna, Spongano, 1960, pp. 241-72 (Sorbonne,<br />
P7297 <strong>in</strong>- 8°).<br />
MARTI (Mario), Sulla genesi del realismo dantesco, <strong>in</strong> “Giornale storico della letteratura<br />
italiana”, CXXXVII, 1960, Tor<strong>in</strong>o, Loescher, pp. 497-532 (Bièvre, 155(420)<br />
et Sorbonne, P231 <strong>in</strong>-8°).<br />
SAPEGNO (Natal<strong>in</strong>o), Il Trecento, cap. II, Poesia realistica e borghese, <strong>in</strong> Storia<br />
letteraria d’Italia, Milano, Vallardi, 1960, pp. 66-117 (Bièvre, L241).<br />
VISCARDI (Antonio), Storia della letteratura italiana: dalle orig<strong>in</strong>i al R<strong>in</strong>ascimento,<br />
Milano, Nuova Accademia, 1960, 661p. (BNC Roma, BNC Firenze).<br />
1961<br />
MARTI (Mario),Realismo dantesco e altri studi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1961,<br />
pp. 156-186 (Sorbonne, LEip 595 <strong>in</strong>-8°).<br />
99
100 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
1963<br />
SAPEGNO (Natal<strong>in</strong>o), Storia letteraria del Trecento, Milano-Napoli, Ricciardi,<br />
1963, 409p. (Bièvre, COL R2B).<br />
ZUMTHOR (Paul),Langue et technique poétique à l’époque romane (XI-XIII siècles),<br />
Paris, Kl<strong>in</strong>cksieck, 1963, 224p. (Bièvre, PH496-L1078).<br />
1965<br />
BATTAGLIA (Salvatore), La coscienza letteraria del Medioevo, Napoli, Lignori,<br />
1965, 748p. (Sorbonne, L29.005 <strong>in</strong>-8° et Bièvre, L Br 243).<br />
1966<br />
ROSZA (Zoltan), Utopia, <strong>in</strong>vettiva e satira, <strong>in</strong> Dante fra medioevo e R<strong>in</strong>ascimento,<br />
Budapest, Accademia delle scienze, 1966.<br />
1968<br />
BALDELLI (Ignazio), Dante e i poeti fiorent<strong>in</strong>i del Duecento, Firenze, Le Monnier,<br />
1968 (Grand Palais it. Br. 93).<br />
1970<br />
CONTINI (Gianfranco), Letteratura italiana delle orig<strong>in</strong>i, Firenze, Sansoni, 1970,<br />
IX-1043p. (Bièvre L3802).<br />
FOLENA (Gianfranco), Cultura poetica dei primi fiorent<strong>in</strong>i, <strong>in</strong> “Giornale Storico<br />
della Letteratura Italiana”, CXLVII, 1970, pp. 1-42, Tor<strong>in</strong>o, Loescher (Sorbonne,<br />
P231 <strong>in</strong>-8°).<br />
1971<br />
BATTAGLIA (Salvatore), La letteratura italiana, Medioevo e Umanesimo, Firenze,<br />
Sansoni, 1971, 523p. (BNC Firenze, C.7.1829.1).<br />
MARTI (Mario), Con Dante fra i poeti del suo tempo, Lecce, Milella, 1971, 203p.<br />
(Sorbonne, Leip 607 <strong>in</strong>-8°).<br />
TARTARO (Achille), Forme poetiche del Trecento, <strong>in</strong> Letteratura italiana Laterza,<br />
Vol. 7, Bari, Laterza, 1971, 175p. (BNC Firenze, O.8.1236).<br />
1972<br />
FLORA (Francesco), Storia della letteratura italiana, Vol. 1, 615p., Dal Medioevo<br />
alla f<strong>in</strong>e del ’400, Milano, Mondadori, 1940, rééd. 1972, 4 Vol. (BNC Firenze,<br />
7.e.2144-2147).<br />
ZUMTHOR (Paul), Essais de poétique médiévale, Paris, Seuil, 1972.<br />
ZUMTHOR (Paul), Jonglerie et langage, <strong>in</strong> “Poétique”, III, 1972, pp. 321-336, Paris,<br />
Seuil (Sorbonne, P6668 <strong>in</strong>-8°).
Nota bibliografica<br />
101<br />
1973<br />
AVALLE (D’Arco Silvio), S<strong>in</strong>tassi e prosodia nella lirica italiana delle orig<strong>in</strong>i, Tor<strong>in</strong>o,<br />
Giappichelli, 1973 (Sorbonne, Leip599 <strong>in</strong>-8°).<br />
BALDUINO (Armando), Premesse ad una storia della poesia trecentesca, <strong>in</strong> “Lettere<br />
italiane”, a. XXV, n. 1, gennaio-marzo 1973, pp. 3-36, Firenze, Olschki (Bièvre,<br />
R20 et Sorbonne, P3813 <strong>in</strong>-8°).<br />
BERTONI (Giulio), Il Duecento, <strong>in</strong> “Storia della letteratura d’Italia”, Milano, Vallardi,<br />
1973, XVIII-495p. (Bièvre, usuel).<br />
BRANCA (Vittorio), Concetto, storia, miti e immag<strong>in</strong>i del Medioevo (a cura di),<br />
Firenze, Sansoni, 1973, XIV-556p. (Bièvre, H 1938).<br />
1974<br />
ASOR ROSA (Alberto), La poesia del Duecento e Dante, Firenze, La Nuova Italia,<br />
1974, 367p. (Grand Palais, It 2683).<br />
1975<br />
SAVONA (Eugenio), Cultura e ideologia nell’età comunale, Ravenna, Longo,<br />
1975, 213p. (Sorbonne, Z 2643(57) <strong>in</strong>-8°).<br />
1976<br />
PORTER (Lambert C.), Le rire au Moyen Age, <strong>in</strong> “L’esprit créateur”, t. 16, 1976,<br />
pp. 5-15.<br />
1977<br />
JAUSS (Hans Robert), Alterità e modernità della letteratura medioevale, Tor<strong>in</strong>o,<br />
Bor<strong>in</strong>ghieri, 1989 (1ère édition en allemand 1977).<br />
1978<br />
CORTI (Maria), Modelli e antimodelli nella cultura medievale, <strong>in</strong> “Strumenti critici”,<br />
XII, 1978, pp. 3-29 (Grand Palais, It P9 R266 P.3).<br />
LANZA (Antonio), Studi sulla lirica del ’300, Roma, Bulzoni, 1978, 211p. (BNC<br />
Firenze).<br />
PAZZAGLIA (Mario), Letteratura italiana : testi e critica con l<strong>in</strong>eamenti di storia<br />
letteraria (a cura di), Bologna, Zanichelli, 1979 (BNC Firenze, B.21.2.1685).<br />
1979<br />
ORTALLI (Gherardo), La pittura <strong>in</strong>famante nei secoli XIII-XVI, Roma, Jouvence,<br />
1979, 206p. (Bièvre, H 2433).<br />
SAVONA (Eugenio), Intellettuali e pubblico nell’età comunale, Mess<strong>in</strong>a-Firenze,<br />
G. D’Anna, 1979, 189p. (Bièvre, L2652).
102 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
1980<br />
FOTI (Francesco), La critica letteraria, vol. I, Dal Medioevo al Settecento, Roma,<br />
Fermenti, 1980, 346p. (BU Lyon, XA5822/1).<br />
1984<br />
BALDUINO (Armando), Boccaccio, Petrarca e altri poeti del Trecento, Firenze,<br />
Olschki, 1984, 341p. (Bièvre, L2372).<br />
PERRUS (Claudette), Libéralité et munificence dans la littérature italienne du<br />
Moyen Age, Pisa, Pac<strong>in</strong>i, 1984, 382p. (Bièvre, L 2113).<br />
1985<br />
LANZA (Antonio), Aspetti e figure della poesia comico-realistica toscana del secolo<br />
XV, <strong>in</strong> “Rassegna della letteratura italiana”, LXXXIX, 1985, pp. 403-443, Firenze,<br />
Sansoni (Sorbonne, P1329 <strong>in</strong>-8°).<br />
1989<br />
BORSELLINO (N<strong>in</strong>o), La tradizione del comico, Milano, Garzanti, 1989, pp. 7-66<br />
(Bièvre, L2801).<br />
CHIAPPELLI (Giovanni), Ridere nel Medioevo, <strong>in</strong> “Quaderni medievali”, n. 28,<br />
déc. 1989 (Sorbonne, P7479 <strong>in</strong>-8°).<br />
1990<br />
BARBERI SQUAROTTI (Giorgio), Storia della civiltà letteraria italiana (diretto da),<br />
Vol. 1, Dalle orig<strong>in</strong>i al Trecento, Tor<strong>in</strong>o, UTET, 1990, XX-514p. (Bièvre, usuel).<br />
1992<br />
AVALLE (D’Arco Silvio), Concordanze della l<strong>in</strong>gua poetica italiana delle orig<strong>in</strong>i<br />
(a cura di), Manoscritti duecenteschi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1992, CCLXX-<br />
870p. (Bièvre, <strong>in</strong>-4° PH90-1).
I manoscritti contenenti composizioni burlesche<br />
Il seguente regesto comprende, elencate per autore (per comodità di reperimento<br />
adotto un <strong>in</strong>dice alfabetico e non cronologico) le collocazioni dei vari codici<br />
manoscritti degli autori giocosi e burleschi precursori del Pistoia.<br />
- Cecco ANGIOLIERI<br />
Codice 10 della Biblioteca civica di Ud<strong>in</strong>e.<br />
Codice 1081 della Biblioteca Palat<strong>in</strong>a di Parma.<br />
Codice 1289 della Biblioteca Universitaria di Bologna.<br />
Codice Ambrosiano O. 63. Sup.<br />
Codice Barber<strong>in</strong>o XLV. 47.<br />
Codice C. 43 della Biblioteca comunale di Perugia.<br />
Codice Casanatense 433.<br />
Codice CCCCXLV della Biblioteca Capitolare di Verona.<br />
Codice Chigiano Lat<strong>in</strong>o VIII. 305.<br />
Codice Escorialense e. III.23.<br />
Codice Galvani-Manzoni, oggi perduto.<br />
Codice H. X. 47 della Biblioteca comunale di Siena.<br />
Codice it. 557 de la Bibliothèque Nationale de Paris.<br />
Codice Laurenziano XL. 49.<br />
Codice Laurenziano 122 del fondo Conv. Soppressi.<br />
Codice Magliabechiani VII, 1040 et 1145.<br />
Codice Panciatichiano 24.<br />
Codici Riccardiani 1103, 2729, 2908, 683 et 1094.<br />
Codice Vaticano 3793.<br />
Codice Vaticano Barber<strong>in</strong>o Lat<strong>in</strong>o 3679.<br />
Codice Vaticano Lat<strong>in</strong>o 3214.<br />
Codice Vaticano 697 del fondo Urb<strong>in</strong>ate.<br />
Memoriale n. 85 dell’Archivio Notarile di Bologna.<br />
- B<strong>in</strong>do BONICHI<br />
Appendice<br />
Codice 101 dell’Accademia dei Concordi di Rovigo.
104 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
Codice 1425 della Biblioteca Angelica di Roma.<br />
Codice Vaticano Chigiano Lat<strong>in</strong>o IV. 131.<br />
Codice Vaticano Chigiano M. VI. 127.<br />
Codice 3 della Biblioteca Venturi G<strong>in</strong>ori Lisci.<br />
Codice 89 del Fondo Landau.<br />
Codice Gaddiano 198.<br />
Codice Laurenziano Ashburnhamiani 1378.<br />
Codici Magliabechiani II, IV. 126 et 114.<br />
Codici Magliabechiani VII. 1034 ; 1040 ; 1145 et 1298.<br />
Codice Marciano IX. 204.<br />
Codice Panciatichiani 24.<br />
Codice Parig<strong>in</strong>o Italiano 557.<br />
Codici Riccardiani 1036 et 1156.<br />
Codice Senese C. IV. 16.<br />
Codice Strozziano 137 degli acquisti e doni.<br />
Codice Trivulziano 1053.<br />
Codice Ud<strong>in</strong>ese Ottelio 10.<br />
Codice Vaticano Lat<strong>in</strong>o 3212.<br />
- Mar<strong>in</strong>o CECCOLI<br />
Codice Vaticano Barber<strong>in</strong>o Lat<strong>in</strong>o 4036.<br />
- D<strong>in</strong>o COMPAGNI<br />
Codice 445 della Biblioteca capitolare di Verona.<br />
Codice Laurenziano Ashburnhamiani 443.<br />
Codice Laurenziano Gaddiani 193.<br />
- Cenne DA LA CHITARRA<br />
Codice Chigiano Lat<strong>in</strong>o IV, 131.<br />
Codice Vaticano Barber<strong>in</strong>o Lat<strong>in</strong>o 3953.<br />
- Iacopo DA LEONA<br />
Codice Vaticano Lat<strong>in</strong>o 3793.
Appendice 105<br />
- Bartolomeo DA SANT’ANGELO<br />
Codice Vaticano Barber<strong>in</strong>o Lat<strong>in</strong>o 3953.<br />
- Stoppa DE’ BOSTICHI<br />
Codice Chigiano Lat<strong>in</strong>o IV. 131.<br />
Codice C. 155 della Marucelliana.<br />
Codice Gaddiano 198.<br />
Codici Laurenziani XC <strong>in</strong>f. 40 et 47.<br />
Codice Magliabechiano VII. 1078.<br />
Codici Marciani It. IX. 486 et 679.<br />
Codice Mediceo-Palat<strong>in</strong>i 118.<br />
Codici Riccardiani 1050 et 2971.<br />
Codice Strozziano 137 degli Acquisti e doni.<br />
Codice Strozziano 122 dei Conventi soppressi.<br />
- Adriano DE’ ROSSI<br />
Codice Vaticano Chigiano L.IV.131.<br />
Codice Laurenziano Rediano 184.<br />
- Pietro DEI FAITINELLI<br />
Codice Chigiano Lat<strong>in</strong>o IV, 131.<br />
Codice Chigiano A. VII, 217.<br />
Codice Vaticano Barber<strong>in</strong>o Lat<strong>in</strong>o 3953.<br />
- Iacopo DEI TOLOMEI<br />
Codice Vaticano Barber<strong>in</strong>o Lat<strong>in</strong>o 3953.<br />
- Meo DEI TOLOMEI<br />
Codice Chigiano Lat<strong>in</strong>o VIII, 305.<br />
Codice Escurialense e. III, 23.<br />
Codice Vaticano Barber<strong>in</strong>o Lat<strong>in</strong>o 3953.
106 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
Codice Vaticano Lat<strong>in</strong>o 3793 della biblioteca vaticana di Roma.<br />
Memoriale n. 85 del 1293 dell’Archivio di Stato di Bologna.<br />
- Niccolò DEL ROSSO<br />
Codice Vaticano Barber<strong>in</strong>o Lat<strong>in</strong>o 3953.<br />
- Rustico FILIPPI<br />
Codice Chigiano Lat<strong>in</strong>o VIII, 305.<br />
Codice Magliabechiano VII, 1040.<br />
Codice Marciano IX. it. 529.<br />
Codici Vaticani Lat<strong>in</strong>i 3793 et 3214.<br />
Codice Vaticano 697 del fondo Urb<strong>in</strong>ate.<br />
- FINO D’AREZZO<br />
Codice Vaticano Barber<strong>in</strong>o Lat<strong>in</strong>o 3953.<br />
-FOLGORE DA SAN GIMIGNANO<br />
Codice Chigiano Lat<strong>in</strong>o IV, 131.<br />
Codice Magliabechiano VII, 1066.<br />
Codici Riccardiani 1158 ; 2795 et 1103.<br />
Codice Vaticano Barber<strong>in</strong>o Lat<strong>in</strong>o 3953.<br />
- Gualpert<strong>in</strong>o DA CODERTA<br />
Codice Vaticano Barber<strong>in</strong>o Lat<strong>in</strong>o 3953.<br />
- GUERCIO DA MONTESANTO<br />
Codice Vaticano Barber<strong>in</strong>o Lat<strong>in</strong>o 3953.<br />
- IMMANUEL Romano<br />
Codice Barber<strong>in</strong>o Lat<strong>in</strong>o 4036.
Appendice<br />
Codice Casanatense 433.<br />
Codice Vaticano Barber<strong>in</strong>o Lat<strong>in</strong>o 3953.<br />
- Giunt<strong>in</strong>o LANFREDI<br />
Codice Vaticano Barber<strong>in</strong>o Lat<strong>in</strong>o 3953.<br />
- Luporo DA LUCCA<br />
Codice Ambrosiano C. 35.<br />
Codici Ricciard<strong>in</strong>i 931 et 1103.<br />
- Neri MOSCOLI<br />
Codice Vaticano Barber<strong>in</strong>o Lat<strong>in</strong>o 4036.<br />
- Niccola (Muscia da Siena) MUSCIA<br />
Codice Chigiano Lat<strong>in</strong>o VIII, 305.<br />
Codice Vaticano Barber<strong>in</strong>o Lat<strong>in</strong>o 3953.<br />
- Cecco NUCCOLI<br />
Codice Vaticano Barber<strong>in</strong>o Lat<strong>in</strong>o 4036.<br />
- PARLANTINO DA FIRENZE<br />
Codice Malgiabechiano VII, 1060.<br />
Codice Vaticano Barber<strong>in</strong>o Lat<strong>in</strong>o 3953.<br />
- Antonio PUCCI<br />
Codice Laurenziano Ashburnham 1378.<br />
Codice Laurenziano Tempi 2.<br />
Codici Magliabechiani VII, 1145 ; 1298 e 1168.<br />
Codici Riccardiani 1050 et 1103.<br />
Codice Vaticano Barber<strong>in</strong>o Lat<strong>in</strong>o 3999.<br />
107
108 <strong>Sonetti</strong> <strong>contro</strong> l’Ariosto<br />
Codice Vaticano Chigiano Lat<strong>in</strong>o IV. 131.<br />
Codice Conventi soppressi B. 7. 2889.<br />
- Benuccio SALIMBENI<br />
Codice 1425 della Biblioteca Angelica di Roma.<br />
Codici Fondo pr<strong>in</strong>cipale, II. II. 40 ; II. IV. 114 et II. IX. 125.<br />
Codice 332 dei Nuovi acquisti (Giunt<strong>in</strong>a Galvani).<br />
Codice Vaticano Chigiano Lat<strong>in</strong>o IV. 110 et 131.<br />
Codici 152 e 155 della Marucelliana.<br />
Codice Gaddiano 198.<br />
Codice Laurenziano Ashuburnham 542.<br />
Codici Magliabechiani VI. 143 ; VI. 163 ; VII. 375 ; VII. 1034 et VII. 1298.<br />
Codici Mediceo-Laurenziani XC. <strong>in</strong>f. 47 et 48.<br />
Codice Mediceo-Palat<strong>in</strong>o 105.
Ariosto, Ludovico;<br />
Ariosto, Niccolò;<br />
Bertoni, Giulio;<br />
Caleff<strong>in</strong>i, Ugo;<br />
Cammelli, Antonio detto il Pistoia;<br />
Cappelli, Antonio;<br />
Carducci, Giosuè;<br />
Catalano, Michele;<br />
da Correggio Niccolò;<br />
Eleonora d’Aragona d’Este;<br />
Ercole I d’Este;<br />
Indice dei nomi<br />
Ermete Bentivoglio;<br />
Federico III;<br />
Isabella d’Este;<br />
Lorenzo il Magnifico;<br />
Magagn<strong>in</strong>o;<br />
Niccolò di Lionello d’Este;<br />
Pardi, Giuseppe;<br />
Pèrcopo, Erasmo;<br />
Pol da Lend<strong>in</strong>ara;<br />
Sardi, Gaspare;<br />
Squarzone;