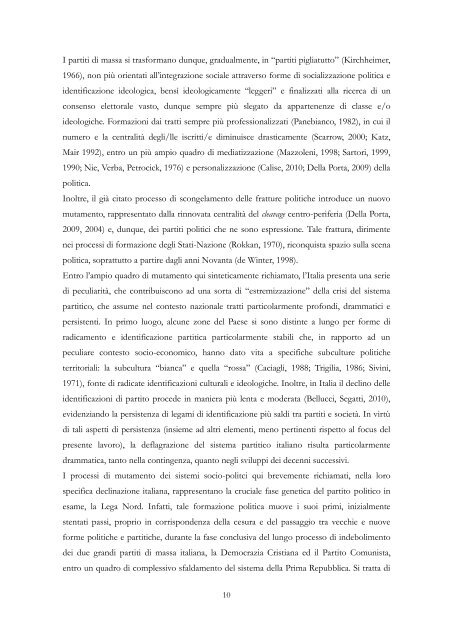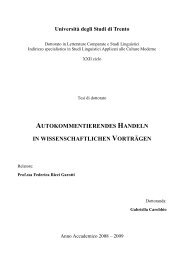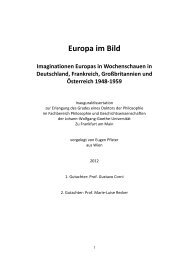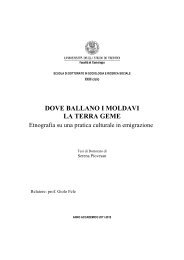- Page 1 and 2: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO D
- Page 3 and 4: RINGRAZIAMENTI La produzione di con
- Page 5 and 6: INDICE INTRODUZIONE ...............
- Page 7 and 8: 3.2. Nemici del lavoro, nemici del
- Page 9: INTRODUZIONE Negli ultimi decenni l
- Page 13 and 14: di vista dell’analisi dei fenomen
- Page 15 and 16: delle caratteristiche del partito o
- Page 17 and 18: ho denominato “Crisi”. A propos
- Page 19 and 20: CAPITOLO I - LA LUNGA MARCIA VERSO
- Page 21 and 22: moderni partiti di massa. Proprio W
- Page 23 and 24: primaria rilevanza. Tuttavia, a par
- Page 25 and 26: I partiti politici vengono profonda
- Page 27 and 28: democrazia diretta, volte a determi
- Page 29 and 30: 1998; Diani, 1996b), che conduce al
- Page 31 and 32: di collocazioni entro l’asse dest
- Page 33 and 34: Nel Nord Est la subcultura bianca s
- Page 35 and 36: dell’autonomismo-indipendentismo
- Page 37 and 38: saldamente” (Taggart, 2000, p. 9)
- Page 39 and 40: 2.2.2. Mediatizzazione Simboli, com
- Page 41 and 42: contesto si evidenzia inoltre il gi
- Page 43 and 44: partito ha inoltre attraversato fas
- Page 45 and 46: appresentanza politica. Per dirla,
- Page 47 and 48: tematiche: il populismo. La Lega No
- Page 49 and 50: abbandona le velleità secessionist
- Page 51 and 52: 3.3. La dimensione comunicativa, si
- Page 53 and 54: collettività leghista. Il fascino,
- Page 55 and 56: che l’interesse sociologico a tal
- Page 57 and 58: configurando quindi la politica com
- Page 59 and 60: corpo alla partecipazione, entro i
- Page 61 and 62:
un piano formale, materiale, uffici
- Page 63 and 64:
Un’altra categoria rilevante in a
- Page 65 and 66:
integrazione, volti a conferire uni
- Page 67 and 68:
4.1. Narrazioni e identità organiz
- Page 69 and 70:
(Czarniawska, 1997), che impongono
- Page 71 and 72:
afforzano quel dualismo pubblico-ma
- Page 73 and 74:
dall’insieme dei men’s studies.
- Page 75 and 76:
quali due o più uomini in maniera
- Page 77 and 78:
si pongono in quanto soggetto (domi
- Page 79 and 80:
Si tratta di una prospettiva analit
- Page 81 and 82:
apporto tra le domande di ricerca v
- Page 83 and 84:
esercita la propria influenza anche
- Page 85 and 86:
isulta infatti evidente la capacit
- Page 87 and 88:
macro: il potere nella sua fase di
- Page 89 and 90:
icorso ad approcci di ricerca quali
- Page 91 and 92:
specifici contesti territoriali. Se
- Page 93 and 94:
TAB. 3 RISULTATI DELLA LN ALLE ELEZ
- Page 95 and 96:
tesseramento mette in luce da una p
- Page 97 and 98:
sia per la concorrenza, dal 1994 in
- Page 99 and 100:
entrambi i casi, va rilevato come l
- Page 101 and 102:
etroscena, dal punto di vista delle
- Page 103 and 104:
sotto una nuova luce sia le impress
- Page 105 and 106:
intervistatrice e intervistata/o e
- Page 107 and 108:
sono emerse anche le prime connessi
- Page 109 and 110:
eninteso, non discendono da una sor
- Page 111 and 112:
linguaggi istituzionalmente, social
- Page 113 and 114:
tratti dell’etnografia coperta. L
- Page 115 and 116:
secondo luogo, perché scelgo un pa
- Page 117 and 118:
sensibili o situazioni di potenzial
- Page 119 and 120:
CAPITOLO IV - LA SEZIONE DI CONTRAD
- Page 121 and 122:
che si sostanziano nelle reti di re
- Page 123 and 124:
leghista precedente a quella di fed
- Page 125 and 126:
Dc, sia per quanto riguarda la pres
- Page 127 and 128:
dell’associazionismo o comunali,
- Page 129 and 130:
strappata e sotto è venuto fuori [
- Page 131 and 132:
Si tratta di un gruppo coeso, a det
- Page 133 and 134:
Pontida che, insieme a quello - pi
- Page 135 and 136:
L’altro capo della strategia è c
- Page 137 and 138:
tutto diversa della storia del part
- Page 139 and 140:
quale si tiene la parte maggiorment
- Page 141 and 142:
iunione ed offerte con particolare
- Page 143 and 144:
lascia emergere una dimensione di c
- Page 145 and 146:
di Serena e Rita si scorge un tenta
- Page 147 and 148:
anche di celebrazione del potere de
- Page 149 and 150:
un evento importante per un paese n
- Page 151 and 152:
tavoli rotondi, ricoperti da lunghe
- Page 153 and 154:
[attuale presidente della società
- Page 155 and 156:
analisi e collocando Contrada entro
- Page 157 and 158:
feudatario o aspirante tale non pu
- Page 159 and 160:
Come si vede dagli stralci riportat
- Page 161 and 162:
Se il pragmatismo rappresenta un va
- Page 163 and 164:
3.2.1. Stato La rabbia del profondo
- Page 165 and 166:
3.2.2. Sud Nel processo di successi
- Page 167 and 168:
elevata rispetto alle rare esternaz
- Page 169 and 170:
grossa azienda agricola: il primo c
- Page 171 and 172:
CAPITOLO V - LA SEZIONE DI METROPOL
- Page 173 and 174:
contraddizioni, che risiede nella c
- Page 175 and 176:
federalismo; la questione del Nord
- Page 177 and 178:
valori e culture politiche collocab
- Page 179 and 180:
fa, racconta di una sua recente esp
- Page 181 and 182:
In questo caso, l’identificazione
- Page 183 and 184:
finisce quasi con il credere che Me
- Page 185 and 186:
discorso“Quindi lo spread è il g
- Page 187 and 188:
personali, sostenendo che i veri be
- Page 189 and 190:
In questo passaggio si evidenzia un
- Page 191 and 192:
contraddittori e conflittuali si sc
- Page 193 and 194:
ed avvicinatasi alla politica con l
- Page 195 and 196:
tenere insieme elementi profondamen
- Page 197 and 198:
livello economico, però comunque d
- Page 199 and 200:
negozi di moda, che vanno bene, per
- Page 201 and 202:
alle un motivo lo trova”) e mobil
- Page 203 and 204:
cui le posizioni leghiste non solo
- Page 205 and 206:
uguale degli altri. Se la chiave de
- Page 207 and 208:
nessun territorio, non rivendicano
- Page 209 and 210:
I/le militanti di sezione passano d
- Page 211 and 212:
La prima forma di contaminazione, c
- Page 213 and 214:
Un militante di mezza età chiede a
- Page 215 and 216:
del cristianesimo in città). Il se
- Page 217 and 218:
scontro con la Nuova Maggioranza em
- Page 219 and 220:
2001). Tuttavia, la dimensione dell
- Page 221 and 222:
fianco a me perché è stanco, per
- Page 223 and 224:
all’ordine e chiarisce al gruppo
- Page 225 and 226:
tratta di un aspetto che è già em
- Page 227 and 228:
I due giovani Consiglieri di zona r
- Page 229 and 230:
- Sposare la causa Nei racconti dei
- Page 231 and 232:
ichiami misticheggianti, peraltro n
- Page 233 and 234:
segretario, da Valentina (giovane m
- Page 235 and 236:
citate distanze, politiche e cultur
- Page 237 and 238:
in scena da una parte la comunità
- Page 239 and 240:
dirigenti Roberto Maroni, Manuela D
- Page 241 and 242:
comunque sulle due sezioni. Tuttavi
- Page 243 and 244:
Lega. Proprio per fugare tali timor
- Page 245 and 246:
Governo, la questione della riforma
- Page 247 and 248:
1.2. Tra Roma e il Nord La Lega ha
- Page 249 and 250:
considerazione risulta particolarme
- Page 251 and 252:
frizione, avrebbero preso un sacco
- Page 253 and 254:
tratto costante, la condizione peri
- Page 255 and 256:
al governo. In questo mutare ed ada
- Page 257 and 258:
Le tre vicende, che hanno fatto mol
- Page 259 and 260:
Il segretario di sezione racconta c
- Page 261 and 262:
voto, ma la decisione è stata stru
- Page 263 and 264:
ed esperienza, avviando un processo
- Page 265 and 266:
diffusamente in letteratura (Passar
- Page 267 and 268:
Si abbassano le luci in sala e la p
- Page 269 and 270:
un sogno nel cuore “Far parte di
- Page 271 and 272:
Metropolis, a riprova dell’avanza
- Page 273 and 274:
infatti, in ultima analisi, di stam
- Page 275 and 276:
stimato da tutti e visto da tutti c
- Page 277 and 278:
condizione di crisi che si trascina
- Page 279 and 280:
“[…] può essere una struttura
- Page 281 and 282:
accompagna all’esigenza di ristab
- Page 283 and 284:
al complotto. Si tratta degli ultim
- Page 285 and 286:
partito dal Consiglio Federale due
- Page 287 and 288:
massacrare dal punto di vista media
- Page 289 and 290:
detrattori più frequenti, i cori p
- Page 291 and 292:
Contrada Rita commenta con aria pre
- Page 293 and 294:
I toni del dibattito a Contrada ved
- Page 295 and 296:
un’organizzazione partitica è se
- Page 297 and 298:
Il cambiamento avviene proprio al m
- Page 299 and 300:
CAPITOLO VII - DISCUSSIONE DEI RISU
- Page 301 and 302:
dedicato a Contrada prende avvio da
- Page 303 and 304:
conferiscano alla politica e, con e
- Page 305 and 306:
legittimazione simbolica e cultural
- Page 307 and 308:
in grado di definire Metropolis, qu
- Page 309 and 310:
ideologizzazione, in quanto articol
- Page 311 and 312:
quella società rurale di piccola p
- Page 313 and 314:
attribuita coerenza ideologica prin
- Page 315 and 316:
trovano un repertorio alternativo i
- Page 317 and 318:
“nostra” cultura. Al contrario,
- Page 319 and 320:
piano dell’efficienza del discors
- Page 321 and 322:
territorio in cui le tensioni all
- Page 323 and 324:
confermando quanto emerso in letter
- Page 325 and 326:
(Goffman, 1959) negli eventi di par
- Page 327 and 328:
La militanza è un’appartenenza c
- Page 329 and 330:
A questo tipo di costruzione di gen
- Page 331 and 332:
prestigio sociale derivante dalla c
- Page 333 and 334:
antitesi al fluire non programmato
- Page 335 and 336:
debba necessariamente interessare l
- Page 337 and 338:
allora a gran voce che si torni a d
- Page 339 and 340:
Ma gli interrogativi, in ultima ana
- Page 341 and 342:
dirigenziale leghista - conteso tra
- Page 343 and 344:
ulteriore conferma di un’inevitab
- Page 345 and 346:
L’opera di messa in scena comunit
- Page 347 and 348:
orghesemente decorosa), che si rive
- Page 349 and 350:
“altri” che, per natura e per d
- Page 351 and 352:
militare che regola la vita di sezi
- Page 353 and 354:
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ABRAVANEL
- Page 355 and 356:
BAGNASCO Arnaldo (1977), Tre Italie
- Page 357 and 358:
BLUMER Herbert (1969), Symbolic Int
- Page 359 and 360:
CASTIELLO Restituta (2012), ““I
- Page 361 and 362:
DALTON Russel J. (2004), Democratic
- Page 363 and 364:
DIRKS Nicholas B., ELEY Geoff, ORTN
- Page 365 and 366:
GHERARDI Silvia (2000), “Presenta
- Page 367 and 368:
INGLEHART Ronald (1977), The Silent
- Page 369 and 370:
MAIR Peter (1997), Party System Cha
- Page 371 and 372:
MOSSE George L. (1996), The Images
- Page 373 and 374:
PIZZORNO Alessandro (1980), I sogge
- Page 375 and 376:
SHAPIRO Ian (2004), “Problems, Me
- Page 377 and 378:
TRIGILIA Carlo (1986), Grandi parti