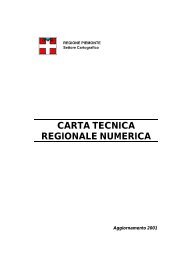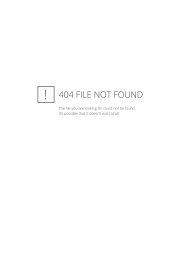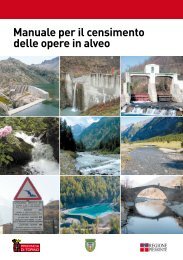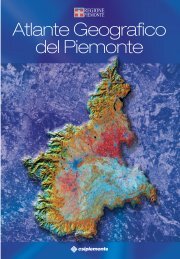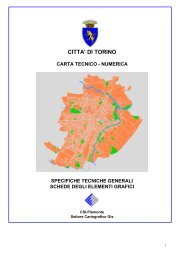della CARTA GEOLOGICA D'ITALIA alla scala 1:50.000
della CARTA GEOLOGICA D'ITALIA alla scala 1:50.000
della CARTA GEOLOGICA D'ITALIA alla scala 1:50.000
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’aspetto più stimolante di questa interpretazione <strong>della</strong> catena è che la parte assiale, che costituisce la<br />
catena collisionale vera e propria, appare completamente svincolata dalle zone più esterne ed interne. In<br />
essa sono contenute tutte le unità che hanno subito una o più degli eventi metamorfici legati <strong>alla</strong><br />
subduzione ed <strong>alla</strong> collisione, e la loro distribuzione all’interno <strong>della</strong> zona assiale non è il frutto di una<br />
evoluzione cilindrica dei domini paleogeografici, ma sembra essere rimessa continuamente in gioco dalle<br />
cinematiche locali. Ne consegue che ogni elemento strutturale <strong>della</strong> catena, definito come unità<br />
tettonostratigrafica (sensu DELA PIERRE et alii, 1997) o unità tettonometamorfica (sensu SPALLA et alii,<br />
1998) può avere una storia tettonometamorfica autonoma rispetto alle unità vicine, e che prima di<br />
effettuare qualsiasi tipo di ricostruzione si dovrà conoscere in modo preciso quale è la storia collisionale<br />
Una ulteriore complicazione dell’assetto geometrico <strong>della</strong> collisione viene introdotto d<strong>alla</strong> complessa<br />
interazione delle cinematiche alpina ed appenninica che avvengono a partire dal Neogene. Il risultato<br />
conferisce <strong>alla</strong> catena la caratteristica forma arcuata del suo settore occidentale che simula una rotazione<br />
antioraria <strong>della</strong> zona di collisione tra la placca europea e quella apula.<br />
La letteratura alpina risente ovviamente di questa complessa evoluzione delle conoscenze ed<br />
interpretazioni, da cui sorge un grave problema di nomenclatura. Questa infatti, ereditata da modelli<br />
passati, non viene ridefinita nelle interpretazioni più recenti. Ne consegue che termini abitualmente<br />
presenti nella bibliografia sono impiegati con significato diverso a seconda degli Autori oppure cambiano<br />
significato col tempo. A questo si aggiunge le naturale inerzia <strong>della</strong> comunità scientifica ad accettare<br />
nuove interpretazioni che mettono in discussione modelli che sembravano consolidati qualche lustro<br />
prima, e soprattutto la nomenclatura che ne consegue.<br />
Un esempio classico è costituito dalle successioni a ofioliti che segnano la sutura oceanica nella catena.<br />
D<strong>alla</strong> primitiva definizione di “Zona delle pietre verdi”, introdotto nella nomenclatura alpina nella metà del<br />
secolo scorso, si è avuto un proliferare di etichette (Zona piemontese dei calcescisti con pietre verdi,<br />
Schistes Lustrés, Ophiolit decke, Ensemble Ligure, Complesso dei calcescisti con pietre verdi, Zona del<br />
Combin, ...) con significato via via paleogeografico, geografico, litostratigrafico, tettonico, metamorfico,<br />
con valenza regionale o locale, che non hanno certo contribuito a semplificare la comprensione al lettore<br />
non specialista.<br />
Nell’area del foglio affiorano estesamente unità appartenenti, nelle interpretazioni classiche, ai “domini<br />
paleogeografici” piemontese e brianzonese. Sembra opportuno quindi fornire qui di seguito un breve<br />
inquadramento regionale delle unità affioranti nell’area, in cui si illustrano anche le scelte effettuate per<br />
1.1. - LE UNITÀ OCEANICHE E OFIOLITICHE DELLE ALPI OCCIDENTALI<br />
Un insieme di successioni che rappresentano la testimonianza del bacino oceanico mesozoico<br />
interposto alle placche europea ed insubrica e definito in letteratura come Bacino Oceanico Ligure<br />
Piemontese (ELTER, 1971; LEMOINE, 1971; DAL PIAZ, 1974a, b) affiora in maniera continua lungo tutto<br />
l’arco alpino occidentale nel settore compreso tra la linea Sestri - Voltaggio ed i ricoprimenti pennidici<br />
inferiori dell’Ossola - Ticino. Altri affioramenti di successioni litologicamente equivalenti si trovano nelle<br />
due finestre tettoniche dell’Engadina e degli Alti Tauri (Alpi orientali), in Corsica nord-orientale e<br />
Negli ultimi decenni queste successioni sono state studiate considerando talora gli aspetti stratigrafici,<br />
talaltra quelli metamorfici o strutturali. Ne è risultato un quadro fortemente innovativo rispetto alle<br />
conoscenze che si avevano all’inizio degli anni settanta, ma anche una oggettiva difficoltà nel configurare<br />
schemi e correlazioni a valenza regionale. Ne risulta infatti un quadro di unità tettoniche differenti<br />
caratterizzate da successioni litostratigrafiche proprie e/o da evoluzioni tettonometamorfiche<br />
indipendenti. Queste unità sono separate da suture di età varia (eoalpine, mesoalpine e neoalpine) che<br />
registrano condizioni metamorfiche proprie di ambienti crostali diversi <strong>della</strong> catena collisionale (CARON et<br />
alii, 1984).<br />
Nelle Alpi Cozie settentrionali fra le unità ritenute deposte nel bacino interposto tra le placche europea<br />
ed insubrica prima <strong>della</strong> collisione continentale, si riconoscono prevalentemente tre tipi di unità:<br />
- unità che mostrano una sicura affinità oceanica, cioè che mostrano o un substrato oceanico o una<br />
copertura sedimentaria che sicuramente si è deposta su un substrato oceanico;