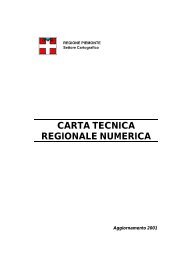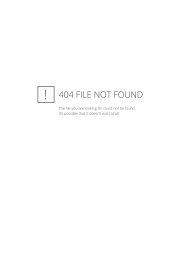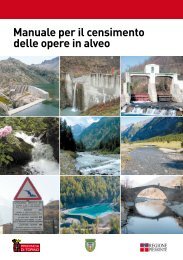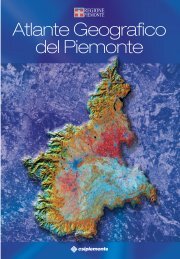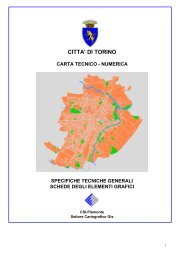della CARTA GEOLOGICA D'ITALIA alla scala 1:50.000
della CARTA GEOLOGICA D'ITALIA alla scala 1:50.000
della CARTA GEOLOGICA D'ITALIA alla scala 1:50.000
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
IV. - BASAMENTO PREQUATERNARIO<br />
Nella “Guida al rilevamento” <strong>della</strong> Carta Geologica d’Italia <strong>alla</strong> <strong>scala</strong> 1:<strong>50.000</strong> (AA.VV., 1992), viene<br />
suggerito di seguire i criteri previsti dall’International Stratigraphic Guide (ISG) (ISSC, 1994), che<br />
prevedono di utilizzare il criterio litostratigrafico in qualsiasi contesto geologico. Le rocce metamorfiche<br />
intensamente deformate dovrebbero quindi, in accordo con la ISG, essere cartografate come formazione,<br />
gruppo ecc. (= unità litostratigrafiche convenzionali) ove i caratteri pre-metamorfici siano ancora ben<br />
riconoscibili, o come complesso quando questi siano sconosciuti o quando i corpi rocciosi siano costituiti<br />
da più tipi litologici con rapporti geometrici complicati.<br />
Volendo seguire questo approccio, ci si è resi conto che l’applicazione rigida <strong>della</strong> litostratigrafia in<br />
aree di catena metamorfica caratterizzate da successioni metasedimentarie, si scontra con sostanziali<br />
problemi di rappresentazione e comporta problemi sia di tipo formale che sostanziale. L’applicazione<br />
rigida di queste regole non consente infatti di rappresentare al meglio la complessa evoluzione postdeposizionale<br />
dei volumi rocciosi e comporta il rischio di cartografare in una sola unità litostratigrafica<br />
successioni di metasedimenti litologicamente simili ma di età diversa, o di distinta provenienza<br />
paleogeografica o che hanno seguito traiettorie significativamente differenti durante l’evoluzione<br />
tettonometamorfica <strong>della</strong> catena. Questo problema si presenta in modo particolare per le monotone<br />
successioni a prevalenti calcescisti che affiorano estesamente nell’area. Una analisi approfondita di queste<br />
DELA PIERRE et alii, (1997).<br />
Nel tentativo di rappresentare in carta il maggior numero di informazioni possibili sulla storia<br />
geologica dei corpi rocciosi si sono utilizzate le unità tettonostratigrafiche, definite come “volumi<br />
rocciosi delimitati da contatti tettonici e contraddistinti da una successione stratigrafica e/o una<br />
sovraimpronta metamorfica e/o un assetto strutturale significativamente diversi da quelli dei volumi<br />
rocciosi adiacenti” (DELA PIERRE et alii, 1997). Qui di seguito vengono descritti i criteri fondamentali e<br />
la filosofia che hanno condotto al rilevamento ed <strong>alla</strong> stesura di una legenda con una impostazione<br />
tettonostratigrafica.<br />
In fase di rilevamento si è privilegiato il riconoscimento di quei caratteri stratigrafici primari<br />
(litostratigrafici) che hanno permesso di definire successioni litostratigrafiche coerenti. Ad esempio nel<br />
caso delle unità a prevalenti calcescisti che affiorano su una buona parte del foglio, si è cercato di mettere<br />
in evidenza successioni litostratigrafiche ad affinità oceanica o continentale sulla base <strong>della</strong> presenza di<br />
ofioliti, <strong>della</strong> loro posizione nella successione litostratigrafica e sulla organizzazione spaziale delle diverse<br />
litofacies. Contemporaneamente si sono messe in evidenza quelle superfici meccaniche di estensione<br />
regionale che potevano rappresentare limiti significativi tra volumi rocciosi ad evoluzione orogenica<br />
indipendente (cfr. ad es. CARON et alii, 1984).<br />
Sono state così riconosciute un certo numero di unità geometriche con caratteristiche interne<br />
omogenee. L’analisi <strong>della</strong> storia post-deposizionale delle singole unità geometriche ha permesso quindi di<br />
ricostruire la loro evoluzione tettonometamorfica, utilizzando indagini petrografiche, strutturali,<br />
petrologiche e geochimiche.<br />
In fase di sintesi sono state poi definite le unità tettonostratigrafiche descritte in legenda, raggruppando<br />
quelle unità geometriche che mostravano stratigrafia correlabile ed evoluzione orogenica confrontabile.<br />
All’interno di ogni unità tettonostratigrafica, delimitata da superfici tettoniche duttili o fragili, le unità<br />
litostratigrafiche (potenzialmente formalizzabili) ed i complessi sono state disposte secondo i normali<br />
criteri stratigrafici (dal basso verso l’alto stratigrafico).<br />
Poiché si ritiene che una carta al 1:<strong>50.000</strong> possa ancora essere utilizzata come uno strumento analitico,<br />
nella definizione <strong>della</strong> legenda si è evitato di fornire attribuzioni paleogeografiche, al fine di ridurre al<br />
massimo l’interpretazione. Seguendo l’approccio tettonostratigrafico, la legenda è stata quindi<br />
organizzata costituendo gruppi omogenei di unità in cui sono state inserite le unità di margine<br />
continentale, le unità oceaniche, quelle ofiolitiche ed isolando infine quelle unità il cui ambiente<br />
deposizionale era di difficile localizzazione. Nelle unità di margine continentale sono state comprese sia<br />
le unità di basamento mono- e polimetamorfico, sia quelle di copertura mesozoica. Per quanto concerne le<br />
unità a calcescisti prevalenti è stato distinto un gruppo di unità definite come oceaniche, in cui si è potuta<br />
ricostruire una successione sedimentaria ad affinità ligure (cioè deposta su crosta oceanica), un gruppo di<br />
ofiolitiche, cioè contenenti ofioliti ma che non mostrano successioni ad evidente affinità