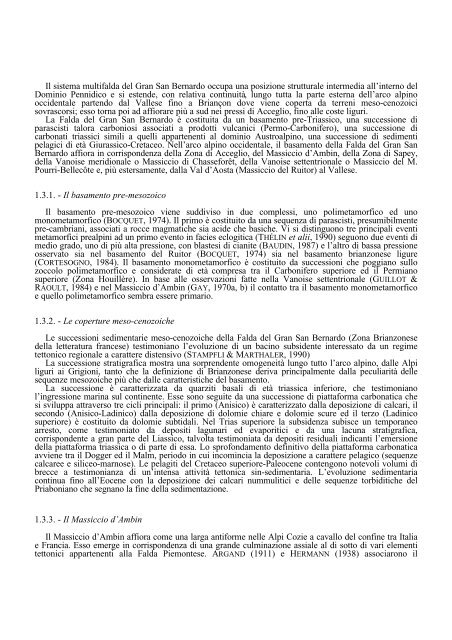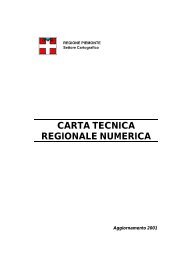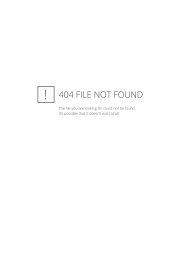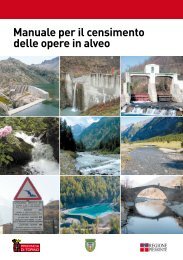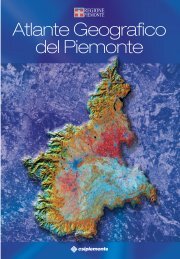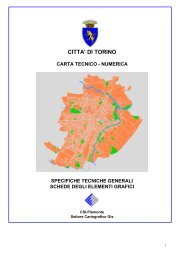della CARTA GEOLOGICA D'ITALIA alla scala 1:50.000
della CARTA GEOLOGICA D'ITALIA alla scala 1:50.000
della CARTA GEOLOGICA D'ITALIA alla scala 1:50.000
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Il sistema multifalda del Gran San Bernardo occupa una posizione strutturale intermedia all’interno del<br />
Dominio Pennidico e si estende, con relativa continuità, lungo tutta la parte esterna dell’arco alpino<br />
occidentale partendo dal Vallese fino a Briançon dove viene coperta da terreni meso-cenozoici<br />
sovrascorsi; esso torna poi ad affiorare più a sud nei pressi di Acceglio, fino alle coste liguri.<br />
La Falda del Gran San Bernardo è costituita da un basamento pre-Triassico, una successione di<br />
parascisti talora carboniosi associati a prodotti vulcanici (Permo-Carbonifero), una successione di<br />
carbonati triassici simili a quelli appartenenti al dominio Austroalpino, una successione di sedimenti<br />
pelagici di età Giurassico-Cretaceo. Nell’arco alpino occidentale, il basamento <strong>della</strong> Falda del Gran San<br />
Bernardo affiora in corrispondenza <strong>della</strong> Zona di Acceglio, del Massiccio d’Ambin, <strong>della</strong> Zona di Sapey,<br />
<strong>della</strong> Vanoise meridionale o Massiccio di Chasseforêt, <strong>della</strong> Vanoise settentrionale o Massiccio del M.<br />
Pourri-Bellecôte e, più estersamente, d<strong>alla</strong> Val d’Aosta (Massiccio del Ruitor) al Vallese.<br />
1.3.1. - Il basamento pre-mesozoico<br />
Il basamento pre-mesozoico viene suddiviso in due complessi, uno polimetamorfico ed uno<br />
monometamorfico (BOCQUET, 1974). Il primo è costituito da una sequenza di parascisti, presumibilmente<br />
pre-cambriani, associati a rocce magmatiche sia acide che basiche. Vi si distinguono tre principali eventi<br />
metamorfici prealpini ad un primo evento in facies eclogitica (THÉLIN et alii, 1990) seguono due eventi di<br />
medio grado, uno di più alta pressione, con blastesi di cianite (BAUDIN, 1987) e l’altro di bassa pressione<br />
osservato sia nel basamento del Ruitor (BOCQUET, 1974) sia nel basamento brianzonese ligure<br />
(CORTESOGNO, 1984). Il basamento monometamorfico è costituito da successioni che poggiano sullo<br />
zoccolo polimetamorfico e considerate di età compresa tra il Carbonifero superiore ed il Permiano<br />
superiore (Zona Houillère). In base alle osservazioni fatte nella Vanoise settentrionale (GUILLOT &<br />
RAOULT, 1984) e nel Massiccio d’Ambin (GAY, 1970a, b) il contatto tra il basamento monometamorfico<br />
e quello polimetamorfico sembra essere primario.<br />
1.3.2. - Le coperture meso-cenozoiche<br />
Le successioni sedimentarie meso-cenozoiche <strong>della</strong> Falda del Gran San Bernardo (Zona Brianzonese<br />
<strong>della</strong> letteratura francese) testimoniano l’evoluzione di un bacino subsidente interessato da un regime<br />
tettonico regionale a carattere distensivo (STAMPFLI & MARTHALER, 1990)<br />
La successione stratigrafica mostra una sorprendente omogeneità lungo tutto l’arco alpino, dalle Alpi<br />
liguri ai Grigioni, tanto che la definizione di Brianzonese deriva principalmente d<strong>alla</strong> peculiarità delle<br />
sequenze mesozoiche più che dalle caratteristiche del basamento.<br />
La successione è caratterizzata da quarziti basali di età triassica inferiore, che testimoniano<br />
l’ingressione marina sul continente. Esse sono seguite da una successione di piattaforma carbonatica che<br />
si sviluppa attraverso tre cicli principali: il primo (Anisico) è caratterizzato d<strong>alla</strong> deposizione di calcari, il<br />
secondo (Anisico-Ladinico) d<strong>alla</strong> deposizione di dolomie chiare e dolomie scure ed il terzo (Ladinico<br />
superiore) è costituito da dolomie subtidali. Nel Trias superiore la subsidenza subisce un temporaneo<br />
arresto, come testimoniato da depositi lagunari ed evaporitici e da una lacuna stratigrafica,<br />
corrispondente a gran parte del Liassico, talvolta testimoniata da depositi residuali indicanti l’emersione<br />
<strong>della</strong> piattaforma triassica o di parte di essa. Lo sprofondamento definitivo <strong>della</strong> piattaforma carbonatica<br />
avviene tra il Dogger ed il Malm, periodo in cui incomincia la deposizione a carattere pelagico (sequenze<br />
calcaree e siliceo-marnose). Le pelagiti del Cretaceo superiore-Paleocene contengono notevoli volumi di<br />
brecce a testimonianza di un’intensa attività tettonica sin-sedimentaria. L’evoluzione sedimentaria<br />
continua fino all’Eocene con la deposizione dei calcari nummulitici e delle sequenze torbiditiche del<br />
Priaboniano che segnano la fine <strong>della</strong> sedimentazione.<br />
1.3.3. - Il Massiccio d’Ambin<br />
Il Massiccio d’Ambin affiora come una larga antiforme nelle Alpi Cozie a cavallo del confine tra Italia<br />
e Francia. Esso emerge in corrispondenza di una grande culminazione assiale al di sotto di vari elementi<br />
tettonici appartenenti <strong>alla</strong> Falda Piemontese. ARGAND (1911) e HERMANN (1938) associarono il