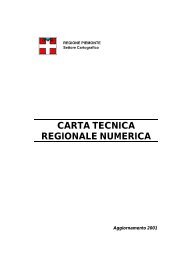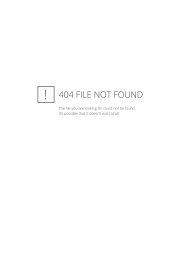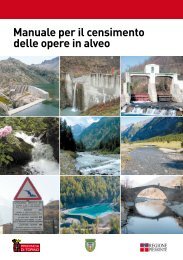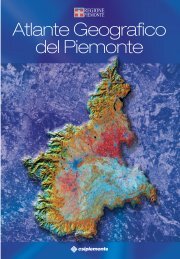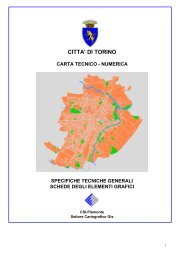della CARTA GEOLOGICA D'ITALIA alla scala 1:50.000
della CARTA GEOLOGICA D'ITALIA alla scala 1:50.000
della CARTA GEOLOGICA D'ITALIA alla scala 1:50.000
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
II. - CARATTERI GEOGRAFICI E GEOMORFOLOGICI<br />
Dal punto di vista geografico e geomorfologico l’elemento dominante è rappresentato dal bacino<br />
<strong>della</strong> Dora Riparia (Valle di Susa s.l.), che nel suo complesso costituisce un sistema di drenaggio<br />
vallivo molto articolato ed esteso. Il sistema <strong>della</strong> Valle di Susa è convenzionalmente suddiviso in<br />
tre parti:<br />
- l’alta valle, che comprende il settore altimetricamente più elevato del sistema vallivo,<br />
dall’attuale spartiacque alpino (rilievi mediamente intorno ai 3.000 m) fino <strong>alla</strong> piana di Oulx-<br />
Salbertrand (1.000 m); qui confluiscono la Dora di Cesana (da Sud), alimentata dai corsi d’acqua<br />
tributari <strong>della</strong> Valle di Thuràs e <strong>della</strong> Valle Ripa, e la Dora di Bardonecchia (da Ovest), a sua volta<br />
alimentata nel tratto iniziale d<strong>alla</strong> Valle Stretta e d<strong>alla</strong> Valle di Rochemolles;<br />
- la media valle, d<strong>alla</strong> Piana di Oulx-Salbertrand, a valle <strong>della</strong> confluenza dei due rami <strong>della</strong><br />
Dora, fino <strong>alla</strong> soglia di Susa (500 m), prima <strong>della</strong> confluenza fra la Dora Riparia ed il Torrente<br />
Cenischia;<br />
- la bassa valle, d<strong>alla</strong> confluenza con la Val Cenischia (compresa) fino allo sbocco in pianura<br />
<strong>della</strong> valle principale (300 m), dove si trovano le colline moreniche dell’Anfiteatro di Rivoli-<br />
Avigliana.<br />
L’area del Foglio “Bardonecchia” comprende il ramo nord-occidentale dell’alta Valle di Susa e<br />
l’intero segmento <strong>della</strong> media Valle di Susa. Inoltre, ai margini SE e NE dell’area, il foglio si<br />
estende, rispettivamente, per un breve tratto nell’adiacente alta Val Chisone e in parte sul versante<br />
destro <strong>della</strong> Val Cenischia.<br />
I rilievi maggiori si ritrovano lungo l’attuale spartiacque principale alpino: Rocca d’Ambin<br />
(3.378 m), Rognosa d’Etiache (3.382 m), Punta Pierre Menue (3.508 m e massima elevazione<br />
dell’area), Rocca Bernauda (3.226 m), Punta Charra (2.984 m), Punta Clotesse (2.872 m). Lo<br />
spartiacque Susa-Chisone è caratterizzato da rilievi meno elevati: M. Genevris (2.583 m), Testa di<br />
Mottas (2.647 m), Punta del Gran Serin (2.689 m), Cima delle Vallette (2.743 m). Nel breve tratto<br />
di spartiacque Susa-Cenischia il rilievo principale è costituito d<strong>alla</strong> Punta Toasso Bianco (2.622 m).<br />
Dal punto di vista orografico va anche ricordato che in questo settore alpino vi sono alcuni<br />
importanti valichi, altimetricamente poco elevati e talora morfologicamente fra i più favorevoli per<br />
attraversare la catena alpina. I più importanti sono il Colle del Moncenisio (2.083 m, che mette in<br />
comunicazione la Valle dell’Arc e la Val Cenischia), il Colle <strong>della</strong> Scala (1.762 m, fra la Valle<br />
Stretta e la Valle <strong>della</strong> Clarée) e il Colle del Monginevro (1.850 m). Tramite il Colle del Sestriere<br />
(2.035 m) inoltre la Valle di Susa è messa in comunicazione con la Val Chisone.<br />
L’orientazione più frequente e persistente degli elementi idrografici e orografici è la direzione<br />
NE-SO (es. Val Chisone, media Valle di Susa, Vallone di Rochemolles). Nei settori orientale ed<br />
occidentale del foglio sono invece prevalenti le direzioni NNW-SSE (es. Val Clarea) e NNE-SSW<br />
(reticolato affluente <strong>della</strong> Dora di Bardonecchia). Anche la posizione dei principali valichi alpini<br />
risulta interposta a segmenti del reticolato idrografico che seguono, sui due versanti adiacenti, le<br />
suddette direzioni prevalenti. L’insieme di queste caratteristiche riflette il condizionamento <strong>alla</strong><br />
morfogenesi indotto tanto dall’assetto litostrutturale regionale e locale che dall’evoluzione tettonica<br />
recente di questo settore <strong>della</strong> catena alpina (cfr. paragrafo “Neotettonica”).<br />
L’elevato grado d’incisione di numerosi tratti delle valli Susa e Chisone testimonia il forte<br />
approfondimento erosionale registratosi soprattutto lungo le direttrici NE-SW: questo fenomeno<br />
esercita un importante controllo anche sull’andamento dell’attuale spartiacque principale alpino,<br />
che proprio nel settore del Foglio “Bardonecchia” si incunea profondamente verso Ovest, cioè verso<br />
l’esterno <strong>della</strong> catena. La Valle di Susa rappresenta, come le altre principali valli alpine del margine<br />
padano, una direttrice di drenaggio persistente nella fase di progressiva migrazione dello<br />
spartiacque alpino verso l’esterno, instauratasi sin dal Miocene. L’attuale testata <strong>della</strong> Valle di Susa<br />
costituirebbe quindi un settore di bacino che originariamente drenava verso Ovest. L’evoluzione<br />
geomorfologica di questo settore montuoso può essere dedotta dalle forme di mo<strong>della</strong>mento del<br />
rilievo e dalle formazioni superficiali (cfr. paragrafo “Copertura pliocenico-quaternaria”).<br />
Chiarissime sono le tracce del mo<strong>della</strong>mento glaciale pleistocenico, soprattutto quelle legate<br />
all’ultima fase di massima espansione (Last Glacial Maximum, LGM), in cui il ghiacciaio<br />
principale <strong>della</strong> Valle di Susa ha raggiunto (come del resto nelle precedenti fasi di massima<br />
espansione) lo sbocco in pianura costruendo l’Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana. La scarsità<br />
di testimonianze glaciali più antiche <strong>della</strong> fase LGM è imputabile all’importante azione erosiva<br />
operata dal ghiacciaio nella sua ultima fase di espansione glaciale e al nuovo mo<strong>della</strong>mento imposto<br />
dal reticolato idrografico post-glaciale. A differenza delle valli Susa e Cenischia, nel tratto dell’alta<br />
Val Chisone compreso entro il Foglio “Bardonecchia” non si rinvengono tracce di un ghiacciaio<br />
principale che occupava l’intero sistema vallivo: sono invece riconoscibili forme e depositi legati ai<br />
ghiacciai delle valli tributarie, che nelle fasi di massima espansione potevano anche raggiungere ed<br />
occupare parte del fondovalle principale. Casi analoghi alle valli tributarie <strong>della</strong> Val Chisone si<br />
registrano anche nella media Valle di Susa; in particolare la Val Clarea presenta al suo sbocco nella