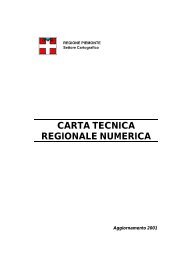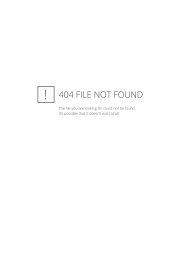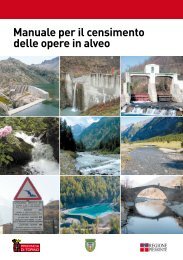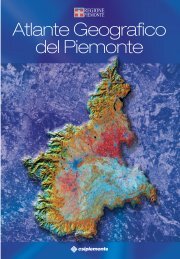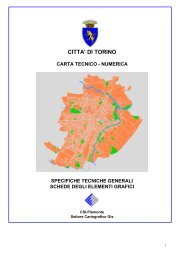della CARTA GEOLOGICA D'ITALIA alla scala 1:50.000
della CARTA GEOLOGICA D'ITALIA alla scala 1:50.000
della CARTA GEOLOGICA D'ITALIA alla scala 1:50.000
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
depositi attribuiti a più eventi erosivo-deposizionali, talvolta non suddivisibile in unità di rango inferiore<br />
per mancanza di elementi.<br />
Diverso è il caso di quei depositi prodotti da eventi a carattere locale (es. il distacco di una frana<br />
oppure la formazione e l’interramento di un bacino lacustre), svincolati d<strong>alla</strong> combinazione dei fattori che<br />
controllano l’evoluzione complessiva del bacino nel quale è invece in atto una generalizzata fase erosiva;<br />
anche se le discontinuità che delimitano i corpi sedimentari sono evidenti, il carattere episodico e<br />
circoscritto di questi eventi ha in tal caso suggerito di applicare il criterio litostratigrafico, cartografando i<br />
depositi come “Unità non distinte in base al bacino di pertinenza”.<br />
In legenda le unità relative <strong>alla</strong> copertura pliocenico-quaternaria sono state ordinate in base al<br />
perdurare dei processi responsabili <strong>della</strong> messa in posto delle singole unità, ed in secondo luogo in base al<br />
bacino di pertinenza. In quest’ottica sono state definite come “Unità completamente formate” le unità<br />
deposizionali attualmente svincolate dall’agente fisico al quale sono geneticamente legate (es. un lembo di<br />
depositi fluviali attualmente non più inondabile da parte del corso d’acqua che l’ha generato); queste<br />
unità, quando non sepolte, sono soggette a rimo<strong>della</strong>mento. Le unità deposizionali generate da processi<br />
fisici potenzialmente riattivabili sono invece raggruppate nelle “Unità in formazione”. Il fatto che un’unità<br />
non sia più in rapporto con l’agente che l’ha generata non significa tuttavia che questa sia stabilizzata: ad<br />
esempio un accumulo di frana non più in rapporto con la sua nicchia di distacco può essere rimobilizzato<br />
dall’erosione al piede da parte di un corso d’acqua; oppure la superficie terrazzata di un deposito<br />
alluvionale completamente formato, se non viene più invasa dalle acque del corso d’acqua al quale è<br />
legata geneticamente, può essere inondata dal reticolato idrografico affluente.<br />
L’approccio allostratigrafico richiede imprescindibilmente che nella carta geologica vengano distinte<br />
tra loro unità, anche se in prima approssimazione coeve, appartenenti a bacini idrografici diversi.<br />
L’evoluzione di un determinato settore <strong>della</strong> superficie terrestre è infatti controllata non solo da variabili<br />
climatiche, come ritenuto in passato, ma anche di natura geodinamica, litologica e morfologica. La<br />
combinazione di più fattori fa sì che ciascun bacino idrografico abbia una propria storia evolutiva e, in<br />
ultima analisi, una successione di forme e depositi che non è mai direttamente correlabile con quella di un<br />
altro. Ciò ha comportato il riconoscimento di successioni sedimentarie distinte per ciascuno dei tre bacini<br />
maggiori in cui si articola l’area di studio: la Val Cenischia, la Valle di Susa e la Val Chisone. Ad ogni<br />
unità corrisponde pertanto un colore che è stato graficamente diversificato mediante l’adozione di un<br />
retino con orientazione diversa a seconda del bacino di appartenenza.<br />
Nell’area del foglio sono tuttavia comprese solo la media ed alta Valle di Susa e settori marginali <strong>della</strong><br />
Val Cenischia e <strong>della</strong> Val Chisone. Per ricostruire le successioni complete di ciascun bacino si è quindi<br />
fatto riferimento, oltre ai dati provenienti dal contiguo Foglio “Susa”, anche ai risultati di una serie di<br />
studi condotti in aree limitrofe come tesi di laurea presso il Dipartimento di Scienze <strong>della</strong> Terra<br />
dell’Università di Torino, applicando la stessa metodologia 2.<br />
Non essendo attualmente disponibile per il Quaternario una <strong>scala</strong> cronologica di riferimento<br />
formalmente accettata d<strong>alla</strong> comunità scientifica internazionale, si precisa che è stata qui adottata quella<br />
proposta da Richmond (cfr. AIQUA, 1982), modificata, che si riporta di seguito. Tutte le datazioni<br />
proposte sono state ricavate da dati pedostratigrafici, calibrati, provenienti da aree esterne al foglio.<br />
OLOCENE<br />
———————————————————-0.01 Ma<br />
PLEISTOCENE SUPERIORE<br />
———————————————————-0.13 Ma<br />
PLEISTOCENE MEDIO<br />
———————————————————-0.73 Ma.<br />
PLEISTOCENE INFERIORE<br />
==================================1.67 Ma<br />
PLIOCENE<br />
1. - UNITA’ COMPLETAMENTE FORMATE NON DISTINTE IN BASE AL BACINO DI<br />
PERTINENZA<br />
Unità del Segurét - La Riposa (slr) (Pliocene? - Pleistocene sup.)