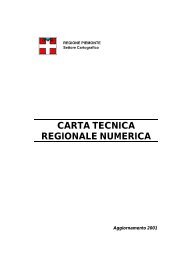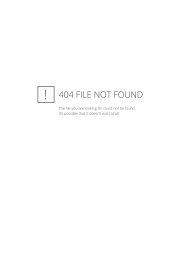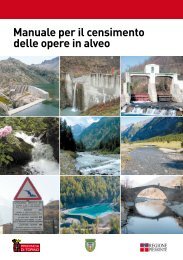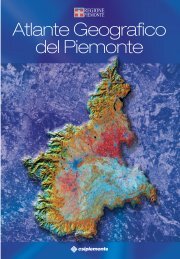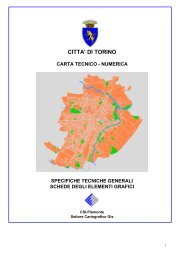della CARTA GEOLOGICA D'ITALIA alla scala 1:50.000
della CARTA GEOLOGICA D'ITALIA alla scala 1:50.000
della CARTA GEOLOGICA D'ITALIA alla scala 1:50.000
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Dolomie stratificate grigie, a patina di alterazione biancastra, in bancate massicce di potenza metrica.<br />
Al tetto degli strati si riconoscono frequentemente lamine ondulate di spessore millimetrico, di probabile<br />
origine algale, e brecce da disseccamento a clasti piatti che testimoniano una deposizione avvenuta in<br />
ambiente tidale. Potenti alcune decine di metri, sono stati attribuite al Norico per analogia litologica con<br />
le successioni piemontesi di margine continentale, datate paleontologicamente (ad es. MEGARD GALLI,<br />
1974; POLINO et alii, 1983) ed affioranti <strong>alla</strong> base <strong>della</strong> successione dell’unità dello Chaberton - Grand<br />
Hoche - Grand Argentier.<br />
Scisti di Côte Belle (ccb)<br />
Costituiti da scisti filladici alternati a marmi grigi di aspetto “nodulare” e a livelli di dolomie a<br />
lumachelle. Affiorano esclusivamente in destra orografica del Rio Segurét, a quota 2800 circa, ove<br />
poggiano con contatto netto sulle sottostanti dolomie e sono potenti alcuni metri. Lateralmente, gli scisti<br />
di Côte Belle mancano per erosione e le dolomie dello Chaberton sono seguite direttamente dai<br />
metasedimenti carbonatici del complesso di Valfredda.<br />
Nonostante il limitato spessore, gli scisti di Côte Belle sono confrontabili con i metasedimenti datati al<br />
Retico - Hettangiano delle successioni del Pic de Roche Brune (DUMONT, 1983) e dello Chaberton -<br />
Grand Hoche (POLINO et alii, 1983). Si tratta di originari sedimenti di piattaforma esterna, testimonianti<br />
il progressivo annegamento <strong>della</strong> piattaforma carbonatica norica.<br />
Complesso di Valfredda<br />
Unità litostratigrafica costituita prevalentemente da calcescisti, in cui sono stati distinti:<br />
- cva: alternanze di calcescisti a patina rugginosa a mica bianca, clorite, glaucofane e di marmi grigioscuri<br />
in livelli di potenza decimetrica. A questi metasedimenti si intercalano potenti livelli di brecce a<br />
cemento carbonatico (cva a) che localmente (Grange di Valfredda) poggiano direttamente sulle dolomie<br />
noriche tramite un’evidente superficie erosionale. Le brecce sono costituite da clasti eterometrici di<br />
dimensioni da centimetriche a metriche di rocce carbonatiche (dolomie, marmi scuri) e silicee (quarziti<br />
micacee, micascisti). Questi ultimi sono decisamente preponderanti, raggiungono dimensioni cospicue e<br />
sono spesso spigolosi ed allungati. La potenza delle brecce diminuisce verso il tetto <strong>della</strong> successione.<br />
L’età dei metasedimenti sopra descritti non è conosciuta. Sulla base <strong>della</strong> loro posizione stratigrafica<br />
essi vengono riferiti al Giurassico, in accordo con ALLENBACH & CARON (1986);<br />
- cvb: scisti filladici nerastri, con rare intercalazioni carbonatiche. Questi metasedimenti, affiorano per<br />
poche decine di metri lungo la cresta Vallonetto - Vin Vert e rappresentano facies di black shales riferibili<br />
<strong>alla</strong> parte alta del Cretacico inferiore (DUMONT, 1983; POLINO et alii, 1983; ALLENBACH & CARON,<br />
1986);<br />
- cvc: calcescisti grigiastri a patina di alterazione rugginosa, fissili, dal tipico detrito in scaglie<br />
decimetriche. Affiorano all’estremità sud-occidentale <strong>della</strong> cresta Vallonetto - Vin Vert, ove poggiano<br />
con contatto netto sulle facies tipo black shale (cvb) e su entrambi i versanti <strong>della</strong> Valfredda, ove<br />
riposano in discordanza sui metasedimenti riferiti al Giurassico (cva).<br />
I calcescisti possono essere confrontati con i termini sommitali <strong>della</strong> successione dell’unità dello<br />
Chaberton - Grand Hoche e vengono pertanto riferiti al Cretacico superiore (Aptiano? - Cenomaniano?<br />
secondo ALLENBACH & CARON, 1986). Mostrano una foliazione tettonica definita da mica bianca, clorite<br />
± rutilo e rara biotite tardiva.<br />
1.5. - UNITÀ TETTONOSTRATIGRAFICA DELLO CHABERTON - GRAND HOCHE - GRAND ARGENTIER<br />
Affiora estesamente nel settore SW del foglio, lungo la dorsale Punta Clotesse - Punta Charrà, a tetto<br />
dell’unità oceanica del Lago Nero su cui riposa tramite un piano di sovrascorrimento a basso angolo. Altri<br />
affioramenti, più limitati come estensione, si rinvengono a Ovest dell’abitato di Melezet sino <strong>alla</strong> cresta di<br />
confine con la Francia, tra il Colle <strong>della</strong> Rho e la Punta Nera (Grand Argentier). Questi affioramenti sono<br />
interpretabili come scaglie pizzicate nella zona di taglio che separa l’unità tettonostratigrafica dei Re Magi<br />
dalle successioni a prevalenti calcescisti dell’unità del Lago Nero.<br />
La successione stratigrafica, osservabile in tutto il suo sviluppo lungo la dorsale Grand Hoche - Punta<br />
Charrà, è costituita da una potente successione di margine continentale, di grado metamorfico molto<br />
MARINI et alii, 1983), che conserva ancora abbastanza chiaramente i caratteri<br />
sedimentari originari nonostante la deformazione alpina. E’ l’unica unità tettonostratigrafica in cui sono<br />
stati ritrovati fossili in buon stato di conservazione.<br />
La successione è costituita da: