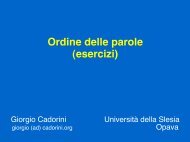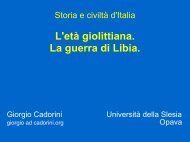- Page 1 and 2: UNIVERZITA MATEJA BELA FAKULTA HUMA
- Page 3 and 4: OBSAH Predhovor 8 Italské divadeln
- Page 5 and 6: des personnes francophones et finno
- Page 7 and 8: Dor e resistência na poesia de Man
- Page 9 and 10: ITALSKÉ DIVADELNÍ ADAPTACE HRABAL
- Page 11 and 12: Zcela jiným způsobem se ujal zpra
- Page 13 and 14: Bohumila Hrabala, oba autoři se sh
- Page 15 and 16: LA LINGUA DELLA CHIESA IERI E OGGI:
- Page 17: Egidio Colonna in un passo del De r
- Page 21 and 22: poveri, saggi e stolti, letterati e
- Page 23 and 24: comune («Melius est reprehendant n
- Page 25 and 26: C’è anche chi, in materia di rec
- Page 27 and 28: trasmetterne i “diari” edifican
- Page 29 and 30: L’EMPLOI DES EMBRAYEURS DE PERSON
- Page 31 and 32: Des programmes pour découvrir les
- Page 33 and 34: Cet exemple n’est pas une annonce
- Page 35 and 36: LA DIVULGAZIONE CULTURALE IN LINGUA
- Page 37 and 38: vista prettamente trentino 5 o per
- Page 39 and 40: fin dal 1774. Solo i testi che avev
- Page 41 and 42: lingua’, ‘buon gusto’ o ‘bu
- Page 43 and 44: piuttosto scarse, anche se sappiamo
- Page 45 and 46: century turns out to be an unexplor
- Page 47 and 48: LES DIVERS SENS DU VERBE CHANTER DA
- Page 49 and 50: En plus, nous avons trouvé très p
- Page 51 and 52: LA ROMÀNIA ESTERNA Giorgio Cadorin
- Page 53 and 54: Un romanista che si ribellò all'ac
- Page 55 and 56: Ai nostri giorni, sperando che le s
- Page 57 and 58: Diversi autori ritengono improbabil
- Page 59 and 60: L’ORDINE DELLE PAROLE NELL’ITAL
- Page 61 and 62: della somma’) si registra subito
- Page 63 and 64: quantificati, preceduti facoltativa
- Page 65 and 66: 3. La posizione del sintagma aggett
- Page 67 and 68: Analizzando l’aspetto dell’ordi
- Page 69 and 70:
GEBERT, L. 2007. Considerazioni sul
- Page 71 and 72:
espacios o rincones en penumbra rep
- Page 73 and 74:
2. Notas sobre el ingenio y el Barr
- Page 75 and 76:
constituya ‛la facultad inventiva
- Page 77 and 78:
verdad y la belleza’, sino la de
- Page 79 and 80:
RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F. 2002. Bar
- Page 81 and 82:
2. Breve historia de los gitanos en
- Page 83 and 84:
una serie de rasgos peculiares, lo
- Page 85 and 86:
Bibliografía ADIEGO, I.-X. 2002. U
- Page 87 and 88:
NOUVEAUX ASPECTS DANS L’ENSEIGNEM
- Page 89 and 90:
exemple sur le Journal télévisé
- Page 91 and 92:
LA QUESTIONE DELLA LINGUA ITALIANA
- Page 93 and 94:
di queste zone, che sono spesso anc
- Page 95 and 96:
La fine della latinità medioevale
- Page 97 and 98:
formarsi di più comunità d’inte
- Page 99 and 100:
PICCHIO, R. 1991. Letteratura della
- Page 101 and 102:
Le Karagöz se définit comme une a
- Page 103 and 104:
simple répétition d’un geste, d
- Page 105 and 106:
Il y a un autre procédé appelé
- Page 107 and 108:
Bibliographie AĞILDERE, S. 2006. B
- Page 109 and 110:
francés y español), disciplina qu
- Page 111 and 112:
primordialmente en el espacio de la
- Page 113 and 114:
según la tesis de I. Hrušovský,
- Page 115 and 116:
HACIA UNA CLASIFICACIÓN JERÁRQUIC
- Page 117 and 118:
sucesivamente. Los diferentes tipos
- Page 119 and 120:
2.2.2. Rama 1.1. Delimitación parc
- Page 121 and 122:
(5) b. Algo incluido en la bañera
- Page 123 and 124:
LA NOVELA HISTÓRICA POSMODERNA. UN
- Page 125 and 126:
La reacción del público y de la c
- Page 127 and 128:
organizador del exterminio de los j
- Page 129 and 130:
ni son para crear mal ambiente, pre
- Page 131 and 132:
Bajo la bandera del Petit Cabrón A
- Page 133 and 134:
the generation of a so-called “pa
- Page 135 and 136:
2. Structures à verbe support Les
- Page 137 and 138:
cas pour dať prednosť - uprednost
- Page 139 and 140:
Slovak verb dať lends itself very
- Page 141 and 142:
autres langues. On peut donc penser
- Page 143 and 144:
fonction ou le placer dans une pers
- Page 145 and 146:
équivalents dans les autres langue
- Page 147 and 148:
etrouver dans toutes les langues. L
- Page 149 and 150:
sens tant dans ce qu’ils ont de s
- Page 151 and 152:
TERMINOLOGIE LINGUISTIQUE : QUELQUE
- Page 153 and 154:
De ce fait la définition ne pourra
- Page 155 and 156:
vedette. La structure minimale de l
- Page 157 and 158:
Informations administratives Les ru
- Page 159 and 160:
(NT/ENC) Každá veta sa skladá z
- Page 161 and 162:
MARGUERITE DURAS : REINE MASQUÉE T
- Page 163 and 164:
décrire. Dans la nature, loin de n
- Page 165 and 166:
Summary L’Amant and Un Barrage Co
- Page 167 and 168:
icorso allo stile nominale e a tecn
- Page 169 and 170:
urocratese 7 . Un’antilingua, dot
- Page 171 and 172:
funzionalità comunicativa del ling
- Page 173 and 174:
Nonostante gli indubbi elementi di
- Page 175 and 176:
RWANDA, PAYS FRANCOPHONE ET/OU ANGL
- Page 177 and 178:
mal perçue au Rwanda à cause du r
- Page 179 and 180:
TRADUCCIÓN COMO MANIPULACIÓN Y MA
- Page 181 and 182:
tanto cualquier deliberación al re
- Page 183 and 184:
En el segundo ejemplo se nota que e
- Page 185 and 186:
Oprócz chłopaka z wąsami i w kra
- Page 187 and 188:
por lo menos algunas de ellas, son
- Page 189 and 190:
papel del profesor. El profesor dej
- Page 191 and 192:
Según los datos presentados en la
- Page 193 and 194:
estudiantes del NB opina que el uso
- Page 195 and 196:
L’aspettualità verbale tra l’u
- Page 197 and 198:
‘operatore di soggettività’ (c
- Page 199 and 200:
3. L’argomento da noi enunciato
- Page 201 and 202:
COMRIE, B. 1983. Universali del lin
- Page 203 and 204:
CONSIDERAZIONI SUL MODO DEONTICO IN
- Page 205 and 206:
un atto illocutorio di richiesta. L
- Page 207 and 208:
il significato di necessità viene
- Page 209 and 210:
Bibliografia ALISOVA, T. 1972. Stru
- Page 211 and 212:
STATI, S. 1982. Il dialogo. Conside
- Page 213 and 214:
des contes et nouvelles intitulés
- Page 215 and 216:
Il avait, en effet, Monsieur, un ef
- Page 217 and 218:
aujourd’hui sous le nom d’écri
- Page 219 and 220:
(Bel-Ami et autres contes) qui ne c
- Page 221 and 222:
interesante investigar los aspectos
- Page 223 and 224:
originalidad discrepa con la exigen
- Page 225 and 226:
LE VARIAZIONI DELLA FIGURA DI MEDEA
- Page 227 and 228:
La vita che ti diedi è un dramma d
- Page 229 and 230:
Il teatro di Rosso diventa una spec
- Page 231 and 232:
Poiché la Madre riesce a sacrifica
- Page 233 and 234:
teatrale in questione, analogamente
- Page 235 and 236:
principio di femminilità dominante
- Page 237 and 238:
LES ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE D
- Page 239 and 240:
littéralement et linguistiquement
- Page 241 and 242:
POURQUOI CONTRASTER DEUX LANGUES NO
- Page 243 and 244:
enfants, l’effet de l’expérien
- Page 245 and 246:
En ce qui concerne les traits non v
- Page 247 and 248:
Le dispositif d'enrichissement de l
- Page 249 and 250:
Cette affirmation de principe impli
- Page 251 and 252:
La Commission générale transmet e
- Page 253 and 254:
15 AÑOS DE ESTUDIO DE HISPANÍSTIC
- Page 255 and 256:
asignaturas que todavía no dispone
- Page 257 and 258:
principalmente del léxico especial
- Page 259 and 260:
Seminář Asociace učitelů špan
- Page 261 and 262:
Además, Lázaro Carreter 3 adviert
- Page 263 and 264:
4. Siglas El léxico de las TIC se
- Page 265 and 266:
RÉFLEXIONS SUR LA PLACE DE LA PHRA
- Page 267 and 268:
cette discipline. G. Gréciano a fo
- Page 269 and 270:
MEJRI, S. 1998. Structuration séma
- Page 271 and 272:
omanos no sólo eran buenos soldado
- Page 273 and 274:
Debido a que nos propusimos describ
- Page 275 and 276:
En la tabla que exponemos a continu
- Page 277 and 278:
en obras que resultan al mismo tiem
- Page 279 and 280:
tiempos democráticos y en distingu
- Page 281 and 282:
27-28). Como cada estereotipo el es
- Page 283 and 284:
EL ESPAÑOL DE AMÉRICA: ACTUALIDAD
- Page 285 and 286:
los compendios normativos más impo
- Page 287 and 288:
El Proyecto Panhispánico de léxic
- Page 289 and 290:
LÓPEZ MORALES, H. 2005. Breve hist
- Page 291 and 292:
que se puede definir como una inter
- Page 293 and 294:
negociador debe ser también un bue
- Page 295 and 296:
LAS TRADUCCIONES AL ESLOVACO DE OBR
- Page 297 and 298:
Poesía Si abordamos la situación
- Page 299 and 300:
traducción amplía nuestra visión
- Page 301 and 302:
Bibliografía BRAT, R. 2007. Don Qu
- Page 303 and 304:
pas nécessairement être présent
- Page 305 and 306:
forme à elle-même n’est pas cap
- Page 307 and 308:
quantité de l’action (la durée,
- Page 309 and 310:
DÉFINITION D’UNE BASE DE DONNÉE
- Page 311 and 312:
- les indications nécessaires à d
- Page 313 and 314:
autres composantes autres composant
- Page 315 and 316:
emprunt par une voyelle en tant que
- Page 317 and 318:
COMMUNICATIONS CONTEXTUELLES Štefa
- Page 319 and 320:
En observant la communication et l
- Page 321 and 322:
Américains, les Grecs se disaient
- Page 323 and 324:
RIFLESSIONI SULL’USO DEL PENSIERO
- Page 325 and 326:
hitleriano, come troviamo affermato
- Page 327 and 328:
dovuto costituire un valido strumen
- Page 329 and 330:
Tali pensieri di Leopardi sulle tem
- Page 331 and 332:
dalla vita sociale, chiusi nel ghet
- Page 333 and 334:
ACERCA DE LA UTOPÍA EN EL PERIQUIL
- Page 335 and 336:
elación entre EE.UU. y México). E
- Page 337 and 338:
cosas, como contraste de la recepci
- Page 339 and 340:
ideas (1789) - the same ideas that
- Page 341 and 342:
importantes que la formation scient
- Page 343 and 344:
congruence des acquis est indispens
- Page 345 and 346:
Centre National de Ressources Textu
- Page 347 and 348:
12) La traducción pone énfasis en
- Page 349 and 350:
Summary In this paper we address th
- Page 351 and 352:
1996), ogni parlante scambierà ide
- Page 353 and 354:
I libri di testo utilizzati in clas
- Page 355 and 356:
Aspetti della ricerca già affronta
- Page 357 and 358:
Di seguito la lista delle 12 catego
- Page 359 and 360:
EXTRANJERISMOS NECESARIOS E INNECES
- Page 361 and 362:
poster (cartel), business (negocio)
- Page 363 and 364:
TRUP, Ladislav. 1996. Capítulos de
- Page 365 and 366:
la frialdad del queso una princesa
- Page 367 and 368:
Mondragón y explica quién es ‛e
- Page 369 and 370:
viscoso templo de lo humano! [...]
- Page 371 and 372:
Leopoldo María Panero en sus poema
- Page 373 and 374:
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ES
- Page 375 and 376:
elementos […] han sido mencionado
- Page 377 and 378:
imprecisa, la frontera borrosa entr
- Page 379 and 380:
APRENDER DEL CINE. AZUL OSCURO CASI
- Page 381 and 382:
además ofrecen un uso de la lengua
- Page 383 and 384:
¿Dónde tiene lugar la entrevista
- Page 385 and 386:
Posteriormente, les proponemos una
- Page 387 and 388:
RELAZIONE FRA IL SIGNIFICATO E IL S
- Page 389 and 390:
• DEISSI CONCRETE Per deissi conc
- Page 391 and 392:
Gli altri gesti polacchi e italiani
- Page 393 and 394:
I pittomimici possono anche: 2) le
- Page 395 and 396:
di vicinanza. L’avere è lo stess
- Page 397 and 398:
INVESTIGACIONES CERVANTINAS, SU EST
- Page 399 and 400:
la lectura del libro, pues conlleva
- Page 401 and 402:
entre su obra y las modernas corrie
- Page 403 and 404:
un perspectivismo que se manifiesta
- Page 405 and 406:
ŠIŠMIŠOVÁ, P. 2006. Itinerario
- Page 407 and 408:
2. La nature et la mythologie Dans
- Page 409 and 410:
envie s’empare d’autres personn
- Page 411 and 412:
sommeil du Grand Pan » 42 . La sie
- Page 413 and 414:
and they desire transformation into
- Page 415 and 416:
1. Le caratteristiche generali di u
- Page 417 and 418:
presentata. Se poi, per complicare
- Page 419 and 420:
dialogo dal singolare al plurale, d
- Page 421 and 422:
grande. E’ troppo difficile.’ (
- Page 423 and 424:
11. Test Valutazione, autovalutazio
- Page 425 and 426:
UN´ANALISI COMPARATA DELLE OPERE M
- Page 427 and 428:
Per quanto riguarda le traduzioni d
- Page 429 and 430:
Questa di cui abbiamo detto e direm
- Page 431 and 432:
pugno mi ha aiutato ad orientarmi n
- Page 433 and 434:
Questo motivo del sogno è presente
- Page 435 and 436:
Slovak author in Slovak (J. Špitze
- Page 437 and 438:
LE ROMAN DU CONQUERANT DE NEDIM GÜ
- Page 439 and 440:
Dans le roman historique la vision
- Page 441 and 442:
derniers à l’époque contemporai
- Page 443 and 444:
À partir du 4 ème chapitre, il es
- Page 445 and 446:
proposent de nous transmettre un me
- Page 447 and 448:
appartenaient aux troupes d’élit
- Page 449 and 450:
nomenclature présentée ne couvre
- Page 451 and 452:
[…] des termes qui se distinguent
- Page 453 and 454:
se rapportent à l’âge différen
- Page 455 and 456:
synonymes peuvent construire les sy
- Page 457 and 458:
DUGUET-PICARD D. 1986. La synonymie
- Page 459 and 460:
d’une perspective et le choix d
- Page 461 and 462:
5. Le 9 novembre 1918, le poète G.
- Page 463 and 464:
Il téléphonait en écoutant la ra
- Page 465 and 466:
usse деепричастие tchè
- Page 467 and 468:
CLASIFICACIÓN DEL ESTILO COLOQUIAL
- Page 469 and 470:
variante valenciana), gallego y eus
- Page 471 and 472:
Desde el punto de vista puramente f
- Page 473 and 474:
Ejemplos: médicos: derma f (dermat
- Page 475 and 476:
Progresando con la investigación d
- Page 477 and 478:
ano de 1926, e de facto também o i
- Page 479 and 480:
3.2. Indivíduo como tipo Maria Cam
- Page 481 and 482:
SYNTAXE COMPARÉE : MÉTHODOLOGIE E
- Page 483 and 484:
et ensuite pour celle du complémen
- Page 485 and 486:
ENGADINOIS FOURLAN Quels chi avaiva
- Page 487 and 488:
4 Roumain 113 5 Français 67 Espagn
- Page 489 and 490:
VARGA, D. 2000-2001. La syntaxe du
- Page 491 and 492:
SENS ailleurs (philosophie, logique
- Page 493 and 494:
Maintenant nous allons passer à no
- Page 495 and 496:
au niveau des mots très fréquents
- Page 497 and 498:
MADINIER Bénédicte, Délégation