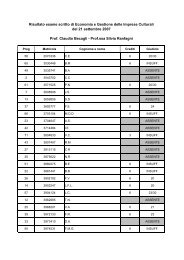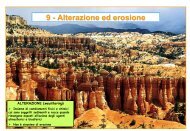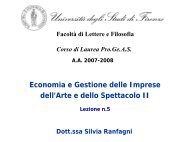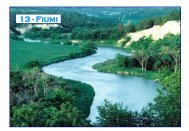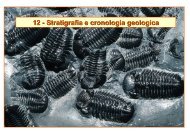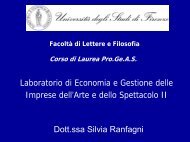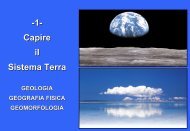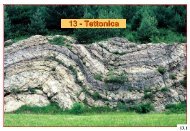SCIPIONE GUARRACINO, Le età della Storia. I concetti di Antico ...
SCIPIONE GUARRACINO, Le età della Storia. I concetti di Antico ...
SCIPIONE GUARRACINO, Le età della Storia. I concetti di Antico ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>SCIPIONE</strong> <strong>GUARRACINO</strong>, <strong>Le</strong> età <strong>della</strong> <strong>Storia</strong>. I <strong>concetti</strong> <strong>di</strong> <strong>Antico</strong>, Me<strong>di</strong>evale, Moderno<br />
e Contemporaneo, Milano, Mondadori 2001, pp. 149-203<br />
3.1 Il Me<strong>di</strong>oevo oscuro<br />
Il Me<strong>di</strong>oevo degli umanisti e degli artisti e scrittori del Rinascimento, da Petrarca a<br />
Vasari, era stato appena in<strong>di</strong>viduato e circoscritto, quando subito a esso si sovrappose<br />
quello definito dalla Riforma protestante. Anche in questo caso si trattava <strong>di</strong> un'epoca<br />
negativa, dalla quale si doveva uscire il più presto possibile, ma le ragioni <strong>di</strong> questo<br />
giu<strong>di</strong>zio non erano più le stesse. Il Me<strong>di</strong>oevo umanista serviva a condannare la<br />
barbarie intellettuale, nelle lettere e nelle arti, dei secoli germanici e gotici. Quello<br />
protestante condannava invece la corrnzione <strong>della</strong> Chiesa, con l'introduzione <strong>di</strong><br />
istituzioni, credenze, riti che sempre più si allontanarono dallo spirito originario del<br />
cristianesimo. L'invito a tornare ad fontes, eliminando le deformazioni, volontarie o<br />
meno, e il principio stesso del commento, riguardava per gli urnanisti i testi<br />
dell'antichità classica, per i protestanti le Sacre scritture. Dal punto <strong>di</strong> vista <strong>della</strong><br />
perio<strong>di</strong>zzazione, il Me<strong>di</strong>oevo urnanista ha un inizio preciso, con il sacco <strong>di</strong> Roma, e<br />
una conclusione più in<strong>di</strong>stinta. Solo con il tempo si affermò la data del 1453, la<br />
conquista turca <strong>di</strong> Costantinopoli: fuggendo verso l'Italia, gli intellettuali greci<br />
portarono con sé una parte cospicua del patrimonio culturale antico e dettero un<br />
contributo decisivo alla rinascita delle buone lettere. Al contrario, quello protestante<br />
ha un inizio vagamente compreso fra Costantino e Carlo Magno, mentre è la sua fine<br />
a corrispondere a una data e ad un evento determinato, il 1517 e la rivolta <strong>di</strong> Martin<br />
Lutero contro le indulgenze<br />
Così Giorgio Falco ha riassunto. i temi dominanti <strong>di</strong> questa nuova visione dell'età<br />
oscura, desumendoli dalla Cronaca universale <strong>di</strong> Filippo Melantone (1558-1560, dalla<br />
Creazione a Carlo Magno): «l'ottenebrarsi <strong>della</strong> pura dottrina, il sopravvento <strong>di</strong><br />
molte superstizioni, come le messe per i defunti e il culto dei santi, l'inizio del monachesimo<br />
e l'incremento <strong>della</strong> potenza papale». In questo elenco fissiamo l'attenzione<br />
soprattutto sulle superstizioni, che non figuravano nell'immagine umanista del Me<strong>di</strong>oevo<br />
e che, separate dal quadro <strong>della</strong> polemica protestante, avranno poi una parte <strong>di</strong><br />
primo piano in quella illuminista. Tutte le pratiche religiose dei cattolici hanno la<br />
tendenza a degenerare verso il ritualismo e la superstizione, e mentre, fra i<br />
protestanti, i teologi volgeranno le loro cure alla messa romana e agli arre<strong>di</strong> degli<br />
e<strong>di</strong>fici ecclesiastici cattolici, gli storici si in<strong>di</strong>rizzeranno sull'origine deI culto dei<br />
santi e delle reliquie e sull'invenzione <strong>di</strong> santi mai esistiti. Un secondo allettante<br />
campo <strong>di</strong> indagine fu per gli storici protestanti quello dei vizi e delle degenerazioni<br />
del papato, e si può <strong>di</strong>re che risalga a loro l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> un'epoca oscurissima<br />
1
all'intero dell'oscuro Me<strong>di</strong>oevo, il IX-X secolo, quella che (recuperando la serie<br />
<strong>di</strong>scendente dei metalli) verrà chiamata «l'età ferrea del papato». Come simbolo del<br />
Me<strong>di</strong>oevo protestante si può perciò scegliere la leggenda <strong>della</strong> papessa Giovanna, che<br />
gli autori <strong>della</strong> luterana Histona ecclesiastica (pubblicata nel 1559-1574 e meglio<br />
nota come Centurie <strong>di</strong> Magdeburgo) raccolsero dalle fantasie me<strong>di</strong>evali e presero per<br />
buona, affermando che alla metà del IX secolo la Chiesa scese così in basso da essere<br />
governata da un papa che in realtà era una donna.<br />
Dopo quello umanista e quello protestante, è il Me<strong>di</strong>oevo degli illuministi a produrre<br />
la più stabile immagine negativa del Me<strong>di</strong>oevo. Gli umanisti italiani deprecavano la<br />
barbarie nella lingua, nelle arti, nella filosofia, ma salvavano la storia comunale; i<br />
protestanti attribuivano alla Chiesa corrotta i vizi e le superstizioni me<strong>di</strong>evali, ma<br />
salvavano l'autorità imperiale considerandola come la forza politica e morale che<br />
aveva tentato, invano, <strong>di</strong> opporsi alla degradazione <strong>della</strong> vita religiosa. Il Me<strong>di</strong>oevo<br />
degli illuministi, che esamineremo attraverso le opere <strong>di</strong> tre fra gli autori più<br />
rappresentativi (Voltaire, Robertson, Condorcet), acquista quella compattezza<br />
negativa che era fino ad allora mancata: alla barbarie culturale e agli abusi del clero si<br />
aggiungono la più generale tendenza all'abbrutimento dei costumi, la crudeltà unita<br />
alla rozzezza, l'ignoranza unita al fanatismo e all'intolleranza.<br />
Il titolo definitivo dell'opera <strong>di</strong> Voltaire, Saggio sui co stumi e lo spirito delle nazioni<br />
e sui principali fatti <strong>della</strong> storia da Carlomagno a Luigi XIII, comparve solo<br />
nell'e<strong>di</strong>zione del 1769, ma con il titolo <strong>di</strong> Abregé de l'histoire universelle essa era già<br />
stata pubblicata nel 1753. Neppure in questa prima e<strong>di</strong>zione (che andava da Carlo<br />
Magno a Carlo V) il periodo storico trattato corrispondeva al Me<strong>di</strong>oevo propriamente<br />
detto, anche senza contare l'interesse <strong>di</strong> Voltaire per le civiltà extraeuropee. Il Saggio<br />
aveva in ogni caso ben chiari i limiti cronologici e i caratteri generali del Me<strong>di</strong>oevo<br />
europeo. All'inizio vi era la «caduta dell'impero romano» (titolo del capitolo II), le<br />
cui cause andavano rintracciate nelle invasioni barbariche e nell'indebolimento<br />
dell'impero provocato dalle lotte religiose fra ariani e trinitari. Dopo <strong>di</strong> allora<br />
«l'intelletto umano si abbrutì nelle superstizioni più insensate [...]. L'Europa intera<br />
ristagna in questo avvilimento fino al XVI secolo e non ne esce che attraverso<br />
convulsioni terribili» (vol. I, ed. 1990, cap. 12, p. 310). Nella prefazione al tomo III<br />
(nell'e<strong>di</strong>zione del 1754) leggiamo poi che i due tomi precedenti «riguardano tempi<br />
oscuri che richiedono ricerche ingrate; è più <strong>di</strong>fficile <strong>di</strong> quanto si pensi trovare nelle<br />
macerie <strong>della</strong> barbarie <strong>di</strong> che costruire un e<strong>di</strong>ficio attraente (vol. Il, p. 888).<br />
Il riferimento al Me<strong>di</strong>oevo è evidente nel titolo del libro <strong>di</strong> William Robertson I<br />
progressi <strong>della</strong> società europea dalla caduta dell'impero romano agli inizi del secolo<br />
XVI, pubblicata nel 1769 e concepita come una lunga premessa all'opera de<strong>di</strong>cata al<br />
regno dell'imperatore Carlo V. Come negli umanisti italiani del XV-XVI secolo, la<br />
"barbarie" dell'epoca trattata dallo storico scozzese <strong>di</strong>pende in principio dalle<br />
invasioni germaniche. Mentre Robertson è <strong>di</strong>sposto a riconoscere ai germani almeno<br />
le virtù <strong>della</strong> <strong>di</strong>gnità e del coraggio, è con l'instaurarsi del sistema feudale che ci<br />
imbattiamo nei caratteri propri del Me<strong>di</strong>oevo, l'anarchia universale e la riduzione del<br />
popolo in servitù (p. 15), cui si aggiunge la scomparsa <strong>di</strong> ogni traccia <strong>di</strong> cultura e<br />
2
civiltà. Dopo la breve parentesi <strong>di</strong> Carlo Magno e Alfredo il Grande, «l'oscurità<br />
ricomparve e tornò a stendersi sull'Europa più profonda e più greve <strong>di</strong> prima» (p. 17).<br />
La terza opera che qui consideriamo, Abbozzo <strong>di</strong> un quadro storico dei progressi<br />
dello spirito umano <strong>di</strong> Condorcet, fu pubblicata postuma nel 1795, l'anno dopo che<br />
l'autore era rimasto vittima del terrore giacobino. L'epoca <strong>di</strong>sastrosa <strong>della</strong> "decadenza<br />
dei lumi" comincia con l'Occidente che cade in mano ai barbari, ma anche con il<br />
<strong>di</strong>sprezzo dei sacerdoti per le lettere umane.<br />
Lo spirito umano [<strong>di</strong>scende] rapidamente dall'altezza cui si era elevato, e l'ignoranza<br />
[trascina] <strong>di</strong>etro <strong>di</strong> sé qui la ferocia, altrove una crudeltà raffinata, dappertutto la<br />
corruzione e la perfi<strong>di</strong>a. Appena qualche bagliore <strong>di</strong> talenti, qualche tratto <strong>di</strong><br />
grandezza d'animo o <strong>di</strong> bontà, possono squarciare questa notte profonda.<br />
Fantasticherie teologiche, imposture superstiziose, sono il solo genio degli uomini;<br />
l'intolleranza religiosa è la loro sola morale; e l'Europa, schiacciata tra la tirannide<br />
sacerdotale e il <strong>di</strong>spotismo militare, attende nel sangue e tra le lacrime, il momento in<br />
cui dei nuovi lumi le permetteranno <strong>di</strong> rinascere alla libertà, all'umanità e alle virtù.<br />
(p. 76)<br />
Attraverso le notazioni <strong>di</strong> Voltaire, Robertson e Condorcet non è <strong>di</strong>fficile mettere<br />
insieme il complesso <strong>di</strong> caratteri che abitualmente si associano all'aggettivo<br />
"me<strong>di</strong>evale". Un punto molto importante da notare è che in nessuno <strong>di</strong> questi tre<br />
autori fa spicco l'uso <strong>di</strong> termini come me<strong>di</strong>evale o Me<strong>di</strong>oevo. "Me<strong>di</strong>evale" è in effetti<br />
un neologismo che si afferma solo dopo il 1870. Il Dictionnaire <strong>di</strong> Émile Littré<br />
(1873), dove figura "Mé<strong>di</strong>éviste", non ammise "Mé<strong>di</strong>éval" (che compare invece nel<br />
supplemento del 1877, con un'occorrenza datata al 1874); Tommaseo lo incluse nel<br />
suo Dizionario, ma lo giu<strong>di</strong>cò «né necessario né. bello». Più sorprendente è l'assenza<br />
<strong>di</strong> "Me<strong>di</strong>oevo". In Robertson la parola compare una sola volta «Ancora più notevole<br />
era l'ignoranza del Me<strong>di</strong>oevo riguardo alla situazione geografica dei paesi lontani», p.<br />
237), in Voltaire e in Condorcet mai. Nella seconda delle "Osservazioni<br />
supplementari" aggiunte nel 1763, Voltaire osserva che «la guerra dell'impero e del<br />
sacerdozio» va considerata come «il filo conduttore attraverso il labirinto <strong>della</strong> storia<br />
moderna», da Carlo Magno ai tempi recenti (vol. II, p. 904); la storia si <strong>di</strong>vide qui<br />
solo in antica e moderna, con una <strong>di</strong>visione binaria che continuerà a lungo a fare<br />
concorrenza alla grande tripartizione. Di storia del Me<strong>di</strong>oevo («storia barbara dei<br />
popoli barbari che, <strong>di</strong>venuti cristiani, non <strong>di</strong>ventano per questo migliori») Voltaire<br />
parla invece nella voce "Histoire" scritta nel 1757 per l'VIII volume<br />
dell'Enciclope<strong>di</strong>a. Quanto a Condorcet, il suo "Me<strong>di</strong>oevo" corrisponde alla sesta delle<br />
<strong>di</strong>eci epoche in cui è sud<strong>di</strong>viso il quadro dei progressi umani, fra l'originario riunirsi<br />
delle famiglie in tribù e i prossimi avanzamenti che dovranno seguire alla<br />
Rivoluzione francese.<br />
<strong>Le</strong> opere che hanno trasferito l'espressione "Me<strong>di</strong>oevo" dal campo <strong>della</strong> metafora al<br />
linguaggio storiografico sono nel Settecento i manuali a uso dei collegi e delle università.<br />
Primo fra tutti viene riconosciuto quello <strong>di</strong> Christopher Keller (o Cellarius),<br />
rettore dell'Università <strong>di</strong> Halle e professore <strong>di</strong> storia ed eloquenza, che nel 1675<br />
3
aveva scritto un compen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> storia antica subor<strong>di</strong>nato alle esigenze (ve<strong>di</strong> capitolo 2,<br />
paragrafo 1) degli studenti più giovani impegnati nella lettura degli autori classici.<br />
Successivamente Keller ampliò il suo piano <strong>di</strong> lavoro e alla seconda e<strong>di</strong>zione <strong>della</strong><br />
Historia antiqua (1685) fece seguire nel 1688 e 1696 altri due volumi <strong>di</strong> Historia<br />
me<strong>di</strong>i aevi e Htstoria nova. Il titolo esatto del secondo volume era Historia meiti aevi<br />
a temporibus Constantini Magni ad Constantinopolim a Turcis captam e fissava<br />
all'anno 1453 il ter minus ad quem <strong>della</strong> trattazione, seguendo il rilievo che nel XVI<br />
secolo molti umanisti europei. avevano attribuito a quella data. In realtà Keller<br />
prolungava la sua esposizione fmo alla fine del XV secolo e teneva conto <strong>di</strong> più punti<br />
<strong>di</strong> vista: quello umanista (il 1453 e la fme delle "tenebre" nelle lettere), quello<br />
protestante (il profilarsi <strong>di</strong> una nuova pietà religiosa) e anche quello <strong>della</strong> "modernità"<br />
determinata dalle invenzioni e scoperte <strong>di</strong> fine Quattrocento (sul quale torneremo nel<br />
prossimo capitolo). Rispetto alle rappresentazioni variamente costruite solo sullo<br />
spirito polemico, il libro <strong>di</strong> Keller faceva ricorso a criteri eterogenei <strong>di</strong> perio<strong>di</strong>zzazione<br />
e accennava a un Me<strong>di</strong>oevo un po' più "neutro" e anche più arido, cioè a<br />
quello dei compen<strong>di</strong> scolastici basati sulla piatta successione <strong>di</strong> eventi, personaggi e<br />
date.<br />
Questo Me<strong>di</strong>oevo puramente scolastico si affermò nel corso del XVIII secolo,<br />
venendosi a combinare in maniera molto esteriore, appunto secondo la natura dei<br />
compen<strong>di</strong>, con quello degli umanisti, dei protestanti e degli illu-ministi. L'e<strong>di</strong>zione<br />
originale <strong>della</strong> Cyclopae<strong>di</strong>a, pubblicata nel 1728 a Londra da Ephraim Chambers,<br />
non contiene la voce Me<strong>di</strong>oevo, aggiunta poi nel volume <strong>di</strong> supplemen-to del 1753.<br />
Bisogna aspettare l'e<strong>di</strong>zione del 1798 perché il Dictionnaire dell' Académie de France<br />
introduca la voce "Me<strong>di</strong>oevo". In entrambi i casi il periodo viene delimitato fra<br />
Costantino e la rinascita delle lettere del 1453.<br />
La storia del concetto <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>oevo non finisce qui. Dopo l'originaria invenzione da<br />
parte degli umanisti, il Me<strong>di</strong>oevo è stato reinventato una decina <strong>di</strong> volte e <strong>di</strong> esso si<br />
può parlare in molti mo<strong>di</strong>.<br />
Anche solo limitandosi all'immagine originaria dei secoli bui, l'ignoranza e la<br />
barbarie sono cose ben <strong>di</strong>verse se riferite al V-VI secolo, con il sacco <strong>di</strong> Roma e i<br />
longobar<strong>di</strong>, o invece al XIII-XIV, con la filosofia scolastica e l'architettura gotica.<br />
Già dalla fine del Settecento, inoltre, attorno al Me<strong>di</strong>oevo oscuro si è sviluppata non<br />
solo la repulsione razionalista, ma anche il torbido coinvolgimento dei noiosissimi<br />
romanzi gotici che con le loro tetre atmosfere e ambientazioni hanno aggiunto - a<br />
cominciare dal Castello <strong>di</strong> Otranto <strong>di</strong> Horace Walpole (1764) e da Il monaco <strong>di</strong><br />
Matthew <strong>Le</strong>wis (1796)- un ulteriore tocco alla figura dell'oscurità. È poi seguito il<br />
Me<strong>di</strong>oevo del romanticismo cattolico, con la trasformazione del termine "gotico" da<br />
insolenza a nome <strong>di</strong> un ammirato stile architettonico e con la riscoperta <strong>della</strong> società<br />
cristiana, organica e gerarchica, rifugio ideale dopo una generazione <strong>di</strong> guerre e<br />
rivoluzioni.<br />
In una successione <strong>di</strong> modelli che non si è interrotta fino ai giorni nostri, si sono<br />
combinati tra loro gli aspetti più <strong>di</strong>sparati, fino a produrre, come ha ben scritto Giuseppe<br />
Sergi, la duplice immagine, <strong>di</strong> un "altrove" positivo e <strong>di</strong> uno negativo:<br />
"Nell'altrove negativo ci sono povertà, fame, pestilenze, <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne politico,<br />
4
soperchierie dei latifon<strong>di</strong>sti sui conta<strong>di</strong>ni, superstizione <strong>di</strong> popolo e corruzione del<br />
clero. Nell' altrove positivo ci sono i tornei, la vita <strong>di</strong> corte, elfi e fate, cavalieri fedeli<br />
e principi magnanimi". Senza forzare molto le cose, si può <strong>di</strong>re che non ci sia<br />
simbolo dell'età me<strong>di</strong>evale, attraverso tutto il suo percorso, che non si presti a una<br />
duplice lettura. A volte questa è apparente, perché compiuta accostando fenomeni o<br />
momenti <strong>di</strong>versi, a volte è insita nella complessità delle cose e suggerita dalle fonti<br />
stesse; ma spesso è legata agli atteggiamenti contrad<strong>di</strong>ttori che assumiamo <strong>di</strong> fronte a<br />
un'identica realtà e fra i quali non riusciamo a decidere. Al Me<strong>di</strong>oevo barbaro si<br />
contrappone così il suo doppione positivo costituito dal Me<strong>di</strong>oevo giovane e<br />
turbolento (le fresche energie germaniche immesse nel decrepito corpo del basso<br />
impero romano); all'anarchia feudale la società organica degli or<strong>di</strong>ni; al mondo<br />
economicamente e culturalmente chiuso dell'età feudale quello delle città, dei<br />
mercanti, dei viaggi <strong>di</strong> Marco Polo; alla crociata come guerra santa motivata<br />
dall'intolleranza e condotta con violenza sanguinaria, la crociata come avventura<br />
dello spirito che ha l'involontario effetto <strong>di</strong> far confrontare due culture; all'«esercito <strong>di</strong><br />
monaci, sempre pronti a esaltare con le loro imposture i terrori superstiziosi»<br />
(Condorcet, op. cit., p. 79), l'estremo razionalismo <strong>della</strong> filosofia scolastica. Ma il<br />
caso più emblematico <strong>di</strong> duplicità è costituito dalla figura del cavaliere, <strong>di</strong>fensore<br />
<strong>della</strong> fede e dei deboli o invece avventuriero e criminale, del quale già nel 1135<br />
Bernardo <strong>di</strong> Chiaravalle smascherava la vocazione <strong>di</strong> malitia nascosta <strong>di</strong>etro la<br />
retorica <strong>della</strong> militia cristiana.<br />
Bibliografia <strong>di</strong> riferimento:<br />
La storia dell'idea <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>oevo è trattata da G. Falco, La polemica" sul Me<strong>di</strong>oevo<br />
(1933), Guida, Napoli 1977 (che resta l'opera più importante sull'argomento; la<br />
citazione è tratta dalla p. 71); R. ManselIi, Il Me<strong>di</strong>oevo. Introduzione storiografica,<br />
Giappichelli, Torino 1967; L. Gatto, Viaggio intorno al concetto <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>oevo, Bulzoni,<br />
Roma 1977, 1995; Mario Sanfilippo, Dentro il Me<strong>di</strong>oevo, La Nuova Italia,<br />
Firenze 1990, pp. 4.10; P. Delogu, Introduzione allo stu<strong>di</strong>o <strong>della</strong> storia me<strong>di</strong>evale, il<br />
Mulino, Bologna 1994, pp. 17-64.<br />
La co<strong>di</strong>ficazione del X secolo come età allo stesso tempo <strong>di</strong> massima superstizione,<br />
barbarie intellettuale e corruzione del papato fu compiuta da F. Gregorovius nel libro<br />
VI <strong>della</strong> <strong>Storia</strong> <strong>della</strong> città <strong>di</strong> Roma nel Me<strong>di</strong>oevo (1859-1872), Einau<strong>di</strong>, Torino 1973.<br />
La formazione <strong>della</strong> leggenda <strong>della</strong> papessa Giovanna è esposta da A. Boureau, La<br />
papessa Giovanna (1988), Einau<strong>di</strong>, Torino 1991. <strong>Le</strong> citazioni dell'Essai sur le<br />
moeurs <strong>di</strong> Voltaire sono tratte dall'e<strong>di</strong>zione a c. <strong>di</strong> R. Pomeau, Garnier-Bordas, Paris<br />
1990,2 voll.; quelle de I progressi <strong>della</strong> società europea <strong>di</strong> W. Robertson dalla trad.<br />
<strong>di</strong> G. Agosti con una "Introduzione" <strong>di</strong> G. Falco, Einau<strong>di</strong>, Torino 1951; quelle<br />
dell'Abbozzo <strong>di</strong> Condorcet dall'ed. it. a c. <strong>di</strong> M. Minerbi, Einau<strong>di</strong>, Torino 1969. <strong>Le</strong><br />
informazioni su Cellarius sono desunte da G. Falco, op. Clt., pp. 104-107. Il passo <strong>di</strong><br />
G. Sergi si trova in L'idea <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>oevo. Tra senso comune e pratica storica, Donzelli,<br />
Roma 1998, p. 13. Anche D. Cantimori aveva osservato: «Chi non sente e non vede<br />
ancora in questa parola e neI corrispondente concetto qualcosa <strong>di</strong> cupo, <strong>di</strong> terribile, da<br />
5
una parte, <strong>di</strong> romanticamente attraente dall'altra» (Sulla storia del concetto <strong>di</strong><br />
Rinascimento, 1932, in Id., Storici e storia, Einau<strong>di</strong>, Torino 1971, p. 413).<br />
All'opposizione "oscurità e awentura" R. Bordone (Lo specchio <strong>di</strong> Shalott.<br />
L'invenzione del Me<strong>di</strong>oevo nella cultura dell'Ottocento, Liguori, Napoli 1993, pp. 13-<br />
16) aggiunge quella tra il catastrofismo (Me<strong>di</strong>oevo storico come anticipazione <strong>di</strong><br />
quello "prossimo venturo") e il miraggio (il Me<strong>di</strong>oevo come alternativa all'età<br />
postindustriale).<br />
W. Robertson parlava dei pellegrinaggi come <strong>di</strong> una «superstiziosa devozione» e<br />
<strong>di</strong>ceva delle crociate che <strong>di</strong> esse «non rimane oggi che un monumento dell'umana<br />
follia». Ma nel suo giu<strong>di</strong>zio era presente un aspetto <strong>di</strong> duplicità, perché i crociati<br />
vennero anche a conoscenza <strong>di</strong> civiità superiori e ampliarono le loro vedute:<br />
«Dobbiamo a queste assurde spe<strong>di</strong>zioni, frutto <strong>di</strong> superstizione e <strong>di</strong> follia, i primi<br />
raggi <strong>di</strong> luce che contribuirono a <strong>di</strong>ssipare la barbarie e l'ignoranza» (p. 22). Sulle<br />
crociate e sul cavaliere, F. Car<strong>di</strong>ni, La crociata, in Id., Minima me<strong>di</strong>aevalia, Arnaud,<br />
Roma 1987, pp. 85-115, e "Introduzione" a M. Keen, La cavalleria, Guida,<br />
Napoli 1986, pp. 5-20.<br />
La duplicità <strong>della</strong> figura deI cavaliere è espressa in maniera ingenua ma efficace dal<br />
cinema <strong>di</strong> Hollywood: basta confrontare il Lancelot du Lac perfetto cavaliere<br />
interpretato da Robert Taylor ne I cavalieri <strong>della</strong> tavola rotonda <strong>di</strong> Richard Thorpe<br />
(1953) con i bruti che compaiono in Excalibur, <strong>di</strong>retto da John Boorman nel 1981 e<br />
sempre basato sulle vicende <strong>della</strong> corte <strong>di</strong> re Artù. In generale si veda Matteo<br />
Sanfilippo, Il Me<strong>di</strong>oevo secondo Walt Disney. Come l'America ha reinventato l'Età <strong>di</strong><br />
Mezzo, CasteIvecchi, Roma 1993.<br />
3.2 Il Me<strong>di</strong>oevo "non me<strong>di</strong>evale"<br />
Nonostante l'indubbia duplicità interna alla nozione <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>oevo recepita dal senso<br />
comune, è forse opportuno non mettere sullo stesso piano la rappresentazione positiva<br />
e quella negativa. La prima ha avuto la sua originaria sistemazione nella cultura<br />
controrivoluzionaria e nell'Europa <strong>della</strong> Restaurazione, definendosi in opposizione ai<br />
caratteri <strong>della</strong> modernità (la bruttezza e volgarità <strong>della</strong>. città industriale o il <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne<br />
permanente legato all' avanzata <strong>della</strong> democrazia) giu<strong>di</strong>cati particolarmente<br />
sgradevoli da intellettuali <strong>di</strong> varia estrazione. Si è poi mantenuta come una variante<br />
nella ricerca dell' evasione fantastica da un mondo meschino, borghese, prosastico.<br />
Agli aspetti ideologici e letterari <strong>della</strong> rappresentazione positiva corrisponde<br />
l'automatismo incolto <strong>di</strong> quella negativa, che fa ricondurre al Me<strong>di</strong>oevo tutto ciò che<br />
nella società e nel costume appare come una sopravvivenza <strong>di</strong> sorpassati tempi <strong>di</strong><br />
ignoranza e sopruso. Il tutto è reso dalle espressioni come "non siamo più nel<br />
Me<strong>di</strong>oevo", "questo si faceva nel Me<strong>di</strong>oevo", "stiamo tornando al Me<strong>di</strong>oevo".<br />
Per opporsi all'immagine del Me<strong>di</strong>oevo oscuro si possono adottare <strong>di</strong>verse strategie.<br />
Si può far notare che un Me<strong>di</strong>oevo che si estende per un millennio mantenendosi<br />
identicamente oscuro per tutta la sua durata va contro l' evidenza dei fatti. Si possono<br />
invece valorizzare, come appunto fa la strategia romantica, alcuni aspetti dell'epoca<br />
proprio per la loro natura tipicamente "me<strong>di</strong>evale". Si può infine rovesciare lo stesso<br />
6
presupposto <strong>della</strong> critica razionalista e mostrare, con un provocatorio ossimoro, la<br />
solida esistenza <strong>di</strong> un Me<strong>di</strong>oevo "non me<strong>di</strong>evale". La concezione romantica ci tiene a<br />
far apprezzare nell'età <strong>di</strong> mezzo proprio la sua non modernità, l'eroico idealismo e<br />
senso dell'onore <strong>della</strong> cavalleria contro il borghese dominio dell'interesse materiale,<br />
la magia contro la tecnica, il fantastico contro la razionalità. La strategia ricordata per<br />
ultima non ha niente a che fare con i perio<strong>di</strong>ci revival in chiave fantasy o New Age e<br />
intende mostrare proprio la modernità, non <strong>di</strong>ciamo del Me<strong>di</strong>oevo dei manuali scolastici<br />
con tutti. i suoi mille anni, ma certamente dei secoli XII-XIV, con i loro artisti,<br />
filosofi, scrittori politici, scien- ziati, mercanti, viaggiatori.<br />
Ciò a cui miravano le riven<strong>di</strong>cazioni dei me<strong>di</strong>evisti avanzate già dagli anni venti del<br />
XX secolo era infatti mostrare che le ra<strong>di</strong>ci <strong>della</strong> modernità non stanno nella<br />
riscoperta <strong>della</strong> cultura antica cominciata, secondo quanto preteso dalla storiografla<br />
dominante, solo con il Rinascimento. Al contrario, la rinascita del Quattrocento era<br />
stata preceduta e preparata da un'altrertanto fondamentale rinascita del XII secolo.<br />
Secondo questa visuale, inoltre, moderni o comunque fondamento <strong>della</strong> modernità<br />
vanno giu<strong>di</strong>cati gli uomini d'affari del Duecento e del Trecento, che con le loro<br />
innovazioni nella pratica commerciale e nella tenuta dei libri contabili hanno aperto<br />
la strada al capitalismo e alla razionalità economica. Ancora, moderni sono i comuni<br />
e gli organismi politici citta<strong>di</strong>ni, che hanno reinventato la politica e l'economia<br />
monetaria e creato il rivoluzionario strumento <strong>della</strong> politica economica, ignoto agli<br />
antichi, che è il debito pubblico. A loro modo sono moderni anche i parlamenti<br />
me<strong>di</strong>evali, che hanno introdotto le istituzioni e le procedure <strong>della</strong> rappresentatività,<br />
del tutto estranee alla mentalità degli antichi; ugualmente essi hanno fatto valere il<br />
fondamento pattizio <strong>della</strong> soggezione ai sovrani, ben <strong>di</strong>verso dai principi<br />
dell'assolutismo che si affermarono con lo stato del Rinascimento. Allo stesso modo,<br />
si è detto, la scienza moderna si ricollega meglio a quella del Trecento che non<br />
all'interesse per la magia e l'astrologia così <strong>di</strong>ffuso fra gli uomini <strong>di</strong> cultura del<br />
Rinascimento.<br />
Alla vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> queste tesi e ai loro punti deboli de<strong>di</strong>cheremo più avanti, in questo e<br />
nel prossimo capitolo, una <strong>di</strong>scussione più particolareggiata. In questo paragrafo ci<br />
limiteremo a in<strong>di</strong>care come la visione del Me<strong>di</strong>oevo oscuro conduca a far commettere<br />
puri e semplici errori <strong>di</strong> fatto, a cominciare dalla scarsa attenzione prestata al culto<br />
<strong>della</strong> luce e dei colori proprio dei costruttori delle cattedrali gotiche. Ovviamente<br />
esiste anche un Me<strong>di</strong>oevo "me<strong>di</strong>evale" e istituzioni come l'Inquisizione non possono<br />
essere ricondotte solo alle polemiche e alle calunnie dell'anticlericalismo illuminista e<br />
positivista. Quel che viene considerato "tipicamente" me<strong>di</strong>evale si rivela però spesso<br />
frutto <strong>di</strong> leggende o tipico piuttosto <strong>di</strong> perio<strong>di</strong> posteriori. Ciò è stato ben mostrato da<br />
Régine Pernoud in un'appassionata apologia <strong>di</strong> quei secoli troppo bistrattati. Restando<br />
su uno solo dei suoi argomenti, dobbiamo ammettere che è <strong>di</strong>fficile presentare le<br />
battaglie per l'emancipazione femminile cominciate nel XIX secolo come un "uscire<br />
finalmente dal Me<strong>di</strong>oevo". Se non ci limitiamo agli stereotipi antifemministi coltivati<br />
dagli ambienti monastici, si deve riconoscere che la con<strong>di</strong>zione <strong>della</strong> donna in termini<br />
<strong>di</strong> capacità giuri<strong>di</strong>ca (possibilità <strong>di</strong> esercitare attività economiche, stipulare contratti e<br />
via <strong>di</strong>cendo) è andata progressivamente peggiorando dopo il XIV secolo e che,<br />
7
ugualmente, fenomeni come la clausura totale delle monache e la monacazione<br />
forzata furono assai più <strong>di</strong>ffusi dopo il XVI secolo che nel XIII.<br />
Uno straor<strong>di</strong>nario accumulatore <strong>di</strong> luoghi comuni sul Me<strong>di</strong>oevo è il cinema. Sergio<br />
Bertelli ha mostrato bene che non è solo la fretta, la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> scarsi mezzi, la<br />
sciatteria mentale e la semplice ignoranza a spingere gli autori <strong>di</strong> film <strong>di</strong><br />
ambientazione me<strong>di</strong>evale a commettere anacronismi ed errori <strong>di</strong> ogni genere nella<br />
ricostruzione <strong>di</strong> ambienti, comportamenti, mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> pensare. Spesso si tratta <strong>di</strong> scelte<br />
volontarie per aderire all'immagine corrente del Me<strong>di</strong>oevo e far sembrare al pubblico<br />
inequivocabilmente "me<strong>di</strong>evali" i personaggi e le vicende cui sta per assistere.<br />
Per verificare questa tendenza sceglieremo prima <strong>di</strong> tutto Il settimo sigillo <strong>di</strong> Ingmar<br />
Bergman (1956), un'intensa riflessione filosofica e teologica sulla morte. Del cavaliere<br />
Antonius Block, il personaggio principale, veniamo a sapere che sta tornando<br />
da una crociata. Successivamente la processione dei flagellanti, sullo sfondo <strong>di</strong> un'epidemia<br />
<strong>di</strong> peste, è uno dei momenti costruiti con maggiore maestria registica. In più<br />
Bergman inserisce a un certo punto il rogo <strong>di</strong> una strega, che assume un'importanza<br />
centrale nel contesto drammatico del film. L'insieme "crociate, peste, streghe" appare<br />
funzionale a rappresentare sinteticamente il Me<strong>di</strong>oevo, ma è quanto <strong>di</strong> più eterogeneo<br />
si possa immaginare. La peste ci fa collocare nel 1350, quando la "morte nera"<br />
raggiunse i paesi scan<strong>di</strong>navi; ma il 1350 è un anno da una parte troppo tar<strong>di</strong>vo<br />
rispetto all'epoca delle crociate e dall'altra troppo precoce rispetto all'epoca <strong>della</strong><br />
"caccia alle streghe". Tutto questo è irrilevante se parliamo del valore artistico del<br />
film e se inten<strong>di</strong>amo <strong>di</strong>scutere le ragioni che, in questa e in altre occasioni, hanno<br />
spinto Bergman a cercare una particolare ambientazione storica per la sua opera. Non<br />
lo è, invece, se l'oggetto <strong>della</strong> <strong>di</strong>scussione è un certo modo <strong>di</strong> rappresentare il<br />
Me<strong>di</strong>oevo.<br />
Pren<strong>di</strong>amo allora come secondo esempio Il nome <strong>della</strong> rosa <strong>di</strong> Jean-Jacques Annaud<br />
(1986), una traduzione puramente commerciale del fortunato e complesso romanzo <strong>di</strong><br />
Umberto Eco. In questo caso gli avvenimenti narrati hanno una precisa collocazione<br />
nel tempo, il 1327, e l'insieme che deve rendere il Me<strong>di</strong>oevo è costituito fra l'altro da<br />
un'abbazia benedettina particolarmente cupa e gotica, dalla sinistra figura<br />
dell'inquisitore domenicano Bernard Gui, dalle torture e dalla condanna al rogo<br />
inflitte da costui a un eretico e a una strega. Prendendosi molte libertà nei confronti<br />
sia del romanzo sia <strong>della</strong> realtà storica (Bemard Gui è realmente esistito, ma morì <strong>di</strong><br />
morte naturale nel 13 31), il fIlm mostra come la crudeltà dell'inquisitore susciti una<br />
sollevazione conta<strong>di</strong>na che lo costringe a fuggire e alla fine lo punisce provocandone<br />
la morte. Non insistiamo su que-ste falsificazioni inserite per garantire meglio la<br />
partecipazione emotiva del pubblico e soffermiamoci invece sugli altri aspetti <strong>di</strong><br />
questo Me<strong>di</strong>oevo "tipico".<br />
La tortura dell'eretico è presentata con esibizione <strong>di</strong> particolari efferati, ma, come<br />
mostra Bertelli, con scarsa aderenza alla realtà giu<strong>di</strong>ziaria del momento. Tutta la<br />
questione sta prendendo in effetti un andamento imbarazzante. I me<strong>di</strong>evisti <strong>di</strong><br />
professione non hanno <strong>di</strong>fficoltà a mostrare che la rappresentazione degli inquisitori<br />
come torturatori sa<strong>di</strong>ci e psicopatici è piuttosto fantastica e che le cifre delle vittime<br />
dell'Inquisizione me<strong>di</strong>evale date da alcuni storici <strong>di</strong> fine Ottocento non hanno alcun<br />
8
fondamento. Ma la ferocia <strong>della</strong> crociata del 1209 contro i catari e i roghi collettivi<br />
or<strong>di</strong>nati da inquisitori fanatici rimangono fatti incontestabili; questo particolare<br />
revisionismo storico insiste un po' troppo sui limiti precisi che aveva il ricorso alla<br />
tortura e sulla necessità <strong>di</strong> smontare la sinistra fama dell'Inquisizione, che non<br />
somigliava molto a un tribunale britannico del XIX secolo. Ma resta anche il fatto che<br />
la tortura comparve nei tribunali laici solo al principio del XIII secolo e in quelli<br />
dell'Inquisizione solo dopo il 1252 e che questo Me<strong>di</strong>oevo torturatore è rimasto in vita<br />
fino al XVIII secolo.<br />
È esistito anche un altro Me<strong>di</strong>oevo, precisamente quello più barbarico dei secoli<br />
altome<strong>di</strong>evali, che per gli uomini liberi non ammetteva né la tortura né le pene corporali,<br />
ma solo la composizione in denaro e la <strong>di</strong>mostrazione <strong>di</strong> innocenza tramite il<br />
"giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Dio".<br />
Ancora più complessa è la questione dei processi alle streghe. È <strong>di</strong> nuovo il<br />
Me<strong>di</strong>oevo più "barbaro" a sorprenderci. Verso il 1012 Burcardo, vescovo <strong>di</strong> Worms,<br />
scrisse un "penitenziale", cioè una raccolta <strong>di</strong> penitenze canoniche (per lo più un certo<br />
numero <strong>di</strong> giorni da passare a pane e acqua) che dovevano essere inflitte ai peccatori.<br />
Burcardo prevede pene molto severe per chi si rivolga a maghi «per avere fortuna o<br />
per scacciare il malocchio» e per chi frequenti luoghi incantati (sorgenti, dolmen,<br />
alberi, crocicchi); e inoltre domanda: «Hai forse creduto anche tu all'esistenza <strong>di</strong> una<br />
donna che la superstizione popolare chiama "strega"». Ma il punto essenziale è che<br />
per Burcardo maghi e streghe sono solo residui pagani e superstizioni: «Troppe<br />
persone, <strong>di</strong>sgraziatamente, sono ingannate da quella superstizione [che fa credere a<br />
certe donne <strong>di</strong> cavalcare bestie insieme alla dea pagana Diana] e credono che sia tutto<br />
vero». Il peccato da condannare con la penitenza non è il partecipare a simili pratiche,<br />
dato che si tratta <strong>di</strong> «fantasie che provengono dalla nostra immaginazione», ma<br />
proprio il credere che siano cose vere.<br />
La convinzione che maghi e streghe potessero realmente ricorrere a pratiche <strong>di</strong><br />
"magia nera" e provocare dei malefici era comunque abbastanza ra<strong>di</strong>cata da<br />
provocare a volte l'intervento dei giu<strong>di</strong>ci or<strong>di</strong>nari, che procedevano, quando era il<br />
caso, a pronunciare delle condanne. Fino al principio del XIV secolo il compito<br />
essenziale degli inquisitori ecclesiastici (istituiti nel 1231) fu la caccia agli eretici, e<br />
solo occasionalmente essi si occuparono <strong>di</strong> fatti <strong>di</strong> stregoneria, quando sorgeva il<br />
dubbio <strong>di</strong> una loro connessione con l'eresia. Ve<strong>di</strong>amo che cosa ha da <strong>di</strong>re in proposito<br />
Bemard Gui, che per <strong>di</strong>ciassette anni (dal 1307 al 1324) esercitò funzioni <strong>di</strong><br />
inquisitore nella Francia sud- occidentale e che scrisse un libro <strong>di</strong> istruzioni su come<br />
dovevano essere condotti gli interrogatori dei sospetti. Il manuale si occupa quasi<br />
esclusivamente <strong>di</strong> catari, valdesi e "apostoli" adepti <strong>della</strong> povertà volontaria, e de<strong>di</strong>ca<br />
solo poche pagine ai maghi e indovini e all' «errore pestifero <strong>di</strong> incantesimi,<br />
<strong>di</strong>vinazioni e invocazioni <strong>di</strong> demoni». In linea <strong>di</strong> principio la faccenda gli sembrava<br />
da liquidare come «fantasie e false credenze dovute alla leggerezza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui<br />
superstiziosi», ma una maggiore attenzione era riservata ad alcune pratiche che<br />
potevano suonare come «offesa ai sacramenti <strong>della</strong> Chiesa»; la formula <strong>di</strong> abiura<br />
imposta a chi prometteva <strong>di</strong> desistere dai propri errori presupponeva che le pratiche<br />
degli accusati avessero incluso a volte «l'adorazione o la reverenza [<strong>di</strong> demoni]». La<br />
9
parificazione fra magia e patto con il <strong>di</strong>avolo venne affermata più frequentemente<br />
dopo il 1350, ma dobbiamo attendere il XV secolo perché siano le donne a occupare<br />
il centro dello scenario stregonesco, con la formazione <strong>della</strong> precisa dottrina delle<br />
streghe, del loro patto con il <strong>di</strong>avolo e delle loro riunioni notturne denominate<br />
"sabba". La dottrina in questione ebbe infine il crisma dell'ufficialità con la bolla<br />
"Summis desiderantes affectibus", emanata il 9 <strong>di</strong>cembre 1484 da papa lnnocenzo<br />
VIII. Nel 1488 due inquisitori domenicani, Heinrich Institor e Jakob Sprenger,<br />
teorizzarono nel ponderoso volume Malleus maleficarum un preciso rapporto tra<br />
l'inferiorità morale <strong>della</strong> donna e la sua propensione alla stregoneria.<br />
Quattro anni dopo cominciava l"'età moderna" dei manuali <strong>di</strong> storia. Di fatto la caccia<br />
alle streghe non è un aspetto significativo del Me<strong>di</strong>oevo, ma piuttosto del Rinascimento<br />
o perfino dell'età cartesiana, cui siamo soliti collegare il fiorire <strong>della</strong><br />
modernità. Fu solo dopo il 1660 che i colti magistrati francesi, i quali si erano<br />
riservati i processi <strong>di</strong> stregoneria, cominciarono a rifiutare <strong>di</strong> prendere in esame le<br />
denunce.<br />
Bibliografia <strong>di</strong> riferimento:<br />
Il libro <strong>di</strong> R. Pernoud, Pour en finir avec le Moyen Age, E<strong>di</strong>tions du Seuil, Paris<br />
1977 (trad. it. Me<strong>di</strong>oevo, un secolare pregiu<strong>di</strong>zio, Bompiani, Milano 1983), è un<br />
eccellente antidoto all'idea <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>oevo compattamente oscuro, barbaro e<br />
intollerante.<br />
L'indagine svolta da S. Bertelli e I. Florescu ha prodotto il volume Corsari del<br />
tempo. Quando il cinema inventa la storia, Ponte alle Grazie, Firenze 1993, una<br />
puntigliosa contestazione degli errori commessi non solo per <strong>di</strong>strazione (le comparse<br />
che portano l'orologio in film <strong>di</strong> ambientazione romana) da registi, sceneggiatori,<br />
scenografi. Per i film me<strong>di</strong>evali e in particolare per quel che riguarda la<br />
rappresentazione <strong>di</strong> processi (compresi quelli ereticali) , torture, pene ed esecuzioni si<br />
vedano il capitolo 3, "Mille anni al buio", pp. 136-174, e le pp. 220-230. Bertelli concede<br />
tuttavia poco o niente alla specificità del linguaggio filmico e non ammette<br />
alcuna esigenza <strong>di</strong>versa da quella dell'esattezza storica, ponendo così sullo stesso<br />
piano le molte varianti hollywoo<strong>di</strong>ane sui cavalieri <strong>della</strong> tavola rotonda e il forte e<br />
profondo Lancillotto e Ginevra <strong>di</strong> Robert Bresson. Sui due film <strong>di</strong>scussi nel testo (Il<br />
settimo sigillo e il Nome <strong>della</strong> rosa), si vedano F. Car<strong>di</strong>ni, Il Me<strong>di</strong>oevo nei films <strong>di</strong><br />
Ingmar Bergman, in Id., Minima me<strong>di</strong>aevalia, cit., pp. 413-420 e gli interventi <strong>di</strong> R.<br />
Bordone, C. Segre in "I viaggi <strong>di</strong> Erodoto", n. 1, 1987. Di F. Car<strong>di</strong>ni si veda inoltre<br />
Me<strong>di</strong>evisti «<strong>di</strong> professione" e revival neome<strong>di</strong>evale, in op. cit., pp. 421-434.<br />
Il Penitenziale <strong>di</strong> Burcardo <strong>di</strong> Worms è stato e<strong>di</strong>to in traduzione italiana con il titolo<br />
A pane e acqua. Peccati e penitenze nel Me<strong>di</strong>oevo. a c. <strong>di</strong> G. Picasso, G. Piana e G.<br />
Motta, Europìa, Novara 1986 (citazioni dalle pp. 82-84, 86-87). All'e<strong>di</strong>zione <strong>della</strong><br />
parte più sostanziosa del Manuale del!' inquisitore (Practica inquisitionis heretice<br />
pravitatis) <strong>di</strong> Bernard Gui curata da G. Mollat, Champion, Paris 1926-27,2 voll., si è<br />
aggiunta recentemente la traduzione italiana con testo latino a fronte curata da N. Pi-<br />
10
notti, C. Gallone e<strong>di</strong>zioni, Milano 1998 (citazione da p. 191). La leggenda nera e la<br />
realtà storica è il titolo del saggio introduttivo <strong>di</strong> F. Car<strong>di</strong>ni, pp. XV-XXXVII.<br />
Sulla stregoneria nel Me<strong>di</strong>oevo, si vedano P. Brown, Magia, demoni e ascesa del<br />
cristianesimo dalla tarda antichità al Me<strong>di</strong>oevo, in M. Douglas (a c. <strong>di</strong>), La<br />
stregoneria (1970), Einau<strong>di</strong>, Torino 1980, pp. 51-81; N. Cohn, Il mito <strong>di</strong> Satana e<br />
degli uomini al suo servizio, in ivi, pp. 35-49; R. Manselli, <strong>Le</strong> premesse me<strong>di</strong>evali<br />
<strong>della</strong> caccia alle streghe, in M. Romanelli (a c. <strong>di</strong>), La stregoneria in Europa, il<br />
Mulino, Bologna 1975, pp. 39-62; R. Manselli, Magia e stregoneria nel Me<strong>di</strong>o Evo,<br />
Giappichelli, Torino 1976; A. Borst, <strong>Le</strong> origini <strong>della</strong> stregoneria nelle Alpi, in Id.,<br />
Barbari, ereti ci, artisti nel Me<strong>di</strong>oevo (1988), Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 126-154;<br />
G. Federici Vescovini, Stregoneria e magia cerimoniale nei secoli XIII e XIV, in<br />
Aa.Vv. Stregoneria e streghe nell'Europa moderna, Pacini, Pisa 1996, pp. 23-47. Del<br />
Martello delle streghe (Malleus maleficarum) <strong>di</strong> H. Institor e J. Sprenger si può<br />
leggere la traduzione italiana e<strong>di</strong>ta presso Marsilio, Venezia 1977.<br />
Va osservato che la strega del film Il nome <strong>della</strong> rosa non è un'invenzione del regista,<br />
perché compare anche nel romanzo (Bompiani, Milano 1981), alla fine del Quarto<br />
giorno. Eco può approfittare <strong>della</strong> fortunata coincidenza fra l'anno <strong>di</strong> ambientazione<br />
del romanzo (1327) e l'anno <strong>della</strong> costituzione <strong>di</strong> papa Giovanni XXII Super illius<br />
specula (1326), il primo documento che faceva ricadere sorto la competenza degli<br />
inquisitori le streghe. Come primo e ancora raro esemplare <strong>della</strong> sua specie, la "strega<br />
inquisitoriale" del 1327 non può perciò essere considerata "normale".<br />
3.3 Il Me<strong>di</strong>oevo come civiltà a sé<br />
L'idea <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>oevo è nata come un insulto, un'invettiva, una denuncia, e, benché sia<br />
stata talora convertita in un mito o in un ideale, tale è prevalentemente rimasta. I<br />
me<strong>di</strong>evisti hanno cercato con successo <strong>di</strong> mostrare che l'oggetto dei loro stu<strong>di</strong> non<br />
corrisponde bene a nessun genere <strong>di</strong> idea preconcetta. Il Me<strong>di</strong>oevo delle<br />
perio<strong>di</strong>zzazioni scolastiche è però troppo lungo e <strong>di</strong>versificato per poter essere<br />
esaurito con uno stereotipo negativo o con la sua confutazione. Si può allora proporre<br />
un terzo modo per "pensare" il Me<strong>di</strong>oevo, considerandolo come una civiltà a sé,<br />
ovvero come un'epoca a sé nella storia <strong>della</strong> civiltà. In questo caso bisogna cercare <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>menticare il significato originario <strong>di</strong> "Me<strong>di</strong>oevo" e conservare questa espressione<br />
come un contrassegno abitu<strong>di</strong>nario e convenzionale, lasciando alla storia <strong>della</strong><br />
storiografia le sue origini e tutta la susseguente polemica.<br />
Ciò convenuto, occorre ugualmente delimitare l'epoca, con la sua unità e i suoi<br />
sottoperio<strong>di</strong>, alla quale riservare la denominazione <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>oevo. A questo proposito<br />
esistono già usi consolidati. C'è prima <strong>di</strong> tutto, analoga alla <strong>di</strong>stinzione fra "alto" e<br />
"basso" (nel senso <strong>di</strong> iniziale e finale) impero romano, quella fra alto e basso<br />
Me<strong>di</strong>oevo, segnata spesso dall'anno Mille e a volte dalla definitiva separazione fra<br />
Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa (scisma d'Oriente del 1054). Ma c'è anche una<br />
<strong>di</strong>visione tria<strong>di</strong>ca, adottata dagli storici inglesi e tedeschi e accolta spesso anche da<br />
quelli italiani. In questo caso "alto" (high in inglese e hoch in tedesco) vale non come<br />
"iniziale", ma come "pienamente sviluppato" e si ha allora la successione <strong>di</strong> "primo,<br />
11
pieno e tardo Me<strong>di</strong>oevo". In entrambi i casi va tuttavia chiarito se la scelta dei due<br />
momenti <strong>di</strong> svolta (per esempio il 1000 e il 1300) è ancora puramente convenzionale<br />
o se invece intende affrontare la più impegnativa e compromettente ricerca <strong>di</strong> una<br />
perio<strong>di</strong>zzazione sostanziale, relativa cioè ai tempi <strong>di</strong> una determinata civiltà, ovvero<br />
sistema sociale, economico e culturale. "Civiltà" può, in effetti, sembrare un concetto<br />
troppo vago o, al contrario, ben determinato e applicabile solo su scale temporali<br />
molto più ampie. Siamo con ciò ri-mandati alla <strong>di</strong>fficile questione dei rapporti fra<br />
Antichità e Me<strong>di</strong>oevo e fra Me<strong>di</strong>oevo ed Età moderna come fasi <strong>di</strong> un'unica civiltà<br />
"occidentale", sulla quale avremo ancora qualcosa da <strong>di</strong>re nel prossimo paragrafo.<br />
Limitiamoci per ora a riconoscere che non pochi stu<strong>di</strong>osi sono piuttosto propensi a<br />
considerare come una civiltà a sé il loro Me<strong>di</strong>oevo. La definizione delle sue coor<strong>di</strong>nate<br />
temporali richiede prima <strong>di</strong> tutto <strong>di</strong> ridare un po' <strong>di</strong> vita a fossilizzate<br />
convenzioni come quella "dal 476 al 1492" dei nostri manuali. I caratteri specifici<br />
dell'epoca sono, quasi per definizione, quelli del pieno o "alto" Me<strong>di</strong>oevo, dei secoli<br />
XI-XIll. Intitolandosi La civiltà dell'Occidente me<strong>di</strong>evale, l'opera <strong>di</strong> sintesi pubblicata<br />
nel 1969 da J acques <strong>Le</strong> Goff poneva appunto una specifica civiltà come oggetto<br />
<strong>della</strong> sua indagine e la delimitava spazialmente riferendosi all' "Occidente" (cosa che<br />
lascia supporre che il Me<strong>di</strong>oevo sia anche una ripartizione interna a un'entità più<br />
ampia). Dal punto <strong>di</strong> vista temporale, inoltre, più <strong>di</strong> quattro quinti del libro erano<br />
de<strong>di</strong>cati al periodo compreso fra il 950 e il 1330. Questo è il Me<strong>di</strong>oevo in senso<br />
stretto. Esso ha naturalmente degli antecedenti, ma il suo "inizio" non pare<br />
collocabile più in<strong>di</strong>etro del Vll secolo. La scoperta <strong>della</strong> "Tarda antichità", uno<br />
specifico periodo <strong>della</strong> storia del mondo antico che si prolunga per <strong>di</strong>versi secoli, ha<br />
scavalcato e cancellato il 476 e ogni altra cesura riferita al V secolo. Citando Paolo<br />
Delogu, si può <strong>di</strong>re che:<br />
L'unità del Me<strong>di</strong>oevo deve essere ravvisata non tanto nella permanenza invariata <strong>di</strong><br />
alcuni caratteri fondamentali, quanto nella coerenza <strong>della</strong> loro evoluzione, secondo<br />
un andamento che può essere considerato come una curva che parte molto in basso<br />
tra vi e vii secolo, tende verso l' alto e raggiunge il culmine tra xii e xiii secolo, per<br />
poi cambiare <strong>di</strong>rezione volgendo verso il basso, senza però tornare ai livelli <strong>di</strong><br />
partenza ed anzi pre<strong>di</strong>sponendosi per un nuovo cambiamento <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione verso la<br />
fine del Quattrocento.<br />
Lasciamo per ora in sospeso la questione <strong>della</strong> "fine del Me<strong>di</strong>oevo" (ci torneremo nel<br />
paragrafo 5). Un punto <strong>di</strong> estrema importanza da mettere in rilievo è che, dopo aver<br />
visto un Me<strong>di</strong>oevo poco "me<strong>di</strong>evale", il Me<strong>di</strong>oevo che stiamo ora <strong>di</strong>scutendo non è<br />
particolarmente "me<strong>di</strong>o", né nel senso letterale, né in quello metaforico <strong>della</strong><br />
tra<strong>di</strong>zione storiografica. "Me<strong>di</strong>o" è un termine relativo, che non può fungere da<br />
pre<strong>di</strong>cato semplice <strong>di</strong> un soggetto, così come, per esempio, <strong>di</strong> una società si <strong>di</strong>ce che<br />
è industriale o agricola; la denominazione <strong>di</strong> "me<strong>di</strong>evale" presuppone tre termini, l'età<br />
<strong>di</strong> mezzo, l'antichità e il rinasciment,o modernità. Anche se per affezione<br />
continuiamo a parlare <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>oevo, vedere quell'epoca come una civiltà a sé<br />
comporta parlare del suo inizio senza riferirsi all' Antichità. Prima, nei secoli III-VII,<br />
12
il mondo antico si trasformò e scomparve; poi, stabilitesi fra il 700 e il 950 le<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> un «nuovo inizio» (secondo l'espressione <strong>di</strong> Aldo Schiavone già ricordata<br />
nella nota bibliografica in fondo al paragrafo 6 del capitolo 2), venne la civiltà<br />
del tutto originale del Me<strong>di</strong>oevo.<br />
Vicolo cieco o falsa partenza, il mondo antico si arrestò <strong>di</strong> fronte ai propri "limiti<br />
dello sviluppo" economici e tecnologici, determinati in parte dalla schiavitù e in parte<br />
dal modo in cui si configuravano le attività degne <strong>di</strong> uomini liberi. Nel suo nuovo<br />
inizio, il Me<strong>di</strong>oevo è prima <strong>di</strong> tutto un mondo scarsamente popolato e dominato dalle<br />
foreste e dalle palu<strong>di</strong>. Ma questo precario nuovo inizio fa da fondamento a<br />
un'originale civiltà, con la sua vitalità demografica e il suo sviluppo agricolo e<br />
urbano, con i suoi aratri pesanti, i mulini ad acqua e a vento, gli archi rampanti, gli<br />
orologi meccanici, gli occhiali, i telai a pedali, con la sua abbondante (relativamente<br />
al mondo antico) produzione <strong>di</strong> ferro, con i suoi tre secoli <strong>di</strong> espansione sulla<br />
frontiera dell'Europa centro-orientale e la sua rivoluzione commerciale e nautica del<br />
XIII secolo. È notevole il fatto che ai secoli XI-XIV appartengono la grande maggioranza<br />
se non la totalità dei motivi istituzionali e culturali che vengono<br />
comunemente associati all'immagine positiva del Me<strong>di</strong>oevo: l'urbanesimo, i comuni,<br />
la cultura citta<strong>di</strong>na, la letteratura cavalleresca, le università, la ricerca filosofica e<br />
scientifica."<br />
È vero che a questo Me<strong>di</strong>oevo appartengono, oltre alla cavalleria e alle crociate,<br />
anche fenomeni sui quali grava una cattiva fama: il feudalesimo e la servitù,<br />
l'Inquisizione e la caccia all'eretico, i pogrom antiebraici. Ma alla fine bisogna anche<br />
riconoscere che fra il Me<strong>di</strong>oevo oscuro e quello luminoso esistono rapporti molto<br />
complessi. La cattedrale gotica, summa dell'intera civiltà, non è precisamente<br />
un'oscurità squarciata dalla luce, uno sforzo per togliere il peso alla bruta materia<br />
La natura propria <strong>della</strong> civiltà me<strong>di</strong>evale viene misconosciuta tutte le volte che si<br />
impone il linguaggio fuorviante <strong>della</strong> "rinascita" dopo il Mille, <strong>della</strong> "ripresa" <strong>della</strong><br />
popolazione, delle città, dell'economia, dei commerci (in questa prospettiva il<br />
"rinascimento" <strong>di</strong>venta un fenomeno plurisecolare, concluso nel XV secolo dal<br />
Rinascimento in senso stretto, quello delle lettere e delle arti). Quanto compare fra il<br />
X e il XI secolo è invece una realtà nuova, <strong>di</strong>versa da quella che esisteva "prima", nel<br />
mondo antico. Questo va verificato non semplicemente mettendo a paragone<br />
Antichità e Me<strong>di</strong>oevo per stabilire chi dei due ha raggiunto le migliori prestazioni in<br />
fatto <strong>di</strong> sviluppo demografico, economico o tecnologico; l'Europa me<strong>di</strong>evale risulta in<br />
molti casi vincente, ma rispetto al Me<strong>di</strong>terraneo ellenistico e romano non ha mai<br />
avuto città <strong>della</strong> taglia <strong>di</strong> Roma o Alessandria o strutture paragonabili agli acquedotti<br />
e alle strade romane. Più interessante è invece rimarcare la <strong>di</strong>versità qualitative fra le<br />
due civiltà.<br />
Ci soffermeremo brevemente su due esempi <strong>di</strong> caratteri specifici <strong>della</strong> civiltà<br />
me<strong>di</strong>evale, cominciando con il caso <strong>della</strong> rete urbana e delle città. Un primo<br />
confronto, che tenga conto delle città romane scomparse e <strong>di</strong> quelle me<strong>di</strong>evali del<br />
tutto nuove, mostrerà che le due reti non coincidono. Ma anche nei casi <strong>di</strong> continuità<br />
fra i due sistemi urbani, questa si rivela piuttosto apparente non appena an<strong>di</strong>amo a<br />
constatare che le maggiori città dell'Europa me<strong>di</strong>evale, a cominciare da quelle<br />
13
italiane, erano per lo più centri secondari in epoca romana. Ancora più importante è<br />
la comparazione fra la città antica e quella me<strong>di</strong>evale dal punto <strong>di</strong> vista delle loro<br />
funzioni e del ruolo <strong>della</strong> citta<strong>di</strong>nanza. La città antica era prima <strong>di</strong> tutto una città<br />
politica, mentre dal punto <strong>di</strong> vista economico si configurava più come un centro <strong>di</strong><br />
consumo e <strong>di</strong> residenza che <strong>di</strong> produzione. Una parte delle attività produttive e<br />
commerciali era lasciata agli schiavi e agli stranieri; per gli uomini liberi la loro veste<br />
<strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni restava in ogni caso qualcosa <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinto dalla loro veste <strong>di</strong> produttori. La<br />
città me<strong>di</strong>evale riuscì invece a integrare le sue funzioni politiche ed economiche. Non<br />
solo essa dette pari <strong>di</strong>gnità alla piazza economica e a quella politica (aggiungendovi<br />
come terza e <strong>di</strong>stinta quella religiosa), ma fece derivare il ruolo <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>no<br />
<strong>di</strong>rettamente da quello <strong>di</strong> soggetto economico, richiedendo l'iscrizione a un'arte come<br />
prerequisito per l'esercizio pieno delle funzioni <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza. D'altra parte, per gli<br />
antichi la citta<strong>di</strong>nanza era legata all'idea <strong>di</strong> uguaglianza fra tutti i liberi (più o meno<br />
numerosi) che godevano <strong>di</strong> questo <strong>di</strong>ritto; il "popolo" delle città me<strong>di</strong>evali non era<br />
invece un insieme <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui, ma (come ha ben messo in rilievo Pietro Costa) un<br />
insieme <strong>di</strong> insiemi (quartieri, consorterie, conjurationes, corpi, arti, "università",<br />
confraternite). Come tutte le libertà me<strong>di</strong>evali, anche la citta<strong>di</strong>nanza era concepita<br />
come un privilegio, uno status eccezionale, che escludeva tutti coloro che vivevano<br />
fuori delle mura, nel contado, ed era riservato a una parte ristretta degli stessi<br />
residenti in città.<br />
Non c'è bisogno <strong>di</strong> una lunga <strong>di</strong>scussione per collegare il feudalesimo al Me<strong>di</strong>oevo. I<br />
due termini (che si scambiano così le loro implicazioni negative) vengono <strong>di</strong> solito<br />
identificati fmo a rendere il feudalesimo una presenza piuttosto invadente: nel<br />
Me<strong>di</strong>oevo lunga è la lista delle cose da qualificare come "feudali", i castelli, i signori,<br />
le guerre, la servitù, i privilegi e, a coronamento, l'anarchia. Valga quel che <strong>di</strong>ceva<br />
Condorcet, che trovava le espressioni «anarchia feudale» e «tirannia feudale» come i<br />
nomi più adatti a rappresentare la sostanza <strong>della</strong> sua «sesta epoca» (Abbozzo <strong>di</strong> un<br />
quadro storico, pp. 80 e 90). I confini temporali <strong>di</strong> questo Me<strong>di</strong>oevo feudale sono<br />
molto incerti e a volte esso risulta persino più ampio <strong>di</strong> quello lungo mille anni dei<br />
manuali <strong>di</strong> storia. Nello schema marxista <strong>di</strong> perio<strong>di</strong>zzazione si ha <strong>di</strong>rettamente un<br />
passaggio dalla società schiavista a quella "feudale", che è equivalente in pratica a<br />
quella "servile". Ma sono innumerevoli gli storici che hanno proposto una datazione<br />
molto alta del feudalesimo, riferendosi a fenomeni già in atto nel IV secolo, come<br />
l"'accasamento" degli schiavi e la trasformazione delle gran<strong>di</strong> proprietà in villae<br />
relativamente autosufficienti, già prossime alle signorie <strong>di</strong> seicento anni dopo. Nel<br />
saggio già citato precedentemente (capitolo 2, paragrafo 6) Max Weber affermò che<br />
«lo sviluppo <strong>della</strong> società feudale era già nell'aria nella tarda età imperiale» (p. 134) e<br />
considerò un «lontano prodromo dd feudo» l'assegnazione <strong>di</strong> terre, «secondo criteri <strong>di</strong><br />
una completa economia naturale», alle truppe che sorvegliavano i confini (p. 140).<br />
In un senso più stretto il feudalesimo deve almeno presupporre il feudo ed è perciò<br />
più frequente che esso venga fatto decorrere dal VII-VIII secolo. Quel che in ogni caso<br />
è parso indubbio a molte generazioni <strong>di</strong> storici è la sua precedenza cronologica<br />
rispetto alla "rinascita" <strong>della</strong> città, così da poter leggere il filo delle vicende<br />
successive al Mille come una lotta fra aristocrazia feudale e borghesia comunale.<br />
14
Collocare invece l'epoca <strong>della</strong> "mutazione feudale" proprio nei decenni attorno al<br />
Mille, e vederla come un fenomeno parallelo alla nascita delle città, conduce in un<br />
certo senso a riabilitare il feudalesimo e a farne un'originale "invenzione" del<br />
Me<strong>di</strong>oevo. Il feudalesimo fu anche una risposta a suo modo efficace a un'anarchia <strong>di</strong><br />
cui non era l'unico responsabile, <strong>di</strong>venendo un principio <strong>di</strong> riorganizzazione del<br />
territorio e dell'economia che, e sempre a suo modo, produsse sicurezza e si intrecciò<br />
positivamente con lo sviluppo <strong>della</strong> popolazione, dell'agricoltura e dell'economia<br />
degli scambi.<br />
Bibliografia <strong>di</strong> riferimento<br />
Alla perio<strong>di</strong>zzazione interna del Me<strong>di</strong>oevo sono de<strong>di</strong>cati i contributi al volume <strong>di</strong> P.<br />
Delogu (a c. <strong>di</strong>), Perio<strong>di</strong> e contenuti del Me<strong>di</strong>oevo, Il Ventaglio, Roma 1988.<br />
Considerazioni molto sensate sui criteri <strong>di</strong> delimitazione nd tempo <strong>della</strong> società<br />
me<strong>di</strong>evale sono state svolte dallo stesso Delogu nel paragrafo "Unità e varietà<br />
dell'epoca me<strong>di</strong>evale" <strong>della</strong> sua Introduzione allo stu<strong>di</strong>o <strong>della</strong> storia me<strong>di</strong>evale, il<br />
Mulino, Bologna 1994, pp. 65-72 (la citazione nel testo è tratta dalla p. 72). La civiltà<br />
dell'Occidente me<strong>di</strong>evale <strong>di</strong> J. <strong>Le</strong> Goff, comparsa originariamente nella collezione<br />
"<strong>Le</strong> gran<strong>di</strong> civiltà", Arthaud, Paris e Sansoni, Firenze 1969, è stata rie<strong>di</strong>ta nd 1981<br />
presso Einau<strong>di</strong>, Torino.<br />
Esagerando leggermente, J. Gimpel ha intitolato La révolution industrielle au Moyen<br />
Age il suo libro sulle innovazioni tecniche dei secoli me<strong>di</strong>evali, E<strong>di</strong>tions du Seuil,<br />
Paris 1975. Gli occhiali per correggere la presbiopia furono inventati verso il 1285. I<br />
primi orologi meccanici comparvero in questo stesso periodo. Il mulino ad acqua è<br />
un'invenzione antica, ma fu l'Europa me<strong>di</strong>evale ad attuare, oltre a una <strong>di</strong>ffusione su<br />
larga scala, la sua conversione da strumento per macinare il grano a macchina<br />
industriale, per fabbricare la carta, frantumare i minerali grezzi, tagliare il legno,<br />
follare i tessuti. Di quest'ultimo uso si occupa P. Malanima, I pie<strong>di</strong> <strong>di</strong> legno, Angeli,<br />
Milano 1988.<br />
«Il gotico» ha scritto O. von Simson «può essere descritto come un'architettura<br />
trasparente», e ancora: «Se il verticalismo gotico sembra ribaltare il movimento <strong>di</strong><br />
gravità, la finestra a vetrate colorate, per analogo paradosso estetico, nega in<br />
apparenza l'impenetrabilità <strong>della</strong> materia, traendo la sua esistenza visiva da un'energia<br />
che la trascende» (La cattedrale gotica. Il concetto me<strong>di</strong>evale <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne, 1962, il<br />
Mulino, Bologna 1988, p. 14). Nd suo celebre libro Architettura gotica e filosofia<br />
scolastica (1951), Liguori, Napoli 1986, E. Panofsky ha esaminato i caratteri <strong>di</strong><br />
razionalità comuni alle cattedrali e alle summae: totalità, <strong>di</strong>sposizione sistematica <strong>di</strong><br />
parti omologhe, <strong>di</strong>visioni e sud<strong>di</strong>visioni, cogenza deduttiva.<br />
Per il confronto fra l'urbanesimo romano e quello me<strong>di</strong>evale in Italia è da consultare<br />
il ricco dossier raccolto da E. Sestan in La città comunale italiana dei secoli XI-XIII<br />
nelle sue note caratteristiche rispetto al movimento comunale europeo (1960), ora in<br />
Id., Italia comunale e signorile, <strong>Le</strong> <strong>Le</strong>ttere, Firenze 1989. Su scala europea, si veda J.<br />
Reers, La città nel Me<strong>di</strong>oevo (1990), Jaca Book, Milano 1995. Per il confronto in<br />
termini socioculturali fra la città antica e quella me<strong>di</strong>evale è bene tornare alle analisi<br />
15
<strong>di</strong> M. Weber in Economia e società (1922), Ed. <strong>di</strong> Comunità, Milano 1974, vol. Il,<br />
pp. 530-679, pubblicate anche a sé con il titolo La città (1920), Bompiani, Milano<br />
1979. Sulla citta<strong>di</strong>nanza me<strong>di</strong>evale, si veda P. Costa, Civitas. <strong>Storia</strong> <strong>della</strong><br />
citta<strong>di</strong>nanza in Europa, vol. I, Laterza, Roma-Bari 1999, cap. 1, specie pp. 9-11. La<br />
contrapposizione fra città antica consumatrice e quella me<strong>di</strong>evale (e moderna)<br />
produttrice incontra comunque parecchie eccezioni; viene del tutto negata da A.<br />
Caran<strong>di</strong>ni, Manifatture rurali e urbane, in Id., Schiavi in Italia, cit., pp. 327-338.<br />
La tesi <strong>di</strong> una "rivoluzione feudale" awenuta in Francia alla fine del X secolo è stata<br />
argomentata da G. Duby in Una società francese nel Me<strong>di</strong>oevo. La regione <strong>di</strong> Mâcon<br />
nei secoli XI e XII (1953), il Mulino, Bologna 1985. Sui <strong>di</strong>battiti attorno al<br />
feudalesimo si vedano: J.P. Poly, E. Boumazd, Il mutamento feudale. Secoli X-XII<br />
(1980), Mursia, Milano 1990; G. Sergi, Lo sviluppo signorile e l'inquadramento<br />
feudale, in La <strong>Storia</strong>, Il. Il Me<strong>di</strong>oevo, <strong>di</strong>retta da N. Tranfaglia e M. Firpo, Utet,<br />
Torino 1988, pp. 369-393; D. Barthelémy, La mutation de l'Am Mil a-t-elle eu lieu,<br />
Fayard, Paris 1997.<br />
3.4 il Me<strong>di</strong>oevo e la nascita dell'Europa<br />
Trattare il Me<strong>di</strong>oevo come una civiltà a sé non <strong>di</strong>spensa dal confrontarsi con la<br />
domanda più impegnativa se il Me<strong>di</strong>oevo sia anche un periodo interno a una più<br />
ampia unità storica. Mentre il rapporto fra modernità/rinascimento e antichità è<br />
prevalentemente <strong>di</strong> natura culturale (e più nel senso <strong>di</strong> "cultura dotta" che in quello<br />
storico-antropologico), quelli fra antico e me<strong>di</strong>evale e fra me<strong>di</strong>evale e moderno<br />
richiedono invece un esame <strong>di</strong> tipo sostanziale.<br />
Del passaggio fra Antichità e Me<strong>di</strong>oevo si è già detto che esso comporta una rottura<br />
<strong>di</strong> continuità: cosa che resta vera sia che pensiamo a rotture catastrofiche (le invasioni<br />
germaniche o la serie <strong>di</strong> epidemie <strong>di</strong> peste bubbonica cominciata nel 541), sia<br />
che pensiamo a una lunga fase interme<strong>di</strong>a quale si configura la Tarda antichità. In entrambi<br />
i casi sono ampiamente provati fenomeni come la riduzione <strong>della</strong> popolazione<br />
e il mutamento del regime demografico, la <strong>di</strong>surbanizzazione e il degrado del paesaggio<br />
rurale. A marcare la <strong>di</strong>scontinuità bisogna aggiungere la profonda<br />
trasformazione <strong>della</strong> carta etnolinguistica dell'impero romano e dell'intera<br />
Europa avvenuta fra il V e il VIII secolo, con le migrazioni germaniche, slave, arabe<br />
e berbere (cui dobbiamo aggiungere la coda del X- XI secolo, con le migrazioni<br />
scan<strong>di</strong>nave e magiare). Un'attenzione particolare deve inoltre essere prestata al fatto<br />
che l'impero romano era stato in certo modo un punto <strong>di</strong> arrivo <strong>della</strong> storia del mondo<br />
antico, non <strong>di</strong>ciamo creando ma certo consolidando una civiltà relativamente unitaria<br />
nell'ambito del Me<strong>di</strong>terraneo. All'impero furono annesse regioni via via più estranee a<br />
questo teatro originario, fino al caso estremo <strong>della</strong> Britannia, ma la sua struttura<br />
fondamentale restò sempre l'unità del Me<strong>di</strong>terraneo. Tale unità era limitata<br />
dall'esistenza <strong>di</strong> due lingue ufficiali (il latino e il greco) e <strong>di</strong> molte lingue locali nonché<br />
dalle molteplici <strong>di</strong>fferenze che permasero fra Occidente e Oriente; ma questi<br />
limiti pesavano solo fino a un certo punto, perché il bilinguismo e il polilinguismo<br />
16
erano <strong>di</strong>ffusi e perché i movimenti <strong>di</strong> persone, merci e idee fra le <strong>di</strong>verse parti<br />
dell'impero erano intensi e non incontravano frontiere <strong>di</strong> nessun genere.<br />
Pur essendo riuscito ad annettere gran parte del continente europeo, portando il<br />
proprio confine fino alla linea Reno-Danubio, l'impero romano continuava a restare<br />
politicamente ed economicamente centrato sul Me<strong>di</strong>terraneo. Nel II secolo d.C. le<br />
province imperiali situate in Europa (nel senso geografico dell'espressione)<br />
rappresentavano più dei due terzi del territorio totale, ma meno <strong>della</strong> metà <strong>della</strong><br />
popolazione. Se ci riferiamo alla parte propriamente me<strong>di</strong>terranea dell'impero,<br />
comparandola alla sola Europa continentale, troveremo che il suo peso territoriale,<br />
demografico, economico e politico era ancor più nettamente preponderante. In queste<br />
con<strong>di</strong>zioni si capisce perché sia storicamente sensato ricondurre, come faceva Henri<br />
Pirenne, il passaggio dall' Antichità al Me<strong>di</strong>oevo alla fine <strong>della</strong> civiltà me<strong>di</strong>terranea e<br />
alla nascita <strong>di</strong> una civiltà europea e vedere quin<strong>di</strong> nel Me<strong>di</strong>oevo stesso il primo vero<br />
atto <strong>della</strong> storia dell'Europa. In altre parole, la fine dell'impero romano e del mondo<br />
antico comportò anche la separazione dell'Europa continentale geografica dai destini<br />
del Me<strong>di</strong>terraneo e l'emergere <strong>di</strong> un'Europa come nuova area <strong>di</strong> civiltà.<br />
Questo fatto va tenuto presente da chi fosse portato a vedere, più <strong>di</strong> quanto sia lecito,<br />
l'Europa come erede universale del mondo antico. In realtà fra il IV e l'VIII secolo il<br />
Me<strong>di</strong>terraneo si <strong>di</strong>vise in tre parti, quella latina, quella greca e quella araba; se è vero<br />
che la <strong>di</strong>sponibilità <strong>della</strong> civiltà islamica ad accogliere elementi <strong>di</strong> quella antica fu limitata<br />
ad alcuni aspetti <strong>della</strong> filosofia e <strong>della</strong> scienza e si esaurì nel giro <strong>di</strong> quattro<br />
secoli, è invece <strong>di</strong>fficile <strong>di</strong>re quale delle altre due ha più <strong>di</strong>ritto a riven<strong>di</strong>care l'ere<strong>di</strong>tà<br />
antica. Così pure, è <strong>di</strong>fficile attribuire maggiore autenticità a una o all'altra delle due<br />
confessioni cristiane, quella cattolico-romana, adottata dall'Europa occidentale, e<br />
quella greco-ortodossa (anche senza considerare le altre chiese cristiane, quelle<br />
monofisite e nestoriane). D'altra parte, la stessa saldatura fra Europa e Me<strong>di</strong>terraneo<br />
latino è stata complessa e problematica fino a tempi relativamente recenti. Volendo<br />
esprimere in maniera molto schematica che cosa costituisce la prima identità culturale<br />
dell'Europa dovremmo in<strong>di</strong>care una miscela composta da un terzo <strong>della</strong> civiltà antica,<br />
da meno <strong>della</strong> metà <strong>della</strong> religione cristiana e infine dal contributo germanico.<br />
La nascita dell'Europa non può peraltro ridursi solo a un dosaggio <strong>di</strong> questi tre<br />
elementi, ma va ricondotta anche ad altri fattori. Henri Pirenne invitò a tener conto <strong>di</strong><br />
quelli <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne geografico-ambientale. Diversi aspetti <strong>della</strong> sua tesi su "Maometto e<br />
Carlo Magno" («senza Maometto Carlo Magno è inconcepibile»), proposta anche<br />
prima <strong>di</strong> far da titolo all'opera postuma del 1937, non possono reggere <strong>di</strong> fronte ai<br />
fatti che la contrad<strong>di</strong>cono. In primo luogo, anche se accettiamo <strong>di</strong> assolvere le<br />
invasioni germaniche dal ruolo <strong>di</strong> fattore catastrofico nella storia finale del mondo<br />
antico, non è possibile affermare che le strutture <strong>di</strong> fondo <strong>di</strong> questo mondo erano<br />
ancora sostanzialmente intatte al principio del VII secolo. La stessa "rottura dell'unità<br />
me<strong>di</strong>terranea" era cominciata prima <strong>di</strong> Maometto e non può essere considerata l'unica<br />
causa del <strong>di</strong>sfacimento del mondo antico. Infine Pirenne dava troppa importanza al<br />
solo aspetto commerciale <strong>di</strong> quella rottura, che era stata peraltro meno prolungata e<br />
drastica <strong>di</strong> quanto egli pretendeva. Ma accettare queste correzioni certo non marginali<br />
non significa anche dover respingere la parte davvero essenziale <strong>della</strong> tesi <strong>di</strong> Pirenne,<br />
17
quella che contrappone l'impero romano e in genere il mondo antico me<strong>di</strong>terraneo<br />
(«la vita si concentra intorno alle rive del grande lago [...]. A misura che ci si<br />
allontana dal mare, la civiltà si va rarefacendo») al Me<strong>di</strong>oevo europeo e continentale<br />
(«l'Occidente fu imbottigliato e costretto a vivere su se stesso, in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vaso<br />
chiuso»).<br />
Fra i molti caratteri <strong>di</strong> questo spazio <strong>di</strong> civiltà europeo colto ai suoi albori dell ' VIII -<br />
IX secolo vi sono certamente il cristianesimo e il tentativo <strong>di</strong> ricollegarsi, con<br />
l'impero e la cosiddetta "rinascenza carolingia", alla prestigiosa tra<strong>di</strong>zione politica e<br />
culturale del mondo romano. Ma bisogna evitare <strong>di</strong> affrettare troppo i tempi, parlando<br />
<strong>di</strong> nascita dell'Europa già con Carlo Magno e con la sua renovatio dell'impero<br />
cristiano. Roberto S. Lopez ha fatto notare che fra il progetto imperiale carolingio e<br />
l'immagine corrente dell'Europa esistono due <strong>di</strong>fferenze fondamentali: «Oggi chi <strong>di</strong>ce<br />
Europa non pensa a una confessione unitaria o uno stato universale». Lo stesso<br />
impero romano, con le sue autonomie municipali e la sua cultura urbana, era stato<br />
meno compattamente "imperiale" degli imperi dell'Oriente antico. L'identità politicoculturale<br />
dell'Europa fu in ogni caso trovata più con l'unità religiosa (così che<br />
l'Europa si chiamò prima <strong>di</strong> tutto "Cristianità") che con i vari e falliti tentativi <strong>di</strong><br />
unificazione imperiale, da Carlo Magno a Carlo V. Dal punto <strong>di</strong> vista politico tale<br />
identità si manifesta lungo tutta la storia europea come la presenza contemporanea <strong>di</strong><br />
stati dalle più <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>mensioni e forme, regni, principati, repubbliche, stati<br />
citta<strong>di</strong>ni, confederazioni. Questa configurazione si costituì precisamente sulle<br />
macerie del <strong>di</strong>ssolto impero carolingio e si affermò nei secoli del pieno Me<strong>di</strong>oevo,<br />
riuscendo poi a sopravvivere a tutti i tentativi egemonici che si sono succeduti nell'età<br />
moderna. Dalla metà del xvii secolo il principio religioso pluriconfessionale e<br />
quello politico dell'equilibrio fra molti stati <strong>di</strong>vennero elementi essenziali <strong>della</strong><br />
"costituzione materiale" <strong>della</strong> complessiva "repubblica europea".<br />
Un altro carattere dell'identità europea è quello <strong>della</strong> separazione fra potere politico e<br />
potere religioso. Nessun impero europeo fu stabilmente costituito perché, da una<br />
parte, il cristianesimo non riuscì mai a ridursi al supporto teocratico del potere<br />
politico e, dall'altra, i sovrani riven<strong>di</strong>carono il valore autonomo delle loro funzioni<br />
secolari <strong>di</strong> pace e giustizia rispetto a quelle <strong>di</strong> salvezza per la vita eterna proprie <strong>della</strong><br />
Chiesa. La fine dell'impero carolingio comportò anche il progressivo estinguersi delle<br />
sue pretese teocratiche, se mai vi sono state, ma è anche da altri punti <strong>di</strong> vista che è<br />
importante prendere atto del suo rivelarsi un «gigante dai pie<strong>di</strong> d'argilla», così che<br />
(ancora con le parole <strong>di</strong> Lopez) «non si può chiamare prelu<strong>di</strong>o d'Europa quello che<br />
più esattamente va definito come una falsa partenza». La vera alba europea va vista<br />
pensando ad altri caratteri essenziali <strong>di</strong> questo nuovo mondo. Esso fu una civiltà <strong>di</strong><br />
pionieri e <strong>di</strong>ssodatori, che partì da basi quasi esclusivamente rurali e si dette spiccate<br />
strutture comunitarie (che la <strong>di</strong>fferenziano dalla proprietà agricola più in<strong>di</strong>vidualista<br />
dell'antico mondo me<strong>di</strong>terraneo), procedendo allo stesso tempo a creare un<br />
urbanesimo originale, molto <strong>di</strong>verso da quello del mondo antico. L'opera <strong>di</strong> Carlo<br />
Magno possiede una sua grande e duratura importanza, che ne fa un momento<br />
effettivo <strong>della</strong> storia dell'Europa, ma come tentativo <strong>di</strong> definire uno spazio politico fu<br />
troppo in anticipo sulla costruzione <strong>di</strong> uno spazio materiale. L'avvio con successo<br />
18
<strong>della</strong> creazione dell'Europa rurale riuscì invece precisamente sul fallimento del<br />
precoce esperimento carolingio, a cominciare, prima che dal troppo simbolico anno<br />
Mille, dalla seconda metà del X secolo. Cade opportuna qui l'osservazione che il<br />
successo <strong>di</strong> questa civiltà rurale <strong>di</strong>pese anche dall'affermazione del "feudalesimo" ,<br />
ovvero <strong>della</strong> signoria terriera, con le sue forme <strong>di</strong> organizzazione economica e<br />
politica del territorio. La «crisi etnica ininterrotta» dei secoli V-VIII, la «falsa<br />
partenza» dell' età carolingia e la «ricostruzione dal basso» cominciata con<br />
l'affermazione del feudalesimo (secondo le espressioni <strong>di</strong> Stefano Gasparri e Roberto<br />
S. Lopez) fanno tutte parte, come prologo a scena chiusa, introduzione e primo<br />
effettivo atto <strong>della</strong> storia d'Europa. E' superfluo avvertire che questa lettura <strong>della</strong><br />
storia del Me<strong>di</strong>oevo non deve essere forzata, creando l'illusione <strong>di</strong> scorgere già nella<br />
carta dei popoli e dei regni del IX o anche del XII secolo gli stati nazionali<br />
dell'Europa moderna. L'atto <strong>di</strong> nascita delle nazioni europee non sta nel giuramento <strong>di</strong><br />
Strasburgo dell'842 e così pure le "nazioni" delle università europee o anche dei<br />
concilii ecumenici non hanno niente a che fare con le nazioni nel senso ottocentesco<br />
<strong>della</strong> parola. La Germania fu a lungo solo la "Francia (nel senso <strong>di</strong> regno dei Franchi)<br />
orientale"; per parecchi secoli la "Francia" corrispose solo a una parte non grande<br />
<strong>della</strong> Gallia a nord <strong>della</strong> Loira. Come ha ben mostrato Yves Renouard, ancora al<br />
principio del XIII secolo molti tratti decisivi <strong>della</strong> futura Europa occidentale<br />
restavano assai incerti: la Spagna meri<strong>di</strong>onale era più legata al Marocco che<br />
all'Europa; in Inghilterra la <strong>di</strong>nastia regnante parlava il franco-normanno e stava per<br />
consolidare l'unione fra i domini normanni e inglesi e quelli posseduti sul lato<br />
atlantico <strong>della</strong> Francia; i legami fra la Catalogna e la Linguadoca erano ben più forti<br />
<strong>di</strong> quelli che l'una e l'altra avevano con la Spagna e con la Francia. Strade ben <strong>di</strong>verse<br />
da quelle che sarebbero state seguite verso gli stati e le nazioni europee erano<br />
ancora del tutto aperte e lo sarebbero rimaste fino al XIV e anche fino al XV secolo.<br />
L'unione Castiglia-Portogallo poteva realizzarsi al posto <strong>di</strong> quella Castiglia-Aragona<br />
e lo stesso vale per quella tra Borgogna e Paesi Bassi al posto <strong>di</strong> quella tra Francia e<br />
Borgogna.<br />
Riferimenti bibliografici:<br />
Sui limiti dell'unità linguistica del mondo romano, si vedano E. Campanile, <strong>Le</strong> lingue<br />
dell'impero, in <strong>Storia</strong> <strong>di</strong> Roma <strong>di</strong>retta da A. Momigliano e A. Schiavone, vol. IV,<br />
Caratteri e morfologie, Einau<strong>di</strong>, Torino 1989, pp. 679-691 e C. Mango, La civiltà<br />
bizantina (1980), Laterza, Roma-Bari 1991, cap. 1, "Popoli e lingue".<br />
Al libro <strong>di</strong> H. Pirenne, Maometto e Carlomagno (1939), Laterza, Bari 1969 (le<br />
citazioni sono tratte dalle pp. 225, 3-4, 276), è ancora legato l'intervento<br />
particolarmente stimolante <strong>di</strong> G. Petralia, A proposito dell'immortalità <strong>di</strong> "Maometto<br />
e Carlo Magno" (o <strong>di</strong> Costantino), in "Storica", 1995, n. 1, pp. 37-87.<br />
Il Me<strong>di</strong>oevo viene presentato spesso in termini <strong>di</strong> "nascita dell'Europa", ma con<br />
angolature tematiche e demarcazioni cronologiche molto <strong>di</strong>verse. C. Dawson, La<br />
nascita dell'Europa (1939), il Saggiatore, Milano 1969, affermando che «è bene ri.<br />
cordare che l'unità <strong>della</strong> nostra civiltà non poggia soltanto sulla cultura laica e sul<br />
19
progresso materiale degli ultimi quattro secoli» e che bisogna saper risalire «oltre i<br />
trionfi superficiali <strong>della</strong> civiltà moderna» (p. 334), trattò il periodo V-XI secolo e<br />
dette un'importanza cruciale alla formazione <strong>della</strong> cristianità occidentale L. Febvre,<br />
L'Europa. <strong>Storia</strong> <strong>di</strong> una Civiltà (1944.45), Donzelli, Roma 1999, de<strong>di</strong>cò gran parte<br />
del suo corso universitario rimasto a lungo ine<strong>di</strong>to al tema "l'Europa sorge quando<br />
l'impero romano crolla", R.S. Lopez, La nascita dell'Europa. Secoli V-XIV, Einau<strong>di</strong>,<br />
Torino 1966 (citazione da p. 107) portò la sua esposizione fino al principio del XIV<br />
secolo. Alla questione Nascita dell'Europa ed Europa carolingia: una equazione da<br />
verificare è stata de<strong>di</strong>cata la XXVII settimana <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> del Centro italiano sull'alto<br />
Me<strong>di</strong>oevo, Spoleto 1981. R. Fossier, Enfance de l'Europe, Puf, Paris 1982, che<br />
concorda con Lopez nel negare a Carlo Magno il ruolo <strong>di</strong> "padre dell'Europa", si<br />
concentra sui secoli X-XII. M. Banniard, La genesi culturale dell'Europa (1989),<br />
Laterza, Roma-Bari 1994, pone l'oggetto specifico <strong>della</strong> sua indagine nel periodo<br />
compreso fra il 400 e l'800, a cavallo fra la Tarda antichità e l'alto Me<strong>di</strong>oevo. J. <strong>Le</strong><br />
Goff è intervenuto due volte sul tema, con L'Europa me<strong>di</strong>evale e il mondo moderno,<br />
Laterza, Roma-Bari 1994 e Il Me<strong>di</strong>o Evo. Alle origini dell'identità europea, Laterza,<br />
Roma-Bari 1996. La storia del termine "Europa", da espressione puramente<br />
geografica a nome <strong>di</strong> una peculiare civiltà, è stata oggetto <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> opere che<br />
mantengono la loro importanza anche al <strong>di</strong> fuori del particolare momento in cui<br />
furono scritte, i <strong>di</strong>battiti europeisti all'indomani <strong>della</strong> Seconda guerra mon<strong>di</strong>ale: F.<br />
Chabod, <strong>Storia</strong> dell' idea d'Europa, Laterza, Bari 1961; C. Curcio, Europa, storia <strong>di</strong><br />
un'idea, Vallecchi, Firenze 1958; D. Hay, Europe, the Emergence of an Idea,<br />
E<strong>di</strong>nburgh University Press, 1957, 1968; J.B. Duroselle, L'idea d'Europa nella storia,<br />
Milano Nuova, Milano 1964.<br />
Sul rapporto fra nazioni me<strong>di</strong>evali e nazioni moderne, si vedano K.F. Werner, <strong>Le</strong>s<br />
nations et le sentiment national dans l'Europe mé<strong>di</strong>évale, in "Revue Historique",<br />
1970, t. 244, pp. 285-304 e S. Gasparri, Prima delle nazioni. Popoli; etnie e regni fra<br />
Antichità e Me<strong>di</strong>oevo, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1997, il lavoro <strong>di</strong> Y.<br />
Renouard ricordato nel testo è 1212-1216. Comment les traits durables de l'Europe<br />
occidentale moderne se soni définis au début du XIII siècle (1958), in Id., Etudes<br />
d'histoire mé<strong>di</strong>évale, Sevpen, Paris 1968, vol. I, pp. 77-91.<br />
3.5 Il lunghissimo Me<strong>di</strong>oevo: il concetto <strong>di</strong> Ancien Régime<br />
Quando finisce il Me<strong>di</strong>oevo Presa alla lettera e nella sua forma più generale, la<br />
domanda non ha alcun senso. Riusciamo a dargliene uno se abbandoniamo la vaga<br />
idea <strong>di</strong> età <strong>di</strong> mezzo e leghiamo il termine "me<strong>di</strong>oevo" solo a processi storici<br />
deteminati avvenuti a partire dal X secolo, come la conquista del territorio rurale, la<br />
crescita demografica, urbana, economica, e a determinati caratteri culturali, sociali,<br />
politici. Di questa ben in<strong>di</strong>viduata realtà storica, l'Europa me<strong>di</strong>evale, possiamo <strong>di</strong>re<br />
che cominciò a volgere al tramonto quando ancora era intenta a progettare un futuro<br />
ottimista e gran<strong>di</strong>oso.<br />
20
Alcuni esempi che spesso vengono ricordati non possono fare a meno <strong>di</strong><br />
impressionare. Ve<strong>di</strong>amo per primo quello <strong>di</strong> Firenze. Nel 1284, supponendo che il<br />
grande sviluppo economico e demografico <strong>della</strong> città fosse destinato a continuare, le<br />
autorità comunali or<strong>di</strong>narono la costruzione <strong>di</strong> una nuova cerchia muraria, che portò<br />
la superficie urbana da 97 ettari (ai quali vanno però aggiunti i numerosi borghi sorti<br />
fuori delle vecchie mura) a 630 ettari. I lavori furono completati nel 1333, quando<br />
Firenze doveva contare circa 100mila abitanti, ma la più ampia superficie restò<br />
totalmente non e<strong>di</strong>ficata e occupata solo da orti e giar<strong>di</strong>ni; dopo essere stata<br />
<strong>di</strong>mezzata dalla peste del 1348, la popolazione oscillò per quattro o cinque secoli fra<br />
le 40 e le 80mila unità e il livello del 1330 fu superato solo dopo il 1830. Un secondo<br />
esempio è quello <strong>di</strong> Siena al principio del Trecento. Negli anni trenta il governo comunale<br />
commissionò ad Ambrogio Lorenzetti l'esecuzione del celebre affresco sugli<br />
Effetti del buon governo, che mostrava fra l'altro i segni <strong>della</strong> vitalità e<strong>di</strong>lizia <strong>della</strong><br />
città. Allo stesso tempo il comune decise <strong>di</strong> intervenire ancora sul duomo, che era<br />
appena stato soggetto ai lavori <strong>di</strong> ampliamento conclusi a fine Duecento con la<br />
costruzione. <strong>della</strong> facciata; la vecchia cattedrale sarebbe ora <strong>di</strong>ventata solo il transetto<br />
<strong>di</strong> una assai più grande. Ma anche in questo caso l'immagine del futuro si rivelò<br />
ingannatrice; la prima fase del progetto, la ristrutturazione <strong>della</strong> piazza, dovette essere<br />
abbandonata nel giro <strong>di</strong> pochi anni.<br />
Sull'orizzonte del breve periodo, in entrambi i casi gli insuccessi sono da ricondurre<br />
agli effetti <strong>della</strong> peste del 1348. Ma a sua volta la peste è un aspetto <strong>della</strong> "crisi generale"<br />
del Trecento, cominciata già prima del 1348 e proseguita oltre i termini<br />
cronologici del secolo, fino alla metà del Quattrocento e oltre. Preso nel suo insieme<br />
il periodo 1300-1450 o anche 1300-1500, il "basso Me<strong>di</strong>oevo" delle perio<strong>di</strong>zzazioni<br />
tria<strong>di</strong>che dell'intero Me<strong>di</strong>oevo, si presenta come una sorta <strong>di</strong> terzo e ultimo tempo<br />
rispetto alla ricerca <strong>di</strong> un "nuovo inizio" del VII-X secolo e alla vera e propria civiltà<br />
me<strong>di</strong>evale del X-XIV secolo. Questo basso Me<strong>di</strong>oevo appare inoltre come un<br />
"autunno", un periodo che si <strong>di</strong>lunga così interminabilmente da assumere quasi<br />
caratteri propri: nella prospettiva dell'analisi culturale <strong>di</strong> Johann Huizinga, «il sogno<br />
<strong>di</strong> una vita più bella» che deve coprire «i toni cru<strong>di</strong> <strong>della</strong> vita».<br />
<strong>Le</strong> carestie, la peste e le guerre riassumono i bene i "toni cru<strong>di</strong>" dell'epoca. A essi<br />
dobbiamo aggiungere i <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni sociali nelle campagne e nelle città e la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong><br />
movimenti <strong>di</strong> panico e angoscia collettiva. Fra questi aspetti esistono sicuramente<br />
concreti rapporti, così da fame un sistema unitario <strong>della</strong> catastrofe, ma non fino al<br />
punto da far scomparire la loro specificità. La peste fu un fenomeno esogeno alla<br />
storia dell'Europa e quasi alla storia come tale. li sistema pulce-bacillo <strong>della</strong> peste,<br />
che si installò fra i ro<strong>di</strong>tori delle steppe centroasiatiche e coinvolse la storia umana<br />
solo accessoriamente, <strong>di</strong>venne endemico in alcuni climi asiatici ma non in Europa,<br />
dove ogni epidemia dovette essere reimportata dall'Oriente. In secondo luogo il grado<br />
<strong>di</strong> letalità <strong>della</strong> peste è del tutto in<strong>di</strong>pendente dalle con<strong>di</strong>zioni delle società nelle quali<br />
viene a imbattersi; se l'epidemia fosse comparsa nel pieno del più felice secolo XIII<br />
non avrebbe avuto effetti molto meno funesti.<br />
Diverso è invece il <strong>di</strong>scorso che si deve fare per le carestie, che non sono<br />
riconducibili solo al fattore, ugualmente esogeno, del peggioramento climatico<br />
21
cominciato nel XIV secolo. È in esse çhe la civiltà me<strong>di</strong>evale mostrò <strong>di</strong> aver<br />
raggiunto i limiti del proprio sviluppo. Questo problema è stato spesso presentato in<br />
termini <strong>di</strong> rapporto fra popolazione e risorse primarie, secondo un semplice modello<br />
malthusiano <strong>di</strong> maggiore crescita <strong>della</strong> prima rispetto alle seconde. Se siamo restii ad<br />
attribuire alla popolazione il ruolo <strong>di</strong> variabile in<strong>di</strong>pendente, possiamo invece<br />
chiederci perché a un certo punto la società me<strong>di</strong>evale non fu in grado <strong>di</strong> aggiungere<br />
una crescita intensiva a quella estensiva perseguita con successo per tre secoli. In<br />
ogni caso è <strong>di</strong>fficile sottrarsi all' ammissione che accanto ai limiti posseduti in quanto<br />
società feudale, l'Europa me<strong>di</strong>evale era soggetta a quelli posseduti in quanto società<br />
preindustriale agricola. Appartiene ai primi il modo con cui l'aristocrazia cavalleresca<br />
reagì <strong>di</strong> fronte alle trasformazioni, come il maggior potere dei re e la <strong>di</strong>ffusione dell'economia<br />
monetaria, che la stavano emarginando; essa accrebbe la sua pressione sul<br />
mondo conta<strong>di</strong>no e partecipò con comportamenti sempre più ban<strong>di</strong>teschi alle guerre<br />
del XIV e XV secolo. Rimanda ai secon<strong>di</strong> ciò che Archibald R. <strong>Le</strong>wis, trasferendo al<br />
Me<strong>di</strong>oevo europeo un concetto creato per la storia nordamericana, ha complessivamente<br />
chiamato «chiusura <strong>della</strong> frontiera». Nei secoli X-XIII la frontiera esterna<br />
dell'Europa era avanzata continuamente, a occidente con la riconquista spagnola e a<br />
oriente con i movimenti <strong>di</strong> colonizzazione nella regione fra Elba e Oder e poi in<br />
quella baltica. I limiti <strong>di</strong> questa frontiera furono raggiunti con la fine <strong>della</strong><br />
reconquista e con la temibile installazione dei mongoli a est <strong>della</strong> linea Cracovia-<br />
Transilvania. I limiti <strong>della</strong> frontiera interna si avvicinarono quando la crescita <strong>della</strong><br />
superficie coltivata prese a minacciare le essenziali fonti energetiche <strong>di</strong> una società<br />
preindustriale: i pascoli naturali, dai quali <strong>di</strong>pendeva la forza motrice bovina ed<br />
equina dei suoi aratri, e i boschi, dai quali <strong>di</strong>pendevano le sue costruzioni e<strong>di</strong>lizie e<br />
navali, le attività produttive <strong>di</strong> ogni genere, il riscaldamento, la cottura dei cibi.<br />
Questo modello <strong>di</strong> spiegazione non è privo <strong>di</strong> punti deboli; va notato in particolare<br />
che, se anche la crisi del basso Me<strong>di</strong>oevo cominciò come chiusura <strong>della</strong> frontiera, si<br />
mantenne poi in con<strong>di</strong>zioni ben <strong>di</strong>verse da quelle <strong>di</strong> partenza, perché l'Europa<br />
posteriore al 1380, con la popolazione permanentemente ridotta <strong>di</strong> un buon terzo, non<br />
era più quella del 1300, prossima alle gran<strong>di</strong> carestie del 1315-1345. In ogni caso, il<br />
punto essenziale <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>scussione è che la crisi trecentesca dell'Europa me<strong>di</strong>evale<br />
è ben <strong>di</strong>versa dalla fine del mondo antico, perché nonostante i suoi aspetti catastrofici<br />
essa resta una fase interna alla storia dell'Europa. Preso nel suo insieme il basso Me<strong>di</strong>oevo<br />
condusse a rendere in gran parte obsoleto quel che aveva caratterizzato la<br />
civiltà me<strong>di</strong>evale, a partire dagli stati citta<strong>di</strong>ni, dal feudalesimo (inteso come<br />
frammentazione locale dei poteri pubblici) e dalla cavalleria, che dovettero cedere <strong>di</strong><br />
fronte alle nuove istituzioni politiche e militari degli stati regionali e delle monarchie<br />
nazionali. Tutto questo e altro ancora viene normalmente classificato sotto la<br />
denominazione <strong>di</strong> "moderno" e ciò ha indubbiamente le sue ragioni. Ma per altri e<br />
non secondari aspetti il basso Me<strong>di</strong>oevo è anche una fase <strong>di</strong> un lunghissimo<br />
"me<strong>di</strong>oevo" che si prolunga fino al Settecento, fino alla Rivoluzione francese e anche<br />
oltre. Il terzo tempo dell'età me<strong>di</strong>evale è innanzitutto il primo tempo del periodo<br />
1350-1700 (e oltre), un altro esempio, accanto al Tardoantico, <strong>di</strong> perio<strong>di</strong>zzazione<br />
costruita proprio ignorando il confine fra le età <strong>della</strong> tra<strong>di</strong>zionale storia tripartita, così<br />
22
da far perdere il suo risalto alla canonica "età moderna". L'unitarietà <strong>di</strong> questo<br />
periodo è data dalla ripetizione <strong>di</strong> due cicli che si presentano con caratteri <strong>di</strong> forte<br />
comparabilità: al ciclo me<strong>di</strong>evale concluso dalla crisi del Trecento segue un nuovo<br />
ciclo, con il ramo ascendente dello sviluppo economico e demografico cinquecentesco<br />
e la nuova crisi generale del Seicento, ancora segnata dalla triste<br />
associazione <strong>di</strong> carestia, peste (e altre epidemie) e guerra. .<br />
Il XVII secolo è stato per gli storici il terreno <strong>di</strong> scoperta e verifica delle singole<br />
perio<strong>di</strong>che "crisi <strong>di</strong> antico regime", oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o congiunto <strong>di</strong> economisti e demografi.<br />
In esse una carestia è alle origini <strong>di</strong> una crisi economica, che dall'agricoltura si<br />
estende alle manifatture e alle attività finanziarie, e <strong>di</strong> una crisi <strong>di</strong> "mortalità", che è<br />
variamente connessa con le epidemie dei tempi <strong>di</strong>fficili (tifo, gastroenteriti) e con la<br />
peste. Ciò che produce una crisi generale è il ripetersi con intensità maggiore, a <strong>di</strong>stanza<br />
più ravvicinata e in connessione con gran<strong>di</strong> guerre, <strong>di</strong> tali "crisi <strong>di</strong> antico<br />
regime". La <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> documenti demografici ed economici permette <strong>di</strong><br />
rintracciarle più facilmente nel XVII e anche nel XVI secolo, ma non c'è dubbio che<br />
ugualmente il Trecento e il Quartrocento ne offrono occorrenze esemplari. Ma<br />
quando finisce esattamente l'epoca <strong>di</strong> queste crisi Nei decenni fra Seicento e<br />
Settecento la peste scomparve dall'Europa per ragioni sulle quali ancora si <strong>di</strong>scute.<br />
Inoltre dopo il 1720 le guerre assunsero un carattere più limitato e non incisero molto<br />
sul nuovo ciclo <strong>di</strong> sviluppo economico e demografico che si stava aprendo. Ciò non<br />
toglie che anche il XVIII secolo abbia visto il ripetersi <strong>di</strong> sequenze <strong>di</strong> crisi innescate<br />
da una carestia, e una <strong>di</strong> queste fu precisamente connessa con gli eventi rivoluzionari<br />
del 1789. L'Europa rurale <strong>di</strong> <strong>Antico</strong> regime aveva raggiunto due volte i limiti dello<br />
sviluppo, verso il 1300-1320 e verso il 1600-1620; restava elevata la probabilità che<br />
il nuovo ciclo <strong>di</strong> crescita agricola e demografica cominciato dopo il 1720 si<br />
concludesse in maniera analoga ai due precedenti, portando il Me<strong>di</strong>oevo-<strong>Antico</strong><br />
regime fin dentro il XIX secolo. Si può supporre che nel non verificarsi <strong>di</strong> una terza<br />
crisi abbiano giocato la loro parte la "riapertura" <strong>della</strong> frontiera interna (con la<br />
rivoluzione industriale) e <strong>di</strong> quella esterna (con l'emigrazione oltre Atlantico <strong>di</strong> 50<br />
milioni <strong>di</strong> europei fra il 1820 e il 1914).<br />
Il protrarsi del lunghissimo Me<strong>di</strong>oevo ben oltre la fine del XV secolo presenta<br />
comunque molti altri aspetti, oltre a quelli economici e demografici. L'espressione<br />
Ancien régime <strong>di</strong>venne <strong>di</strong> uso comune nella Francia rivoluzionaria del 1790-91,<br />
avendo lo stesso significato <strong>di</strong> "regime feudale", ciò che l'Assemblea nazionale aveva<br />
<strong>di</strong>chiarato «completamente <strong>di</strong>strutto» con i decreti <strong>di</strong>scussi e approvati fra il 4 e l'11<br />
agosto 1789. A sua volta "regime feudale" era una nozione molto più estesa <strong>della</strong><br />
speciale con<strong>di</strong>zione giuri<strong>di</strong>ca cui erano soggette le terre denominate feu<strong>di</strong> (e in<br />
genere del complesso delle norme che limitavano la proprietà privata borghese e<br />
conta<strong>di</strong>na) e costituiva in gran parte l'essenza del Me<strong>di</strong>oevo oscuro condannato dagli<br />
illuministi. Ma mentre i feu<strong>di</strong> erano un'istituzione che era riuscita a sopravvivere per<br />
mille anni, altri aspetti dell'<strong>Antico</strong> regime erano storicamente più recenti e<br />
riconducevano alla società <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ni, <strong>di</strong> "stati" o <strong>di</strong> "corpi" i cui tratti stabili si erano<br />
venuti definendo nel Duecento se non nel basso Me<strong>di</strong>oevo. Fanno parte dell' <strong>Antico</strong><br />
regime così inteso i privilegi, che riguardavano in primo luogo la nobiltà, ma che per<br />
23
ogni "corpo" (le città, le province, le università, le corporazioni) costituivano un<br />
possesso da <strong>di</strong>fendere accanitamente; e ancora la superiorità delle <strong>di</strong>stinzioni sociali<br />
fondate sull'onore e sul rango rispetto a quelle fondate sul profitto; la venalità delle<br />
cariche, gli appalti delle imposte, le assemblee rappresentative degli "stati".<br />
Soffermiamoci in particolare sul sistema <strong>della</strong> rappresentanza. Esso riuscì a rendere<br />
nuovamente attuale la democrazia sulla scala dei gran<strong>di</strong> stati nazionali, ma Rousseau<br />
non aveva torto a <strong>di</strong>re che ci derivava «dal governo feudale, da questo iniquo e<br />
assurdo governo nel quale la specie umana è degradata» (p. 802 dell'e<strong>di</strong>zione citata<br />
nel capitolo 2, paragrafo 4). In quanto sistema degli "stati", l'<strong>Antico</strong> regime si<br />
mantenne in Europa ben oltre il 1789. Il moderno sistema parlamentare inglese non<br />
ebbe fino al 1832 mo<strong>di</strong>fiche sostanziali rispetto a quello derivato <strong>di</strong>rettamente dal<br />
Me<strong>di</strong>oevo, e la riforma elettorale che garantì alla borghesia commerciale e industriale<br />
una prima presenza nella camera dei comuni fu percepita come non molto lontana da<br />
una rivoluzione.<br />
In tutti gli stati del XIX secolo nei quali esisteva un senato <strong>di</strong> nomina regia restò<br />
anche in vita un pezzo <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>oevo. Un caso limite, che riguardava peraltro la<br />
maggiore potenza continentale europea, era quello <strong>della</strong> legge elettorale <strong>della</strong> Prussia;<br />
in questo stato, <strong>di</strong>venuto dopo il 1870 il centro politico del Reich tedesco, ancora al<br />
principio del XX secolo il Landtag continuava a essere eletto secondo il sistema<br />
me<strong>di</strong>evale degli "stati", che garantiva un terzo dei seggi alla nobiltà terriera degli<br />
Junker.<br />
Bibliografia <strong>di</strong> riferimento:<br />
Per gli esempi <strong>di</strong> Firenze e Siena, si vedano: G. Fanelli, Firenze, architettura e città,<br />
Vallecchi, Firenze 1973; D. Balestracci, G. Piccinni, Siena nel Trecento: assetto<br />
urbanistico e strutture e<strong>di</strong>li zie, Clusf, Firenze 1977; C. Frugoni, Il governo dei Nove<br />
a Siena e il loro credo politico nell'affresco <strong>di</strong> Ambrogio Lorenzetti, in "Quaderni<br />
me<strong>di</strong>evali", 1979, n. 7, pp. 14-42, e n. 8, pp. 71-103. Dell'Autunno del Me<strong>di</strong>oevo <strong>di</strong> J.<br />
Huizinga (1919), Sansoni, Firenze 1966, sono stati citati i titoli dei due primi capitoli.<br />
L'articolo <strong>di</strong> A.R. <strong>Le</strong>wis è The Closing o/ the Me<strong>di</strong>eval Frontiel; 1250-1350, in<br />
"Speculum", 1958, pp. 475-483.<br />
La tesi <strong>di</strong> un «lungo Me<strong>di</strong>oevo che giunge fmo al XIX secolo» è stata argomentata<br />
dal. <strong>Le</strong> Goff, Intervista sulla storia, a c. <strong>di</strong> F. Maiello, Laterza, Roma-Bari 1982, pp.<br />
81-86. P. Goubert ha de- finito l'origine e la portata del concerto <strong>di</strong> Ancien Régime<br />
«un magma confuso <strong>di</strong> cose vecchie e recenti» nel primo capitolo <strong>di</strong> L'Ancien Régime<br />
(1969),Jaca Book, Milano 1976, vol. I, pp. 17- 43 (la 2' e<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> quest'opera, 1984,<br />
trad. it. 1989, è scritta in collaborazione con D. Roche).<br />
L'Europa tra due crisi (Einau<strong>di</strong>, Torino 1980) è il titolo sotto il quale R. Romano ha<br />
raccolto i suoi stu<strong>di</strong> sulla crisi del Trecento e del Seicento. La letteratura sui due cicli<br />
<strong>di</strong> crisi, variamente affermati e negati dagli storici, è ovviamente immensa e bisogna<br />
rinunciare a darne un resoconto anche sommario. Il concetto <strong>di</strong> "crisi <strong>di</strong> antico<br />
regime" è stato introdotto dal. Meuvret, <strong>Le</strong>s crise de subsistance et la démographie<br />
de la France d'Ancien Régime (1946), in Id., Etudes d'histoire économique, A. Colin,<br />
24
Paris 1971, pp. 271-278. La mancanza <strong>di</strong> connessione fra carestie ed epidemie <strong>di</strong><br />
peste è facilmente verificabile anche per il XVII secolo; è invece evidente il ruolo<br />
delle guerre, con i movimenti <strong>di</strong> truppe appestate, nella trasmissione da una regione<br />
all'altra <strong>della</strong> peste bubbonica.<br />
La "società <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ni" come ben <strong>di</strong>stinta dalla "società <strong>di</strong> classi" ha costituito l'oggetto<br />
degli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> R. Mousnier, in particolare <strong>Le</strong> gerarchie sociali dal 1450 al nostri<br />
giorni (1969), Vita e Pensiero, Milano 1971 e <strong>Le</strong>s institutions de la France sous la<br />
monarchie absolue, 1598-1789, Puf, Paris 1974-1980, 2voll.<br />
Lo "stato <strong>di</strong> ceti" o anche lo "stato <strong>di</strong> stati" occupa una posizione centrale anche in O.<br />
Brunner, Terra e nobiltà (1939, 1965), Giuffré, Milano 1983 (in particolare le pp.<br />
561-588), che si serve <strong>della</strong> sua peculiare nozione <strong>di</strong> storia costituzionale per<br />
esaminare le strutture politico-territoriali austriache nel periodo 1250-1600. A.I.<br />
Mayer, Il potere dell'Ancien Régime fino alla prima guerra mon<strong>di</strong>ale (1981), Laterza,<br />
Roma-Bari 1982, ha mostrato come l'aristocrazia terriera e militare dell' <strong>Antico</strong><br />
regime abbia conservato per tutto il XIX secolo un ruolo determinante nelle<br />
istituzioni politiche europee.<br />
3.6 Il Me<strong>di</strong>oevo, l'Europa e l'Asia<br />
Nelle cinque accezioni <strong>di</strong> "Me<strong>di</strong>oevo" fm qui esaminate ci siamo sempre limitati alla<br />
storia europea. Qualunque tentativo <strong>di</strong>.parlare <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>oevo al <strong>di</strong> fuori dell'Europa non<br />
ha molte speranze <strong>di</strong> presentarsi come un'indagine legittima, se quel che compiamo<br />
attraverso questa nozione è una definizione <strong>di</strong> identità culturale, volta cioè a stabilire<br />
un rapporto fra noi e i "nostri antichi" oppure a porre una <strong>di</strong>stanza polemica fra<br />
la nostra modernità e i secoli bui (o altro ancora). Abbiamo però anche visto che è<br />
possibile fare un uso non convenzionale dell'idea <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>oevo, parlando <strong>di</strong> prima età<br />
nella specifica storia dell'Europa invece che <strong>di</strong> età <strong>di</strong> mezzo. Ma non appena<br />
l'obiettivo dell'indagine <strong>di</strong>venta quello <strong>di</strong> definire i tempi dell'Europa, non si può<br />
respingere a priori il tentativo <strong>di</strong> estendere il campo <strong>di</strong> osservazione ai tempi del<br />
mondo, ricercando gli intrecci fra <strong>di</strong>verse aree geografiche e fra <strong>di</strong>verse storie <strong>di</strong><br />
civiltà e, quando è possibile, proponendo perio<strong>di</strong>zzazioni che cerchino <strong>di</strong><br />
sincronizzarle tutte su un'unica storia del mondo.<br />
Il nuovo Me<strong>di</strong>oevo che compare da questo punto <strong>di</strong> vista, quello <strong>della</strong> World History,<br />
dovrà necessariamente fare a meno <strong>di</strong> un nome troppo compromettente e figurerà in<br />
principio solo come il periodo compreso fra il III e il XIV secolo. Questo per quanto<br />
riguarda la <strong>di</strong>mensione temporale, che cercheremo più avanti <strong>di</strong> giustificare. Per ciò<br />
che riguarda la <strong>di</strong>mensione spaziale, non dobbiamo attenderci dalla World History<br />
un'assunzione <strong>di</strong> garanzia circa l'unità <strong>della</strong> storia del mondo in qualsiasi epoca. Nel<br />
periodo considerato la nostra attenzione si concentrerà, oltre che sui rapporti fra<br />
Europa e Me<strong>di</strong>terraneo, su quelli fra Europa e Asia, non solo, naturalmente,<br />
limitandosi alle aree dei due continenti che avevano fatto parte da millenni <strong>della</strong><br />
storia comune me<strong>di</strong>terranea. Affinché si stabiliscano relazioni fra l'Europa e l' Africa<br />
subsahariana dobbiamo invece aspettare epoche successive; a partire dall'VIII secolo<br />
e più ancora dall'XI cominciò tuttavia a esistere un'area <strong>di</strong> storia comune fra l'Africa e<br />
25
il mondo islamico, sia attraverso i rapporti che correvano con il Nordafrica e la<br />
Spagna dalla parte del Sahara, sia attraverso quelli tra Africa orientale, Arabia e<br />
Me<strong>di</strong>o Oriente dalla parte dell'oceano In<strong>di</strong>ano, del golfo Persico e dal mar Rosso.<br />
Ancora <strong>di</strong> più dobbiamo aspettare per il primo stabilirsi <strong>di</strong> relazioni fra l'America e<br />
l'Europa e (dopo quelle originarie avvenute prima <strong>di</strong> 15mila anni fa) fra l'America e<br />
l'Asia, escludendo quelle non durevoli che possono essere esistite prima dell'epoca<br />
<strong>della</strong> "scoperta". Per ciò che riguarda i rapporti fra l'Europa e l'Asia, si è già detto<br />
(capitolo 2, paragrafo 2) del ruolo strategico ricoperto dalla Bactriana lungo la via<br />
<strong>della</strong> seta. Nel I secolo d.C. <strong>di</strong>versi testi latini e greci davano notizie dettagliate sui<br />
vari percorsi terrestri che conducevano dalla Siria a Bactra e nel Il secolo la<br />
Geografia <strong>di</strong> Clau<strong>di</strong>o Tolomeo aggiunse una precisa descrizione del percorso<br />
successivo, da Bactra a Kashgar, l'oasi situata alle soglie del deserto centroasiatico<br />
del Taklamakan. Verso la fine del I secolo a.C. navigatori greci scoprirono le pratiche<br />
<strong>della</strong> navigazione monsonica fra il corno d'Africa e l'In<strong>di</strong>a occidentale, da dove<br />
arrivavano il pepe e le spezie; Roma, che si era appena impadronita dell'Egitto in<br />
seguito alla vittoria <strong>di</strong> Azio, dette la giusta importanza a questa scoperta considerando<br />
essenziale per i propri interessi strategici il controllo del mar Rosso. Nel I e Il secolo<br />
d.C. lungo le vie terrestri e marittime il Me<strong>di</strong>terraneo e la Cina si scambiarono,<br />
accanto alle merci, almeno alcune sommarie informazioni sui rispettivi popoli e<br />
imperi: i romani chiamavano "seres" i cinesi, mentre la storia ufficiale degli Han<br />
posteriori menziona con il nome <strong>di</strong> "Ta Ch'in" l'impero romano e con quello <strong>di</strong> "An-<br />
Tun" l'imperatore Marco Aurelio Antonino.<br />
Questo primo incrociarsi fra l'Europa e l'Asia orientale restò comunque episo<strong>di</strong>co e i<br />
rapporti <strong>di</strong>retti fra Roma e l'In<strong>di</strong>a, e a maggior ragione la Cina, furono certo minimi in<br />
confronto a quelli condotti tramite i rami occidentali delle piste carovaniere e le rotte<br />
dell'oceano In<strong>di</strong>ano, le une e le altre soggette al controllo dei parti. Per trovare<br />
sincronie rivelatrici <strong>di</strong> veri e propri momenti unitari nella storia dell'Eurasia<br />
dobbiamo spostarci al iv-v secolo, un avvio <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>oevo segnato ovunque dalla crisi<br />
<strong>di</strong> gran<strong>di</strong> imperi, con il duplice sconvolgimento delle crisi generali interne ed esterne.<br />
In questo periodo la pressione <strong>di</strong> popoli "barbari" provocò il crollo quasi simultaneo<br />
dell'impero cinese, <strong>di</strong> quello romano e <strong>di</strong> quello in<strong>di</strong>ano dei Gupta, mettendo inoltre<br />
in serio pericolo quello persiano dei Sasani<strong>di</strong>. I circa trecento anni che vanno dal 220<br />
(crollo dell'impero cinese degli Han posteriori) ai decenni attorno al 500 (invasioni <strong>di</strong><br />
noma<strong>di</strong> in In<strong>di</strong>a e in Persia) sono forse un po' troppi perché si possa parlare <strong>di</strong> un'unitaria<br />
grande crisi eurasiatica; l'espressione "simultaneità" non sembra usata nel suo<br />
significato letterale, pur ammettendo che alle gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni degli spazi coinvolti<br />
devono avere corrisposto relazioni temporali non istantanee. D'altra parte non è del<br />
tutto provato che gli xiong-nu presenti nelle fonti cinesi dal III secolo a.C. al III d.C.<br />
e gli unni delle fonti romane siano lo stesso popolo, e qualche dubbio si ha anche<br />
sull'identificazione fra gli unni invasori dell'impero romano e gli huna (o eftali<strong>di</strong>) e<br />
gli hyon invasori dell'In<strong>di</strong>a e <strong>della</strong> Persia.<br />
Nonostante il peso <strong>di</strong> questi argomenti, gli storici dell'Asia centrale continuano a<br />
mostrarsi favorevoli a vedere come legate fra <strong>di</strong> loro le serie <strong>di</strong> avvenimenti che sono<br />
state più sopra ricordate. Per affermare qualche relazione fra i <strong>di</strong>versi popoli che<br />
26
portarono il nome <strong>di</strong> "unni" o le sue varianti, non è necessario considerarli uno stesso<br />
popolo in movimento da un capo all'altro dell' Asia centrale. Il nome "unni" può<br />
essere ben circolato da un gruppo etnico e linguistico all'altro; si può anzi considerare<br />
un dato <strong>di</strong> fatto che il nome "unni" sia passato e ripassato dal I al IV secolo da gruppi<br />
europoi<strong>di</strong> (gli "unni bianchi") a gruppi proto-turchi e proto-mongoli. Se poi<br />
consideriamo il protrarsi delle invasioni noma<strong>di</strong> in Cina nel III e IV secolo e delle<br />
lotte continue fra gruppi <strong>di</strong>versi, l'intervallo fra il 220 e il 375 (l'anno in cui gli unni<br />
comparvero per la prima volta a Occidente) non appare del tutto incolmabile. Non<br />
molto tempo dopo l'Asia centrale offrì un altro esempio (questa volta maggiormente<br />
provato) <strong>di</strong> spostamento su lunghe <strong>di</strong>stanze e su un lungo arco <strong>di</strong> tempo <strong>di</strong> uno stesso<br />
impero nomade: gli avari comparvero in Cina settentrionale al principio del V secolo<br />
(venendo chiamati "juan-juan" o "ruan-ruan") e ricomparvero nella seconda metà del<br />
VI secolo ai confini settentrionali <strong>della</strong> Persia e poi sulla frontiera fra la Pannonia e<br />
l'impero bizantino.<br />
È interessante osservare che adottando il punto <strong>di</strong> vista <strong>della</strong> crisi generale eurasiatica<br />
si è costretti a rivedere in parte il ruolo dei germani nella <strong>di</strong>ssoluzione dell'impero<br />
romano d'Occidente. Tutto ciò che abitualmente si <strong>di</strong>ce sulle cause interne, profonde<br />
e <strong>di</strong> lunga data, <strong>della</strong> crisi dell'impero resta naturalmente vero, e lo stesso vale per la<br />
capacità <strong>di</strong> sopravvivere dell'impero d'Oriente, che pure fu in principio assai più<br />
esposto alla minaccia degli unni. Ma anche quel che viene suggerito dal confronto fra<br />
le scorrerie germaniche del III secolo e le "gran<strong>di</strong> invasioni" del IV-V va tenuto nel<br />
debito conto. La prime, in<strong>di</strong>pendenti dalle vicende del noma<strong>di</strong>smo centroasiatico,<br />
furono alla fme arrestate dallo stato romano; le seconde, provocate dal terrore che<br />
incuteva l'avanzata degli unni, svelarono drammaticamente la debolezza dell'impero<br />
d'Occidente. <strong>Le</strong> scorrerie degli avari nell'VIII secolo e quello degli ungari nel X,<br />
sempre a partire dalla Pannonia/Ungheria, furono le estreme (e anche le ultime in<br />
or<strong>di</strong>ne cronologico) frange del noma<strong>di</strong>smo centroasiatico a toccare l'Europa. Nel<br />
corso del VI secolo l'attacco dei noma<strong>di</strong> delle steppe alla fascia delle civiltà urbanoagricole<br />
che correva dalla Cina all'impero romano si era andato esaurendo.<br />
Me<strong>di</strong>evale<br />
Il "me<strong>di</strong>oevo barbarico" con<strong>di</strong>viso da tutte queste civiltà era finito. Per trovare<br />
un'altra epoca nella quale la storia del continente eurasiatico appare muoversi<br />
secondo un unico "tempo del mondo" dobbiamo attendere l'XI secolo. Fra il 600 e il<br />
1000 l'Europa rimase in rapporto solo con la parte più occidentale dell' Asia, prima<br />
quella inserita nell'impero bizantino e successivamente quella conquistata dagli arabi.<br />
In entrambi i casi è evidente che è solo l'Europa a essere collocata in un'epoca<br />
"me<strong>di</strong>evale". Compiendo solo in parte un abuso concettuale, gli storici hanno a volte<br />
presentato la relazione fra l'Europa dell'alto Me<strong>di</strong>oevo e gli imperi bizantino e arabo<br />
come una relazione fra un'area sottosviluppata e società sviluppate. Dal punto <strong>di</strong> vista<br />
economico l'Europa scambiava materie prime e prodotti agricoli (ferro, legname,<br />
forza-lavoro schiavile, grano) contro prodotti manifatturieri e agricoli più daborati<br />
(tessuti preziosi, spezie, zucchero). Dal punto <strong>di</strong> vista intellettuale l'arretratezza<br />
27
europea era anche maggiore, perché fu solo dalla fine del X secolo e dall'XI che<br />
l'Occidente cominciò a "importare" dalla Spagna e dall'Italia meri<strong>di</strong>onale testi<br />
filosofici e scientifici tradotti dall'arabo e dal greco. La seconda fase <strong>di</strong> una storia<br />
eurasiatica con tratti unitari è compresa più o meno fra il 1000 e il 1350 e corrisponde<br />
dalla parte dell'Europa al pieno <strong>di</strong>spiegarsi dei caratteri propri <strong>della</strong> civiltà<br />
me<strong>di</strong>evale, dalla parte dell' Asia alla serie <strong>di</strong> eventi che molto sommariamente si<br />
possono riassumere come segue. Per prime, nell'XI-XII secolo, vengono le gran<strong>di</strong><br />
migrazioni turche verso occidente, nel "Turkestan" sorto nelle regioni storiche <strong>della</strong><br />
Sog<strong>di</strong>ana, Corasmia e Bactriana (corrispondenti circa agli attuali Uzbechistan e<br />
Mghanistan settentrionale), nd califfato <strong>di</strong> Baghdad e nell'Asia minore bizantina (la<br />
futura Turchia). Nel XII-XIII secolo fu la volta dei mongoli. Verso il 1130 la tribù dei<br />
Kara-Khitai emigrò in <strong>di</strong>rezione dell' Asia centrale; dal 1206 Gengis Khan cominciò<br />
la costruzione dell'impero mongolo, che a sud-est si estese fino alla Cina e a ovest e<br />
sud-ovest conquistò il regno Kara-Khitai, l'impero turco-persiano <strong>della</strong> Corasmia, la<br />
Russia meri<strong>di</strong>onale e il califfato <strong>di</strong> Baghdad.<br />
Ciò che si verifica in questo periodo è qualcosa <strong>di</strong> più intenso <strong>di</strong> occasionali<br />
accostamenti fra storie che restano sostanzialmente in<strong>di</strong>pendenti e anche <strong>di</strong> più<br />
complesso del "me<strong>di</strong>oevo barbarico" eurasiatico del III-VI secolo. È vero che<br />
l'espansione dei turchi selgiuchi<strong>di</strong> (a <strong>di</strong>fferenza. <strong>di</strong> quanto accadrà nel XIV-XV<br />
secolo per i turchi ottomani) non toccò il continente europeo e che esso fu toccato<br />
marginalmente, nel 1241, dall'avanzata mongola; le conseguenze in<strong>di</strong>rette <strong>di</strong> questi<br />
avvenimenti sull'Europa furono non<strong>di</strong>meno molto forti. <strong>Le</strong> crociate sono in gran parte<br />
un sottoprodotto delle migrazioni/invasioni turche nel Me<strong>di</strong>o Oriente (alle quali va<br />
ricondotto l'inizio del "Me<strong>di</strong>oevo arabo", su cui torneremo nel paragrafo seguente).<br />
Ugualmente la "rivoluzione commerciale" europea del XIII-XIV secolo è certo una<br />
conseguenza <strong>della</strong> vitalità <strong>della</strong> civiltà me<strong>di</strong>evale, ma è anche un momento interno<br />
alla storia complessiva dell'Eurasia, nell'epoca <strong>della</strong> pax mongolica e del pieno<br />
ristabilimento <strong>della</strong> funzionalità <strong>della</strong> via <strong>della</strong> seta.<br />
Fra il 1250 e il 1340 le relazioni Europa-Cina raggiunsero il più alto grado <strong>di</strong><br />
intensità mai verificatosi fino ad allora. Fu nel secolo dell'unificazione dell'Asia<br />
centrale sotto l'impero mongolo che, secondo alcuni stu<strong>di</strong>osi, l'Europa importò<br />
dall'Oriente non solo sete e spezie, ma anche alcune decisive tecnologie cinesi (la<br />
tecnologia è il tratto culturale più facile a trasmettersi), che includono fra l'altro i tre<br />
fondamenti <strong>della</strong> modernità: la bussola, la stampa, la polvere da sparo; e fu in questo<br />
stesso periodo che si venne formando il duraturo mito dell'Oriente favoloso, che<br />
rimanda alle visioni <strong>di</strong> Cristoforo Colombo e <strong>di</strong> nuovo all'inizio canonico dell'età<br />
moderna. Un ultimo aspetto <strong>della</strong> storia eurasiatica del XIV secolo, cui abbiamo già<br />
fatto riferimento nel paragrafo 5, è quello <strong>della</strong> <strong>di</strong>ffusione <strong>della</strong> peste. Benché non<br />
tutto sia chiarito in questo meccanismo, si può considerare come un dato certo il<br />
ruolo giocato dai più intensi rapporti fra l'Asia centrale e il mar Nero, dove si<br />
trovavano le più importanti stazioni terminali <strong>della</strong> via <strong>della</strong> seta. Fu nella colonia<br />
genovese <strong>di</strong> Caffa che, nella primavera del 1347 , comparve l'epidemia <strong>di</strong> peste che si<br />
sarebbe poi <strong>di</strong>ffusa in tutta l'area me<strong>di</strong>terranea e nell'Europa continentale.<br />
28
Di poco successiva alla peste fu la fine <strong>della</strong> pax mongolica lungo la via <strong>della</strong> seta.<br />
Dal 1359 il khanato dell'Orda d'oro cominciò a <strong>di</strong>ssolversi in principati fra <strong>di</strong> loro<br />
rivali. Nel 1368 le rivolte cinesi si conclusero con l'espulsione dei mongoli; la nuova<br />
<strong>di</strong>nastia Ming si <strong>di</strong>mostrò poco favorevole alla presenza <strong>di</strong> missionari europei. Si<br />
chiudeva così un'intera epoca <strong>della</strong> storia eurasiatica. <strong>Le</strong> relazioni fra Europa e Cina<br />
sarebbero riprese solo sul finire del xvi secolo.<br />
Bibliografia <strong>di</strong> riferimento:<br />
<strong>Le</strong> notizie sui contatti fra l'impero romano e la Cina sono raccolte e commentate da J.<br />
Innes Miller, Roma e la via delle spezie (1969), Einau<strong>di</strong>, Torino 1974, cap. 7; G.<br />
Borsa, La nascita del mondo moderno in Asia Orientale, Rizzoli, Milano 1977, pp.<br />
13-18, 461-463; M. Poinsotte, <strong>Le</strong>s romains et la Chine: réalités et mythes, in<br />
"Mélanges de l'École Française de Rome. Antiquité", 1979, pp. 431-479; C. Nicolet,<br />
L'inventario del mondo. Geografia e politica alle origini dell'impero romano (1988),<br />
Laterza, Roma-Bari 1989, cap. 4.<br />
Al parallelismo fra gli avvenimenti dell'Occidente romano e quelli dell'Oriente cinese<br />
dà un certo rilievo R.S. Lopez, La nascita dell'Europa, cit., pp. 31-34. Anche M.<br />
Bussagli, L'Asia centrale e il mondo dei noma<strong>di</strong>, in L'Asia centrale e il Giappone,<br />
Utet, Torino 1970, cap. 2, parla <strong>di</strong> crisi generale eurasiatica. L.N. Gurnilev, Gli unni<br />
(1960), Einau<strong>di</strong>, Torino 1972, stu<strong>di</strong>a i rapporti fra unni e xiong-nu. I.P. Roux, L'Asie<br />
centrale. Histoire et civilisations, Fayard, Paris 1997, è la più recente sintesi sull' A-<br />
sia centrale. La ricerca <strong>di</strong> una causa unica per i movimenti dei noma<strong>di</strong> nel III-V<br />
secolo (in particolare una fase <strong>di</strong> inari<strong>di</strong>mento del clima e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> contrazione dei<br />
pascoli) non ha comunque portato ad alcun risultato.<br />
I saggi raccolti nel volume D. Lombard, J. Aubin (a c. <strong>di</strong>), Marchands et hommes<br />
d'a/faire asiatiques dons l'Océan ln<strong>di</strong>en et la Mer de la Chine, trattano l'oceano<br />
In<strong>di</strong>ano come un'area <strong>di</strong> World History sul lungo periodo XIII-XVI secolo, portando<br />
il loro orizzonte cronologico anche fino al xx. Ai rapporti dell'Europa con Bisanzio e<br />
con l'impero islamico nell' alto Me<strong>di</strong>oevo sono de<strong>di</strong>cati R.S. Lopez, Bysantium and<br />
the World around it, Variorum Reprints, London 1978 e M. Lombard, Espace et<br />
réseaux du Haut Moyen Age, Mouton, Paris-La Haye 1972. C. Cahen, Oriente e<br />
Occidente ai tempi delle crociate (1983), il Mulino, Bologna 1986, presenta le<br />
crociate non solo come un episo<strong>di</strong>o <strong>della</strong> storia europea, ma anche dal punto <strong>di</strong> vista<br />
<strong>della</strong> storia dell' Asia nei secoli XI-XIII.<br />
Sui rapporti Europa-Asia e in particolare Europa-Cina nel Me<strong>di</strong>oevo, si vedano: J.<br />
Needham, Scienza e civiltà in Cina, vol. I, Uneamenti introduttivi (1954), Einau<strong>di</strong>,<br />
Torino 1981; J.P. Roux, Gli esploratori nel Me<strong>di</strong>oevo (1985), Garzanti, Milano 1990;<br />
R. Etiemble, L'Europe chinoise, vol. I, GaIlimard, Paris 1988.<br />
3.7 Il Me<strong>di</strong>oevo come modello teorico universale :<br />
29
Un ulteriore (e ultimo) passo in <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> una definizione sempre più larga <strong>di</strong><br />
"Me<strong>di</strong>oevo" si può azzardare con la proposta <strong>di</strong> un vero e proprio modello teorico,<br />
applicabile a tempi e spazi del tutto in<strong>di</strong>pendenti da quelli dell'originaria applicazione<br />
del concetto. Ciò può essere fatto in due mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>stinti. Il primo, conforme allo stile<br />
<strong>della</strong> World History, ci riporta alle idee <strong>di</strong> "nuovo inizio" (o semplicemente <strong>di</strong> inizio)<br />
e <strong>di</strong> conquista <strong>della</strong> frontiera, specialmente <strong>di</strong> quella "esterna" (ve<strong>di</strong> paragrafi 3 e 5).<br />
Si tratta <strong>della</strong> costruzione <strong>di</strong> uno spazio rurale <strong>di</strong> villaggi e campi coltivati partendo<br />
dall'ambiente selvaggio e quasi <strong>di</strong>sabitato delle gran<strong>di</strong> foreste, degli acquitrini nelle<br />
gran<strong>di</strong> pianure alluvionali, delle palu<strong>di</strong>, dei mari d'erba delle steppe e procedendo poi<br />
con le opere <strong>di</strong> <strong>di</strong>sboscamento, <strong>di</strong>ssodamento, bonifica. Lynn White jr. ha presentato<br />
la conquista del "selvaggio West" americano come una sorta <strong>di</strong> proseguimento del<br />
Me<strong>di</strong>oevo europeo e come fondato su una sua solida ere<strong>di</strong>tà. Nel <strong>di</strong>sparato insieme <strong>di</strong><br />
fattori in<strong>di</strong>cato da White troviamo tecnologie come il mulino a vento e il carro dei<br />
pionieri, che <strong>di</strong>scende dai carri me<strong>di</strong>evali e dalle innovazioni (ferratura dei cavalli e<br />
sistema <strong>di</strong> attacco basato sul collare da spalla e sul timone) con le quali dall'XI-XII<br />
secolo il Me<strong>di</strong>oevo europeo si assicurò un controllo degli spazi terrestri superiore a<br />
quello che ebbero i romani; ma anche segni <strong>di</strong>stintivi come il gioco delle carte,<br />
un'invenzione del XIV secolo, e il whisky, che deriva dalle procedure <strong>di</strong> <strong>di</strong>stillazione<br />
scoperte in Italia nel XII secolo e applicate al grano fermentato al principio del XV<br />
secolo in Boemia e successivamente in Scozia. L'analogia fra il Wild West e l'Europa<br />
me<strong>di</strong>evale (presa anche a rovescio, utilizzando il primo come termine <strong>di</strong> paragone)<br />
può essere anche spinta oltre, pensando alla storia <strong>della</strong> frontiera dal X al XIV secolo<br />
nel "selvaggio est" al <strong>di</strong> là del fiume Elba, dal Meclemburgo e dalla Pomerania alla<br />
Prussia e alla Livonia: anche qui abbiamo i pionieri, gli "in<strong>di</strong>ani" (prima i polacchi,<br />
poi i prussiani e gli altri popoli baltici), la "cavalleria" (prima quella degli Ottoni, poi<br />
quella <strong>di</strong> Enrico il <strong>Le</strong>one, infine gli or<strong>di</strong>ni dei cavalieri Teutonici e Portaspada) e le<br />
città e le postazioni militari <strong>di</strong> frontiera (come Lubecca nel XII secolo o Marienburg<br />
nel XIV). Un forte limite a questa analogia parrebbe essere costituito dal fatto che<br />
nell'Europa centro-orientale dei secoli me<strong>di</strong>evali c'era il feudalesimo (nel senso <strong>di</strong><br />
relazioni vassallatiche con un prevalente contenuto militare), mentre, secondo<br />
l'immagine più comune, nel Wild West americano vigeva una libertà molto prossima<br />
all'anarchia, nonché, come sostenne Frederick J. Turner, a una peculiare forma <strong>di</strong><br />
democrazia. Ma va tenuto presente che le istituzioni feudali trasferite sulla frontiera<br />
orientale dell'Europa me<strong>di</strong>evale riuscirono a lungo a convivere non solo con i<br />
privilegi garantiti nelle città a borghesi e mercanti, ma anche con la relativa<br />
con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> libertà dei piccoli pos- sessori conta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> fronte ai proprietari laici ed<br />
ecclesiastici, Fu solo a partire dal XV secolo che feudalesimo e servitù conta<strong>di</strong>na<br />
vennero a ricongiungersi e a identificarsi. È notevole, come è stato spesso osservato<br />
dagli stu<strong>di</strong>osi dell'Europa orientale, che la servitù conta<strong>di</strong>na si sia qui<br />
progressivamente rafforzata assieme ai gran<strong>di</strong> latifon<strong>di</strong> granari essenzialmente<br />
orientati all'esportazione verso occidente; anche la frontiera americana vide nelle<br />
colonie e poi negli stati del sud il procedere simultaneo dell'economia delle<br />
piantagioni e <strong>della</strong> schiavitù.<br />
30
Un' altra situazione storica che si presenta come leggibile attraverso il modello<br />
Me<strong>di</strong>oevo/frontiera è quella dell'Ucraina, <strong>della</strong> Russia meri<strong>di</strong>onale e per ultimo del<br />
Kazakistan settentrionale nel periodo compreso fra la fine del XVI secolo e la fine del<br />
XVIII o anche la metà del XIX. Anche qui abbiamo la lenta avanzata <strong>di</strong> una società<br />
rurale, nuova in un enorme spazio potenzialmente dotato <strong>di</strong> terra fertile, ma poco<br />
abitato perché a<strong>di</strong>bito unicamente a pascolo dalle popolazioni noma<strong>di</strong> che lo<br />
controllavano. Anche qui, inoltre, lo spazio <strong>della</strong> frontiera si identifica in principio<br />
con uno spazio <strong>della</strong> libertà, verso il quale sono attratti i conta<strong>di</strong>ni <strong>della</strong> Polonia e<br />
<strong>della</strong> Russia settentrionale che cercano <strong>di</strong> sfuggire ai processi <strong>di</strong> asservimento. In<br />
questo mondo <strong>di</strong> fuggiaschi e fuorilegge, collocato cioè al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> ogni costrizione<br />
legale, i tartari <strong>di</strong> Crimea e gli altri noma<strong>di</strong> turco-mongoli ricoprono il ruolo dei "selvaggi»<br />
da sloggiare e i cosacchi figurano in un ruolo paragonabile in parte a quello<br />
dei cavalieri teutonici e <strong>della</strong> cavalleria americana, assumendo spesso <strong>di</strong> fatto il ruolo<br />
<strong>di</strong> protettori dei conta<strong>di</strong>ni fuggiaschi. Ma la frontiera ucraino-russa ebbe<br />
un'evoluzione ben <strong>di</strong>versa rispetto a quella americana e anche a quella orientale<br />
dell'Europa me<strong>di</strong>evale, anche a non voler tener conto <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>pendeva dai<br />
<strong>di</strong>fferenti contesti politico-religiosi (ortodosso, calvinista, cattolico me<strong>di</strong>evale). I<br />
turco-mongoli erano un avversario ben più pericoloso degli in<strong>di</strong>ani d'America e<br />
inoltre potevano godere dell'aiuto dell'impero ottomano; per conseguenza il mondo<br />
<strong>della</strong> frontiera <strong>della</strong> Russia meri<strong>di</strong>onale non poté fare a meno <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendere dall' aiuto<br />
politico-militare degli zar. In secondo luogo l'emigrazione verso le regioni dei bassi<br />
corsi del Dnepr, del Don e del Volga cominciò quando la servitù conta<strong>di</strong>na si trovava<br />
in Russia a uno sta<strong>di</strong>o già assai più avanzato <strong>di</strong> quello <strong>della</strong> Germania orientale<br />
nell'XI-XII secolo. Che quella russa non sarebbe stata una frontiera <strong>di</strong> libertà sociale<br />
e politica era in gran parte scritto ben prima <strong>della</strong> fallita ribellione dei cosacchi e dei<br />
conta<strong>di</strong>ni nel 1773-1774.<br />
Esiste anche un secondo modo per parlare <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>oevo al <strong>di</strong> fuori dello spazio-tempo<br />
europeo; con esso rischiamo <strong>di</strong> entrare nel generoso terreno dei problemi inesistenti,<br />
ma possiamo anche recuperare alcuni aspetti del significato originario del concetto.<br />
Torniamo dunque a ripetere che, in questo senso, un "me<strong>di</strong>oevo" è una fase interme<strong>di</strong>a<br />
fra altre due età. La prima, un'epoca antica o forse meglio "classica",<br />
fornisce le basi religiose e culturali <strong>di</strong> una civiltà, viene troncata da un'epoca <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni interni e invasioni "barbariche" dall'esterno e seguita da un'età <strong>di</strong> mezzo dai<br />
volti molteplici, oscura eppure costretta a essere creativa. La seconda è caratterizzata<br />
dal fatto <strong>di</strong> essere allo stesso tempo nuova e rivolta al futuro ("moderna") e<br />
desiderosa <strong>di</strong> ricollegarsi con le proprie ra<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> classicità ("rinascimento").<br />
Di un "me<strong>di</strong>oevo" così inteso si è parlato per la prima volta a proposito <strong>della</strong> storia<br />
ellenica antica, facendo seguire a un'età "classica" micenea un'età "oscura" compresa<br />
fra il 1150 e il 900 a.C. e poi, preceduta da una fase arcaica che include anche<br />
la <strong>di</strong>ffusione dei poemi omerici (VIII secolo), una nuova epoca classica, quella <strong>della</strong><br />
polis. L'espressione "età oscura" si giustifica in parte con il fatto che essa appare<br />
piuttosto priva <strong>di</strong> documentazione e che vide anche la scomparsa del sistema <strong>di</strong><br />
scrittura detto "Lineare B" in uso nell'età micenea. È evidente che fra gli storici ebbe<br />
anche una gran presa l'immagine delle invasioni barbariche, rappresentate in questo<br />
31
caso dai dori. Ma è su alcuni altri esemplari <strong>di</strong> me<strong>di</strong>oevo che vorremmo soprattutto<br />
richiamare l'attenzione, a cominciare da quello cinese. Jacques Gernet ha intitolato "Il<br />
me<strong>di</strong>oevo" la parte del suo libro Il mondo cinese sul periodo compreso fra la fine del<br />
II secolo e il 589, con il ristabilimento dell'unità <strong>della</strong> Cina sotto la <strong>di</strong>nastia Sui,<br />
oppure il 626, con il consolidamento <strong>della</strong> <strong>di</strong>nastia T'ang. Il paragone con il<br />
Me<strong>di</strong>oevo europeo è ovviamente limitato dal fatto che quello cinese è molto più<br />
breve, perché dura solo poco più <strong>di</strong> quattro secoli. Ma gli elementi che rendono interessante<br />
una comparazione sono troppo numerosi per essere considerati secondari:<br />
non solo la <strong>di</strong>visione in molti regni barbarici, ma anche una crisi religiosa <strong>di</strong> portata<br />
simile all'estinzione del paganesimo ellenistico-romano <strong>di</strong> fronte al cristianesimo.<br />
Come ha scrirto Gernet, «il me<strong>di</strong>oevo cinese è anche un periodo <strong>di</strong> grande fervore<br />
religioso e si può <strong>di</strong>re che la Cina <strong>di</strong> quell'epoca fu bud<strong>di</strong>sta così come fu cristiana la<br />
nostra Europa me<strong>di</strong>evale». La fine del Me<strong>di</strong>oevo cinese comportò nell'VIII secolo un<br />
«ritorno alle fonti <strong>della</strong> tra<strong>di</strong>zione classica», nel senso <strong>di</strong> un "rinascimento" letterario<br />
e filosofico; la Cina andò anche più in là, perché il governo imperiale ridette il posto<br />
che competeva alle religioni tra<strong>di</strong>zionali e si oppose attivamente al bud<strong>di</strong>smo, fino a<br />
vietare completamente questo culto. D'altra parte, come fanno notare Mario Sabattini<br />
e Paolo Santangelo nella loro <strong>Storia</strong> <strong>della</strong> Cina, se il concetto <strong>di</strong> me<strong>di</strong>oevo si applica<br />
utilmente alla storia cinese, è anche vero che questo Me<strong>di</strong>oevo non conobbe né il feudalesimo<br />
né la capacità del bud<strong>di</strong>smo (a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto fece il cristianesimo in<br />
Occidente) <strong>di</strong> porsi «come potere autonomo nei confronti dello stato».<br />
Un'altra <strong>di</strong>fferenza con il Me<strong>di</strong>oevo europeo consiste nel fatto che questo è accaduto<br />
storicamente una sola volta, mentre la Cina ne ha attraversati ancora due o tre. Anche<br />
per il mondo arabo si può parlare con qualche utilità <strong>di</strong> una o più età me<strong>di</strong>evali,<br />
ma è solo sulla prima <strong>di</strong> queste che svolgeremo qualche rapida considerazione,<br />
osservando prima <strong>di</strong> tutto che il "me<strong>di</strong>oevo barbarico" arabo comincia poco dopo che<br />
quello europeo si era avviato a finire. Nel corso dell'XI secolo l'Islam dovette subire<br />
la pressione dei barbari cristiani (spagnoli, franchi, normanni) in Spagna, in Sicilia, in<br />
Palestina. Ma l'analogia più interessante va trovata piuttosto nelle migrazioni dei<br />
turchi selgiuchi<strong>di</strong>. Come era già accaduto all'impero romano con i germani, i turchi<br />
erano stati da principio ammessi come soldati a Baghdad e nei principati islamici<br />
persiani dei Samani<strong>di</strong> e dei Ghaznavi<strong>di</strong>; si erano inoltre convertiti all'Islam, avevano<br />
costituito dei principati barbarici dalla Bactriana alla Persia e infine dal 1055 erano<br />
<strong>di</strong>ventati i protettori militari del califfo <strong>di</strong> Baghdad, un po' come i franchi avevano<br />
fatto nei confronti <strong>della</strong> Chiesa <strong>della</strong> Gallia e più tar<strong>di</strong> dello stesso papa <strong>di</strong> Roma. Ma<br />
fu nel XIII secolo che il me<strong>di</strong>oevo arabo e persiano raggiunse il suo punto più basso,<br />
con le incursioni dei mongoli, la <strong>di</strong>struzione <strong>di</strong> Baghdad e la soppressione del<br />
califfato. Dopo la nuova fase <strong>di</strong> guerre <strong>di</strong>struttive avvenute al tempo <strong>di</strong> Tamerlano,<br />
alcuni stu<strong>di</strong>osi hanno potuto parlare <strong>di</strong> un "rinascimento" islamico (letterario,<br />
artistico, religioso) nel XV-XVI secolo, a Samarcanda, nella Persia sciita, nell'impero<br />
ottomano e nell'In<strong>di</strong>a Moghul; Jean-Paul Roux ha potuto anche azzardare un<br />
paragone fra Lorenzo il Magnifico e alcuni timuri<strong>di</strong> (<strong>di</strong>scendenti <strong>di</strong> Tamerlano) <strong>di</strong><br />
Samarcanda. Un'ultima osservazione riguarda il Giappone, le cui istituzioni militari<br />
hanno colpito l'attenzione <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>osi come Marc Bloch e Robert Boutruche per la<br />
32
loro somiglianza con quelle del feudalesimo europeo. Ma il Giappone si segnala<br />
anche per aver posseduto un feudalesimo senza passare attraverso nulla <strong>di</strong><br />
comparabile a un me<strong>di</strong>oevo. È precisamente il caso inverso <strong>della</strong> Russia, che ha<br />
conosciuto un me<strong>di</strong>oevo barbarico con le invasioni turche dell'XI- XII secolo e più<br />
ancora durante l'età del dominio mongolo, dal XIII al XV secolo, ma senza nulla <strong>di</strong><br />
comparabile al feudalesimo occidentale. Nessuno dei tratti che abitualmente gli<br />
associamo (le istituzioni cavalleresche, gli aspetti quasi-contrattuali dei rapporti<br />
feudali, con la fedeltà del vassallo e i corrispondenti doveri del signore) si ritrovano<br />
nella Russia. Quando qui si affermò l'autocrazia degli zar, i boiar<strong>di</strong> <strong>di</strong>vennero<br />
anch'essi suoi servi e la Russia non conobbe mai niente <strong>di</strong> lontanamente somigliante<br />
al Parlamento inglese o agli Stati generali francesi.<br />
Bibliografia <strong>di</strong> riferimento:<br />
L'articolo <strong>di</strong> L. White jr. è The legacy of the Middle Ages in the american Wild West<br />
(1965), in Id., Me<strong>di</strong>eval Religion and Technology, University of California Press,<br />
Berkekey 1978, pp. 105-120. Alle implicazioni <strong>della</strong> "grammatica sociale <strong>della</strong><br />
frontiera" sono de<strong>di</strong>cate le penetranti analisi <strong>di</strong> W.H. McNeill, The Great Frontiel:<br />
Freedom and Hierarchy in Modern Times, in Id., The Global Con<strong>di</strong>tion, Princeton<br />
University Press, Princeton 1983. Entrambi questi scritti fanno naturalmente<br />
riferimento a RJ. Turner, La frontiera nella storia americana (1920), il Mulino, Bologna<br />
1975, respingendo però il carattere deterministico <strong>della</strong> "sfida ambientale"<br />
rappresentata dalla frontiera; in alternativa White pensa al primato dell'«attrezzatura<br />
mentale, emozionale e tecnica» dei pionieri americani, mentre McNeill tiene a<br />
mostrare i fattori che in situazioni apparentemente simili producono effetti <strong>di</strong>versi e<br />
anche opposti (come è espresso dalla contrapposizione fra libertà e gerarchia nel<br />
titolo del saggio). Una qualche propensione per il determinismo ambientale mostra, in<br />
riferimento al caso <strong>della</strong> storia russa, R. Pipes, La Russia. Potere e so- cietà dal<br />
Me<strong>di</strong>oevo alla <strong>di</strong>ssoluzione dell'Ancien Régime (1974), <strong>Le</strong>onardo, Milano 1992, cap.<br />
1, "Con<strong>di</strong>zioni ambientati e loro conseguenze". Con una perio<strong>di</strong>zzazione che include<br />
anche l'età omerica e i primi tempi <strong>della</strong> polis, un "me<strong>di</strong>oevo ellenico" figura quale<br />
periodo a sé in un'opera classica come G. De Sanctis, <strong>Storia</strong> dei Greci dalle origini<br />
alla fine del secolo V (1939), La Nuova Italia, Firenze 1961, vol. I, libro II; M.I.<br />
Finley, Il mondo <strong>di</strong> O<strong>di</strong>sseo (1953, 1977), Marietti, Casale Monferrato 1992, presenta<br />
il mondo degli eroi omerici, collocato fra l'età oscura e l'età arcaica <strong>della</strong> polis, come<br />
una ricostruzione mitica del lontano passato miceneo. <strong>Le</strong> opere ricordate a proposito<br />
del Me<strong>di</strong>oevo cinese sono J. Gernet, Il mondo cinese (1972), Einau<strong>di</strong>, Torino 1978,<br />
libro III (citazioni dalle pp. 155 e 252) e M. Sabattini, P. SantangeIo, <strong>Storia</strong> <strong>della</strong><br />
Cina, Laterza, Roma-Bari, cap. 3 (citazioni dalle pp. 217 e 218). Per il mondo<br />
islamico, si vedano M. Lombard, Splendore e apogeo dell'Islam, VIII-XI secolo<br />
(1971), Rizzoli, Milano 1980; M.G.S. Hodgson, Rethinking World History. Essays on<br />
Europe, Islam and World History, Cambridge University Press, New York 1993 e<br />
J.P. Roux, Histoire deI Grands Moghols, Fayard, Paris 1986 (citazione da p. 55). Per<br />
il feudalesimo giapponese e quello russo, si vedano: J. W. Hall, L'impero giapponese,<br />
33
Feltrinelli, Milano 1968, pp. 83-96; C. Goebrke, Russtiz, Feltrinelli, Milano 1973, pp.<br />
126-128; N.V. Riasanovsky, <strong>Storia</strong> <strong>della</strong> Russia (1984), Bompiani, Milano 1989, pp.<br />
121-126.<br />
34


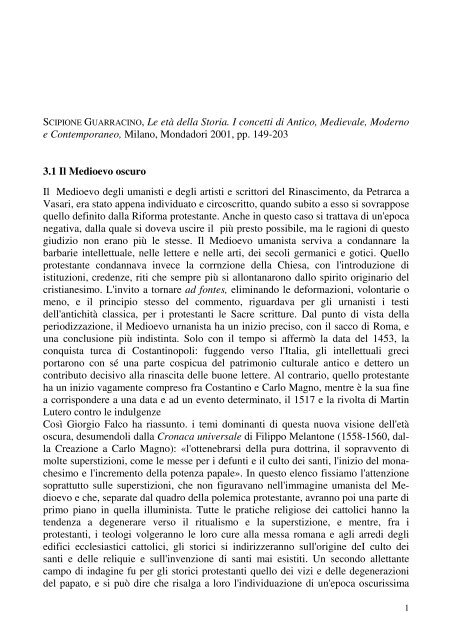
![PATROLOGIA GRECA E LATINA [Patrologiae cursus completus]. All ...](https://img.yumpu.com/50711133/1/184x260/patrologia-greca-e-latina-patrologiae-cursus-completus-all-.jpg?quality=85)