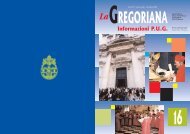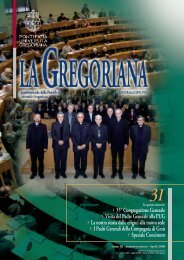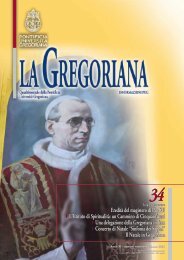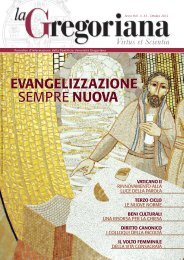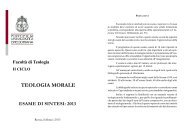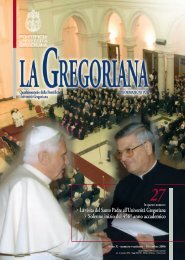FOCUS<strong>La</strong> forza della verità è liberatrice“e occorre avere il coraggiodi guardare la realtà a occhi apertiper obbedire al Signore [...]Il coraggio della verità ela lotta spirituale per la veritàaprono la strada a una fedesempre più profonda,sempre più vera”In questa foto e a pagina 5due momenti della Messadi Azione di Grazie pressola Chiesa del Gesù,lo scorso 25 febbraio <strong>2013</strong>.∫ Foto PAOLO PEGORARO/ TOBIAS TILTSCHER<strong>La</strong> forza della verità è liberatrice e occorre avere il coraggio diguardare la realtà a occhi aperti per obbedire al Signore. <strong>La</strong>Chiesa cammina, con la grazia di Dio, sulle vie del mondo e dellastoria e si ricorda sempre che non è il potere mondano – ma il poteredella Croce, dell’umiltà e dell’amore – a salvare il mondo. Ilcoraggio della verità e la lotta spirituale per la verità aprono lastrada di una fede sempre più profonda, sempre più vera.L’intelligenza della fede, fonte di dignità e responsabilitàIl Santo Padre ci ha chiamato a «essere sempre pronti a risponderea chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi» (1 Pt3, 15). Ci ha chiamato a dedicarci all’intelligenza della fede contutto l’impegno e la dedizione di coloro che sanno come tantesfide del nostro tempo siano al fondo intellettuali e richiedanole risorse della ragione, la conoscenza della nostra tradizione ela consapevolezza dei problemi e delle problematiche di oggi.Nel suo discorso alla <strong>Gregoriana</strong> (03 novembre 2006) diceva:«È il compito che Dio ha affidato all’uomo nel crearlo a sua immaginee somiglianza, un compito che riempie ogni uomo della più grande dignità,ma anche di una immensa responsabilità». Sappiamo bene cheper assumere questo compito dobbiamo vivere l’apertura e la profondità,l’interiorità e il rigore, l’impegno e il discernimento cherichiedono le questioni e poste in gioco nel nostro tempo. E questoè il nostro cammino comune in una Università come la <strong>Gregoriana</strong>.Si tratta infatti di impegnarci senza paura in questo serviziodell’intelligenza per far arrivare all’uomo di oggi il messaggiodella fede come Parola che fa vivere e sperare.L’Apostolo che disse: «Tu sai che ti amo!»<strong>La</strong> memoria viva di questo periodo ci spinge ad esprimere staseratutta la nostra gratitudine al Santo Padre e a ringraziare il Signoreper tutto ciò che ci ha dato attraverso la persona e ilministero di Papa Benedetto XVI. Possiamo vivere questo momentoeccezionale in questa Chiesa del Gesù – una chiesa e unluogo che parlano di Ignazio di Loyola, fondatore della nostraUniversità e della Compagnia di Gesù, alla quale è affidata la <strong>Gregoriana</strong>.Fin dall’inizio c’è un legame speciale, affettivo ed effettivo,che unisce ogni singolo gesuita e la Compagnia di Gesù nelsuo insieme al Santo Padre. Fin dall’inizio, il desiderio di portareil Vangelo di Cristo a tutte le frontiere del mondo e della societàha condotto a vivere l’obbedienza al Papa per essere inviati aquelle missioni che egli vorrà affidarci.Aldilà della specificità della vita religiosa gesuitica, però, tuttinoi possiamo comprendere che il nostro desiderio di seguire eamare Cristo, la nostra docilità allo Spirito Santo e la nostra disponibilitàa servire Dio e la Chiesa nel mondo ci conducono alSuccessore di Pietro – l’apostolo che disse al Risorto: «Signore, tusai tutto, tu sai che ti amo» (Gv 21, 15-17) – questo successore diPietro che si chiama Benedetto XVI e al quale vogliamo esprimereil nostro profondo affetto, la nostra grande ammirazione e la nostragratitudine, e a Colui al quale lo Spirito di Dio affiderà il Ministerodi Pietro.Lo sappiamo: il Signore è fedele e la Sua fedeltà fonda la nostrafiducia. 8 | 44/<strong>2013</strong>
Rileggere i Concilidi Trento e Vaticano IIDies Academicus <strong>2013</strong>«L’evento conciliare nella vita della Chiesa»di JOHN W. O’MALLEY, S.I.Facoltà di Teologia - Georgetown University, Washington D.C.Quando parliamo del Concilio Vaticano II, in riferimento al problemadel cambiamento, siamo facilmente condotti ad un’altraquestione pertinente ai due Concili. Spesso sentiamo, ad esempio,che una delle più grandi differenze tra il Concilio di Trento eil Concilio Vaticano II, è che quello di Trento fu convocato per affrontarela grande crisi della Riforma, mentre nessuna crisi minacciavala Chiesa nel 1959. A sostenere questo punto di vista è il fattoche l’annuncio di Papa Giovanni ha stupito praticamente tutti. Perchéc’è bisogno di un Concilio? <strong>La</strong> Chiesa sembra andare bene. Gliargomenti proposti dai vescovi per l’agenda svelavano uno scarsocarattere di urgenza, o necessità di esaminare lo stato della Chiesa.Persino quando il Concilio emanò i suoi decreti, non sembrache i vescovi avessero più di un’intuizione che, specialmente nei150 anni precedenti, il mondo era radicalmente cambiato e chemolti presupposti su cui si fondava la Chiesa erano stati sfidatialla base. Nella chiara visione del senno di poi, cinquant’anni dopola chiusura del Concilio, possiamo in realtà capire che la Chiesaha affrontato una crisi epocale – non esplosiva e ovvia come conla Riforma – ma una più sottile crisi della cultura, non meno minacciosaperché meno evidente.Quali erano gli elementi della crisi? Ho già parlato di uno deglielementi più invadenti e profondi, ovvero la nuova coscienza storicae l’applicazione di una raffinata metodologia critica a ogniaspetto del passato. Sebbene questo approccio critico al passatoavesse le sue radici nel Rinascimento italiano del XV secolo, preseuna forma pungente e maggiormente critica solo nel XIX secolo.Non sorprende che esso iniziò ad essere applicato alla Bibbia, allaliturgia, alla storia della Chiesa, e persino al dogma.L’affermazione della nuova coscienza storicaAppena il passato iniziò ad essere studiato in modo più critico,i suoi valori normativi vennero messi in dubbio. Così, come avevaosservato molti anni prima Bernard Lonergan, illustre ex professorealla <strong>Gregoriana</strong>, la concezione classica del mondo iniziava afrantumarsi. Due tratti caratterizzavano questa visione: primo,l’universo era stabile e, secondo, il presente doveva essere giudicatoin base ai risultati del passato. Entrambi questi aspetti furonoI 50 anni dall’aperturadel concilio Vaticano II(1962-2012) e i 450 annidalla chiusura del conciliodi Trento (1563-<strong>2013</strong>)si sono seguiti in pochi mesi.<strong>La</strong> <strong>Gregoriana</strong> ha riflettutosul significato dei Conciliper la vita della Chiesacon l’aiuto dello storicoJ.W. O’Malley, S.I.Queste le parole conclusivedel suo interventoal Dies Academicus <strong>2013</strong>44/<strong>2013</strong> | 9