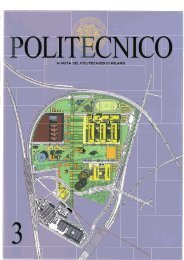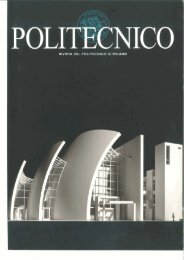POLITECNICO
Scarica il PDF (5174KB) - Rivista Politecnico - Politecnico di Milano
Scarica il PDF (5174KB) - Rivista Politecnico - Politecnico di Milano
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
TabeUa 1<br />
al) Equazione<br />
-=-<br />
PT<br />
G ~ A ~<br />
4,l'<br />
i2) P~ G ~ A ~<br />
-<br />
PT 4,l'<br />
Limitato da:<br />
c"xumcna di<br />
pimiamcnto<br />
o C ~ U r s<br />
rnrrimaanni conh<br />
durrmi di<br />
.ntenoasbado<br />
aauotenadipmamerd<br />
a m a anni eonh<br />
dimmriardi mnnm<br />
dimemimedi anicm<br />
Introduzione<br />
Considerando le limitate capacità dei primi vettori di<br />
lancio, le comunicazioni satellitari sono cominciate<br />
con satelliti sperimentali LE0 (Low EartA<br />
Orbit)(Telstai e Rela~i).<br />
A questa fase segui una dimostrazione di fattibilità e<br />
una diffusa applicazione dei GEO (satelliti geosiazionari)<br />
i cui vantaggi, identificati chiaramente fin dall'iniziale<br />
proposta di Clarkel, si identificano nella loro<br />
capacità di definire un sistema "fisso" rispetto alla<br />
Terra. Ciò permette di richiedere unicamente la presenza<br />
di tre satelliti per ottenere una copertura globale<br />
(con esclusione delle regioni polari). Questo vantaggio<br />
è apparso così importante, da porre in secondo piano<br />
le perplessità riguardo la considerevole propagazione<br />
del ritardo che, nonostante fosse di un livello accenabile,<br />
produce effetti percettibili sulla velocità di comunicazione.<br />
Di. particolare rilievo tra le succitate applicazioni<br />
è stata la rete Intelsat, che realizzò il sogno di<br />
connettere tutti gli stati nel mondo, anche se isolati o<br />
in via di sviluppo. A causa delle limitazioni nella<br />
potenza e misura dei satelliti, erano tuttavia necessari<br />
imponenti terminali di terra, con antenne del diametro<br />
di 30 metri. Questo requisito è risultato accettabile<br />
anche se ben lontano da un'ottimiiione economica,<br />
perché queste stazioni potevano essere condivise a<br />
livello di un intero Stato. L'evoluzione dei sistemi<br />
satellitari ha portato comunque verso terminali più<br />
piccoli che potessero servire un'area più ristretta o<br />
addirittura un singolo utente. Inoltre, è cresciuta la tendenza<br />
verso l'uso di più alte frequenze, per ottenere<br />
maggiori capacità di comunicazione. A questo pmposito<br />
permettetemi di fare qualche considerazione. In<br />
Appiicdone tipica<br />
Rapporto di trarmissione<br />
Tabella l sono riportate le maggiori caratteristiche<br />
concernenti alcuni sistemi GEO, ME0 e LE0 esistenti<br />
o proposti, che usano frequenze a partire dalla banda L<br />
(1-2 GHz) alla banda Ka (20-30 G~Z)~". in ciascuna<br />
delle categorie GEO, ME0 e LEO, le prime due<br />
colonne sono relative a sistemi mobili o mobili personali,<br />
dove il temine "mobile" indica operazioni con<br />
piccoli terminali di tetra capaci di essere montati e utilizzati<br />
su veicoli e di usare, moderatamente, antenne<br />
direzionali; il termine "mobile-personale" indica operazioni<br />
con terminali palmari che usano antenne omnidirezionali<br />
per evitare problemi di puntamento.<br />
L'ultima colonna relativa ai satelliti GEO e LE0<br />
riguarda sistemi a larga banda che usano piccoli terminali<br />
da installare presso siti predefiniti dall'utente.<br />
Copertura completa versus copertura "a spotn<br />
L'architettura dei sistemi satellitari può essere classificata,<br />
in principio (Figura 2) in due categorie concettualmente<br />
differenti: a) sistemi che usano un transponder<br />
trasparente ed un'antenna a copertura completa<br />
(cioè un'antenna che copra I'inera area di nutenza);<br />
b) sistemi cellulari che usano antenne multifascio e<br />
on-boardnvitchirig. Da notare è che sebbene i satelliti<br />
multifascio producono una copertura cellulare concettualmente<br />
identica alla copertura di sistemi cellulari<br />
terrestri, c'è una difirenza fondamentale riguardo alla<br />
dimensione della cellula, che è molto più elevata nel<br />
caso dei satelliti. La soluzione a) è ottimale quando lo<br />
stesso segnale èinviato a tutti gli utenti connessi in<br />
"broadcastiiig". E tuttavia lontana dalla soluzione 0thmale<br />
quando segnali differenti sono inviati ad utenti<br />
differenti e, nel caso estremo, quando ogni segnale<br />
particolare è inviato ad un siigolo utente; questo chia-<br />
ramente awiene in conversazioni bilaterali, cioè nei<br />
classici sistemi di telecomunicazioni.<br />
In effetti, inviando dappertuito un segnale che abbia<br />
una specifica destiiazione, si produce dispersione di<br />
potenza e di spettro di frequenza. In questo caso, la<br />
soluzione b) è più conveniente perché permette di:<br />
risparmiare potenza da satellite e da tetra concentrando<br />
e focalido l'irradiazione e la captazione del segnale<br />
lungo la direzione di interesse, di riutilizzare le<br />
medesime frequenze su fasci non adiacenti.<br />
Questi vantaggi, tuttavia, vengono raggiunti a costo di<br />
una maggiore complessità e di una flessibilità molto<br />
ridotta. Con riferimento all'ultimo punto, si consideri<br />
ad esempio che la soluzione a), al contrario di b), consente<br />
di cambiare, in un determinato sistema satellitare<br />
anche se gia operativo, il metodo di modulazione e di<br />
accesso senza la necessità di variare il segmento di<br />
spazio.<br />
Broadcasting<br />
Sulla base delle considerazioni precedenti e valutando<br />
le potenzialità dei satelliti che posso essere costnllti e<br />
lanciati ai nostri giorni, è immediato concludere che i<br />
satelliti GEO sono particolarmente adatti ad ofire,<br />
con configurazioni semplici e flessibili, broadcastitig<br />
televisivi con l'impiego di terminali a ridotta apertura<br />
(antenne con diametri di pochi decimetri). La menzionata<br />
flessibilità permette oggi di variare in un deteminato<br />
satellite la trasmissione di segnali visivi da analogica<br />
a digitale, approfittando in questo modo delle tecniche<br />
moderne ed avanzate di compressione a larghezza<br />
di banda. E possibile la allocazione di almeno cinque<br />
canali digitali in vece di un canale analogico.<br />
Comunicazioni bilaterali<br />
Quando, contrariamente al puro broadcasti~~g, è necessaria<br />
la trasmissione di ritorno da un piccolo terminale,<br />
nascono notevoli difficoltà a causa delle limitazioni di<br />
potenza nei terminale stesso. Casi estremi sono :<br />
Catiale di iitortio coli tiiolta riiiriore<br />
capacità rispelto al canale diretto<br />
Questa è una situazione che nasce ad esempio in sistemi<br />
di teleeducazione, quando un segnale video è trasmesso<br />
da un centro di insegnamento ad una comunità<br />
di utenti mentre un segnale audio è messo a disposizione<br />
per una comunicazione di ritorno (per domande,<br />
osservazioni etc.). ,Alcuni sistemi V-SAT, rientrano in<br />
questa categoria. E in effetti la modesta capacità del<br />
canale di ritorno che consente di mantenere entro limiti<br />
accettabili la potenza di trasmissione da piccoli terminali<br />
di terra. Un'ulteriore riduzione di tale potenza<br />
pub essere ottenuta usando un sistema multifascio sul-<br />
I'irplink, a patto che tale riduzione sia così importante<br />
da giustificare l'incremento di complessità.<br />
Figura 3<br />
Funzioni di accesso ed interconnessione in un sistema<br />
multisatellitare: il sistema corrisponde ad una rete<br />
terrestre in cui le stazioni di base, le stazioni<br />
di controllo e le reti di interconnessione sono state<br />
trasferite nello spazio. Una singola stazione gateway<br />
b sufficiente in linea di principio per connettere il<br />
sistema alla rete terrestre (ad esempio la soluzione<br />
IRIDIUM, vedi Tabella I).<br />
Figura 4<br />
Funzione di accesso solo In sistema mutisatellitare:<br />
corrisponde ad una rete terrestre in cui le stazioni<br />
di base sono state trasierite nello spazio (ad esempio<br />
la soluzione Globestar. vedi Tabella I).<br />
Comirriicazioiii bilanciate bilaterali irtente-iriente<br />
Come già rilevato, questa soluzione è tipica di classiche<br />
telecomunicazioni per le quali la soluzione ottimale<br />
in termini di potenza e spettro di frequenza k un<br />
sistema multifascio (o cellulare). Daremo attenzione a<br />
questo aspetto nei prossimi paragrafi. in Figura 2, si fa<br />
riferimento a soluzioni che sono tipiche dei sistemi<br />
GEO e particolarmente di un satellite GEO che serve<br />
una determinata regione.<br />
Se si considerano sistemi multiisatellitari (e questo è<br />
sempre più il caso per sistemi ME0 e LEO) i collegamenti<br />
intersatellitari possono dare la possibilità di